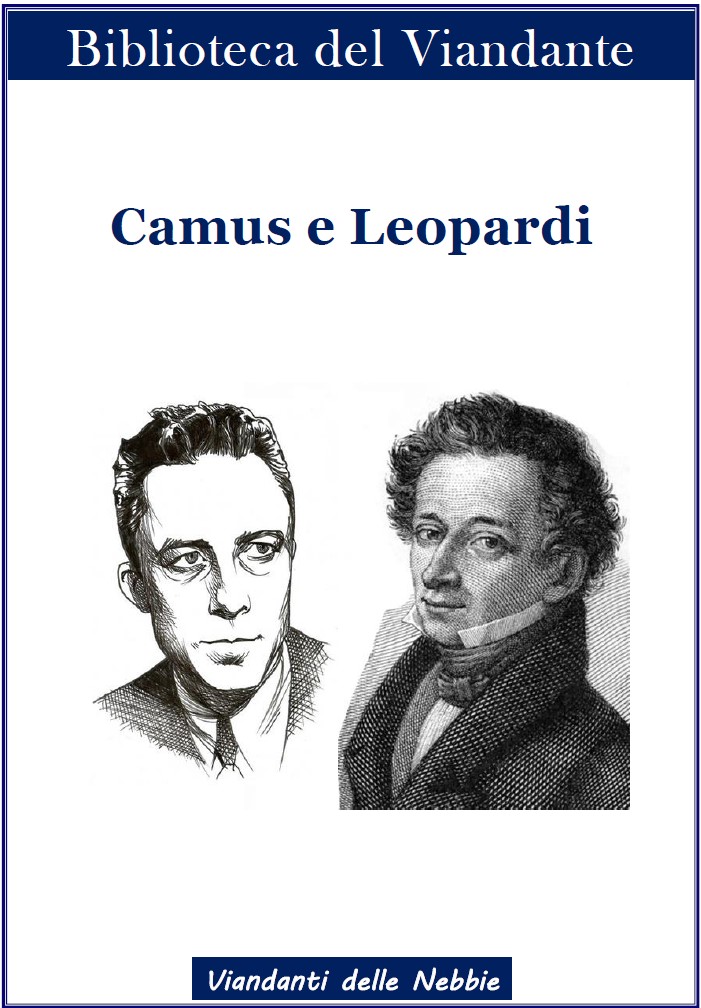Andrea Caffi, o della socievolezza
Andrea Caffi, o della socievolezza
di Paolo Repetto, 25 aprile 2025
Introduzione
Una brava persona
Una vita sopra (e dietro) le righe
Amicizia
Socialismo
Stato, popolo, società
Democrazia e libertà
Europeismo
Intellettuali
Verità
Utopia
Straniero
Verso una conclusione
E finalmente ….
Bibliografia
Appendice: Nicola Chiaromonte, Introduzione a Andrea Caffi, Critica della violenza, Bompiani, 1966
Introduzione
 Arrivava all’improvviso,
Arrivava all’improvviso,
non si sapeva da che parte del mondo,
con gli abiti sgualciti e l’aria di avere un grande appetito.
Scompariva allo stesso modo,
senza che si sapesse perché né per dove.
Da per tutto portava la sua gentilezza,
un’aria d’innocenza,
un enorme fascio di erudizione che slegava
e da cui traeva regali a qualunque richiesta.
Non sono granché espansivo e non amo i superlativi. Il complimento più sentito che arrivo ad esprimere è: “Sei una brava persona”. E nemmeno questo lo spendo spesso, non perché sia particolarmente esigente (insomma, forse solo un po’) ma perché ritengo che anche la stima, come il disprezzo, vada distribuita con parsimonia, per lo stesso motivo: perché sono in molti a meritarseli (non è mia, l’originale è di Chateaubriand). Lo uso quindi solo eccezionalmente, con chi magari ho occasione di frequentare per un breve periodo e la prospettiva di non rivedere più; gli altri, coloro che mi conoscono bene, non hanno bisogno che esterni il mio apprezzamento: voglio credere che lo sentano.
Io ritengo che esistano le “brave persone”, nell’accezione più inclusiva di questa qualifica, così come esistono esseri spregevoli, e che tanto le une che gli altri non siano resi tali dall’ambiente, dai condizionamenti famigliari, dalle circostanze o dallo status sociale. Credo semplicemente che alcuni nascano onesti e ben disposti, e altri no. Le circostanze, i condizionamenti, l’ambiente, stanno tra queste due polarità, spiegano e a volte giustificano molte cose, ma la sostanza rimane quella.
L’essere o meno una brava persona (che vale anche per “intelligente”) è innanzitutto una questione di indole. Lo dico nella consapevolezza di non stare ad uno dei due poli, di stazionare in mezzo: la mia presunzione, o la mia speranza, arriva al massimo a collocarmi leggermente spostato verso quello positivo, piuttosto che verso le carogne.
Per essere una brava persona non necessitano meriti particolari e virtù specifiche: è sufficiente vivere nel costante rispetto degli altri, prestando attenzione a non arrecare loro danno o fastidio, e comprendere le necessità altrui, condividerne sinceramente i problemi e aiutarli, nei limiti delle possibilità e della non invadenza, a risolverli. Nella sostanza, concedere fiducia agli altri ed evitare nei rapporti il sospetto, l’invidia, il rancore e l’egoistica attesa di una gratificazione che non sia quella interiore: gioire dei loro successi e partecipare dei loro dolori. Che, a pensarci bene, non è poco. Comunque, altrove ho definito questo atteggiamento “solidarietà”, usando un termine caro a Camus, e ritengo fosse già una definizione esauriente.
Ora, chiamatelo pure “determinismo genetico”, chiamatelo come volete, ma è quello che penso, e che ho espresso credo abbastanza chiaramente in tutto ciò che ho scritto sino ad oggi, distinguendo semplicemente tra coloro che si sentono sempre in debito con la vita (e con gli altri) e coloro che rivendicano costantemente un credito. Sarà poco confortante ritenere che i nostri comportamenti siano dettati piuttosto dalla natura che dalla nostra cultura, potrà sembrare anche che finisca per deresponsabilizzarci (non per come la vedo io), ma lo ritengo l’unico modo per dare un senso alla nostra vita e organizzare realisticamente la nostra risposta alle disillusioni e alle trappole che ci riserva.
25 aprile 2025
Una brava persona
Andrea Caffi era tra coloro che vivono sentendosi in debito, e che non gestiscono questa attitudine con angoscia, ma con spirito propositivo: che ritengono cioè di doversi dare da fare per migliorare il mondo, ma sempre nel rispetto della dignità e della libertà altrui. Era prima di tutto, e soprattutto, una “brava persona”. Poi era tante altre cose, un intellettuale enciclopedico e raffinato, un poliglotta che parlava sette o otto lingue, un sincero amante della libertà, un conversatore affascinante: ma il motivo per cui ha lasciato in chi lo conobbe un’impronta così forte era innanzitutto il suo modo discreto, schivo ma tutt’altro che scostante, di proporsi.
Per introdurre questo singolare personaggio ho scelto due diverse descrizioni, quella di Prezzolini riportata in esergo e quella fattane da Nicola Chiaromonte, forse il suo migliore amico e maggiore estimatore, nella prefazione a Critica della violenza (Bompiani 1966): Scrive Chiaromonte: «Era, questo, un uomo che più delicato e nobile è difficile immaginare, e certamente rarissimo trovarne: un uomo che tutte le qualità della mente e dell’animo dicevano fatto per essere accolto e onorato nei luoghi più eccelsi di una società ideale, e particolarmente fra gli uomini di pensiero e di cultura; e il quale invece sceglieva deliberatamente la solitudine e l’oscurità, incapace com’era di fare la più piccola concessione quando si trattava non dico della sua integrità morale o delle sue idee, che sarebbe un parlare solenne, ma semplicemente della sua sensibilità. Ogni tentativo, anche il meglio intenzionato, di procurargli una via d’uscita da tale isolamento, e dalle angustie che comportava, rimase inutile fino all’ultimo. Sicché era evidente che non si trattava tanto di riluttanza al compromesso, quanto della volontà di non “inserirsi” in alcun modo in una società che gli dispiaceva profondamente. […] C’era il Caffi eretico, intellettuale la cui visione non si adattava a nessuna prospettiva comunemente accettata e verso il quale solo alcuni pochi individui isolati, o comunque insoddisfatti dei gruppi esistenti e delle idee correnti, potevano sentirsi attratti; e di questi, pochissimi a lungo, perché i sentieri per i quali Caffi trascinava chi lo seguiva erano davvero Holzwege, sentieri non tracciati in anticipo e di cui non si sapeva dove conducessero; dunque stancanti. Dietro questo Caffi eretico e irrequieto c’era lo spirito solitario, assorto in un mondo di pensieri segreti e di operazioni intellettuali addirittura misteriose nel quale raramente, anche nei momenti di maggiore confidenza, si apriva qualche spiraglio».
A sua volta, invece, il ricordo di Prezzolini prosegue così: «Siccome era di un’estrema delicatezza e indipendenza di spirito, non ci si accorgeva delle sue ristrettezze altro che dagli abiti e dallo sguardo con il quale di traverso guardava una tavola apparecchiata quando lo si invitava […]. Aveva un modo di sfuggire ogni curiosità e indagine sulla sua persona che lo rendeva molto simile a quei personaggi dei romanzi russi che rispondono con frasi svagate e allusive alla polizia degli zar».
Si sarà già capito a questo punto che la figura di Caffi non si lascia catturare facilmente. Bisogna più che mai guadagnarsela, andando a leggere, oltre allo scritto di Chiaromonte (che allegherò integralmente a questo pezzo), anche gli altri interventi, i ricordi, le recensioni agli scritti raccolte già diverso tempo fa in due Quaderni pubblicati dalla Biblioteca dei Viandanti (Su Andrea Caffi e Andrea Caffi. Scritti scelti di un socialista libertario che per l’occasione ora rieditiamo, ampliati e aggiornati). Poi, certo, meglio ancora sarebbe accostare direttamente gli scritti di Caffi, che negli ultimi tempi sono divenuti in parte rintracciabili, o affidarsi agli studi a lui dedicati che, dopo un lunghissimo periodo di oblio, cominciano a fiorire (li segnalerò nella bibliografia). Anche così, comunque, non si arriverà mai ad una conoscenza non dico completa, ma nemmeno sufficientemente esaustiva: la sua figura rimarrà sfuggente e misteriosa, perché trovare una vita più disordinatamente ricca è quasi impossibile, ma anche perché più che attraverso gli scritti Caffi testimoniò il suo impegno con un singolarissimo stile di vita, con un magistero di esemplarità socratica («Vivergli vicino era una gran lezione di generosità e di nobiltà», scrive Chiaromonte), che si esplicava soprattutto nelle conversazioni con gli amici (i suoi modelli culturali erano principalmente quelli dell’antica Grecia, del dialogo platonico, e dei salotti pietroburghesi nei quali si raccoglieva l’intelligencija russa nell’Ottocento), o nelle chilometriche lettere che inviava loro. E comunque non si è mai rivelato completamente ad alcuno. Tra l’altro, e anche questo è significativo, possediamo solo tre o quattro suoi ritratti fotografici, tutti molto sfocati, a bassissima definizione. Perfettamente in linea con lo stile del personaggio.
Molti aspetti dell’esistenza di Caffi rimangono dunque oscuri. Si aggiunga che buona parte dei suoi scritti è andata dispersa e infine che la “pietas” amicale ha indotto chi lo conosceva a passare sotto silenzio certi tratti della sua personalità ritenuti, all’epoca, sconvenienti. In altre parole, Caffi era probabilmente omosessuale, e non è un caso che a farne menzione sia Alberto Moravia, che lo aveva conosciuto e ne era diventato amico prima ancora di pubblicare Gli indifferenti, e che in queste cose aveva l’occhio lungo: ma il nostro era così discreto che nessun altro dei suoi conoscenti ha mai toccato questo tasto, e neppure i dossier della polizia fascista e di quella di Vichy ne fanno menzione. Ora, se anche è vero che ciò non sposta di una virgola il senso del suo impegno e la portata del suo ingegno, è presumibile che abbia comunque influito in qualche misura sulle sue scelte culturali e politiche, oltre che sul suo comportamento. Stiamo parlando della prima metà del secolo scorso, di un periodo nel quale la considerazione sociale dell’omosessualità era pessima, e gli intellettuali inglesi della “generazione perduta”, anche quelli più “impegnati”, da Ishewood a Austen, cercavano “autenticità” sulle due sponde del Mediterraneo. Ma Caffi è di un’altra pasta, e credo occorra tenerne conto se davvero si vuole correttamente interpretare e valorizzare il suo pensiero.
Date queste premesse, mi limiterò a sbozzare le linee essenziali (che non sono poche, e corrono tutt’altro che rette) della biografia di Caffi, le vicende e le traversie più significative: quel tanto insomma sufficiente ad offrire un minimo di indicazioni a chi non l’avesse mai sentito nominare. Premetto già che sarà una ridda di incontri, di collaborazioni, di nomi e di titoli, ma questo è ciò che passa la sua agitatissima esistenza. Ed è anche ciò che rende quasi inspiegabile il silenzio che ha poi inghiottito la sua figura, stante che tutte le iniziative culturali e politiche del periodo tra le due guerre, nonché di uno scampolo di quello immediatamente successivo, lo vedono presente, sia pure sempre nello sfondo, di passaggio, con una gamba già in uscita dalla foto.
P.S. nel rileggere questo pezzo ho contato almeno trenta nomi che rappresentano l’élite del pensiero europeo nel primo mezzo secolo del Novecento e che hanno interagito con Caffi. E Caffi non era un cacciatore di autografi o di selfie, al contrario. Tutta questa gente non solo lo ha conosciuto o ha lavorato con lui, ma è rimasta affascinata dalla sua personalità e sbalordita per la vastità e la profondità della sua cultura.

Una vita sopra (e dietro) le righe
Andrea Caffi nasce a Pietroburgo nel 1887, da genitori italiani che lavorano nell’ambiente teatrale e che non sono privi di sensibilità politica oltre che artistica (il nonno paterno, Ippolito Caffi, pittore vedutista, aveva partecipato come garibaldino alle rivoluzioni del ‘48 e all’impresa dei Mille, ed era morto nella battaglia di Lissa). Riceve un’ottima istruzione, della quale si dichiarerà poi grato per tutta la vita, nel Liceo Internazionale di quella città, conosce il pensiero di Proudhon e si appassiona alla vicenda di Aleksandr Herzen e dei populisti russi dell’Ottocento, e ancora giovanissimo aderisce al socialismo, militando nella corrente menscevica. A sedici anni è tra gli organizzatori del sindacato dei tipografi e lavora nella clandestinità al fianco di Kalinin e di Molotov.
Nel 1905 è in prima fila in quella che può essere considerata la prova generale nella rivoluzione russa. Viene più volte arrestato ed è condannato infine a tre anni di carcere; due di questi li sconta nella colonia penale di Jekaterinoslav, rischiando seriamente di lasciarci la pelle per il tifo e per gli stenti. Liberato nel maggio del 1908, inizia per lui un esilio destinato a durare praticamente tutta la vita. Si rifugia come studente universitario a Berlino, dove segue le lezioni di Georg Simmel e stringe amicizia con Antonio Banfi (che così lo ricorderà: «M’era compagno lo spirito più arcangelo e più vivo che mai conobbi, Andrea Caffi, fuggitivo dalla prigionia per i moti del 1905-06, un umanitario ribelle, raffinato e semplice insieme di vita, poliglotta e colto all’estremo, arguto e entusiasta, con cui scrivemmo pagine e pagine sulla cultura europea contemporanea».
In questo periodo viaggia per tutta l’Europa, facendo spesso base a Parigi, dove entra in contatto con le avanguardie artistiche e letterarie di inizio secolo e in una sentita amicizia con Ungaretti. Crea inoltre, con un gruppo di amici, la Jeune Europe, un sodalizio che ha fortissime (e ingenue) ambizioni di rigenerazione della cultura occidentale. Soggiorna anche in Italia, collaborando con Giuseppe Prezzolini e Scipio Slataper e frequentando a Firenze il gruppo della rivista La Voce. E visita, a Rapallo, il grande esule Piotr Kropotkin (che considera «lo spirito più puro del movimento rivoluzionario russo»).
Nel 1914 è sconvolto dallo scoppio della guerra in Europa; eppure, nonostante professi sin da ragazzo il più convinto pacifismo, si arruola volontario nelle legioni internazionali “garibaldine” in Francia. Come spiegherà in seguito a Chiaromonte, che gliene chiede ragione, «in primo luogo, non gli era stato possibile non desiderare la sconfitta del militarismo tedesco e la vittoria della Francia; in secondo luogo, vedendo partire tanti amici incontro alla morte la sola scelta personale ammissibile gli era parsa quella di condividerne il destino; in terzo luogo, di fronte a una guerra che lui, come molti altri in Europa, aveva sentito approssimarsi fatalmente fin dal 1911, e della quale si poteva esser certi che avrebbe messo a ferro e fuoco l’intero continente, non gli era sembrato possibile invocare delle ragioni di principio». Insomma, sicuramente ha anche desiderio di contribuire alla sconfitta del militarismo prussiano, ma soprattutto non intende sottrarsi alla sofferenza e al destino della sua generazione. Senza contare che attorno a lui aleggiava sempre lo spirito del nonno.
Ai primi di settembre prende dunque parte alla battaglia delle Argonne, nel corso della quale viene ferito. Se dobbiamo credere alla testimonianza di Banfi, andava all’assalto senza impugnare un’arma (ma è una cosa raccontatagli da Caffi stesso, sulla quale avrei parecchie perplessità: non che non fosse capace di farlo, ma dubito glielo lasciassero fare). L’anno successivo viene arruolato nell’esercito italiano, ed è nuovamente ferito nel luglio 1915 sul Sabotino, riportando una menomazione che lo tormenterà per tutta la vita. Il resto del conflitto lo trascorre poi a Belluno, come interprete presso il comando della 4ªarmata. All’inizio del 1918 viene trasferito, per la sua conoscenza delle lingue slave, presso un ufficio speciale creato a Berna per fare propaganda fra le nazionalità oppresse dell’impero asburgico.
Dopo il congedo rimane in Italia e avvia una collaborazione con i nascenti circoli europeisti, pubblicando assieme a Umberto Zanotti-Bianco una rivista, La giovane Europa, che vuole denunciare i problemi creati dalle durissime condizioni di pace imposte dai vincitori a Versailles, e chiederne la revisione. L’esperienza dura poco, ma detta già alcune linee di pensiero alle quali Caffi rimarrà fedele sino alla fine dei suoi giorni.
Nell’estate del 1919 è inviato come corrispondente del Corriere della Sera nel Caucaso, dove i crolli dell’impero russo e di quello ottomano hanno lasciato via libera a rivendicazioni e ritorsioni nazionalistiche e a scontri caotici e sanguinosi; si ferma però per qualche mese a Costantinopoli, dove assiste alle convulsioni della nascita del nuovo stato turco e ha anche modo di constatare come le potenze europee trattino con arroganza e sprezzante miopia le aspirazioni dei popoli ex-ottomani.
Di lì, all’inizio dell’anno successivo passa clandestinamente via Odessa in Ucraina, e finisce in un primo momento tra le truppe del generale “bianco” Denikin. Quando queste si ritirano viene finalmente a contatto con i “rossi” e comincia a collaborare con l’amministrazione bolscevica, prima a Kiev e poi a Char’kov.
Il paese è dilaniato dalla guerra civile, tenuto sotto assedio dalle diverse armate controrivoluzionarie arruolate e supportate dall’Intesa, e inizialmente Caffi non vede altra via d’uscita che l’energica dittatura dei bolscevichi, per spietata che sia. Rimane però critico rispetto al progetto di esportare la rivoluzione su scala europea o addirittura mondiale. «Le imitazioni – scrive – sono una povera cosa nella vita dei popoli come in quella delle persone.» A maggio è a Mosca, ospitato da Angelica Balabanoff, ex amante del Mussolini socialista, poi segretaria della Terza Internazionale e introdotta nelle alte sfere del governo rivoluzionario. Qui collabora con istituti culturali – come lo Studio Italiano – promossi dai sostenitori nostrani della rivoluzione (tra questi Prezzolini, Zanotti-Bianco e Odoardo Campa), che intendono propagandare all’esterno i programmi e sostenere all’interno l’azione del nuovo governo, nonché restaurare i rapporti economici tra la Russia e l’Italia interrotti dal blocco commerciale antisovietico che l’Intesa ha decretato. Caffi è convinto che l’impegno più urgente sia quello di una collaborazione economica, prima ancora di quella culturale, per consentire al paese di uscire dall’emergenza e al regime di allentare la stretta.
Nel giro di pochi mesi però la sua valutazione del bolscevismo cambia, e Caffi diventa sempre più insofferente dei metodi che il governo rivoluzionario usa e degli scopi che sembra proporsi. Grazie alla Babalanoff riesce ad infiltrarsi nel servizio stampa del Comintern, e qui intraprende un’opera di contro-informazione, raccogliendo in un bollettino «ritagli di giornali stranieri, tradotti in russo, accuratamente scelti al fine di suscitare il massimo possibile di dubbi nell’animo di un ancora onesto militante della Terza Internazionale». Naturalmente dopo la pubblicazione di una decina di opuscoli la Ceka si accorge della beffa e nell’ottobre del 1920 Caffi viene denunciato come “controrivoluzionario”, arrestato e imprigionato alla Lubianka. Ancora una volta a cavarlo dai guai è la provvidenziale Balabanoff, che lo sottrae all’ultimo momento al plotone d’esecuzione. Ormai è però divento sospetto al nuovo regime: gli è vietata ogni corrispondenza con l’estero e sono sequestrati i suoi (peraltro scarsissimi) beni. Già agli inizi del 1921 scrive a Prezzolini: «Comprenderai come non ti possa scrivere molte cose che dovrei dirti. Mi dispiacerebbe se tu pensasti male di me o se ponessi tutto sul conto di un temperamento irregolare. Quest’anno è stato il più serio della mia vita. Non so quando potrò rivedere l’Europa»; che neanche troppo velatamente è la confessione di un fallimento. È costretto a «disinteressarsi completamente da ogni intrigo, […] essere molto riservato». Lascia Mosca, uscendo «da un continuo incubo, da quasi tre anni di astrazione completa di ogni senso di esistenza personale» all’inizio di giugno del 1923, e con un percorso contorto e difficile, attraverso la Lettonia, la Polonia e l’Austria, arriva a Roma alla fine del mese. Angelica Balabanoff, caduta anche lei in disgrazia, lo ha preceduto di un anno.
Una volta in Italia Caffi ricuce i contatti con Salvemini e con Zanotti-Bianco collaborando prima al quotidiano Il popolo (del partito popolare) e poi dirigendo dall’aprile ‘25 all’ottobre seguente La Vita delle Nazioni. I suoi articoli sulla rivoluzione bolscevica suscitano l’ammirazione di Piero Gobetti e persino di Gramsci, e il suo attivismo politico nei quartieri popolari romani conquista adesioni alla causa socialista. Nel frattempo si occupa di storia bizantina, diventando uno specialista della materia, tanto che sarà chiamato ancora nel 1927 da Gioacchino Volpe a redigere voci di storia dei paesi slavi per l’Enciclopedia Italiana. Nel maggio 1925 è tra i firmatari del Manifesto degli intellettuali antifascisti promosso da Benedetto Croce, mentre nel corso del 1926 collabora a Quarto Stato di Pietro Nenni e di Carlo Rosselli e alle Ricerche religiose di Ernesto Buonaiuti. Pubblica inoltre su Volontà, una rivista diretta da Vincenzo Torraca, l’articolo Cronaca di dieci giornate, dove ricostruisce nel dettaglio il delitto Matteotti. È significativa la descrizione che dà Francesco Fancello, il redattore della rivista, del primo incontro con Caffi: «Entrò uno spilungone, per accento e aspetto simile ad uno dei tanti intellettuali russi che si erano sparsi per l’Europa dopo la rivoluzione bolscevica: era Caffi. Mi si presentò senza preamboli col suo solo nome e cognome e mi espose il motivo della sua visita. “Ho preparato questo articolo – disse – intitolato Cronache di dieci giornate, che riguarda l’assassinio Matteotti. Penso che potrà interessarvi”. Gli risposi che avrei letto e volentieri pubblicato il pezzo se consono all’indirizzo della Rivista. Poiché eravamo circondati da spie e da agenti provocatori, lo accomiatai senza chiedergli né chi fosse né chi lo avesse a noi indirizzato».
A dispetto di tutte le cautele Caffi è comunque già nel mirino dei fascisti. Tra l’esilio e la clandestinità ha sino ad ora scelto quest’ultima, ma nell’autunno del 1927, per sfuggire al rischio di arresto da parte dell’OVRA, deve rifugiarsi in Francia. Trova in verità una sistemazione ottima, perché è ospitato a Versailles nella villa del principe Caetani, dei cui nipoti diventa precettore, ed è inoltre segretario di redazione della rivista Commerce. Partecipa dunque agli incontri periodici di artisti e scrittori che si ritrovano nella villa, tra cui Paul Valéry, Fernand Léger e Jean Paulhan.
Verso la fine del 1930 però, chiusa anche la collaborazione con la rivista, si trasferisce nel sud della Francia, per stabilirsi poi di lì a poco stabilmente a Parigi. Qui entra subito nel giro dei fuorusciti antifascisti, nonché nei circoli degli esuli russi. Frequenta Modigliani, Saragat, Angelo Tasca e Giuseppe Faravelli, che condividono con lui le riserve nei confronti dell’unità d’azione con i comunisti nei fronti popolari e il rifiuto dello stalinismo. Collabora per un certo periodo con Carlo Rosselli e con Giustizia e Libertà, salvo interrompere poi la collaborazione per dissensi sulla linea del gruppo, sino a rompere definitivamente assieme a Mario Levi, Renzo Giua e Nicola Chiaromonte. Nasce in questo frangente la strettissima amicizia che lo legherà all’intellettuale lucano sino alla morte (e anche oltre, visto il prodigarsi di Chiaromonte per far conoscere postumi la figura e il pensiero di Caffi).
Dopo l’invasione tedesca della Francia si trasferisce a Tolosa, dove opera un gruppo di socialisti italiani fuorusciti, tra i quali Olindo Gorni, e prende contatto con gruppi della resistenza francese. Nel 1944 è arrestato, imprigionato nelle carceri di Vichy e torturato. Ma la scampa anche stavolta.
Nel dopoguerra torna a Parigi, dove diventa amico di Albert Camus e grazie a lui lavora (saltuariamente) presso l’editore Gallimard. Pubblica anche articoli su Politics, la rivista della sinistra radicale anticonformista statunitense diretta da Dwight Macdonald, sulla quale scrivono Chiaromonte – che è ormai il suo tramite, come lo era stato prima Salvemini –, Hannah Arendt, Mary McCarthy e Paul Goodman. A dispetto di tutti questi contatti la sua esistenza continua a svolgersi nella più assoluta precarietà. Di norma non ha in tasca una lira, e quando ce l’ha trova il modo di disfarsene velocemente, magari anteponendo piccole innocenti vanità – ha la fissa dell’acqua di colonia – ai bisogni alimentari più immediati. Alla lunga però la sua salute ne risente, Nel 1955 finisce all’ospedale della Salpetrière, e lì muore in perfetta solitudine, senza disturbare nessuno, così come aveva fatto per tutta la vita. Che può non sembrare tale, ma è un modo elegante per andarsene con dignità e lasciare negli amici una immagine “viva”.
Fin qui la parte “utile”, che spero contribuisca ad allargare a qualche amico la familiarità con la figura di Caffi. Personaggio che riesce intrigante già di per sé, per la sua storia personale, ma va necessariamente letto di conserva con le sue opere. Mi rendo conto di dire una banalità, le opere sono sempre parte essenziale di ogni esistenza, di quella di un intellettuale o di un politico come di quella di un idraulico, ma in questo caso intendo sottolineare come esista una coerenza perfetta e costante tra quel che Caffi ha predicato e come ha razzolato. Non è sempre così (anzi, non lo è quasi mai), per altri vale esattamente il contrario, e anche questo offre una chiave di lettura.
Ciò che segue è invece un tentativo di mettere sinteticamente a fuoco i temi che caratterizzano un complesso percorso intellettuale, seguendo proprio il filo di quella coerenza. Anche se cercherò di farlo con le sue parole, più che di ciò che Caffi ha effettivamente detto parlerò naturalmente di quello che io ci ho trovato: che è davvero molto, e che mi sarebbe servito già tanto tempo fa per schiarirmi un po’ le idee, ma che va assunto (come il Manifesto di Ventotene, tanto per rimanere nell’attualità, del quale il nostro è stato a distanza un ispiratore, ma su molti aspetti del quale non sarebbe stato d’accordo) con la consapevolezza della distanza temporale che è intercorsa. Quindi parlerò (come al solito) molto di me, di quel me che nel suo piccolo vorrebbe sentirsi compagno di spiriti come quello di Caffi, e in qualche modestissima misura depositario del loro insegnamento. Va da sé che tali considerazioni sono meno “utili”, non hanno la pretesa di fornire alcuna “interpretazione autentica”, e che danno per scontata la conoscenza dei testi cui mi riferisco, in assenza della quale sarà difficile coglierne appieno il senso: ma confido possano magari essere di stimolo proprio a recuperare questa conoscenza.

Andrea Caffi e Nicola Chiaromonte, Tolosa 1947
Amicizia
Quando mi imbatto in personaggi della stoffa di Caffi provo immancabilmente disappunto per non averli incontrati prima. Nel suo caso, come dicevo sopra, non si tratta del rammarico per una mancata consuetudine diretta (è morto quando avevo sette anni, anagraficamente poteva essere mio nonno), ma dell’irritazione per non essere arrivato a conoscenza del suo pensiero, e della sua stessa esistenza, sino a pochi decenni fa. Penso che leggerlo ai tempi della mia prima formazione mi avrebbe risparmiato parecchi giri a vuoto nei meandri delle varie sinistre, e mi è di scarsa consolazione l’essere approdato, con un percorso molto personale e spesso contradditorio, a una particolare consonanza con molte delle sue analisi e delle sue valutazioni e coi suoi convincimenti, lo scoprire che un itinerario abbastanza simile al mio era già stato compiuto, con ben altri esiti, da una mente di quel calibro. Un conto però era percorrere quella strada un secolo fa, come fece Caffi, viaggiare controcorrente nel pieno della bufera della transizione verso un “nuovo ordine” politico, culturale e sociale, denunciare le menzogne e le illusioni dietro le quali si nascondeva, sotto nuove spoglie, l’eterna prosaica lotta per il potere; e almeno in parte lo sarebbe stato ancora sessant’anni fa, quando si era costretti a zigzagare tra le ubriacature ideologiche e il vandalismo decostruzionista che hanno accompagnato la nascita della società post-moderna. Altra cosa è doversi limitare a prendere atto oggi, col senno di poi, delle false piste e delle disillusioni indotte, oltre che dalla mia indubbia ignoranza, dalla malafede (per usare un termine di Chiaromonte) altrui.
L’impressione che Caffi ha lasciato nel cuore e nella testa di chi lo ha frequentato mi dice che mi sono perso davvero molto. Possedeva un’erudizione sterminata, tutt’altro però che esibita e spocchiosa, anzi, messa totalmente al servizio della funzione reciprocamente accrescitiva che attribuiva all’amicizia. Prezzolini racconta: «Era curioso che un uomo sapesse tante cose senza avere accanto una biblioteca personale. Se in una conversazione usciva qualche frase contenente un’inesattezza, si poteva esser sicuri che il giorno dopo si riceveva una lettera di lunghe correzioni e prove. Da giovane, mi accadde di dire qualche corbelleria intorno all’Ucraina, e credo di conservare ancora una lettera di trenta pagine nella quale mi faceva tutta la storia della lingua, della letteratura e della nazione ucraina. Tutto questo, certamente, senza consultare un libro, senza chiedere il parere di nessuno […]». (In realtà, a stesura ultimata di questo scritto ho fortunosamente rintracciato il testo della lettera: le pagine erano probabilmente non più di mezza dozzina – a stampa sono tre – e l’occasione era una recensione frettolosa comparsa su La Voce. Caffi avrebbe apprezzato questa precisazione, e tuttavia ho voluto citare la versione “mitizzante” data da Prezzolini, perché credo che anche questa non gli sarebbe spiaciuta).
È comunque ciò che ci si dovrebbe attendere da un vero amico: e in effetti per Caffi l’amicizia gioca un ruolo assolutamente centrale. Parla spesso di “filia”, riprendendo il termine nell’accezione aristotelica di empatia e di solidarietà reciproca, e intende questo sentimento come il valore fondante e il nerbo vero della socialità. «La realtà […] del tessuto sociale – scrive – consiste unicamente in un sistema di molteplici “azioni reciproche” fra individui con infinite gradazioni di spontaneità. realtà […] Fuori degli individui che vivono insieme e agiscono in rapporti reciproci, non vi è nessuna realtà concreta in quel complesso fenomeno che s’usa riassumere nella parola “società”.»
La relazione che si stabilisce entro il “gruppo d’amici” così come la immagina Caffi è caratterizzata dalla possibilità per ciascuno di esprimersi in totale libertà e di esercitare il proprio spirito critico, dal rispetto delle singole individualità che in positivo diventa solidarietà: dall’etica del dialogo insomma, che si contrappone all’etica della potenza e della prevaricazione.
Di questo specialissimo rapporto dà un’interpretazione molto efficace Massimo La Torre ne Il profeta muto. Politica e cultura nell’opera di Andrea Caffi. «Caffi si richiama alla philia, all’amicizia, piuttosto che alla fratellanza, alla fraternité della grande rivoluzione. […] La fratellanza si basa sull’assunzione di una natura umana che ci unisce fondamentalmente attraverso il sentimento della compassione. Essa rappresenta pertanto un sentimento generosissimo che si rivolge in maniera indiscriminata verso ogni nostro simile. La fratellanza non sceglie i propri soggetti, essa è per certi versi un dato primitivo dell’esperienza. Non si sceglie un fratello: lo si trova. […] La compassione, la pietà o la solidarietà, che costituiscono il nocciolo della fratellanza, si danno a tutti, anche ai malvagi, se si trovano in stato di bisogno. L’amicizia invece è selettiva. Ci si sceglie l’amico, non lo si trova già dato per una relazione di natura. L’amicizia si instaura tra soggetti che si stimano reciprocamente, e che si scambiano il dono della fiducia. E se la fiducia è tradita, l’amicizia si rompe. […] Mentre la fratellanza presuppone soltanto un’eguaglianza naturale, l’eguale condizione umana – ma può invece tollerare diseguaglianze sociali anche rilevanti – l’amicizia è possibile solo tra soggetti che si riconoscono una pari dignità e si collocano su posizioni di forza grosso modo equivalenti». Per questo «è bidirezionale, dialogica: si dà e si dice, ma ci si aspetta un riscontro, un dire o un dare più o meno equivalente». E ciò fa sì che possa costituire la base per un vero e proprio vincolo sociale e politico.
Proprio da questa centralità dell’amicizia, che si traduce anzitutto in esemplarità, lealtà e coerenza, occorre partire per seguire il filo del discorso di Caffi. Quindi, nell’ordine, semplificando al massimo: viene anzitutto la coscienza individuale (quando esista, naturalmente: e non è detto che la capacità di coltivarla sia propria a tutti), che si esplica e si accresce nel confronto empatico con altre coscienze, creando un rapporto che a sua volta entra in rete con altri sodalizi similmente fondati sulla reciprocità, in una interazione sempre maggiormente estesa (anche se di sempre minore intensità), fino a costituire il tessuto sociale.
Non è una concezione così banale e campata per aria: ribalta il concetto che sta a monte di quasi tutte le ideologie rivoluzionarie, quella marxista in primis, che partono dalla costruzione (più o meno violenta, guidata da “rivoluzionari professionisti” e imposta alle masse) di una società che a sua volta formi o rimodelli le coscienze individuali. Non è lontana dalla “rivoluzione individuale” predicata da Gustav Landauer, e corrisponde grosso modo all’idea di socialità che ho sempre coltivato anch’io, comprensiva sia della consapevolezza di un certo elitarismo e di una valenza fortemente utopica, sia anche di una realistica dose di disincanto, per cui il valore primario rimane quello della socievolezza insito nel rapporto amicale, indipendentemente dal fatto che questa possa poi tradursi in società. Alla luce delle pur scarse esperienze di azione politica che ho maturato non posso che condividere questa impostazione (cfr. Fare le pulci, in Muli, gitanti e cavalieri erranti).

Socialismo
«Se il socialismo oggigiorno non può essere altra cosa che un “apparato” d’azione politica (con stinte o tarlate coperture ideologiche) impegnato – assieme ad altri partiti – nel mesto compito di mantenere più l’apparenza che la sostanza di regimi “democratici” in una Europa sconquassata e imbarbarita, non vale proprio la pena di essere socialista piuttosto che radicale o liberale o magari democratico-cristiano; se invece intendiamo per socialismo la continuazione – con discesa nel popolo – delle grandiose ed audacissime speranze concepite nel Settecento, di attuare una completa emancipazione della ragione umana, sui principii della quale è unicamente possibile fondare la pace, la fraternità, la felicità per tutti – allora dobbiamo cominciare col riconoscere che tutti gli eventi dall’agosto 1914 in poi hanno calpestato, soffocato, deviato questo movimento – e che … bisogna ricominciare da capo.»
Dovessi però spiegare cosa “concretamente” intende Caffi per socialismo sarei in grossa difficoltà. E in qualche modo lo era anche lui. Intanto perché non amava affatto gli “ismi”, e usa il termine solo nella misura in cui connota una generica disposizione di spirito nei confronti dell’assetto sociale. D’altro canto, ha vissuto dall’interno – molto dall’interno, addirittura tra i muri della Lubianka, in attesa di essere fucilato – l’instaurazione di un “regime socialista”, della “dittatura del proletariato”.
Era esattamente quello che aveva paventato fin dalla sua prima militanza menscevica, e che gli era stato confermato già allo scoppio della Prima guerra mondiale, quando tutti i partiti affiliati alla Seconda Internazionale avevano appoggiato l’interventismo scellerato degli stati nazionali. Era il logico sbocco di una concezione della politica solo apparentemente “rivoluzionaria”, nella realtà mirata essenzialmente alla conquista del potere e all’esercizio del dominio, e come tale intrisa totalmente dalla violenza.
A ben considerare, tuttavia, la spiegazione non sarebbe solo difficile. Sarebbe inutile. Il linguaggio di Caffi è infatti quello di un impolitico, di un radicale intransigente, cosmopolita e aristocratico, senz’altro legato più all’utopismo ottocentesco che alla pragmatica concretezza dei “socialisti reali”.
Per lui ogni forma di organizzazione che non riconosca come fondamentali nozioni quali civiltà, dignità, giustizia, eguaglianza, fratellanza, gentilezza, ha nulla a che vedere col socialismo. Non possono essere fondanti i rapporti economici o quelli di classe, non si può ridurre l’eguaglianza ai soli aspetti della distribuzione quantitativa. «Non sono tanto le letture, i classici del marxismo, o dei revisori di Marx, degli ortodossi o degli eterodossi del marxismo a creare il socialismo. Il socialismo nasce sul campo, dai rapporti di empatia e “filia” che l’individuo riesce a creare con chi si trova di fronte.»
Il criterio che sta alla base del marxismo, il “materialismo storico”, per il quale i rapporti di produzione che costituiscono la struttura economica sono il terreno concreto su cui viene eretta poi una sovrastruttura giuridica e politica, è a suo parere assolutamente riduttivo, riconduce tutto a un razionalismo artificioso. Non tiene conto infatti che la socievolezza «produce motivi d’affetto, di comunione, di dedizione, di gelosia, che hanno poco a che vedere o addirittura contrastano le finalità economiche». In altre parole, a muovere gli uomini non sono solo i criteri razionali del rendimento economico, perseguiti attraverso la ricerca del potere.
Insomma. Caffi non dà mai del socialismo una definizione nei termini squisitamente “politici”, o almeno in quelli dell’accezione “moderna” della politica. Non lo fa volutamente, perché una traduzione in quei termini costituirebbe per lui uno stravolgimento del suo reale significato.
«Ora il socialismo deriva il suo stesso nome, il suo pathos, la sua gloriosa qualifica di “neo-umanesimo”, proprio dal fatto che si è eretto a difesa della “società” contro gli inumani congegni dell’“ordinamento statale” ed ha perseguito la completa emancipazione della società – delle concrete comunità di uomini vivi – dal coercitivo sistema, dove gli uomini non figurano che come numeri, “soggetti”, schede. E se il socialismo abbandona questo motivo dominante, non troverà più argomenti, né morale sostegno per combattere la dittatura comunista.»
Dice piuttosto cosa non è. E la sua concezione la si ritrova diffusa in ogni sua pagina, e in ogni scelta comportamentale. «Oggi, il moltiplicarsi di gruppi di amici, partecipi delle medesime ansie e uniti dal rispetto per gli stessi valori avrebbe più importanza di qualsiasi macchina di propaganda. Tali gruppi non avrebbero bisogno di regole obbligatorie né di ortodossie ideologiche; non fiderebbero sull’azione collettiva, ma piuttosto sull’iniziativa individuale e sulla solidarietà che può esistere fra amici che si conoscono bene e dei quali nessuno persegue fini di potenza.»
Il suo socialismo è dunque da intendersi in senso etimologico: viene dalla società, che come abbiamo già visto è innanzitutto un insieme di individui, ma che «esiste solo sopra un certo livello di dignità umana. Se vissuta secondo verità e giustizia da individui che si sentano “personalmente responsabili” e assolutamente uguali, impegnati a rispettare l’autonomia sovrana della persona altrui». Ovvero, solo dove vige il rispetto di sé e degli altri.
Il socialismo consiste in definitiva per lui nella organizzazione il meno possibile coercitiva e gerarchizzata di questi rapporti, nel renderli possibili e nello sganciarli dai criteri del “rendimento economico”, per indirizzarli invece alla verità, alla giustizia e all’uguaglianza. Si fonda sulla libera socievolezza, e quindi rifiuta le tendenze autoritarie e l’esercizio della violenza, ma anche le istituzioni in generale. Prima tra tutte, lo Stato.

Stato, popolo, società
Lo Stato (che identifica col “governo”) è per Caffi un apparato burocratico e militare messo in piedi ai fini del dominio. Una struttura di potere che tiene in soggezione il “popolo”. Il quale “popolo” non è affatto depositario di quelle particolari virtù morali che troppi letterati romantici o una demagogia d’accatto gli attribuiscono (sagacia, generosità, modestia, dignità, ecc…), di una saggezza «i cui effetti miracolosi si produrrebbero di colpo non appena spezzate le catene del servaggio. L’esistenza di tali catene non è un accidente assurdo […] la loro conservazione e il loro aggravamento millenario non si spiegano senza la complicità essenziale dei prigionieri. […] Dopotutto, molti dei seguaci di Mussolini e di Hitler sono “popolo”». Di per sé il “popolo” è una entità amorfa, per certi versi “responsabile del suo stato di oppressione e sfruttamento”. Con la modernità poi è diventato sempre più “massa”: e a differenza del popolo la massa non ha più, a tenerla unita, un minimo di sentimento di appartenenza ad una comunità, nella quale si condividano almeno riti, credenze, tradizioni, e comunque momenti di sentire collettivi. «È uno stato dei sensi e della volontà nel quale l’individuo rimane fondamentalmente indifferente alla sorte dei suoi simili, con i quali tuttavia si aduna e si aggrega, e con i quali finisce per marciare al passo in formazioni serrate […]. La sua esistenza è inseparabile dal macchinismo in senso stretto, da quegli apparati giganteschi che assoggettano la società a una direzione totalitaria.» Caffi ha qui certo in mente le “adunate oceaniche”.
La trasformazione del popolo in “massa” è correlata ai mutamenti politico-economici intervenuti tra la fine e del settecento e quella dell’Ottocento: “Il fatto apparentemente privo d’importanza “ideologica” e “rivoluzionaria” che fu l’introduzione di uno stato civile tenuto da burocrati secondo metodi ricavati dalla “scienza impassibile” (nuda notazione dei fatti, subordinazione di ogni “qualità” a un ordine quantitativo, legame con la statistica, ecc …) ha tuttavia avuto ripercussioni più considerevoli che non si pensi. Lo stato civile uniforme, democratico, laico, è un particolare necessario di quel rimaneggiamento del regime sociale e dello Stato che ha stabilito l’eguaglianza davanti alla legge, la coscrizione, la potenza in certo senso assoluta e impersonale del denaro, la libertà di esercitare una professione o di cambiare. L’intenzione sembrava essere quella di sopprimere per astrazione o di ignorare radicalmente ogni “qualità intrinseca”, in quell’“unità” i cui caratteri distintivi si esprimevano in grandezze di tempo, di spazio, di volume, di livello, ecc… Il risultato era naturalmente di ribadire la potenza e la supremazia del generale sul particolare, della macchina sociale sull’individuo.»
Mentre il popolo subisce più o meno passivamente la soggezione, e la massa corre a farsi schedare e irreggimentare, unica ad opporre una resistenza, e quindi soggetta ad una azione maggiormente repressiva, è la “società”. «Conveniamo di chiamare “società” – scrive Caffi – l’insieme di quei rapporti umani che si possono definire spontanei, e in certo qual modo gratuiti, nel senso che hanno almeno l’apparenza della libertà nella scelta delle relazioni, nella loro durata e nella loro rottura … uno stile di vita diretto a esaltare la socievolezza, la cortesia, l’amicizia.» E che evidentemente non possono essere inseriti “in questa o in quella colonna di cifre statistiche”.
Ora, dice Caffi, «il socialismo deriva il suo stesso nome, il suo pathos, la sua gloriosa pretesa alla qualifica di “nuovo umanesimo” proprio dal fatto che si è eretto a difesa della “società” contro gli inumani congegni dell’“ordinamento statale”, ed ha perseguito la completa emancipazione della società – delle concrete comunità di uomini vivi – dal coercitivo sistema, dove gli uomini non figurano che come numeri, “soggetti”.».
Quindi: la “società” nasce per aggregazione spontanea e non si organizza gerarchicamente, non si identifica con una particolare classe sociale o con un gruppo economico, non si compromette con il potere e non coltiva ambizioni di dominio. Caffi è consapevole che questo stile di vita presuppone condizioni particolari, e infatti ammette: «la vita di società si realizza ad opera di un ceto emancipato dalla necessità di lavorare e, almeno fino ad un certo punto attaccato alle seduzioni della vita privata, e talvolta anche a quelle della “vita interiore”». E si rende anche conto che queste condizioni sono tutt’altro che la norma, che la “società” dunque risulta particolarmente vulnerabile, per cui necessita di godere di tranquillità politica e sociale, e di bandire ogni forma di violenza.
Ma come può esistere una società nella quale le differenze (e quindi le attitudini, le competenze) dei singoli non si traducano in disuguaglianze?
«Gerarchie veramente sentite e spontaneamente volute esistono certamente, ma non si trovano là dove c’è chi comanda e chi obbedisce, dei capi e una massa, dei privilegiati e dei diseredati. Si trovano nelle comunità autentiche, religiose, politiche o semplicemente sociali che siano, dove l’autorità riconosciuta si esercita nel riconoscimento di un’eguaglianza, di una comunanza o di una fraternità fondamentale».
Le gerarchie nascono spontaneamente quando si danno occasioni nelle quali diventa necessario attribuire a qualcuno un ruolo decisionale, e che questo ruolo qualcuno sia disposto ad assumerselo. Ma sono appunto occasioni, situazioni particolari, e la delega non può diventare sistema.
«C’è un limite chiaro, varcato il quale il “senso di responsabilità”, la forza d’animo per cui si accetta di rispondere personalmente del successo di un’impresa comune di fronte ai compagni impegnati nell’impresa su piede d’eguaglianza e con egual diritto a beneficiare del risultato, muta di carattere e di natura: è il momento in cui si attribuisce a se stessi, in qualità di capo, potere di comando sugli altri, ossia il diritto di servirsene come mezzi per ottenere un certo scopo di cui si vuoi essere il solo a detenere la gloria e i vantaggi. Questo limite coincide in sostanza con la sostituzione della volontà d’efficacia al senso dell’obbligo verso gli altri, considerati come propri eguali, oppure verso coloro dei quali ci si è assunta appunto la responsabilità. Una guida di montagna si preoccuperà di riportare a valle tutto il suo gruppo sano e salvo: per lui, sarà sconfitta bruciante se un incidente grave capiterà sia pure a uno solo della cordata; ma un generale non sarà soddisfatto se non avrà raggiunto l’“obbiettivo prescritto”, magari col sacrifizio di tre quarti dei suoi soldati.»
Tutto ciò ha evidentemente poco a che fare con l’idea della politica che si è affermata nel mondo moderno (ben diversa dalla politeia di cui parlavano i greci), e mette in discussione le forme e i mezzi con i quali può essere esercitato il potere, oltre che l’idea stessa di potere. Ogni forma di potere è una limitazione della libera espressione individuale, unica guida della quale dovrebbe essere il senso di responsabilità. «Quanto meno è formato da individui responsabili tanto più il popolo ha bisogno di essere governato, assoggettato a un potere che non può essere esercitato che con la violenza.» Quindi i rapporti politici non solo non agevolano la crescita dei legami spontanei e creativi tra individui e gruppi, ma anzi, ne rappresentano una vera e propria antitesi, li snaturano e li travisano. Se si vorrà costruire una società in cui possano fiorire socievolezza e fratellanza lo si dovrà fare contro o nonostante la politica.
Di conseguenza Caffi afferma che «l’obiettivo essenziale di una politica socialista, oggi, non potrebbe che essere che la lotta tenace contro la “macchina” dello Stato nazionale, che è diventato l’agente principale, se non unico, dell’oppressione sociale». E si riferisce a quella forma di statualità che ha mostrato la peggiore e più veritiera immagine di sé a partire dal 1914, dalla guerra mondiale, in occasione della quale il suo intrinseco legame con l’esercizio della violenza si è palesemente rivelato, ma che già era andato affermandosi nel corso del XIX secolo con l’adozione del modello Stato-Nazione, quello per intenderci che sfocerà nel culto del “sangue e suolo”. La dissoluzione dell’ancien régime, delle monarchie dinastiche ereditarie, ecc… ha fatto spazio, per adeguare il mondo alle esigenze del nuovo modo di produzione industriale, alla creazione del mito della Nazione, dei suoi sacri confini. Questo ha reso se possibile più sanguinosi i conflitti, che coinvolgono tutta la popolazione e diventano terreno di sperimentazione, di innovazione tecnologica, di stimolo alla produzione industriale.
Quindi: lo stato va scomposto in unità territoriali e sociali subnazionali, in ordine inversamente crescente di responsabilizzazione amministrativa e di partecipazione diretta alla stessa di tutti gli individui. Ma soprattutto gli va sottratto il monopolio del diritto, che non può essere uno per tutti, fissato per sempre, ma frutto di creatività continua e attenta ad ogni specifica situazione.
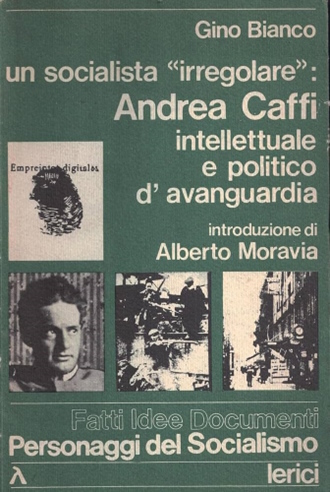
Democrazia e libertà
Piaccia o meno, gli stati esistono, e con essi occorre confrontarsi. Lo scontro è evidente e inevitabile là dove il potere politico si configura come un’autocrazia; più difficile invece far prendere coscienza della necessità di questa opposizione dove la facciata appare democratica: «I regimi moderni, abusivamente qualificati come “democratici”, sono in realtà una combinazione di “ochlocrazia” (sovranità più apparente che reale di folle senza coesione) con la plutocrazia – regno effettivo delle grosse fortune».
Con queste premesse si capisce come Caffi non possa essere un entusiasta sostenitore della democrazia parlamentare, “borghese”. E meno che mai lo è di quella sedicente “diretta”. L’idea che ha della democrazia non si concilia con alcuno dei sistemi politici esistenti al suo tempo. «La democrazia quale funziona oggi nei grandi Stati moderni non può più essere considerata terreno naturalmente propizio ai progressi del socialismo». Non solo. La storia, e la sua personale esperienza, insegnano che: «se si ammette la delega della “sovranità popolare” sia di un uomo sia di un partito politico, i risultati tipici che offre sinora l’esperienza della storia sono da un lato il cesarismo plebiscitario, dall’altro quella vera (o “nuova”) democrazia che rende ora felici i polacchi, i bulgari, gli jugoslavi».
Quanto alla democrazia diretta: «Scartiamo decisamente l’assurda supposizione che “democrazia” debba significare “popolo governato dal popolo stesso”. Nessuna adunata di popolo (e neppure alcuna assemblea tampoco numerosa) ha mai potuto effettivamente governare, esercitando cioè in concreto i “poteri” (legislativo, esecutivo, giudiziario, ecc…), neppure in una minuscola città greca o in quei cantoni rurali della Svizzera famosi come esempi di democrazia diretta». Questo perché non ha alcuna fiducia particolare nel “popolo”, sempre più sul punto di diventare “massa”.
Insomma, la democrazia è interpretata da Caffi in funzione “difensiva”, più che propositiva: non deve essere intesa come regime di governo, ma piuttosto come regime di diritti: «La realtà della democrazia s’afferma non con la fiducia negli eletti, ma con la possibilità di manifestare efficacemente la propria sfiducia verso di loro, di controllarli ad ogni passo, di limitarli in funzioni strettamente definite». Ciò significa che è necessario difendere la democrazia “formale” (dove formale significa ispirata e fedele agli inderogabili principi di verità – ovvero trasparenza – e di giustizia – ovvero eguaglianza) contro chi è pronto a sacrificarla a quella “sostanziale” (ovvero a quella che si spaccia come realizzata negli stati liberaldemocratici di origine ottocentesca). I principi, al di là della possibilità di tradurli poi in prassi politica, vanno salvaguardati contro ogni snaturamento e compromesso.
È evidente comunque che ritiene attuabile questa difesa solo nei piccoli circoli di “resistenza” contro la macchina burocratica, quelli nei quali identifica la “società”. Della loro libertà la democrazia deve farsi garante: «La sostanza dell’ordinamento democratico sta nella difesa della incolumità personale di ogni cittadino contro qualsiasi arbitrio o eccesso della “potestà coercitiva” e nel raggiungimento di un massimo di uguaglianza, quell’uguaglianza che deve essere estesa a tutti gli uomini, senza mai ammettere alcuna idea di superiorità o inferiorità né tra persone né fra gruppi».
Vedo però a questo punto che sto girando attorno al nodo della questione. Che è: in positivo, come modalità politica e amministrativa quotidiana, la “democrazia” ha qualche chance di funzionare? Confesso che non ho trovato in Caffi indicazioni convinte, se non i riferimenti alle autonomie diffuse, ad una democrazia “locale”, applicabile in ambiti estremamente ristretti. La verità è, a mio parere, che in fondo Caffi, anche senza aver mai avuto esperienza di un’assemblea di condominio, non sia affatto persuaso della possibilità di un esercizio “universale” della democrazia. Almeno nell’immediato, ma anche a breve termine. Ha una sua idea della democrazia, la migliore in assoluto, perché si fonda sul presupposto della partecipazione cosciente e responsabile di tutti i singoli individui, e perché si pone come scopo la verità e la giustizia: ma sa perfettamente che nella realtà quel presupposto non è affatto dato, che la maggioranza degli individui è popolo, o addirittura massa. E allora non rinuncia al suo ideale, lo conserva intatto da compromessi: ma non ne fa una bandiera d’attacco quanto piuttosto un vessillo di resistenza.
Caffi si candida dunque, anche all’interno di un regime “democratico”, a vivere in minoranza. Lo afferma esplicitamente, quando rivendica il ruolo e la dignità delle minoranze. Le minoranze non hanno l’obbligo di cercare di diventare maggioranze. Devono avere coscienza di sé, e del fatto che magari i più possono non condividere le loro proposte e il loro operato. Non devono conquistare il potere, ma condizionarlo, e per quanto possibile svuotarlo.
«I cenacoli di libertini e di enciclopedisti, le piccole “società di atei” di cui parlano volentieri Fielding e Smollett, le Logge massoniche e i “salotti dove si conversava” svolsero una propaganda irresistibile, mettendo in contatto gli spiriti liberi da un capo all’altro d’Europa. Quegli uomini non avevano alcun bisogno di un’organizzazione centrale che prendesse decisioni e applicasse sanzioni in loro nome. Il loro scopo era di trasformare i modi di pensare e i costumi piuttosto che le cose, e perciò la loro opera portò nel mondo un cambiamento reale.»
Può non sembrare tale, ma è un’alternativa molto più realistica del mettersi in concorrenza con chi il potere ce l’ha, a meno di accettare di scendere sul suo stesso piano. Che non prevede il perseguire verità e giustizia. E non salvaguarda la libertà.
Su cosa poi si debba intendere, concretamente, per “libertà” Caffi è molto asciutto: «Dovunque si abbia vita in comune (e dove non si ha vita in comune con gli altri?) la libertà è che mi si lasci in pace il più possibile, sicché io non abbia a scervellarmi sulla famosa scelta fra “libertà astratta” e “libertà concreta”, democrazia “formale” e democrazia “sostanziale”. Se non ho paura di esser svegliato alle sei di mattina dalla NKVD o dalla Gestapo, sono libero; se no, non lo sono, e non c’è altro da dire».
Non si può certo dire che parli senza cognizione di causa.

Europeismo
In opposizione al modello dello Stato-Nazione Caffi propone quello antistatalista di una federazione europea. Lo fa già nei primi anni Venti. È reduce dalla devastante esperienza della guerra e dalla delusione per gli esiti della rivoluzione bolscevica, e assiste da un lato a un riassetto dei confini che non tiene in minimo conto le aspirazioni dei popoli, dall’altro all’esplodere dalle contraddizioni all’interno della sinistra, di quella italiana e di quelle europee, proprio in merito alle valutazioni su quella rivoluzione. Inoltre si è formato sui testi di Pierre-Joseph Proudhon, che rimarranno sempre un suo riferimento, e sul ricordo dell’esperienza dei populisti russi; dagli uni e dall’altro mutua l’idea del federalismo.
Meno significativa, o addirittura quasi nulla, l’influenza esercitata su di lui dai federalisti italiani risorgimentali, quali Carlo Cattaneo e Giuseppe Ferrari. In effetti la loro concezione del federalismo rimaneva tutta interna al gioco politico e a quello economico. Doveva garantire la convivenza pacifica tra le nazioni. Per Caffi invece il federalismo è l’unico assetto istituzionale che garantisca la libertà degli individui e delle comunità (o, se vogliamo, della società). Permette infatti di abolire il dispotismo dello stato centralizzato, che impone la propria volontà alla società tramite un rapporto che va dall’alto al basso. L’organizzazione deve al contrario nascere dal basso, dalla libera federazione degli individui nei comuni, dei comuni nelle provincie, delle provincie nelle nazioni e infine di queste ultime negli Stati Uniti d’Europa (e magari più tardi del mondo intero).
La sua è una proposta radicale, fondata sul completo superamento dell’idea di “sovranità” nazionale. E tanto più lo diventa dopo che è passato attraverso una seconda guerra fratricida. Nel 1946 in una lettera scrive: «Se vogliamo sul serio salvare la società dalle guerre, dai governi totalitari e da tutte le bestialità che questi due aspetti d’un medesimo fenomeno implicano […] bisogna abbattere al più presto l’idolo della nazione; in particolare l’Europa sarà ridotta allo stato di “giungla” (terreno per tigri e grossi cacciatori) se non si rinuncia radicalmente alle “sovranità nazionali”, agli orgogli e “sacri egoismi” patriottici, alla superstizione della solidarietà etnica in nome della quale bisogna uccidere e morire».
Il che non significa però negare un riconoscimento delle identità nazionali e di un senso del radicamento che risponde alla necessità di riconoscersi in un passato, al bisogno di una identità collettiva. Significa invece che questi bisogni vanno sottratti alle sirene nazionalistiche che suggeriscono vendette e sanguinose rivalse, e vanno incanalati a rendere coscienti gli individui di una possibilità di coesistenza autonoma, e soprattutto di partecipazione diretta al governo della futura entità sovranazionale.
«La nazione come patrimonio culturale (lingua, “memorie comuni”, costumi nella misura della nostra vita planetaria) si deve dissociare da qualsiasi formazione politica, privare completamente d’ogni mezzo di coercizione e suoi “membri” – che tali saranno unicamente per spontanea e revocabile adesione. […] Se per ragioni ovvie conviene che ogni regione abbia un suo autonomo governo, bisogna stabilire fra i vari “paesi” patti non di semplice “amicizia, non aggressione” ecc … – ma di completa “simpolitia” (usando un vocabolo che definiva l’unione per esempio fra Atene e Samo) per cui cioè, senza formalità alcuna, il “cittadino” d’un paese trasferendosi in un altro vi godrà degli identici diritti che gli “indigeni” di quello.»
Le posizioni di Caffi sul socialismo, sulla politica, sul potere, nonché quelle sulla democrazia, sulla libertà e sulla non violenza, sono destinate a rimanere minoritarie (se non addirittura isolate) nella sinistra italiana dell’epoca, in quella liberal-democratica come in quella socialdemocratica, per non parlare poi di quella “ortodossamente” marxista. La cosa vale tanto più per la sua concezione dell’europeismo, rispetto alla quale anche i ristrettissimi gruppi che immediatamente dopo sia il primo che il secondo conflitto mondiale sembrano imboccare quella direzione rimangono molto tiepidi.
Tale marginalità si è protratta sino ad oggi, al punto che quando si parla dei precursori del pensiero europeista Caffi non viene mai menzionato. Eppure quelle posizioni erano di una rarissima lucidità e conservano oggi una sorprendente attualità. Il suo disegno di una Europa federale pare scritto in questi giorni, e anticipa di un secolo tesi e proposte sulle quali con molta minore lucidità e convinzione, in piena emergenza di sfaldamento dell’Occidente, si sta ora quotidianamente discutendo (non quella di un “riarmo”, naturalmente). Ad esempio, Caffi, quasi solo anche nel ristretto circolo degli europeisti tra le due guerre, vede il rischio comportato da un’unione economica che anticipi quella politica, in ciò andando in controtendenza rispetto a quanto da tre quarti di secolo a questa parte è stato invece fatto.
Non oso immaginare cosa penserebbe oggi al cospetto di un elefante burocratico che dopo una gestazione di settant’anni ha partorito topolini ciechi e rissosi, e che in luogo del senso di comunità ha messo in circolazione solo la moneta unica.

Andrea Caffi e l’amico Gianni, Tolosa 1947
Intellettuali
L’insistenza sulla necessità urgente di adottare una visione federalista, espressa già da Caffi nell’immediato primo dopoguerra e ribadita sino agli ultimi suoi giorni, suona da monito alla classe intellettuale antifascista (quella che dovrebbe esprimere la futura “società”). Gli intellettuali di sinistra debbono darsi una svegliata e non arrendersi, o addirittura crogiolarsi, nella contemplazione delle rovine della civiltà europea (a questo già ci pensa la destra: è di pochi anni dopo Il tramonto dell’Occidente di Spengler). Devono elaborare un progetto di fratellanza sovranazionale, costruire una visione capace di entusiasmare le giovani generazioni, un ideale da offrire loro in alternativa alle parole d’ordine barbariche diffuse dai fascismi; il tutto tenendo sempre ben presente che i fascismi sono solo la manifestazione più eclatante, e certo nell’immediato più pericolosa, di una crisi molto più profonda e diffusa della coscienza europea. Ma deve trattarsi di progetti e visioni che prescindono da ogni calcolo economicistico.
In tal senso va interpretata la riflessione che Caffi fa sul rapporto tra i giovani e il fascismo: «Poco importa loro la meta, di solito così fantastica che ogni tentativo di precisarla finirebbe in delusione: ciò che conta è il temerario cimento, è l’occasione di drammatici sacrifici. Affascina il sogno di “vivere pericolosamente, di poter servire e comandare con tutto impegno” e soprattutto di trovarsi in permanenza “come in guerra”, cioè sbarazzati da tutte le norme e le abitudini del “consorzio civile”». Questo la sinistra dovrebbe avere ben presente, e sbarazzarsi del dogmatismo del “materialismo storico” e delle dispute sulle interpretazioni più o meno autentiche del verbo marxista.
Dovrebbe anche, secondo Caffi, fare i conti con la mitologia risorgimentale. A dispetto della militanza del nonno, è molto critico nei confronti del Risorgimento, soprattutto di Mazzini, ritenendo che proprio la nascita degli stati nazionali, destinati a confrontarsi immediatamente nella logica del potere. violenza, rappresenti oggi l’ostacolo all’unificazione europea, e spieghi la deriva totalitaria.
«Se mi fosse dunque permesso di dare un consiglio, raccomanderei la rinuncia ad ogni conato di collegare il movimento rivoluzionario a cui vorremmo chiamare gli “europei svegli” e le “sacre memorie” del Risorgimento italiano. Anzitutto, perché questo residuo di vanità nazionale è da “mettere in soffitta”. Poi perché nel Risorgimento italiano prevalgono elementi, ai quali i nostri avversari hanno più ragione di attingere che non noialtri, sovversivi senza riguardi.»
Come a dire che il fascismo era già in qualche modo intrinseco al pensiero risorgimentale. Questo giudizio pone fine alla collaborazione con Carlo Rosselli e con il gruppo di Giustizia e Libertà, che danno invece credito al racconto di un Risorgimento popolare.
Non è comunque l’unico motivo di rottura. Caffi è anche contrario a “fronti popolari” che implichino una coabitazione col comunismo staliniano. Significherebbe a suo giudizio svendere per un piatto di lenticchie, tra l’altro guaste, le idealità che devono animare una genuina resistenza ai totalitarismi: a tutti, quale che sia l’etichetta politica dietro la quale si mascherano.
«La rivoluzione che ci libererà dal fascismo – sarà un movimento veramente efficace se allo stesso tempo porterà un più alto tono, un “clima” più fecondo nella vita sociale e nella vita spirituale degli italiani. Inoltre, il fascismo non essendo un problema particolare all’Italia, ma una crisi della società e della coltura europea, è ovvio che per “superarlo” bisogna mettere in campo, “valorizzare” tutte le forze vive e tutta l’esperienza accumulata appunto “nei vari campi dell’attività umana”: giungere cioè ad un modo di concepire e di attuare la giustizia, l’eguaglianza sociale, la libertà dell’uomo e delle associazioni umane, che corrisponda veramente alle esigenze morali, intellettuali, estetiche, religiose, quali l’epoca nostra le ha rivelate o fatte maturare nelle così dette “avanguardie” attraverso le più diverse forme di ricerca della verità.»

Verità
Della verità, appunto. «Il mio terzo principio l’ho attinto dalla lettura di Erodoto che ai giovani persiani si insegnava soprattutto di “dire sempre la verità”. M’è sembrato che l’esperienza della vita confermasse la bontà di tale precetto – e che la furbizia “politica” avesse sempre “le gambe corte”. Se si è potuto augurare che “da persone oneste” si comportassero gli Stati, perché non fare lo stesso augurio per i partiti politici? Può essere qualche volta incomodo e qualche volta ridicolo. Ma pure il ridicolo è sempre stato impavidamente affrontato dagli apostoli d’un movimento veramente grande.»
Caffi individua precocemente un aspetto cruciale del futuro che si va delineando: la manipolazione delle masse operata dal nuovo populismo, di destra o di sinistra, attraverso la falsificazione della “verità”. Sembra intuire addirittura quello che un secolo dopo sarà il fenomeno della post-verità. Oserei dire però che ne ha già conosciuta la concreta esemplificazione nel titolo, nei modi e nei contenuti dell’organo ufficiale dei bolscevichi, la Pravda (la Verità), e questo è stato forse il primo degli aspetti del nuovo regime a disilluderlo. Oggi in Italia ne troverebbe sotto lo stesso titolo una grottesca parodia.
Non è comunque l’unico della sua generazione di libertari a insistere su questo tema, basti pensare ad Ortega y Gasset, o ancor più a Orwell. E non scopre nulla di nuovo: la manipolazione della verità, assieme al ripetersi dei massacri, è una delle costanti della storia e dei rapporti di potere. Di nuovo c’è il fatto che ora il terzo incomodo in questi rapporti, la “società”, gode di una autonomia sufficiente per metterla a nudo. La post-verità tuttavia va oltre la manipolazione: quest’ultima è la narrazione distorta o anche totalmente stravolta dei fatti, ma gira comunque attorno ad essi ed è soggetta a smentite e a revisioni, mentre la prima opera già a partire dall’assunto che la verità sia una questione di secondaria importanza, e i fatti li inventa. Fa leva quindi sull’ignoranza dei riceventi (il popolo, le masse), sulla pigrizia intellettuale di chi non vuole o non ha il coraggio di approfondire (gli intellettuali) e sulla determinazione degli emittenti (il potere, politico ed economico) ad asservire i primi e ad arruolare o mettere a tacere i secondi. E agisce subdolamente su vari piani, banalizzando la realtà dei problemi in slogan che non significano nulla (Via la guerra dalla storia, per citarne uno che ho sentito recentemente e che a Caffi sarebbe magari piaciuto, ma solo sulla bocca di chi la storia la conosce) e offrendo spiegazioni e soluzioni rapide con l’identificazione a tutti i costi di un responsabile, un individuo, un popolo, una classe sociale o economica. Identificare un responsabile è il modo per non considerarsi mai responsabili (in negativo) o per non diventarlo mai (in positivo, nell’accezione nella quale Caffi usa il termine). E in questo la sinistra, quando non è andata a rimorchio della destra, è stata addirittura anticipatrice.
Caffi sogna una società giusta ed equa, fondata sul “vero”. Quindi sulla presunzione che il “vero” esista. Ora, qui non si tratta di arrogarsi l’accesso ad un “vero” filosofico, assoluto: molto più semplicemente chiede sincerità e trasparenza, e le chiede in primo luogo agli intellettuali – chiede loro di raccontare le cose come stanno, come accadono, di non piegare la parola e la ricerca per imporre il proprio punto di vista o quello degli interessi che rappresentano.
In una lettera ad Angelo Tasca, suo compagno d’esilio in Francia, scrive: «Soltanto una cosa mi pare perniciosa, disperante e tale da rendere impossibile una partecipazione anche teorica: è l’assenza di schiettezza. […] intendo per tale assenza ogni sostituzione di idoli o schemi alla immediata visione di realtà umane: qualsiasi sussiego in nome di un “istituto”, d’una bandiera, d’una gerarchia, qualsiasi forma di patriottismo, qualsiasi pretesa di sacrificare il singolo ad una generica “collettività”, di calpestare o mutilare l’espressione personale per raggiungere “effetti di massa”; che da più di vent’anni tutti gli amici marxisti che ho avuto abbiano tacciato come “mentalità anarcoide – estetizzante – intellettualistica – piccolo borghese” questo punto di vista non può controbilanciare l’esperienza troppo sicura degli inevitabili sviluppi cui si va incontro, indulgendo a tali espedienti; sempre ho visto come risultato una degradazione e falsificazione dei migliori intenti ed anche dei migliori uomini. […]
Ecco quel chiamo assenza della schiettezza, causa di continue “delusioni” nel grande sforzo di emancipazione dell’uomo. Ben inteso non l’ascrivo a malvagità connaturata negli individui; è ovvio come tutto un reticolato di circostanze materiali, d’educazione, di inerzie consuete si sovrappongono alle migliori intenzioni di uomini rispettabilissimi. Ma la questione rimane angosciosa: se non si lacera quel reticolato (così se a principio d’ogni iniziativa sociale non si pone come regole assolute: a) di dire sempre la verità e tutta la verità; b) di evitare con sforzo massimo ogni manifestazione o reazione gregaria, ogni “semplificazione ad usum plebi”; c) di sabotare spietatamente ogni “apparecchio”, ogni fissazione di gerarchia, ogni durevole subordinazione dell’uomo a “istituti” o “capi”) sarà sempre fatica di Sisifo la riforma e del regime di proprietà».
Più chiaro di così …
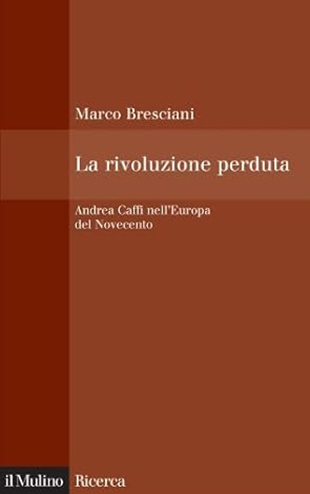
Utopia
«Platone fu condotto a immaginare la Città dove “tutto sarebbe messo in comune” dal disgusto per la politica: non solo per la politica tirannica dei Trenta, alla quale si era trovato mescolato a causa dei suoi legami di famiglia, ma per quella dei loro successori “democratici” responsabili della morte di Socrate. L’esempio di Platone suggerisce che ci sono momenti, nella storia, in cui è ragionevole e lungimirante abbandonare ogni speranza di risultati immediati e massicci.»
A volte Caffi sembrerebbe tentato di seguire questo esempio, di arrendersi al disgusto e alle disillusioni che la politica gli ha provocato e di viaggiare con la mente verso l’isola che non c’è. O meglio, questo è ciò che gli contestano persino molti dei “compagni di strada” coi quali ha condiviso la lotta contro i totalitarismi. Una bravissima persona, una mente fuori del comune, ma una testa piena di sogni e un carattere incapace di venire a patti con la realtà. Il fatto è che la realtà Caffi la conosce benissimo, in genere molto meglio di chi lo taccia di fumisterie: talmente bene che non gli piace per nulla, e per questo vuole cambiarla.
Ha creduto anche lui, in gioventù, nella possibilità di arrivare con la rivoluzione a risultati massicci e immediati: ma quello che ha visto gli ha fatto capire che cambiare non significa mettere tutto sottosopra, favorire la rivalsa di una classe nei confronti di un’altra, ecc …, confidando che la storia faccia il suo corso. Occorre invece “ripartire da zero”, ma avendo ben chiari alcuni inderogabili valori: che devono essere ciò a cui si mira, ma al tempo stesso ciò in base a cui si agisce. Devono cioè ispirare tanto la meta quanto il metodo. Quando si è reso conto che la sua idea del mondo non combaciava col mondo, non era sovrapponibile alla realtà – e di questo si è accorto molto presto – non ha mollato tutto: ha risolto che in fin dei conti la cosa non fosse poi così determinante. Quel che contava era mantenere intatta una linea di pensiero che fornisse non il miraggio di un risultato finale, ma i dettami per il comportamento immediato. Perché era proprio quel comportamento, quel modo di “stare al mondo”, la vera meta. E quella linea di pensiero non può deviare sui compromessi, perché l’esperienza insegna che al di là di coloro che abbracciano le soluzioni compromissorie solo in funzione del proprio interesse, della propria partecipazione al potere, anche gli altri, quelli più sinceri e più puri, nel momento in cui cedono anche di un millimetro sui punti più importanti entrano nella logica del potere e finiscono per sacrificare ad essa i principi.
Questa convinzione fa di lui un “utopista consapevole”, uno che sogna da sveglio, sa di sognare, e proprio per questo col sogno non si trastulla (persino Lenin diceva che occorre essere seri coi propri sogni). Credo che questa consapevolezza gli sia stata dettata, oltre che dalle esperienze dirette, dal clima culturale nel quale era maturato a Pietroburgo, in un ambiente che conservava forte l’impronta dell’illuminismo (tra i suoi riferimenti ci sono Diderot e Condorcet) e al tempo la lezione di Aleksandr Herzen. Caffi infatti non è un sognatore romantico, e nemmeno crede nel progresso. Non dà una lettura evoluzionistica della storia, alla maniera di Spencer, né una finalistica alla maniera di Hegel. Non crede cioè che la società evolva sulla base di leggi proprie o di idealistiche finalità, e nemmeno che sia governata da superiori meccanismi economici. Nasce e si sviluppa in funzione di un bisogno, quello che lui chiama socievolezza, intrinseco alla natura umana.
Questo lo distingue dagli utopisti inconsapevoli. Sa che i sogni male interpretati possono diventare pericolosi, dei veri incubi, tanto quando vengono scambiasti per realtà quanto se si cerca di calarli forzatamente nella realtà. E il fronte sul quale si vede costretto a combattere più tenacemente è proprio quello interno al movimento, e di questo soffre moltissimo:
«Sento un isolamento morale più grave di ogni altro, oggi come oggi ho la certezza assoluta che nessuno di quelli che conosco vorrebbe prendermi a collaborare, diventarmi compagno di ricerche. Non è perché presuntuosamente io creda di arrampicarmi su vette più difficili di altri. È semplicemente il gioco delle combinazioni create dall’esistenza fatta finora da me: non posso entrare in un campo perché ne conosco altri che con questo non hanno né avranno mai punti di contatto. E la sintesi può interessare, appassionare, imporsi come indispensabile a me solo. Le assicuro che niente è così amaro come la coscienza di un “residuo” incomunicabile nei propri sentimenti, nei propri pensieri ogni volta che si avvicina con simpatia, con grande desiderio d’intendersi, uno che combatte in fin dei conti per la stessa meta: la liberazione spirituale degli uomini, il rinnovamento della nostra civiltà tutta.»
È una storia che si ripete, ogni volta che una mente sgombra riesce a inquadrare con sofferta lucidità la condizione umana. Non lo cita mai, ma a me fa venire in mente il Leopardi del venditore di almanacchi e delle passeggere: che fa razionalmente strage delle illusioni, ma sa che le illusioni, se coltivate nella consapevolezza, aiutano a vivere. Caffi va anche oltre: per lui vale la perfetta definizione offerta da Claudio Magris: «L’utopia dà senso alla vita, perché esige, contro ogni verosimiglianza, che la vita abbia un senso».

Straniero
Non è un caso che Caffi sia entrato nelle mie simpatie da subito, dalle prime notizie su di lui che ho trovato tempo fa in una rivista dei primi anni Settanta, dal titolo appunto “Settanta”, oggi totalmente ignorata dai radar pur sensibilissimi della ricerca storica. Ne parlava Nicola Chiaromonte, che lo descriveva come un infaticabile camminatore, e la cosa mi è stata poi confermata dai ricordi di Moravia e di altri amici: «Non prendeva mai né il metro né gli autobus. – scrive quest’ultimo – Una volta si trovava a Montmartre e io gli diedi appuntamento a Montparnasse e attraversò tutta Parigi a piedi, e arrivò a Montparnasse sempre a piedi con il suo passo slogato di cammello. Era un uomo molto alto, aveva un corpo come disossato, appunto come un cammello, dondolante, con gambe infaticabili dove non si sapeva dove stesse la forza, dentro pantaloni che erano fatti così: il ginocchio dei pantaloni stava all’altezza dello stinco, la coscia stava all’altezza del ginocchio e degli enormi scarponi neri».
Caffi era in sostanza un vagabondo, piuttosto che un viandante: ha viaggiato molto, ma quasi mai per scelta. Il più delle volte aveva alle calcagna una qualche polizia. Dopo i vent’anni non ha mai più abitato in una casa propria, ha conosciuto le sistemazioni più precarie, nonché le carceri russe prima e dopo la rivoluzione e quelle francesi durante la Seconda guerra mondiale. Il suo recapito più continuativo fu una minuscola camera in un alberghetto di terza categoria a Parigi, la cui porta era sempre aperta: per lasciare entrare e per poter uscire.
Diceva di sé di aver scelto «un vagabondaggio puramente “recettivo”, attraverso paesi, libri, ambienti sociali, senza appartenere ufficialmente a un corpo organizzato qualunque». Per questo sta benissimo in compagnia con tutti gli spiriti irrequieti ed erranti dai quali da sempre sono intrigato.
Del vagabondo aveva una buona dose di incoscienza, quella di chi vive pensando di non aver nulla da perdere e che lo portava, quale fosse la sua sistemazione, in una istituzione bolscevica o in un ministero fascista, a giocare scherzi al regime, applicando forme di lotta che sarebbero piaciute a Debord e ai situazionisti.
Il termine più adatto per definire questo atteggiamento potrebbe sembrare temerarietà, ma direi che Caffi non era un temerario: semplicemente gli sembrava naturale fare, e dire, tutto quello che gli passava per la testa. Era un uomo libero.
Ma libero nel senso più esteso del termine, che arriva a comprendere anche risvolti che di per sé possono sembrare negativi. Era un uomo libero perché era, e si sentiva, ed era sentito, uno “straniero”.
«Per me – scrive in un’altra lettera del 1946 – il fatto d’essere cresciuto in Russia […] ha avuto un effetto che non rimpiango, benché mi abbia privato di certe gioie probabilmente profonde che può dare la totale communione [sic] con i circostanti: fin dall’“età di ragione” in Russia insistevo gelosamente (talvolta quasi “ringhiosamente”) sulla mia qualità di straniero e d’“occidentale”; più tardi, vivendo in Italia, in Germania, in Francia ecc. – un’indelebile [sic] sfondo di mentalità (o di “visuale”) acquisita in Russia, mi costringeva ad una certa “presa di distanza” rispetto alle mode intellettuali, ai costumi, ai pregiudizi agli entusiasmi del luogo e fra l’altro mi ha sempre impedito di capire una qualsiasi presa di posizione schiettamente “nazionale”. Ciò non andava, come accennavo, senza malinconie: è triste non potere partecipare di tutto cuore a esultanze, speranze ecc. di persone a cui si vuol molto bene e di sentirsi alquanto in disparte nei momenti d’un certo parossismo vitale.»

La tomba di Andrea Caffi – Parigi, Cimitero di Père-Lachaise
Verso una conclusione
A questo punto ritengo di aver messo sin troppa carne al fuoco, per un intervento che voleva essere solo di semplice segnalazione. Probabilmente ho alzato parecchio fumo e creato una gran confusione. D’altro canto il pensiero di Caffi è così ricco, tocca tanti e tali ambiti, e in maniera così profonda e sorprendentemente anticipatrice, che riesce difficile costringerlo in telegrafici accenni.
Tanto vale allora che rubi ancora un minuto per un paio di considerazioni su temi che magari ho appena sfiorato, o rispetto ai quali nutro qualche perplessità.
La prima concerne il ruolo degli intellettuali. Sono senz’altro d’accordo con Caffi nel rifiuto dell’esistenza della proprietà privata nelle cose dell’intelletto. È un rifiuto che ho maturato da quando ho imparato a scrivere, lo applicavo già ai tempi della scuola e continuo ad applicarlo, per le cose mie e per quelle altrui, ancora oggi. Questo ha nulla a che vedere però col plagio (che è solo un passaggio di proprietà), e nemmeno con la copiatura pura e semplice, che è una pratica disonesta e avvilente per chi la mette in atto. Io parlo, e Caffi lo faceva molto prima di me, di condivisione. Di mettere cioè in circolazione le proprie idee, di renderle gratuitamente disponibili per chiunque sia interessato e voglia farne uso, si spera in modo intelligente, e di poter altrettanto liberamente – e responsabilmente – disporre di quelle altrui. Per capire meglio cosa intendo, basti considerare come funziona questo blog, e prendere ad esempio tutti i materiali di e su Caffi che abbiamo pubblicato sul sito, recuperati da altri siti o su pubblicazioni cartacee e trascritti nella convinzione che Caffi avrebbe senz’altro approvato questa operazione.
Per Caffi infatti il lavoro intellettuale non consiste nello sfornare quelli che oggi sono etichettati come “prodotti immateriali” e marchiati col codice a barre come il burro o il pesce congelato, quanto piuttosto lo sforzo di stimolare la curiosità sul senso del mondo, sui percorsi possibili per indagarlo, di discuterne, di alimentare un confronto ininterrotto. Ma soprattutto: «C’è un valore più intenso, il quale non può tradursi in nulla di materiale, o per un intellettuale magari in conversazioni o in fasci di appunti apparentemente slegati, e che consiste nell’essere in un certo modo, nello stare in un certo modo». La differenza sta tra l’“essere” un intellettuale o il “fare” l’intellettuale. Ed è una differenza sostanziale.
Mi chiedo però quanto valga oggi questo discorso, quello di Caffi e tanto più il mio. Aveva un senso senza dubbio all’epoca sua, lo ha perso in gran parte già nella seconda metà del secolo scorso, quando l’avvento della televisione ha creato poli di riferimento culturale e modalità di conoscenza inediti; non ne ha più alcuno, almeno per quanto concerne l’effettivo impatto sulle scelte dell’opinione pubblica, nell’era di Internet.
Oggi coloro che credono che la terra sia piatta, o cava, o fatta a coppa sono probabilmente molti più di quelli che hanno idea di cosa significhi “rivoluzione copernicana”. E non vale il discorso che anche prima di Copernico, o solo fino a un paio di secoli fa, i terrapiattisti fossero la maggioranza. Era oggettivamente difficile avere notizia di queste cose, e soprattutto la stragrande maggioranza aveva problemi più urgenti di sopravvivenza cui pensare. Ma oggi la possibilità di conoscere c’è, e viene rifiutata e contestata, addirittura adducendo argomentazioni pseudoscientifiche, e non da quattro gatti (in America hanno appena eletto un presidente che si fa paladino di qualsiasi causa antiscientifica). Eppure parrebbero realizzate le condizioni cui faceva riferimento Caffi, l’esistenza di gruppi di persone liberate dall’immediata necessità di guadagnarsi il pane con il sudore della fronte, del tutto o almeno in parte: mai come oggi un sacco di gente ha avuto la possibilità di vivere senza “lavorare”, senza cioè svolgere un’attività materialmente produttiva. Per Caffi «Gli “interessi” e i rapporti che si sviluppano nelle ore di distacco dalle obbligatorie fatiche produttive o governative formano la trama di una “vita di società”. E, se la prosperità dura alquanto, si differenzia un ceto emancipato dalla necessità di lavorare (e quindi dalla voglia di pregare) e, almeno fino a un certo punto, attaccato alle seduzioni della vita privata, e talvolta anche a quelle della “vita interiore” ed emancipato dall’ambizione di dominare». Ovvero, mentre il popolo non fa altro che “pagare e pregare”, «la vita di società si realizza nelle ore di distacco dalle obbligatorie fatiche produttive o governative».
Ma oggi gli stessi meccanismi che hanno emancipato progressivamente gli individui dalla fatica produttiva e avrebbero dovuto liberarli anche dai timori e dalle incertezze del quotidiano, arrogandosi il monopolio della violenza, hanno completamente disumanizzato l’esistenza e colonizzato la vita di società (vi risparmio tutti i passaggi, perché verrebbe troppo lunga). In questo nuovo contesto – possiamo aggiungere noi, trasportando al presente le intuizioni di Caffi – l’intellettuale ha ceduto il posto all’influencer. Si badi bene: gli influencer esistono da sempre, già all’epoca di san Francesco raccoglievano migliaia di followers: la differenza sta nel fatto che in genere mettevano in circolazione valori, idealità, stili di vita controcorrente, alternativi a quelli religiosi, politici o esistenziali diffusi dal potere, mentre quelli odierni fanno da cassa di risonanza proprio a questi ultimi. San Francesco predicava scelte di povertà mentre si stava affermando una nascente borghesia commerciale, Ferragni and Co insegnano come diventare ricchi, o come sembrarlo.
E gli intellettuali? Sono diventati pura suppellettile. Con questi chiari di luna si sono convertiti rapidamente al mercato: corrono a far marchette in televisione per promuovere i loro libri o i loro film, sottoscrivono manifesti indignati e partecipano a manifestazioni e ad eventi per dimostrare che esistono, ma non influenzano più nessuno e tantomeno tessono la trama di una “vita di società”. Con buona pace dei “fasci di appunti slegati” e della civiltà della conversazione. Caffi questo giustamente non poteva prevederlo, ma la sua stessa continua insistenza sul tema rivela che aveva comunque già ben chiara la deriva. Le sue esortazioni suonano quasi come un rituale esorcistico. E lui sembra voler convincere soprattutto se stesso: «Per quanto ingenuo (o banale) sembri il mio richiamo alla considerazione dell’uomo in carne e ossa, dell’“uomo mio fratello”, dell’uomo sempre superiore ad ogni regola o istituzione, vi è – mi pare sinceramente – l’embrione d’una vera religione; la quale come ogni religione non sarà mai rigorosamente osservata in tutti gli istanti della vita pubblica e privata che da pochi; ma il loro esempio e apostolato potrà fruttare, modificare l’opinione pubblica, stabilire nuovi criteri, penetrare nella “comune mentalità” nelle abitudini sociali».
La cosa buffa è che anch’io, testimone oculare dello sfascio, insisto a volerci credere.

Un’altra considerazione nasce della rilettura di quella Critica della violenza che Caffi redasse nel 1946 e che fu pubblicata su Politics. Nella mia vecchia copia ho trovato diversi periodi sottolineati o annotati a margine, segno che la prima lettura mi aveva parecchio intrigato, e ho vista riconfermata l’impressione che Caffi fosse un pacifista di stampo ben diverso da quello degli odierni sbandieratori di drappi arcobaleno.
Intanto la sua critica della violenza va letta nel particolare contesto in cui Caffi l’ha formulata, in mezzo alle macerie fumanti dell’immediato secondo dopoguerra, avendo ancora negli occhi i massacri, le distruzioni, le persecuzioni di cui era stato non solo spettatore, ma vittima. Era naturale che dopo tanto orrore auspicasse un ripensamento generale sulle cause e sull’uso della violenza, che volesse scorgervi almeno l’occasione per il mondo di invertire decisamente rotta. E che arrivasse a sostenere: «un movimento il quale abbia per scopo di assicurare agli uomini il pane, la libertà e la pace […] deve rinunciare a considerare come utili, o anche possibili, i mezzi della violenza organizzata, e cioè: a) l’insurrezione armata; b) la guerra civile; c) la guerra internazionale (sia pure contro Hitler, […] o Stalin); d) un regime di dittatura o di terrore per consolidare l’ordine nuovo».
Caffi non perviene comunque a questa affermazione sull’onda delle emozioni: essa è invece il naturale esito, e tanto più doveva apparirlo in quel frangente, di un percorso iniziato trent’anni prima, a seguito dell’esperienza del fronte, e sostanziato per tutto il periodo successivo da una analisi serrata delle cause della violenza intraspecifica. Vale a dire che è perfettamente conseguente coi suoi discorsi sullo stato, sulle forme del potere, sul socialismo, ecc …
E ci tiene anche a sottolineare e a distinguere e a difendere questa coerenza: «I governi detti liberali o democratici […] facendo uso abbondante di formole pacifiste ed umanitarie ‒ con l’inveterata convinzione che simili ossequi alla virtù non impegnano a nulla ‒ compromettono l’azione dei sinceri artigiani della pace e della solidarietà umana, i quali per la forzata somiglianza dei concetti da essi profferiti con quelli che adornano le logomachie ufficiali, possono facilmente essere sospettati della medesima malafede o ipocrisia».
Personalmente non condivido la posizione di Caffi, per la ragione che ho esposto all’inizio di questo scritto: perché sono meno fiducioso di lui nella naturale positività della natura umana originaria, e conseguentemente ritengo che non sempre esistano margini “dignitosi” di trattativa (non esistevano all’epoca con Hitler o con Stalin, non esistono oggi con Putin o con Trump). Capisco la necessità di preservare ogni singola vita umana, ma dubito fortemente che trattare con Hitler mantenendo fermo questo punto avrebbe evitato gli stermini compiuti dai nazisti; e penso anche che ci sia un limite minimo della dignità, al di sotto del quale è dubbio che la vita valga la pena essere vissuta (l’ho premesso, non sto al polo positivo).
Non sono d’accordo quindi col pacifismo “integralista” di Caffi (che non ha nulla però da spartire con la fumosità – quando non malafede – degli pseudo-pacifisti nostrani in fregola filo-putiniana), ma comprendo perfettamente le sue ragioni, e sono convinto che andando a leggerlo bene ci si può rendere conto che la sua critica della violenza si differenzia anche dalla Nonviolenza assoluta, quella di matrice religiosa (vedi un san Francesco, o anche Simone Weil, o Gandhi).
«Si tratta dunque di “costumi”, di “cultura”, di “umanità”, e non di principi metafisici o di precetti religiosi. Dall’ateniese che trattava umanamente il suo schiavo alla signora inglese che apostrofava il carrettiere che maltrattava il suo cavallo, la politesse, o refinement, consiste essenzialmente nel bandire ogni violenza. In nome di che? Del “rispetto di sé”, impossibile senza il rispetto degli altri; di una socievolezza che, estendendosi dall’uno all’altro, finisce logicamente col comprendere tutti gli esseri viventi. Alla superficie, si tratta di buona educazione e di “costumi civili”; in profondo, c’è in primo luogo la coscienza della “società” come fatto e come valore, e dunque immancabilmente della “giustizia” nei rapporti sociali, una nozione che – lo si vorrà ammettere– è più fondamentale di qualsiasi dogma religioso o morale.»
Almeno fino al termine del secondo conflitto mondiale non è comunque così integralista da escludere che possano esistere situazioni estreme, nelle quali il ricorso alla violenza si rende necessario come legittima difesa sia individuale che collettiva.
Semmai Caffi sposta la questione da un piano prettamente morale ad uno etico-politico, nel senso che ritiene che il problema vero, quello che dà origine alla pratica della violenza e che va affrontato prioritariamente, sia l’involuzione totalitaristica degli stati; ma cerca poi di scendere anche su quello pratico, sforzandosi di dimostrare con esempi concreti come la scelta della violenza non abbia mai portato a soluzioni positive e definitive.
«È possibile vincere la violenza con la violenza? La questione, in realtà, ne nasconde due molto diverse. La prima è d’ordine empirico: quale probabilità c’è che un’organizzazione di refrattari, uomini liberi e pienamente coscienti dello scopo da raggiungere, disponga delle armi, dell’equipaggiamento, delle capacità tecniche per affrontare gli attuali padroni del mondo con una ragionevole prospettiva di successo? Ma la questione decisiva è l’altra: anche supponendo che si riesca a inquadrare le masse (ribelli, oppure repentinamente convertite a un ideale altamente illuminato della società e della civiltà), a strappare la bomba atomica ai suoi attuali detentori, e infine a impegnare la battaglia, è seriamente credibile che si possa evitare una ricaduta, in circostanze quanto si voglia “rivoluzionarie”, in quelle abitudini barbare, in quegli eccessi della volontà di potenza, e infine nella divisione fra un gregge docile e dei capi imperiosi che l’impiego organizzato della violenza inesorabilmente genera?»
Il che dal mio punto di vista è ingenuamente semplicistico, ma se collegato al quadro di socievolezza universale ipotizzato da Caffi ha senz’altro anche una sua logica.
«Il problema che Platone cerca di risolvere è come si possa concepire una società capace di attingere a un grado supremo di civiltà e, al tempo stesso, di difendersi contro un ambiente barbaro. Il filosofo immagina quindi la sua Città: 1) come un’isola nell’oceano di un’umanità imperfetta, con la quale essa non avrà che dei contatti occasionali; 2) come un luogo dove si sarà una volta per tutte regolato il male inevitabile relegando una parte della popolazione nell’esercizio della violenza, mentre i lavoratori da una parte, i filosofi dall’altra, potranno godere i benefici di un’esistenza pacifica e di costumi gentili. Una tal situazione, e una tal divisione, non hanno nulla di utopico: rappresentano, in sostanza, quella che è stata la condizione di un buon numero di società civilizzate quando la lotta fra le classi non vi s’inaspriva fino a prendervi forme violente.»
Vivesse oggi vedrebbe confermate tutte le sue paure e smentita la sua speranza, non solo in un mondo meno violento, ma in una responsabile e costruttiva reazione dei “filosofi”. E tuttavia, se ho capito qualcosa del personaggio, non cesserebbe di battersi per le sue idee.

E finalmente …
Le pagine risultanti nella redazione finale di questo scritto sono forse nemmeno un terzo di quelle che avevo buttato giù inizialmente. Ho deciso di tagliare drasticamente (e tagliare mi costa sempre, ogni riga è un brandello di pelle), un po’ perché mi sono reso conto che stavo sfidando troppo la capacità di attenzione di qualsivoglia lettore, ma soprattutto per un altro motivo. Per pagare a Caffi quel che ritenevo di dovergli sono innanzitutto andato a riprendere le raccolte degli scritti suoi e di quelli a lui dedicati, raccolte che avevo compilato e postato già parecchi anni fa, nell’intento di aggiornarle e rinnovare la bibliografia. Non avrei mai pensato di trovarmi di fronte a tanto materiale nuovo, in parte pubblicato nel frattempo e in parte sfuggitomi a suo tempo. Leggendo queste cose ho sentito insorgere una sorta di sindrome dell’impostore, perché ho scoperto interventi davvero informati e stimolanti, che colpevolmente ignoravo, e che andavano talmente oltre da rendere del tutto superfluo il mio. Ho provato imbarazzato per l’inadeguatezza della mia presentazione, tanto che ero sul punto di cestinare tutto. Ho risolto poi soltanto di alleggerirlo, così posso fingere con me stesso di essere rimasto nei limiti dell’impegno originario e proporre queste pagine come propedeutiche alle letture ben più serie che invito a fare.
C’era tuttavia ancora un’altra motivazione. L’improvvisa abbondanza di interventi e contributi sulla figura e sul pensiero di Caffi mi ha fatto sospettare l’inizio di un processo di beatificazione, di quelli “usa e getta” che si celebrano molto velocemente oggi. Nella penuria di idee e di precursori ai quali aggrapparsi e nella corsa dell’editoria al fast food culturale ho temuto che Caffi diventasse una delle tante varianti passeggere di pizza destinate a diversificare l’offerta per un trancio d’estate.
Ho poi realizzato che avendo indirizzato la mia ricerca nella direzione Caffi era più che logico incontrare per strada tutti i possibili riferimenti che portavano a lui, e che la mia era solo una forma strana di gelosia che provo nei riguardi degli autori “dimenticati” sui quali rivendico una immeritata prelazione. Mi è capitato con Humboldt, con Seume, con Timpanaro, con un sacco di altri.
Di per sé comunque la scoperta non mi ha depresso, al contrario: mi ha confermato che le cerchie di amici cui faceva costante riferimento Caffi esistono, sia pure in una dimensione “virtuale” che lui non poteva prevedere. «Senza spingersi ad esagerazioni di analogie (che applicate a momenti della storia sono sempre fallaci) – si può dire che oggi – come alla vigilia del “Manifesto Comunista”, come prima della costituzione della Seconda Internazionale – vi è in Europa un numero impressionante di sparuti cenacoli e di “isolati” nei quali nonostante tutto vive la convinzione che “qualche cosa bisogna fare” per combattere l’assurdità dell’attuale “condizione umana”, per muovere le menti e le “volontà di vivere” verso la redenzione (che si desidera totale, anche se la si sa irraggiungibile).»
Tiro dunque finalmente le somme, cercando di spiegare, se ancora non si fosse capito, i motivi del mio entusiasmo per il personaggio Caffi, ma soprattutto per quello che ha significato (e potrebbe ancora significare) il suo pensiero. Non ho alcuna riluttanza a comprenderlo tra i “maestri”, intesi come coloro al cui pensiero devo qualcosa, fermo restando beninteso che non significa che lo abbracci incondizionatamente. Sono “maestri” quelli che mi hanno costretto a pensare, a interrogarmi, a scorgere altre strade rispetto a quelle che stavo percorrendo, e a tenerle poi ben presenti anche quando non avevo ritenuto di intraprenderle. In questo senso Caffi è il più esemplare tra i maestri, proprio perché non pensa affatto di esserlo e non pretende di essere ritenuto tale. È uno spirito talmente indipendente che sarebbe infastidito all’idea di avere degli allievi: la cosa gli avrebbe creato degli obblighi, lo avrebbe volente o nolente condizionato nelle sue scelte di posizione. Voleva avere degli amici, questo sì: spiriti affini al suo, indipendenti come il suo, capaci di confrontarsi sullo stesso piano, e non di accettarne supinamente e devotamente il magistero: in caso contrario non sarebbero stati di alcuna utilità a lui, e nemmeno a se stessi.
Caffi non era un santo, se per santo intendiamo un uomo pervaso dalla moralità del sacrificio e della rinuncia assoluta. Lui stesso avverte che «il santo e l’eroe sono poco socievoli», e che «la società prova disagio non solo di fronte a tutto ciò che sta al disotto d’un certo livello di dignità umana, ma anche al cospetto del “sovrumano”». Io aggiungerei alla lista dei poco socievoli anche il genio, e cito quello che scrivevo quaranta anni fa: «In fondo tutti i grandi geni sono stati degli implacabili egoisti, che sono riusciti (beati loro) a passare sopra le esigenze altrui e i condizionamenti affettivi e sentimentali. Da Cristo a Marx, è tutta una storia di gente che dice a padri, madri, figli, mogli e amanti: ma che volete? E che tutto sommato non ha amici, ma solo discepoli».
Piuttosto, credo gli calzi a pennello la definizione datane da Moravia, che gli fu amico, ma senz’altro non allievo, essendo finito ad incarnare proprio il modello di “intellettuale organico” dal quale Caffi prendeva le distanze: «Forse si potrebbe definire Caffi un eterno studente, nel senso che voleva sempre imparare qualche cosa. Il suo fascino vero era questa curiosità, freschezza […]».
A parte il fascino, è il modo in cui vorrei essere ricordato anch’io.
Quindi: ho proposto la figura di Caffi per come l’ho letta io, senza la pretesa di averne interpretato ed esaurito tutte le sfumature. Ho sottolineato quello che ho riconosciuto, che in qualche modo, spesso molto confusamente, già mi apparteneva, più ancora che quello che ho scoperto e imparato.
E ho cercato per quanto possibile di leggere le sue parole in un contesto che è pur sempre quello di un secolo fa, tenendo presente che erano rivolte a un paio di generazioni entrambe precedenti la mia, che avevano attraversato o stavano attraversando due guerre mondiali e avevano maturato o stavano maturando esperienze completamente diverse dalle nostre.
Insomma, non nego che la figura di Caffi abbia per vari motivi, che stanno al di là del valore del suo pensiero e che ho cercato anche di spiegare, esercitato un certo “fascino”: ma penso di essere riuscito nel complesso a mantenere la giusta distanza per coglierne correttamente le implicazioni.
E allora ciò che viene fuori è questo. Caffi non può essere iscritto nel novero dei rivoluzionari anarchici, né dei bombaroli né dei “gradualisti”: non è l’erede di Bakunin, nel pensiero e meno che mai nel “modo d’essere” (non era certo così disinvolto nello spendere i soldi altrui); è semmai piuttosto vicino nel modo di pensare a un Landauer e a Camillo Berneri, ma con una ricaduta sull’azione pratica ben diversa; non è assolutamente un marxista, in nessuna delle declinazioni possibili del marxismo; non è un riformista, a dispetto della sua amicizia con Salvemini e della stima reciproca che i due si tributavano. È un socialista libertario (e lascio a chi legge scegliere in che ordine disporre i due qualificativi), definizione che non specifica molto e può significare tutto. Senza dubbio è un individualista, che pone in primo piano la libertà individuale, ma al tempo stesso ritiene che ogni individuo ha senso solo nelle relazioni che intrattiene con gli altri, e ha senso profondo solo se queste relazioni si svolgono su un piano di pari dignità e reciproco rispetto.
Insomma: se qualcosa Caffi ci trasmette non è tanto il cosa fare ma il come essere. E si badi, non vuole trasmetterlo, non lo pretende dagli altri, lo chiede e lo impone a se stesso. Questa è una vera lezione di esemplarità. Questo rimane di lui, e mi sembra che già basterebbe.
Personalmente però, per me rappresenta qualcosa di più. Nel leggere i suoi scritti politici, che sulle prime mi erano apparsi utopisticamente ingenui, salvo poi, raffrontati alla realtà di ciò che mi accadeva attorno, rivelarsi profetici e anticipatori, ho avuto costantemente l’impressione di trovarmi davanti a quelle possibilità, a quelle opzioni alternative che la storia ci propone costantemente e che finiscono come macerie ai margini della strada che abbiamo scelto di percorrere, o siamo stati costretti a percorrere per scelte fatte da altri, siano di volta in volta il capitalismo, la tecnica, il populismo, ecc. Ecco, nelle sue pagine mi si presentavano le immagini di come “avrebbe potuto essere”, e capivo che ad un certo punto Caffi, deluso dalle scelte fatte sopra la sua testa ma anche dalla constatazione di non poter uscire dal suo isolamento, abbia deciso di vivere “come se” la sua idea di società fosse non solo possibile, ma anche immediatamente praticabile.
Questo per quanto riguarda le personalissime ragioni del mio interesse. A spiegare invece quello che sembra essersi risvegliato più diffusamente attorno a Caffi, e a chiudere un po’ meno banalmente questa rimpatriata col suo pensiero lascio sia Marco Bresciani (da La rivoluzione perduta. Andrea Caffi e l’Europa del Novecento): «L’orientamento impolitico dell’italo-russo funziona da reagente chimico rispetto all’epoca successiva al 1914, facendo interagire ed esplodere le contraddizioni e le tensioni, i miti e i dilemmi della cultura rivoluzionaria europea. In particolare, Caffi si confrontò con l’esperienza e il mito dell’Unione Sovietica che di quella cultura portava profonde tracce, pur senza identificarsi o esaurirsi con essa. In questo senso, offre un punto d’osservazione privilegiato, che non si codificò nella rigidità del linguaggio marxista-leninista e che non si inquadrò nell’organizzazione comunista. In questa capacità di incarnare il mito rivoluzionario europeo, vivo e vitale al di là del mito sovietico, con tutte le sue molteplici articolazioni, le sue sotterranee diramazioni e le sue contraddittorie implicazioni, sta la ragione dell’interesse storico di Caffi all’inizio del XXI secolo, dopo la fine del “socialismo reale”».

Bibliografia
Testi di Andrea Caffi
Socialismo libertario, a cura di Gino Bianco, Milano, Azione Comune, 1964
Critica della violenza, con prefazione di Nicola Chiaromonte, Bompiani, 1966
Critica della violenza, introduzione di Gino Bianco, e/o, 1995
Scritti politici, a cura di Gino Bianco, La Nuova Italia, 1970
Scritti scelti di un socialista libertario, a cura di Sara Spreafico, con prefazione di Nicola Del Corno, Milano, Biblion, 2009
Cosa sperare? Il carteggio tra Andrea Caffi e Nicola Chiaromonte (1932-1955), a cura di Marco Bresciani, Napoli, Edizioni Scientifi che Italiane, 2012
Politica e cultura, a cura di Massimo La Torre, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2014
L’unità d’Italia. Pro e contro il Risorgimento, a cura di Alberto Castelli, Roma, e/o, 2010 [scritti di: A. Caffi, U. Calosso, N. Chiaromonte, P. Gobetti, A. Gramsci, C. Rosselli, G. Salvemini, F. Venturi]
“Politics” e il nuovo socialismo. Per una critica radicale del marxismo, a cura di Alberto Castelli, Genova-Milano, Marietti, 2012
Testi su Andrea Caffi
Gino Bianco, Un socialista “irregolare”: Andrea Caffi intellettuale e politico d’avanguardia, Cosenza, Lerici, 1977 (Nuova edizione, con il titolo: Gino Bianco Socialismo e libertà. L’avventura umana di Andrea Caffi, Roma, Jouvence, 2006)
Carlo Vallauri, Il socialismo umanitario di Andrea Caffi, Giuffrè, 1973
Gino Bianco, Nicola Chiaromonte e il tempo della malafede, Manduria-Bari-Roma, Lacaita, 1999
Andrea Caffi: un socialista libertario, Atti del convegno di Bologna (7 novembre 1993), a cura di Gianpiero Landi, Pisa, BFS, 1996
Marco Bresciani, La rivoluzione perduta: Andrea Caffi nell’Europa del Novecento, Bologna, Il Mulino, 2009
Alberto Castelli, Andrea Caffi. Socialismo e critica della violenza (in L’altro Novecento. Comunismo eretico e pensiero critico, a c. di P. P. Poggio, Milano, Jaca Book, 2010
Appendice
Nicola Chiaromonte, Introduzione a Andrea Caffi, Critica della violenza, Bompiani, 1966
Parlo di Andrea Caffi come dell’“uomo migliore, e inoltre il più savio e il più giusto” che nel mio tempo io abbia conosciuto. Ne parlo per essergli stato amico durante ventitré anni, dal maggio 1932 quando, a Parigi, Alberto Moravia me lo fece incontrare, al luglio 1955, quando morì nella stessa città, e perché alla sua amicizia devo quel che di meglio posso aver acquistato nel corso della mia vita; ne parlo perché penso che le poche tracce scritte della sua personalità che si sono potute conservare o recuperare meritano di essere conosciute, ma d’altra parte hanno bisogno di essere accompagnate da qualche notizia.
Ma, come sono relativamente pochi, anzi pochissimi, nella gran quantità di schede, note e quaderni da lui lasciati, gli scritti di Caffi abbastanza compiuti per poter essere offerti in lettura a chi non lo conobbe, così sono singolarmente poche e frammentarie le notizie che della sua vita, pur ricchissima di peripezie, d’incontri, di sodalizi, d’amicizie, si possono dare come “obbiettive”. Quelle che ho, le ho raccolte quasi tutte dai suoi discorsi, ma sempre a proposito d’altre cose, mai parlando di sé e dei propri fatti, argomento che egli considerava fastidioso e indiscreto.
Mi trovo dunque, da una parte con gli scritti che qui si pubblicano e con alcune notizie frammentarie, dall’altra con un’immagine prodigiosamente viva dell’uomo: tanto viva da scoraggiare la descrizione, poiché essa ha della vita la caratteristica essenziale, che è il non finito, l’indeciso, l’elusivo.
Come si vedrà in queste pagine, se c’era nella mente di Caffi un’idea centrale attorno alla quale tutte le altre si ordinavano naturalmente, questa era l’idea di socievolezza: la philìa aristotelica, fondamento della vita associata. Ma la socievolezza non era solo un’idea, per Caffi, era anche il tratto saliente della sua personalità.
La socievolezza spontanea e continuamente traboccante, accompagnata da una prodigalità illimitata nel dono di sé, dava all’esistenza di Andrea Caffi una pluralità d’aspetti che finiva per diventare innumerevole. C’era, per esempio, come io lo conobbi, il Caffi italiano amico di Gaetano Salvernini come di Umberto Zanotti-Bianco, di G. A. Borgese e di Giuseppe Ungaretti come di Alberto Moravia, di Umberto Morrà, di Vincenzo Torraca, di Giuseppe Fancello, come poi di Carlo Rosselli e di molti altri uomini dell’emigrazione antifascista a Parigi. Insieme a questo, c’era il Caffi intimamente legato a gruppi e persone della diaspora intellettuale, letteraria e politica russa, e non era certo meno reale dell’italiano. C’era poi il Caffi francese d’elezione, con amicizie e impegni in molti circoli della vita politica e intellettuale francese. Ci fu persino, fra il 1950 e il 1955, attraverso l’incontro con Paolo Emilio Comes, Mario Pedrosa e i loro amici, un Caffi brasiliano.
Ma c’era poi anche il Caffi eretico di tutti questi gruppi, intellettuale la cui visione non si adattava a nessuna prospettiva comunemente accettata e verso il quale solo alcuni pochi individui isolati, o comunque insoddisfatti dei gruppi esistenti e delle idee correnti, potevano sentirsi attratti; e di questi, pochissimi a lungo, perché i sentieri per i quali Caffi trascinava chi lo seguiva erano davvero Holzwege, sentieri non tracciati in anticipo e di cui non si sapeva dove conducessero; dunque stancanti. Dietro questo Caffi eretico e irrequieto c’era lo spirito solitario, assorto in un mondo di pensieri segreti e di operazioni intellettuali addirittura misteriose nel quale raramente, anche nei momenti di maggiore confidenza, si apriva qualche spiraglio.
C’era infine, a riunire e confondere di continuo queste parti diverse, Caffi al naturale, per così dire: uomo dal tratto quanto mai affabile e amabile, egualmente a suo agio nella compagnia delle persone più diverse, purché non appartenessero alla specie odiata dei mediocri soddisfatti. Era, questo, un uomo che più delicato e nobile è difficile immaginare, e certamente rarissimo trovarne: un uomo che tutte le qualità della mente e dell’animo dicevano fatto per essere accolto e onorato nei luoghi più eccelsi di una società ideale, e particolarmente fra gli uomini di pensiero e di cultura; e il quale invece sceglieva deliberatamente la solitudine e l’oscurità, incapace com’era di fare la più piccola concessione quando si trattava non dico della sua integrità morale o delle sue idee, che sarebbe un parlare solenne, ma semplicemente della sua sensibilità. Ogni tentativo, anche il meglio intenzionato, di procurargli una via d’uscita da tale isolamento, e dalle angustie che comportava, rimase inutile fino all’ultimo. Sicché era evidente che non si trattava tanto di riluttanza al compromesso, quanto della volontà di non “inserirsi” in alcun modo in una società che gli dispiaceva profondamente.
Questa pluralità di esistenze, il vivere alla ventura nella più completa noncuranza non solo di ogni carriera, ma di ogni vantaggio personale, l’incoercibile irrequietezza dello spirito spiegano almeno in parte le immagini così diverse, frammentarie e incerte che rimangono di Caffi. In tutte, anche in quelle dei testimoni meno perspicaci, la sua natura eccezionale è presente, e più particolarmente sono presenti di lui la generosità spensierata e la stupefacente cultura. Ma in nessuna la sua immagine è chiara e rilevata. In tutte rimane l’enigma di chi fosse in realtà lo “spirito arcangelo” così vivo nel ricordo di Antonio Banfi, lo “strano tipo” di cui ha sentito il bisogno di scrivere Giuseppe Prezzolini riducendone tuttavia la figura a quella di un amabile scombinato, il “personaggio socratico” di cui serba memoria ammirata Alberto Spaini, facendone d’altro canto un mazziniano (cosa che egli certamente non era) e un fautore degli Stati Uniti d’Europa, cosa certamente vera, di lui, ma insieme a molte altre alquanto più importanti (v. Il Messaggero di Roma — 5 ottobre 1959).
La diversità, frammentarietà e incertezza delle testimonianze su Caffi (fra le quali è da ricordare quella di Gaetano Salvemini, che ne parlava come dell’uomo più straordinario e dello spirito più eletto che egli avesse conosciuto, e anche, scherzando sulla piena strabocchevole delle sue cognizioni, come del “caos prima della creazione”), si riflette nell’incompletezza dei dati più elementari della sua biografia, la quale, per essere in qualche modo completa, avrebbe dovuto essere redatta già molti anni fa, andando a consultare in giro per il mondo le molte persone che l’avevano conosciuto e gli erano state amiche, il numero delle quali è ormai irreparabilmente assottigliato. Io dunque dirò, per quanto posso in ordine, quello che so di sicuro.
Andrea Caffi era nato a Pietroburgo il 1° maggio 1887, da genitori italiani. Originario di Belluno, suo padre era nipote del pittore e patriota garibaldino Ippolito Caffi. Il quale, essendo stato scenografo dei teatri imperiali, aveva aperto al nipote la via di un impiego nell’amministrazione dei teatri medesimi.
Considerato dai maestri un ragazzo di doti eccezionali, il padre lo iscrisse a quella che era allora la migliore scuola di Pietroburgo, e una delle migliori d’Europa: il Liceo Internazionale. Di quell’insegnamento e di quell’ambiente egli serbava memoria grata e affettuosa, come si può vedere da quel che ne dice nello scritto Società e gerarchia, pubblicato in questo volume.
A quattordici anni, Andrea Caffi era già socialista d’idee: diceva che la sua scelta risaliva al raccapriccio provato per le condizioni di lavoro degli operai industriali durante una visita alle officine Putilov, dove era stato condotto, insieme alla sua classe, da un professore probabilmente socialista egli stesso. A sedici anni, egli fu tra gli organizzatori del primo sindacato dei tipografi di Pietroburgo, dei quali si vantava di aver contribuito a fare dei socialisti senza mai parlar loro di marxismo, ma solo di storia, di letteratura e di filosofia. In questo lavoro clandestino, egli ebbe compagni Kalinin (che doveva diventare il primo Presidente dell’Unione delle Repubbliche Sovietiche) e Molotov, destinato alla fama come ministro degli esteri di Stalin.
Seguendo questa via, a diciotto anni Caffi prese parte alla rivoluzione del 1905, nelle file dei menscevichi. Arrestato e condannato a tre anni di carcere, fu liberato nel 1907 per intervento dell’ambasciatore d’Italia. Andò allora in Germania per compiervi gli studi universitari. A Berlino, ebbe maestro particolarmente amato Georg Simmel, del cui pensiero si trova più di una traccia nei suoi scritti. Fra i suoi compagni di studi c’era Antonio Banfi, il futuro docente di filosofia all’Università di Milano e senatore comunista, il quale lo ha ricordato con queste parole: «M’era compagno lo spirito più arcangelo e più vivo che mai conobbi, Andrea Caffi, fuggitivo dalla prigionia per i moti del 1905-06, un umanitario ribelle, raffinato e semplice insieme di vita, poliglotta e colto all’estremo, arguto e entusiasta, con cui scrivemmo pagine e pagine sulla cultura europea contemporanea. Dove sia quel manoscritto non so, so che da lui ebbi un vero fiotto di vita e di entusiasmo» (v. Aut Aut, 1958, n. 43-44). Al che voglio aggiungere che il Frammento politico del 1910 di Antonio Banfi, pubblicato da Fulvio Papi nel 1961, porta per me l’impronta inconfondibile di Caffi quando, senza il soccorso di un appunto, tracciava a viva voce vasti panorami di storia delle idee, e l’ascoltatore cercava di notarne l’essenziale, trovandosi alla fine fra le mani il disegno suggestivo di un’opera originale che solo Caffi avrebbe potuto condurre a termine.
Mentre proseguiva gli studi e continuava a militare nel movimento socialista, Caffi viaggiava per tutta l’Europa. Soggiornò a lungo a Firenze, dove frequentò il gruppo della Voce. Amico di Scipio Slataper e di Alberto Spaini, strinse anche rapporti amichevoli con Giuseppe Prezzolini, e collaborò alla rivista con uno scritto firmato insieme a Antonio Banfi e Confucio Cotti. Nel presentare una lettera di lui pubblicata nel volume Testimonianze (Longanesi, 1960), Prezzolini così lo descrive: «Arrivava all’improvviso, non si sapeva da che parte del mondo, con gli abiti sgualciti e l’aria di avere un grande appetito… e scompariva allo stesso modo, senza che si sapesse perché né per dove. Da per tutto portava la sua gentilezza, un’aria d’innocenza, un enorme fascio d’erudizione che slegava e da cui traeva regali a qualunque richiesta […].».
In un articolo dello stesso Prezzolini, pubblicato nel giornale Il Tempo di Roma il 15 agosto 1959 e intitolato Uno strano tipo, si trovano ricordati altri tratti della personalità di Caffi: «Siccome era di un’estrema delicatezza e indipendenza di spirito, non ci si accorgeva delle sue ristrettezze altro che dagli abiti e dallo sguardo con il quale di traverso guardava una tavola apparecchiata quando lo si invitava… Aveva un modo di sfuggire ogni curiosità e indagine sulla sua persona che lo rendeva molto simile a quei personaggi dei romanzi russi che rispondono con frasi svagate e allusive alla polizia degli zar… Il suo ingegno era vivace, la sua memoria potentissima. Era curioso che un uomo sapesse tante cose senza avere accanto una biblioteca personale. Se in una conversazione usciva qualche frase contenente un’inesattezza, si poteva esser sicuri che il giorno dopo si riceveva una lettera di lunghe correzioni e prove. Da giovane, mi accadde di dire qualche corbelleria intorno all’Ucraina, e credo di conservare ancora una lettera di trenta pagine nella quale mi faceva tutta la storia della lingua, della letteratura e della nazione ucraina. Tutto questo, certamente, senza consultare un libro, senza chiedere il parere di nessuno […]».
Tale era il Caffi venticinquenne. Non molto diverso dal Caffi adulto, a giudicare da questo ritratto. Direi che i lineamenti esteriori Prezzolini li vede molto bene; quelli morali e intellettuali, invece, in una luce curiosamente opaca, quasi nello sforzo di non lasciare la figura di questo “strano tipo” invadere la coscienza con le domande di cui è portatrice, ma ridurla invece entro i limiti del pittoresco: sforzo che mi sembra caratteristico della guicciardiniana “saviezza” di Giuseppe Prezzolini.”Enorme fascio d’erudizione”, “memoria potentissima”, “ingegno vivace”: sembra uno di quei terzetti d’aggettivi in scala discendente che Proust nota comicamente nei discorsi di Madame de Cambremer.
Enorme era certo, l’erudizione di Caffi; ed è più giusto, nel suo caso, parlare di erudizione che di cultura, perché le sue conoscenze storiche (e ogni nozione si ordinava secondo storia, ossia secondo la dimensione del tempo, nella sua mente), illimitate come sembravano, erano quelle di un conoscitore profondo e minuzioso il quale accresceva, riordinava, riesaminava e ristudiava ogni giorno quel che sapeva. Di questo sono prova la gran quantità di schede, fogli e quaderni da lui lasciati (ma la massima parte è andata perduta) in cui si trova annotato ciò che egli veniva di continuo apprendendo e riapprendendo.
Ma l’“enormità” stessa delle sue conoscenze era motivo di una meraviglia che non poteva fermarsi alla constatazione della “memoria potentissima”, né dell’“ingegno vivace”. Giacché da una parte la memoria di Caffi, portentosa com’era, non aveva niente di acrobatico, era spontanea, palpitante di vita e d’intelligenza; dall’altra, il suo ingegno si manifestava nella prodigiosa sicurezza con cui, quale che fosse l’argomento, egli andava al vivo della questione senza cura di opinioni stabilite, idoli o tabu di sorta. C’era in questo assai più che della “vivacità”: una libertà di giudizio e di pensiero di cui non ho conosciuto l’eguale in nessun intellettuale dei tempi nostri; ed era in primo luogo una conquista morale, il frutto, cioè, di una coerenza di vita eccezionale.
Riprendendo il filo della cronologia, dirò che terminati gli studi universitari (compiuti peregrinando per tutte le università tedesche, come permetteva la disciplina degli studi superiori in Germania), Caffi si stabilì a Parigi, o almeno a Parigi dimorava la maggior parte del tempo. Erano gli anni delle famose lezioni di Bergson al College de France, dei Cahiers de la Quinzaine di Péguy, del socialismo di Jaurès, della polemica di Sorci, del fiorire della nuova letteratura, della nuova pittura, della nuova musica: inizio splendido di un secolo destinato alla tragedia. A quegli anni risale il legame d’amicizia con Giuseppe Ungaretti, rimasto affettuoso fino all’ultimo.
Con un gruppo di amici francesi, russi, tedeschi e, credo, anche inglesi, che s’era dato nome La Jeune Europe, Caffi concepì allora il progetto di un’“enciclopedia” in cui fosse steso il bilancio della situazione della cultura europea all’inizio del secolo. L’impresa fu stroncata dalla guerra: dispersi fra i paesi belligeranti, gli amici non dovevano più ritrovarsi.
Il 2 agosto 1914, Caffi si arruolò volontario nell’esercito francese. Non so se, da parte di un socialista come lui, tale decisione meravigliasse i suoi amici. Meravigliò me quando l’appresi, perché il suo giudizio sul comportamento dei partiti socialisti europei, arresisi quasi tutti al principio dell’interesse nazionale e dell’union sacrée, era quanto mai severo, non distinguendosi sostanzialmente da quello di Lenin e di Trotzki. Ma egli spiegò candidamente che, in primo luogo, non gli era stato possibile non desiderare la sconfitta del militarismo tedesco e la vittoria della Francia; in secondo luogo, vedendo partire tanti amici incontro alla morte la sola scelta personale ammissibile gli era parsa quella di condividerne il destino; in terzo luogo, di fronte a una guerra che lui, come molti altri in Europa, aveva sentito approssimarsi fatalmente fin dal 1911, e della quale si poteva esser certi che avrebbe messo a ferro e fuoco l’intero continente, non gli era sembrato possibile invocare delle ragioni di principio. La catastrofe era avvenuta, non c’era che da subirla. Il che, d’altra parte, non significava mutare il proprio giudizio sull’avvenimento e sulle sue probabili conseguenze.
Caffi, insomma, fu nell’agosto 1914 fra i numerosi intellettuali europei, che, per oscuro che paresse loro l’avvenire, credettero tuttavia che dalla sconfitta della Germania imperiale dipendessero le sorti della democrazia e del socialismo. Le sue speranze andavano allora nel senso di un’Europa federata sulla base dei principi mazziniani.
Ferito quasi subito nei combattimenti delle Argonne, nel 1915 fu mobilitato in Italia. Ferito di nuovo sul fronte del Trentino, fu addetto presso il comando della IV Armata. Di lì, nel 1917, passò con G. A. Borgese a Zurigo, nell’ufficio speciale da questi creato per la propaganda fra le nazionalità oppresse dell’Impero absburgico.
Nel 1919, Caffi diede vita in Italia a due riviste il cui scopo era di contribuire, con un’informazione seria sui problemi lasciati dalla guerra, a influenzare ragionevolmente le decisioni che si stavano per prendere a Versailles sul nuovo assetto dell’Europa: la prima fu La Vita delle Nazioni; la seconda (pubblicata in collaborazione con Umberto Zanotti-Bianco) La Giovane Europa. Il primo scritto seriamente informativo sulla rivoluzione russa e i suoi capi apparso in Europa occidentale fu un lungo saggio di Caffi ne La Vita delle Nazioni. Si sa peraltro che cosa avvenne a Versailles dell’ideale di una pace giusta cui queste pubblicazioni intendevano giovare.
A pace conclusa, amici comuni intervennero presso Luigi Albertini perché il Corriere della Sera si valesse delle conoscenze e dell’esperienza di Caffi mandandolo in Russia come inviato speciale. Arrivato a Costantinopoli, egli mandò (a quanto scrive in una lettera inviata da lì a Prezzolini) otto articoli. Di questi, uno solo fu pubblicato, suscitando l’ammirazione di molti lettori. Si può pensare che la ragione per cui gli altri articoli di Caffi rimasero inediti fosse l’indignazione che in essi si esprimeva (e della quale si trovano tracce vibranti in un’altra lettera a Prezzolini) per la condotta brutale degli Alleati nei territori dell’ex Impero ottomano.
Comunque, arrivato a Odessa, Caffi terminò bruscamente le sue mansioni d’inviato speciale. L’idea di attraversare la Russia devastata dalle epidemie, dalla fame e dalla guerra civile in veste di giornalista gli parve insopportabile. Invece di continuare il suo servizio, si aggregò alla missione internazionale di soccorso organizzata e diretta dal norvegese Fridtjof Nansen, proseguendo così il viaggio verso Mosca.
Per i capi bolscevichi al potere, Caffi, che li aveva ben conosciuti come militante socialista, non aveva alcuna simpatia. Egli rimaneva naturalmente solidale con i menscevichi e i socialisti rivoluzionari ora perseguitati. È da notare tuttavia che già nell’articolo sopracitato egli aveva esposto con molta chiarezza le loro ragioni e mostratone la forza e la fondatezza. Ma nel trionfo dei bolscevichi egli vide, con uno scoramento simile a quello provato allo scoppio della guerra, la sconfitta di quanto c’era stato di più schiettamente libertario e socialista, e anche di più europeo, nella tradizione rivoluzionaria russa quale si era iniziata nel dicembre 1825. Ciò che lo rese una volta per sempre avverso ai bolscevichi fu il loro autoritarismo implacabile, nel quale tuttavia non mancava di riconoscere la fonte principale della loro forza. D’altra parte, gli fu anche chiaro che l’aggressione anglo-francese contro la rivoluzione russa aveva reso irreparabile lo scisma fra la nuova Russia e l’Europa, contribuendo a irrigidire la situazione interna e a fare del terrore un’istituzione permanente del nuovo regime.
Un’idea di quale fosse il comportamento di Caffi a Mosca in quegli anni la si potrà avere leggendo quello che egli stesso narra nel corso delle sue considerazioni su “Stato, Nazione e Cultura” della “monelleria” perpetrata da lui e dai suoi giovani compagni quando, lavorando negli uffici della Terza Internazionale, si divertivano a inserire nel bollettino da essi redatto notizie sgradite in alto loco.
Fu come “controrivoluzionario”, sotto l’accusa (infondata) di essersi adoperato a dissuadere i socialisti italiani venuti a Mosca con G. M. Serrati dall’aderire alla Terza Internazionale, che la Ceka lo arrestò. Rinchiuso nella prigione della Lubianka, dove ogni notte le porte delle celle si aprivano per l’appello dei condannati a morte (“fatto piuttosto a casaccio”, ricordava Caffi), fu liberato dopo alcune settimane grazie all’intervento di Angelica Balabanoff.
Rimasto a Mosca, quando vi giunse la prima missione diplomatica italiana gli fu chiesto di assumervi le funzioni di segretario. Le quali egli si vantava scherzosamente di aver sfruttato per fabbricare un cospicuo numero di falsi cittadini italiani, rilasciando passaporti a persone che volevano fuggire dalla Russia.
Ma ebbe anche da fare altro. Poco dopo la “marcia su Roma”, giunse alla missione di Mosca, direttamente da Mussolini nella sua qualità di ministro degli esteri, la richiesta di un rapporto sul costo in vite umane della rivoluzione russa, fra terrore bolscevico, guerra civile, fame e flagelli concomitanti. Fu Caffi a fare le ricerche e a redigere il documento. Il quale non potè essere d’alcuna utilità a Mussolini, visto che il motivo che l’aveva spinto a chiederlo era di poter affermare (come più tardi in un discorso non si peritò di fare) che la rivoluzione fascista era stata un fatto altrettanto importante della rivoluzione francese e di quella russa perché altrettanto e più sanguinoso.
Noterò qui in parentesi che, prima di lasciare la Russia, Caffi ebbe cura di depositare alla biblioteca centrale di Mosca (poi Biblioteca Lenin) un pacco di scritti e di documenti da lui raccolti, nel quale per parte mia son certo che lo storico futuro troverà materia importante di studio.
Tornato in Italia nel 1923, l’impiego avuto in Russia gliene valse uno al ministero degli esteri, a Roma. Fu incaricato della redazione di un notiziario per le ambasciate. Lontano com’era stato dall’Italia fin dal 1920, non sapeva quasi nulla del fascismo. Non tardò a farsene un’idea, e un giorno uscì dall’ufficio per non più tornarvi. Ma non senza prima aver ripetuto una “monelleria” del genere di quella perpetrata a Mosca: a guisa di commiato dalle sue mansioni ufficiali, aveva scritto e regolarmente spedito alle ambasciate nei vari paesi un ultimo bollettino, contenente un resoconto burlesco del famoso ricevimento offerto a Palazzo Venezia in onore dei neo-nobili del regime, dove Mussolini era insignito del titolo di “duca del Manganello”. Quale fosse dopo di allora il suo modo di vita a Roma, ne dà un’idea l’episodio raccontatomi da Vincenzo Torraca.
Un giorno, i suoi amici seppero che Caffi non aveva un domicilio e che, con la complicità di un guardiano, passava le notti su un giaciglio improvvisato nei locali della Biblioteca Vittorio Emanuele. Si provvide subito a trovargli un alloggio meno aleatorio. Per qualche tempo, parve che egli avesse consentito ad avere una dimora convenzionale. Ma dopo un po’ si seppe che dormiva di nuovo fra i libri. È un piccolo esempio di quanto fosse inutile cercare di persuadere Caffi ad avere un’esistenza “normale”.
A Roma, legato com’era all’ambiente intellettuale antifascista, e particolarmente a uomini come Umberto Zanotti-Bianco, Gaetano Salvemini, Emilio Lussu, Giuseppe Fancello, Umberto Morra, Vincenzo Torraca, partecipò alle vicissitudini della crisi Matteotti e dell’Aventino, con ciò che seguì. Collaborò con articoli politici a Volontà di Roberto Marvasi e al Quarto Stato di Pietro Nenni e Carlo Rosselli. Al tempo stesso, ebbe rapporti di cordiale, reciproca stima con Ernesto Buonaiuti e scrisse un articolo per la sua rivista Ricerche religiose. Risale a quegli anni l’amicizia con Alberto Moravia, allora giovanissimo e sconosciuto.
A titolo d’azione antifascista, tentò d’impiantare a Roma i metodi di cospirazione che aveva praticato in Russia. Frequentava perciò gli operai del vecchio quartiere dietro piazza Venezia, poi demolito per far largo a Via dell’Impero. In quell’ambiente, faceva propaganda sovversiva a suo modo, parlando della Russia e del socialismo, ma anche di storia e letteratura greca, senza cercar mai di far proseliti per una determinata parte politica o di farsi campione di un’ideologia particolare.
Per questa specie di attività sovversiva, nel 1926 fu minacciato d’arresto. Avvertito in tempo, partì per la Francia, dove fu per tre anni, a Versailles, precettore dei figli del principe Caetani, nonché segretario di redazione di Commerce, la rivista letteraria internazionale fondata da Margherita Caetani per suggerimento di Paul Valéry.
Stabilitosi nel 1929 a Parigi, in un albergo del quartiere della Convention dove aveva abitato anche prima della guerra, cominciò per Caffi un’esistenza molto diversa da quella che egli aveva condotto fino ad allora. Non che mutasse il suo stile di vita, ma venne, fra l’altro, a mancargli il modo di continuare l’esistenza errante e spensierata che aveva condotto da giovane.
Ma il passaggio dalla vita nomade a quella sedentaria non era che l’aspetto esteriore di un mutamento più profondo, indotto dall’esperienza della guerra e della rivoluzione russa.
Il 2 agosto 1914, come Caffi ripeteva ogni volta che ne aveva occasione, aveva segnato per lui non solo la fine della gioventù, ma il crollo di tutto un mondo d’idee e di speranze. Dopo la guerra, e dopo i tentativi che fece, insieme a qualche “uomo di buona volontà”, per rendersi utile alla causa di un’Europa più giusta, si formò in lui la convinzione che le nazioni europee erano ormai avviate sulla strada di crisi sempre più radicali che rendevano futile ogni idea di “restaurazione” della democrazia e del socialismo quali li si era concepiti prima del 1914. Tali crisi investivano naturalmente anche i “valori culturali” e il posto che essi avevano avuto nella società all’inizio del secolo. L’esito della rivoluzione russa, il sorgere del fascismo e delle altre specie di regimi autoritari confermavano questa convinzione, come la confermavano d’altra parte le tendenze che si manifestavano nel campo della cultura.
Non si trattava, come sarebbe troppo facile interpretare, di “disillusione” o di “pessimismo”, bensì di un rivolgimento profondo il quale sboccò nella convinzione ragionata che fra il culto dei veri valori umani e la società qual era, e ancor più quale si avviava a essere, non sussisteva alcuna possibilità di compromesso: la cultura, intesa come asserzione intransigente dei valori di verità e di giustizia, diventava un culto segreto, praticabile soltanto in piccoli gruppi eretici.
Ma, naturalmente, il principio di una tale convinzione era già nella personalità di Caffi giovane. Ciò si trova indicato con sufficiente chiarezza in una lettera cui il destinatario, Giuseppe Prezzolini, pubblicandola nel già citato volume Testimonianze, assegna la data probabile del novembre 1913. Parlando della sorte di «coloro che nell’epoca nostra seriamente “vogliono volere” e sentono il bisogno di soluzioni nuove senza però essere in grado di precisare concretamente questa “nuova terra” verso la quale navighiamo», a un certo punto Caffi così scrive di se stesso: «Sento un isolamento morale forse più grave di ogni altro, oggi come oggi ho la certezza assoluta che nessuno di quelli che conosco vorrebbe prendermi a collaboratore, diventarmi compagno di ricerche. Non è perché presuntuosamente io creda di arrampicarmi su vette più difficili degli altri. È semplicemente il gioco delle combinazioni create dall’esistenza fatta finora da me: non posso entrare in un campo perché ne conosco altri che con questo non hanno né avranno mai punti di contatto. E la sintesi può interessare, appassionare, imporsi come indispensabile a me solo. Le assicuro che niente è così amaro come la coscienza di un “residuo” incomunicabile nei propri sentimenti, nei propri pensieri ogni volta che si avvicina con simpatia, con grande desiderio d’intendersi, uno che combatte in fin dei conti per la stessa mèta: la liberazione spirituale degli uomini, il rinnovamento della nostra civiltà tutta […]».
In queste righe è già delineata la disposizione d’animo che dopo la guerra doveva portare Caffi alla decisione di appartarsi dal “secolo”, senza tuttavia separarsene. Cessando di essere nomade, la sua esistenza personale divenne quella di un “eremita socievole”. La porta della sua stanza, nell’hotel meublé dove abitava, rimaneva sempre aperta, all’uso russo, a chiunque venisse a fargli visita e a conversare; ed egli accoglieva tutti come se il suo tempo fosse a loro disposizione; i soli sui quali cadeva un pesante silenzio oppure, anche peggio, un seguito di monosillabiche imbarazzate risposte, erano le persone “importanti” che venivano talvolta a intervistarlo o, come lui diceva, a tentare di “ripescarlo” per riportarlo nella vita normale.
La sua vita, cioè la sua attività giornaliera, rimase sempre più fermamente dedicata alla causa che nella lettera a Prezzolini indicava con parole ingenue e fiere insieme: la liberazione spirituale degli uomini e il rinnovamento della nostra civiltà. La sua solitudine era decisione di non avere altra società che quella da lui scelta: non aveva niente di ascetico, esprimeva semplicemente la libertà di una natura incapace di adattarsi alle ragioni del mondo e risoluta a rimaner fedele al non serviam pronunciato in gioventù. In sostanza, quella di Andrea Caffi era la vita di un “filosofo” nel senso antico della parola: di un uomo, cioè, unicamente devoto alla ricerca del vero e del giusto e convinto che tale ricerca diventava un affare equivoco non appena vi si mescolassero preoccupazioni di successo mondano o di carriera.
A Parigi, dopo il 1929, egli visse di traduzioni e di lavori da “negro”; e so, a questo proposito, di più di un personaggio eminente che deve a lui i suoi successi accademici o letterari. Pochi erano infatti quelli che, come Gaetano Salvemini, riconoscevano apertamente il contributo dato da Caffi alle loro ricerche. I più lo consideravano uno scombinato fornito di grande cultura al quale essi, dietro compenso, davano almeno l’occasione di far uso delle sue conoscenze. Si tendeva, anzi, a ignorare, o addirittura a disconoscere, ciò che gli si doveva tanto più quanto più gli si doveva: ad appropriarsi, cioè, puramente e semplicemente delle sue idee per farne quel qualsiasi uso che conveniva. Né egli era uomo da accettare per un solo momento il concetto che esistesse qualcosa come la proprietà privata delle cose dell’intelletto.
Visse così in una povertà che troppo spesso era miseria. Una miseria prodiga e sdegnosa del sia pur minimo calcolo. Come preferiva non mangiare piuttosto che sedersi a una di quelle mense a prezzo fisso delle quali noi suoi amici eravamo clienti non troppo difficili, così per lui il cosiddetto superfluo veniva sempre prima del necessario, e i primi acquisti, quando aveva qualche franco in tasca, erano di saponi, dentifrici e acqua di Colonia. Né d’altra parte esitava un momento a vuotarsi letteralmente le tasche se s’imbatteva in qualcuno che avesse comunque bisogno d’aiuto. Vivergli vicino era una gran lezione di generosità e di nobiltà.
Povero com’era, egli aveva d’altronde in sé una ricchezza inesauribile: la capacità del dono di sé nell’amicizia. Il dono era, a dir vero, la sola forma di commercio umano che per parte sua egli riconoscesse e praticasse. Non c’è nessuno, fra quelli che gli sono stati amici, o anche che lo han conosciuto un po’ da vicino, che non abbia ricevuto da lui infinitamente più di quello che abbia potuto dargli. Ciò valse, a lui solitario e misconosciuto, di essere sempre attorniato da amici tanto più devoti e ammirati quanto più erano giovani. Ad essi, egli offriva senza risparmio i doni di una mente che (contrariamente al precetto dantesco), non stava mai contenta al quia, di un animo delicatissimo e, soprattutto, l’esempio di che cosa volesse dire vivere come un uomo libero in un mondo, come quello contemporaneo, servo dell’utile, del successo e della forza.
A Parigi, fino al 1935, Caffi fu collaboratore dei Quaderni e del settimanale di Giustizia e Libertà. Dei suoi rapporti con Carlo Rosselli e col suo gruppo si trova ampia notizia nella Vita di Carlo Rosselli di Aldo Garosci.
Molto ci sarebbe da notare sull’argomento. Ma la sede più adatta a questo sarà il volume degli scritti politici di Caffi, che dovrebbe seguire a poca distanza la pubblicazione della presente raccolta. Qui basti dire che la collaborazione di Caffi ai Quaderni e al settimanale di Giustizia e Libertà fu dovuta alla simpatia per quel gruppo, che gli parve il più vivace e spregiudicato dell’emigrazione antifascista, e non a un’adesione politica che del resto non gli fu mai chiesta. Quanto alle critiche che egli contemporaneamente non risparmiava alle idee e ai criteri ispiratori del “movimento”, esse erano dovute al desiderio che l’antifascismo italiano, almeno nella sua parte più giovane e intellettualmente più avvertita, si sollevasse dal terreno della polemica spicciola e della propaganda antimussoliniana per attingere al livello di movimento europeo e contribuire in modo positivo al rinnovamento della tradizione socialista e libertaria.
Fra i fuorusciti italiani, oltre che con Carlo Rosselli e i suoi compagni, Caffi ebbe rapporti di amicizia e di collaborazione con Salvemini, Tasca, Lussu, Saragat, Giuseppe Faravelli, G.E. Modigliani; senza dimenticare il vecchio sindacalista di Parma Giovanni Faraboli, che egli conobbe a Toulouse nel 1940 e aiutò a tenere in piedi un’impresa di solidarietà e mutua assistenza fra gli operai italiani emigrati della regione. Sia lecito infine ricordare, fra i suoi più giovani amici di allora, oltre il sottoscritto, Mario Levi e Renzo Giua, quest’ultimo caduto in Spagna nel 1937.
Ma, come si è già accennato, la cerchia delle amicizie di Caffi era singolarmente larga e diversa. Partecipò assiduamente alla vita di molti gruppi d’emigrati russi, fra i quali aveva amici particolarmente cari. Fu attivo in vari ambienti politici e intellettuali francesi, essendo molto vicino, fra gli altri, a Paul Langevin, il fisico illustre.
A Toulouse, Caffi rimase dal luglio 1940 al febbraio 1948. Nel periodo dell’occupazione tedesca prese parte all’attività di gruppi di resistenza sia italiani che spagnoli e francesi. Per questo, nel 1944, fu imprigionato.
Tornato a Parigi, non mancò di attirarsi nuovi amici. Fra questi fu Albert Camus, il quale, pensando che un tale lavoro avrebbe potuto aprirgli la strada verso mansioni meno modeste, gli procurò un lavoro di lettore presso Gallimard. Infatti, le schede di lettura da lui compilate attirarono subito l’attenzione. Ma il gradimento dei letterati non era stimolo che potesse vincere la ritrosia di Caffi; ed era d’altra parte impensabile, per chi lo conosceva, che egli potesse fare un passo qualsiasi, avvicinare una persona o scrivere una riga, per un motivo d’utilità personale.
Con l’avanzare degli anni, la sua vita rimase quella che era sempre stata: povera e prodiga. Nel frattempo, gli stenti e i disagi in cui aveva vissuto da anni, e che erano stati particolarmente duri negli anni della guerra, cominciarono a mostrare i loro effetti sulla sua costituzione fisica, che pure era molto vigorosa. Fra il 1954 e il 1955 la sua salute declinò rapidamente. Colpito da un male che probabilmente lo minava da tempo, mori il 22 luglio 1955 all’ospedale della Salpétrière. Le sue ceneri sono deposte al cimitero del PéreLachaise.
Scritti di Andrea Caffi sono sparsi in riviste e giornali italiani, russi e americani. Nelle biblioteche italiane si trova un volume di Paolo Orsi, Le chiese basiliane della Calabria, pubblicato da Vallecchi, a Firenze, nel 1929, con una lunga appendice storica di Caffi intitolata Santi e guerrieri di Bisanzio nell’Italia meridionale. Nell’Enciclopedia Italiana, alcuni articoli di storia bizantina sono suoi. In questo campo, infatti, le sue conoscenze erano particolarmente sicure e profonde. Si era laureato con una tesi di storia bizantina e da allora lo studio della civiltà bizantina, legato a un più vasto interesse per la storia dell’ellenismo, era rimasto la sua passione particolare. Ma, come si è detto, la sua cultura era enciclopedica nel senso più forte della parola: talmente vasta da dar l’impressione di essere propriamente sconfinata, essa rimaneva mirabilmente precisa su ogni punto. C’era, in questo, qualcosa come la luce di un dono incomparabile.
È nello scambio amichevole d’idee, oltre che nell’esempio di libertà e di disinteresse che offriva giorno per giorno la sua esistenza, che Andrea Caffi dava il meglio di sé, irradiando quello “spirito arcangelo” di cui parlava Antonio Banfi. Ciò che di più somigliante, direi, rimane di lui si trova nelle lunghe lettere agli amici e nelle lunghe note che egli usava fare ai loro scritti o per chiarire opinioni espresse conversando.
Quelli ai quali nel presente volume si è data forma di saggi sono dunque propriamente brani e frammenti del bel discorso che fu, considerata dal punto di vista del commercio intellettuale, la sua vita. Sono brani e frammenti estratti dalle lettere e note di lui che chi scrive è riuscito a preservare. Molto, purtroppo, è andato perduto. Tuttavia, non solo si tratta di una minima parte di ciò che a Caffi accadde di scrivere, ma anche di una piccola parte di ciò che è stato conservato. Per non parlare, infatti, di ciò che hanno potuto conservare di lui gli amici russi e francesi, e a parte i manoscritti lasciati alla biblioteca Lenin di Mosca, esistono scritti e documenti di Caffi nell’archivio del Grande Oriente di Francia e in quelli di altre logge massoniche francesi e russe. Come alla causa del socialismo abbracciata in gioventù, egli era infatti rimasto fedele all’ideale massonico, al quale era stato iniziato adolescente in Russia.
Veramente e doppiamente frammenti, dunque, gli scritti che qui si pubblicano. Note e lettere non sono infatti, a loro volta, che brani di quella lunga lezione d’umanità che fu per il sottoscritto l’amicizia con Andrea Caffi.
Troverà il lettore in questi brani quel “principio filosofico” o quella “idea centrale” che, dopo averne letto alcuni nella rivista Tempo presente (dove la massima parte di essi è stata pubblicata) Giuseppe Prezzolini non ci ha trovato, e ha tenuto a dirlo in un articolo dedicato a Caffi e intitolato Uno strano tipo, che si può leggere nel Tempo di Roma del 5 agosto 1959?
In un certo senso è da sperare che no, che non li trovi, questo “principio filosofico” e questa “idea centrale”. Giacché nulla era più contrario al modo di vedere di Caffi dell’idea che il sapere e l’esperienza dell’uomo potessero o dovessero organizzarsi secondo un principio unico. Si potrebbe anzi dire che tutti i suoi discorsi tendevano a minare nell’interlocutore ogni certezza, o presunzione, di questo tipo; e la ragione principale, forse, per cui un uomo così straordinariamente dotato e erudito non produsse l’opera che pure avrebbe certamente potuto lasciare è la diffidenza per ogni “idea centrale” e per ogni “principio filosofico” applicabile per via di deduzione ai fatti umani. Tale diffidenza andava unita a una grande ambizione di ritrovare nel tessuto vivo della storia delle costanti secondo cui i fatti potessero ordinarsi senza nulla perdere della loro individualità. Ma lo scetticismo non perdeva i suoi diritti quando si trattava delle sue proprie idee. Molte volte gli capitava di accennare alla possibilità che, per esempio, i grandi sistemi di pensiero fossero apparsi nella storia a un ritmo determinato, o che un ritmo analogo si potesse scoprire nella durata dei grandi imperi. Ma si fermava subito, trattando simili speculazioni come dei giochi, e rimanendo sempre altrettanto guardingo nelle affermazioni quanto era preciso e sottile nella critica.
Si può dunque dire che la conoscenza storica gli serviva allo scopo eminentemente socratico di mostrare quanto poco sapessero in realtà gli storici e gli storiografi che avanzavano (come gli hegeliani e i neohegeliani) tesi categoriche sull’“idea” che ispirava questo o quel periodo della storia umana, sui parallelismi “morfologici” fra civiltà diverse e non comunicanti (come Spengler), ovvero (come Toynbee) sulle leggi che regolano la genesi, la crescita e la morte delle civiltà.
A tali “idee centrali”, Caffi rispondeva in un solo metodico modo: adducendo i singoli inconfutabili fatti che tagliavan loro, per dir così, l’erba sotto i piedi. Ma poiché consisteva nel rammentare tutto ciò che, in un dato evento o seguito di eventi, sfuggiva al particolare tentativo d’“inquadramento” di cui si trattava, la dimostrazione assumeva naturalmente un carattere positivo. Sicché, come dall’interrogazione socratica, così dalla critica di Caffi finiva per sprigionarsi la luce di una rivelazione: quella del fatto stesso nella sua vivezza e libertà, scevro delle sovrastrutture di cui volevano ricoprirlo i pregiudizi di chiesa, di setta o d’accademia.
Questo era il dono che si riceveva continuamente da Caffi: la visione del fenomeno “salvo” dai rigori della presunzione intellettuale e del dogmatismo. Se non bastava a fondare una filosofia della storia, l’esperienza ripetuta di una tale visione finiva per costituire qualcosa di più prezioso: il sentimento di ciò che vi è di sacro nei fatti umani e fa tutt’uno con la loro verità viva o, si potrebbe dire, la loro “essenza”. E tale sentimento era accompagnato dall’impossibilità ormai di dimenticare questa realtà, o comunque farne astrazione.
Giacché l’originalità profonda del pensiero di Andrea Caffi, e la grande lezione in esso implicita, era di concepire l’essenza, la verità viva, la sostanza sacra dei fatti umani come una realtà concreta, non come un’idea astratta, un principio ideologico o un precetto morale.
Tale realtà concreta non era altro che il tessuto intimo dei rapporti sociali. Questo tessuto cominciava secondo Caffi con la facoltà mitopoietica (da lui definita come “quel senso della situazione dell’uomo nell’universo, della persona nella società, della norma di una giustizia imprescrittibile… che unisce e connette come dal profondo i membri di una società, e grazie al quale essi comunicano in una visione armonica del significato dell’esistenza”) per continuarsi e articolarsi nei costumi, nella cultura e in tutte le forme di rapporti che noi chiamiamo “umani” per indicare che sono una conquista dell’uomo sull’informità e la brutalità, maniere non di subire la “natura”, ma di darle un senso e una forma.
Se il lettore di queste pagine non si preoccuperà troppo di sapere in anticipo dove – a quali conclusioni d’ordine generale – lo conduca il discorso di Caffi, è da credere che egli scoprirà presto come esso sia tutto ispirato da una sola e medesima idea e passione: quella di suscitare (o risuscitare) nella nostra epoca di inerzia massiccia e d’indifferenza il sentimento di quella realtà alla quale Aristotele dava il nome di philia, e la metteva a base del legame sociale, che Leopardi chiamava l’“umana compagnia” e che Caffi amava indicare col termine “società”, dando ad esso un significato particolare che egli spiega e esemplifica molto chiaramente.
Che cos’è la “società” di cui è continuamente questione nel discorso di Caffi? «È» egli dice, «l’insieme di quei rapporti umani che si possono definire spontanei e in certo qual modo gratuiti, nel senso che hanno almeno l’apparenza della libertà».
La definizione non potrebb’essere più piana e modesta. Essa tuttavia contiene al tempo stesso un sentimento della storia assai profondo e un ideale d’umanità assai alto. È infatti nel permanere di tali rapporti “che hanno almeno l’apparenza della libertà” attraverso le tormente della storia, nella loro capacità di resistere e sussistere malgrado le violenze, le deformazioni e gli stenti cui le assoggetta la volontà di potenza, nel loro riaffermarsi e dar frutto non appena le circostanze si facciano meno avverse, è in questa alterna e sempre tragica vicenda dell’“umana compagnia”, che Caffi scorgeva l’unico “senso” intelligibile della Storia.
Questo è il tema fondamentale del discorso molto coerente, anche se frammentario, che si svolge in queste pagine sia a proposito del rapporto fra violenza organizzata e ideale socialista o di quello fra Stato, nazione e società, sia che si trattino argomenti in apparenza disparati come il mito, la nozione di borghesia o la situazione della cultura nel mondo attuale.
È un discorso, quello di Caffi, che riflette una piena, pienamente sofferta e quanto mai ricca esperienza delle vicissitudini sia della storia che della cultura europea fra gl’inizi del secolo e i giorni nostri. Esso è anzitutto, per dirla con Montaigne, un discorso di buona fede. Aggiungerò che io, per parte mia, non ne conosco di più “attuale”, nel senso che, mentre la sua intenzione profonda è di salvare ciò che ha di prezioso la tradizione umanistica europea, esso rimane nel contempo interamente proteso verso “il rinnovamento della nostra civiltà tutta”.
È anche un discorso chiaro, e non esige ulteriore chiosa. Domanda soltanto quella disposizione ad ascoltare che non tardava a nascere in quelli che avvicinavano Caffi e che fra i più giovani si mutava subito in desiderio di conoscere il seguito delle sue idee; o forse meglio si direbbe: del suo racconto.
Ho dato a questa raccolta un titolo, Critica della violenza, che, se è ben lontano dall’indicarne la ricchezza, ne esprime però abbastanza bene l’intenzione complessiva. Giacché, in un’epoca in cui non solo legioni d’intellettuali si son gloriati di essere affiliati al partito della violenza, ma si son trovati filosofi per introdurre la violenza nella natura stessa del pensiero, Andrea Caffi opponeva alla violenza in ogni sua forma un rifiuto radicale. Quale che ne sia il punto di partenza, si può ben dire che il suo discorso è sempre diretto a opporre le ragioni dell’uomo all’urgenza delle forze che lo assillano, e talvolta lo sopraffanno.



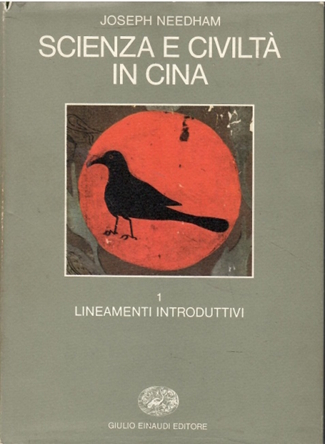













 Arrivava all’improvviso,
Arrivava all’improvviso,



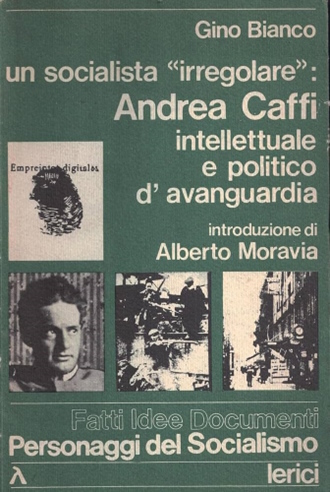



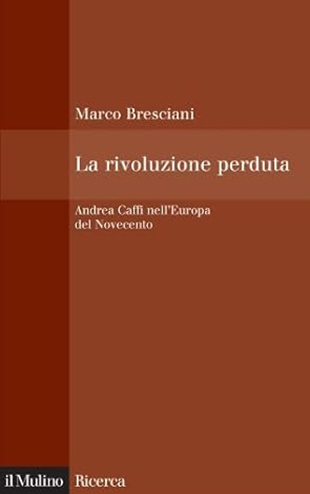












 Ordinare è un lemma dai molteplici significati, tutti assimilabili, tutti connessi alla stessa radice, sia pure a diversi gradi di parentela
Ordinare è un lemma dai molteplici significati, tutti assimilabili, tutti connessi alla stessa radice, sia pure a diversi gradi di parentela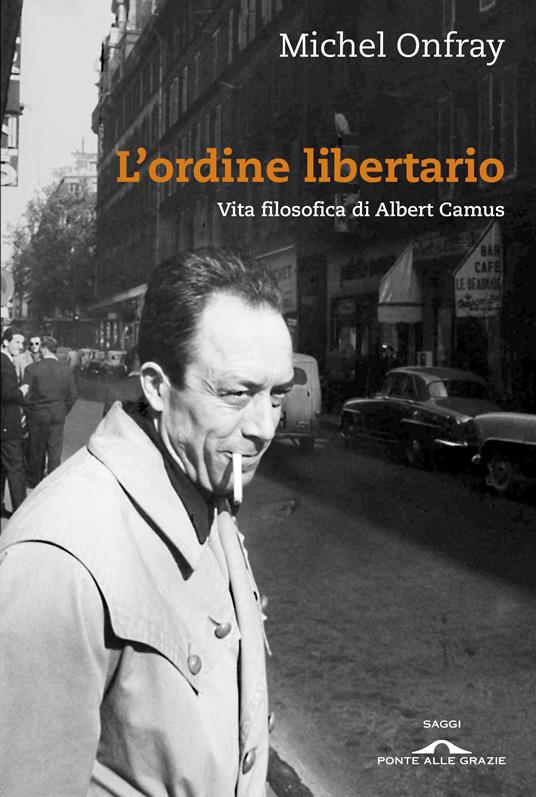 L’apparente chiasmo racchiuso in L’ordine libertario sintetizza, come dicevo, la mia concezione del mondo, degli uomini e dei loro rapporti coi loro simili e col mondo stesso. Quella ideale, naturalmente, di come questi rapporti dovrebbero essere, che non si oppone però alla consapevolezza di come le cose funzionino nella realtà. Non sono ancora così psichicamente turbato da credere in una reale possibilità di riordino del mondo, e da volerla. Ma penso sia importante, ai fini delle nostre scelte e del nostro agire, avere all’orizzonte un traguardo al quale le nostre azioni si ispirino, una direzione nella quale muovere. Sapendo tuttavia che l’orizzonte si sposta in avanti ad ogni passo che fai, e soprattutto che è importante, mentre cammini, tenere sott’occhio il paesaggio circostante e la terra su cui posi i piedi.
L’apparente chiasmo racchiuso in L’ordine libertario sintetizza, come dicevo, la mia concezione del mondo, degli uomini e dei loro rapporti coi loro simili e col mondo stesso. Quella ideale, naturalmente, di come questi rapporti dovrebbero essere, che non si oppone però alla consapevolezza di come le cose funzionino nella realtà. Non sono ancora così psichicamente turbato da credere in una reale possibilità di riordino del mondo, e da volerla. Ma penso sia importante, ai fini delle nostre scelte e del nostro agire, avere all’orizzonte un traguardo al quale le nostre azioni si ispirino, una direzione nella quale muovere. Sapendo tuttavia che l’orizzonte si sposta in avanti ad ogni passo che fai, e soprattutto che è importante, mentre cammini, tenere sott’occhio il paesaggio circostante e la terra su cui posi i piedi.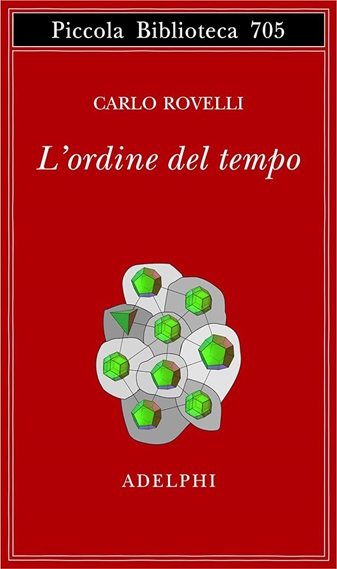 Questo sta accadendo. Rispetto a ciò, se fossi un rivoluzionario, cercherei di cambiare non solo l’ordine e la disposizione dei volumi, ma muterei radicalmente l’approccio coi libri, buttandomi sul supporto digitale. In questo modo guadagnerei, forse, in efficacia e in efficienza, ma perderei tutto quel valore aggiunto che il possesso e il rapporto fisico con il libro cartaceo mi garantisce. Sacrificherei alla praticità uno dei maggiori piaceri che la vita, nella dimensione dell’ordine culturale, può offrire.
Questo sta accadendo. Rispetto a ciò, se fossi un rivoluzionario, cercherei di cambiare non solo l’ordine e la disposizione dei volumi, ma muterei radicalmente l’approccio coi libri, buttandomi sul supporto digitale. In questo modo guadagnerei, forse, in efficacia e in efficienza, ma perderei tutto quel valore aggiunto che il possesso e il rapporto fisico con il libro cartaceo mi garantisce. Sacrificherei alla praticità uno dei maggiori piaceri che la vita, nella dimensione dell’ordine culturale, può offrire. Ma tutto questo, poi, all’atto pratico, in cosa si traduce? Per quanto mi concerne sono convinto che la mia vera attitudine fosse quella del correttore di bozze, o dell’editor, come si usa oggi (sto dicendo sul serio). Alla maniera di Sebastiano Timpanaro. Non “scrivere una storia” (o “la” storia)”, ma aiutarla a scorrere senza troppe frizioni. Sono però anche consapevole che difficilmente avrei potuto svolgere quella mansione, perché tendo ad allargarmi troppo: non mi sarei limitato a emendare i testi, ma avrei anche discusso della loro pertinenza nello specifico, o della loro opportunità in assoluto. Ho trasferito allora la mia coazione a correggere sulle sovrascritture che ciascuno di noi lascia, come traccia del suo passaggio, su quel testo indecifrabile che s’intitola “vita”.
Ma tutto questo, poi, all’atto pratico, in cosa si traduce? Per quanto mi concerne sono convinto che la mia vera attitudine fosse quella del correttore di bozze, o dell’editor, come si usa oggi (sto dicendo sul serio). Alla maniera di Sebastiano Timpanaro. Non “scrivere una storia” (o “la” storia)”, ma aiutarla a scorrere senza troppe frizioni. Sono però anche consapevole che difficilmente avrei potuto svolgere quella mansione, perché tendo ad allargarmi troppo: non mi sarei limitato a emendare i testi, ma avrei anche discusso della loro pertinenza nello specifico, o della loro opportunità in assoluto. Ho trasferito allora la mia coazione a correggere sulle sovrascritture che ciascuno di noi lascia, come traccia del suo passaggio, su quel testo indecifrabile che s’intitola “vita”. Un quasi gemello di Camus, Jean Paul Sartre, prima sodale del nostro e poi rancoroso rivale, ha scritto: “L’Uomo è condannato ad essere libero: condannato perché non si è creato da se stesso, e pur tuttavia libero, perché, una volta gettato nel mondo, è responsabile di tutto ciò che fa”.
Un quasi gemello di Camus, Jean Paul Sartre, prima sodale del nostro e poi rancoroso rivale, ha scritto: “L’Uomo è condannato ad essere libero: condannato perché non si è creato da se stesso, e pur tuttavia libero, perché, una volta gettato nel mondo, è responsabile di tutto ciò che fa”.


 L’albero genealogico dei Viandanti è fittissimo e composito. Risalendo di due secoli (non abbiamo voluto andare oltre, era già abbastanza complicato così) si incontrano un po’ tutte le tipologie e le varietà umane: scrittori, artisti, esploratori, viaggiatori, rivoluzionari, filosofi, storici, fumettisti, ecc…). In un modo o nell’altro coloro che abbiamo rintracciato hanno contribuito a indicare percorsi, a suggerire svolte, a portare ristoro e a orientarci nella nebbia. Non sono gli unici, naturalmente, perché la nostra è una famiglia molto allargata. Potremmo citarne almeno altrettanti, e anzi, quella dei gradi meno prossimi di parentela potrebbe già essere un’idea per una strenna futura.
L’albero genealogico dei Viandanti è fittissimo e composito. Risalendo di due secoli (non abbiamo voluto andare oltre, era già abbastanza complicato così) si incontrano un po’ tutte le tipologie e le varietà umane: scrittori, artisti, esploratori, viaggiatori, rivoluzionari, filosofi, storici, fumettisti, ecc…). In un modo o nell’altro coloro che abbiamo rintracciato hanno contribuito a indicare percorsi, a suggerire svolte, a portare ristoro e a orientarci nella nebbia. Non sono gli unici, naturalmente, perché la nostra è una famiglia molto allargata. Potremmo citarne almeno altrettanti, e anzi, quella dei gradi meno prossimi di parentela potrebbe già essere un’idea per una strenna futura.




 Ho impugnato il fucile per tutta la vita, eppure, il mio popolo è stato distrutto, la mia sposa torturata a morte…
Ho impugnato il fucile per tutta la vita, eppure, il mio popolo è stato distrutto, la mia sposa torturata a morte…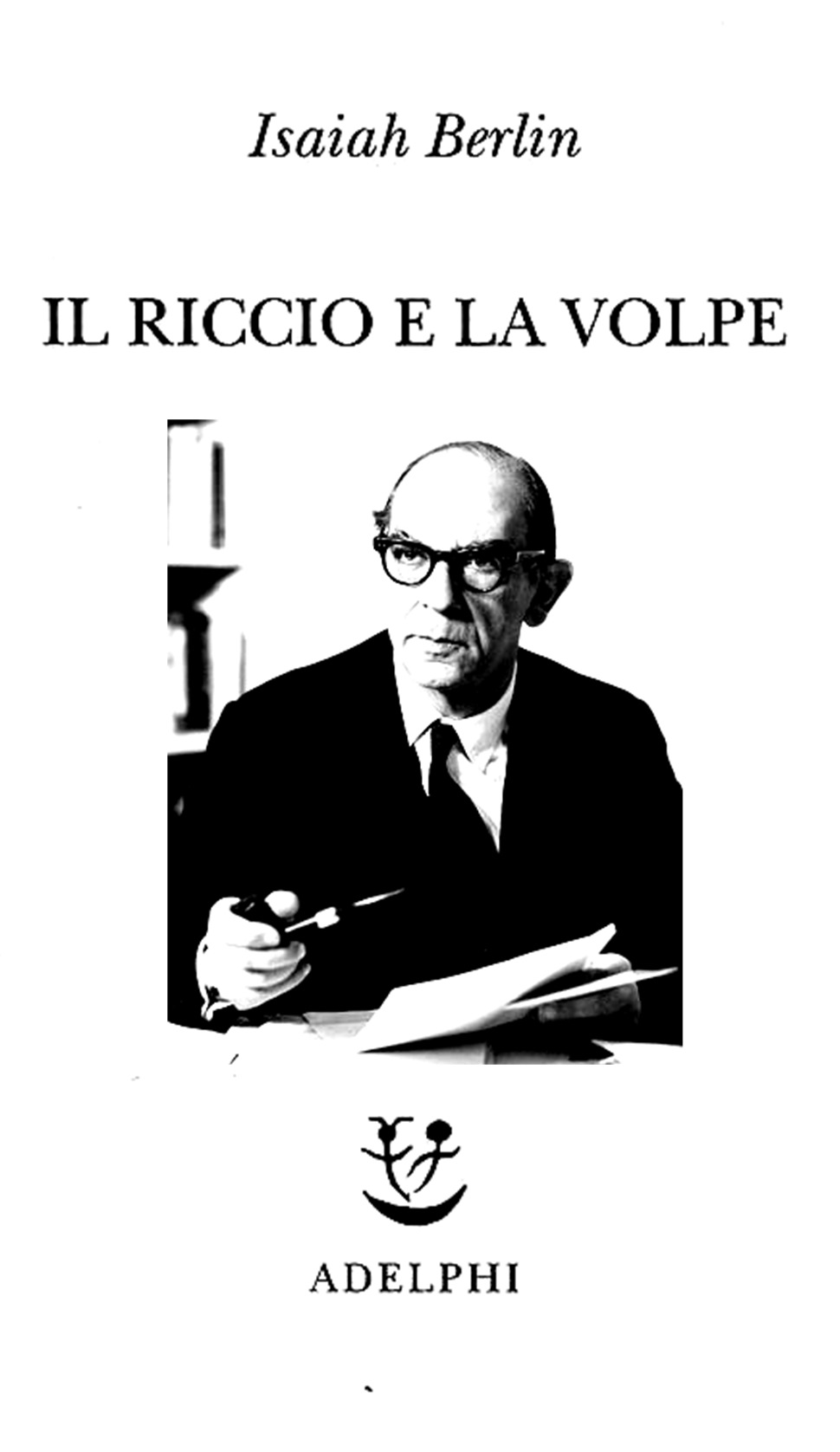 Garantire la libertà ai lupi significa condannare a morte le pecore.
Garantire la libertà ai lupi significa condannare a morte le pecore.
 L’anarchismo è il viandante che va per le vie della Storia, e lotta con gli uomini quali sono e costruisce con le pietre che gli fornisce la sua epoca. Egli si sofferma per adagiarsi all’ombra avvelenata, per dissetarsi alla fontana insidiosa. Egli sa che il destino, che la sua missione è riprendere il cammino, additando alle genti nuove mete.
L’anarchismo è il viandante che va per le vie della Storia, e lotta con gli uomini quali sono e costruisce con le pietre che gli fornisce la sua epoca. Egli si sofferma per adagiarsi all’ombra avvelenata, per dissetarsi alla fontana insidiosa. Egli sa che il destino, che la sua missione è riprendere il cammino, additando alle genti nuove mete.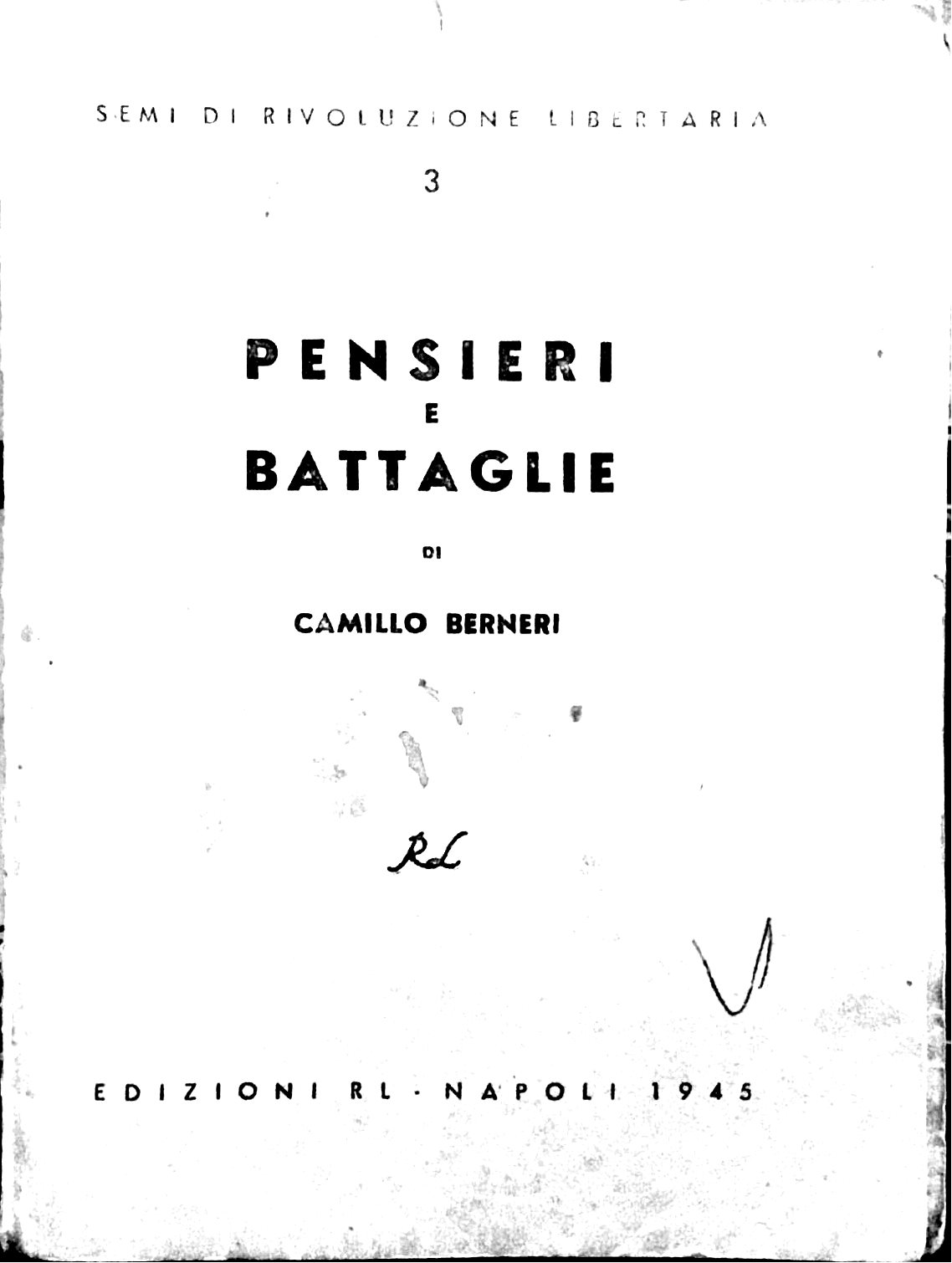
 Questa storia è finita come doveva, con dei vincitori e dei vinti … il mio guaio è che non appartengo né agli uni né agli altri.
Questa storia è finita come doveva, con dei vincitori e dei vinti … il mio guaio è che non appartengo né agli uni né agli altri.
 Perché un pensiero cambi il mondo, bisogna che cambi prima la vita di colui che lo esprime. Bisogna che si cambi in esempio.
Perché un pensiero cambi il mondo, bisogna che cambi prima la vita di colui che lo esprime. Bisogna che si cambi in esempio. Quando giunge l’ora in cui la morte comincia a guardarci negli occhi con una certa continuità, e quindi noi lei, se non vogliamo distogliere lo sguardo e far finta che tutto è come prima e non c’è niente da cambiare, la domanda che per pri-ma ci si articola nella mente è: Che cosa rimane?… Rimane, se rimane, quello che si è, quello che si era: il ricordo d’esser stati “belli”, direbbe Plotino… Rimane, se rimane, la capacità di mantenere che ciò che è bene è bene, ciò che è male è male, e non si può fare che sia diversa-mente (e non si deve fare che appaia diversamente).
Quando giunge l’ora in cui la morte comincia a guardarci negli occhi con una certa continuità, e quindi noi lei, se non vogliamo distogliere lo sguardo e far finta che tutto è come prima e non c’è niente da cambiare, la domanda che per pri-ma ci si articola nella mente è: Che cosa rimane?… Rimane, se rimane, quello che si è, quello che si era: il ricordo d’esser stati “belli”, direbbe Plotino… Rimane, se rimane, la capacità di mantenere che ciò che è bene è bene, ciò che è male è male, e non si può fare che sia diversa-mente (e non si deve fare che appaia diversamente).
 Le auguro due cose che spesso ostacolano il successo esteriore e hanno tutto il diritto di farlo perché sono più importanti: l’amore e la libertà.
Le auguro due cose che spesso ostacolano il successo esteriore e hanno tutto il diritto di farlo perché sono più importanti: l’amore e la libertà.
 Nella lunga storia del genere umano (e anche del genere animale) hanno prevalso coloro che hanno imparato a collaborare ed a improvvisare con più efficacia.
Nella lunga storia del genere umano (e anche del genere animale) hanno prevalso coloro che hanno imparato a collaborare ed a improvvisare con più efficacia.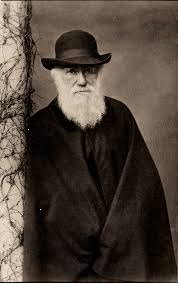
 Tutti sanno che gli animali hanno emozioni e sentimenti, e che prendono decisioni simili alle nostre. Gli unici a fare eccezione, sembrerebbe, sono alcuni universitari.
Tutti sanno che gli animali hanno emozioni e sentimenti, e che prendono decisioni simili alle nostre. Gli unici a fare eccezione, sembrerebbe, sono alcuni universitari. 
 La televisione è puro terrorismo. La parola scompare, e con la parola ogni possibilità di riflessione.
La televisione è puro terrorismo. La parola scompare, e con la parola ogni possibilità di riflessione.
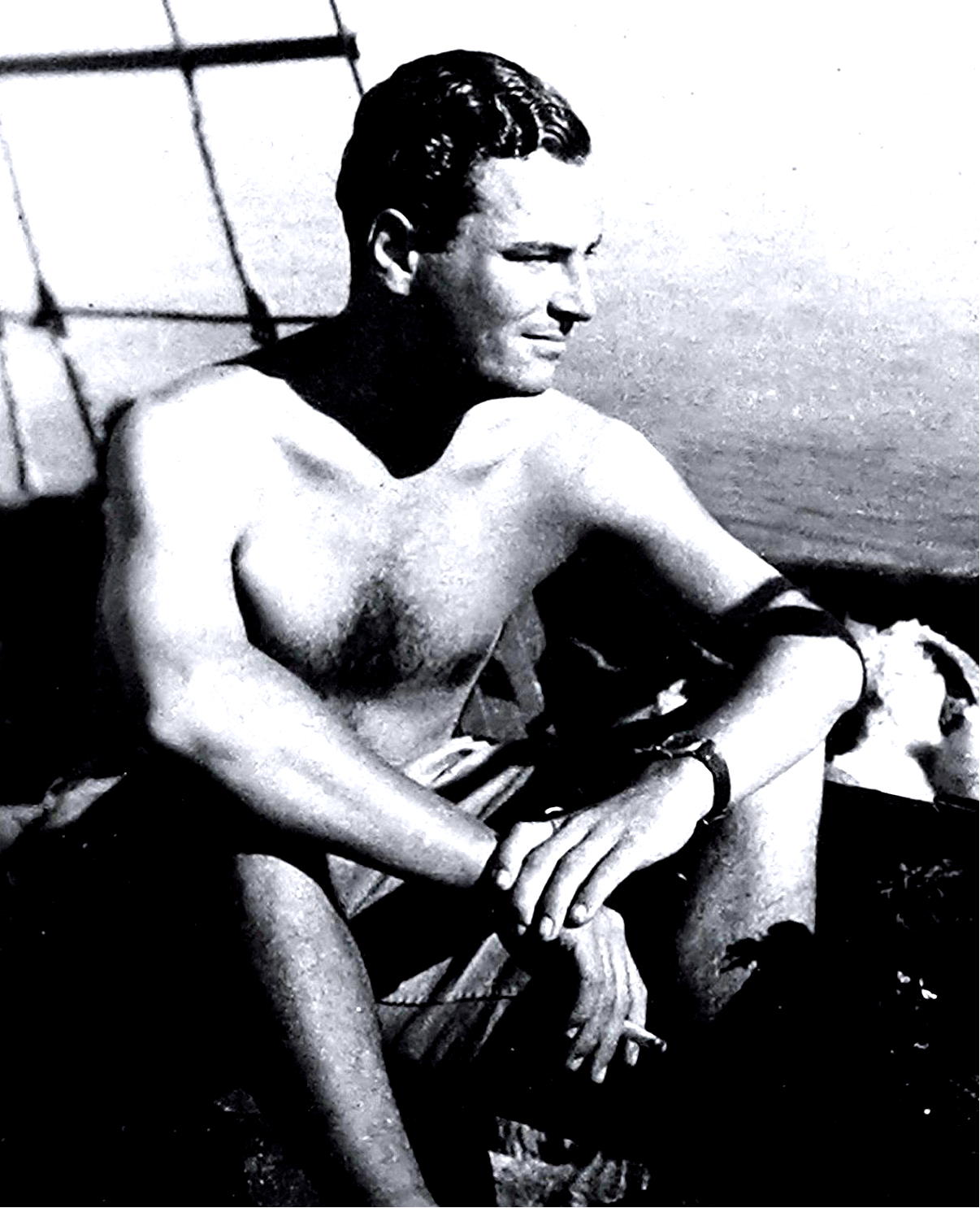 Una magica pace vive nelle rovine dei templi greci. Il viaggiatore si adagia tra i capitelli caduti e lascia passare le ore, e l’incantesimo gli vuota la mente di ansie e pensieri molesti e a poco a poco la riempie di un’estasi tranquilla.
Una magica pace vive nelle rovine dei templi greci. Il viaggiatore si adagia tra i capitelli caduti e lascia passare le ore, e l’incantesimo gli vuota la mente di ansie e pensieri molesti e a poco a poco la riempie di un’estasi tranquilla. Non si parte per andare da nessuna parte senza aver prima di tutto sognato un posto. E viceversa, senza viaggiare prima o poi finiscono tutti i sogni, o si resta bloccati sempre nello stesso sogno.
Non si parte per andare da nessuna parte senza aver prima di tutto sognato un posto. E viceversa, senza viaggiare prima o poi finiscono tutti i sogni, o si resta bloccati sempre nello stesso sogno. L’unica vera sorgente dell’arte è il nostro cuore, il linguaggio di un animo infallibilmente puro. Un’opera che non sia sgorgata da questa sorgente può essere soltanto artificio.
L’unica vera sorgente dell’arte è il nostro cuore, il linguaggio di un animo infallibilmente puro. Un’opera che non sia sgorgata da questa sorgente può essere soltanto artificio. Perché, mi son sovente domandato, scegli sì spesso a oggetto di pittura la morte, la caducità, la tomba? È perché, per vivere in eterno, bisogna spesso abbandonarsi alla morte.
Perché, mi son sovente domandato, scegli sì spesso a oggetto di pittura la morte, la caducità, la tomba? È perché, per vivere in eterno, bisogna spesso abbandonarsi alla morte. Il fascismo è il governo che si merita un’Italia di disoccupati e di parassiti ancora lontana dalle moderne forme di convivenza democratiche e liberali, e che per combatterlo bisogna lavorare per una rivoluzione integrale, dell’economia come delle coscienze.
Il fascismo è il governo che si merita un’Italia di disoccupati e di parassiti ancora lontana dalle moderne forme di convivenza democratiche e liberali, e che per combatterlo bisogna lavorare per una rivoluzione integrale, dell’economia come delle coscienze.
 Quando parlo con un uomo, non ho bisogno di guardarlo per seguire esattamente quello che dice; sento subito se egli mi dà a bere qualche cosa o me ne nasconde qualche altra; la voce, credetemi, è un apparecchio pericoloso
Quando parlo con un uomo, non ho bisogno di guardarlo per seguire esattamente quello che dice; sento subito se egli mi dà a bere qualche cosa o me ne nasconde qualche altra; la voce, credetemi, è un apparecchio pericoloso
 Provo un sentimento d’amicizia verso i maiali in generale, e li considero tra le bestie più intelligenti. Mi piacciono il temperamento e l’atteggiamento del maiale verso le altre creature, soprattutto l’uomo. Non è sospettoso o timidamente sottomesso, come i cavalli, i bovini e le pecore; né impudente e strafottente come la capra; non è ostile come l’oca, né condiscendente come il gatto; e neppure un parassita adulatorio come il cane. Il maiale ci osserva da una posizione totalmente diversa, una specie di punto di vista democratico,
Provo un sentimento d’amicizia verso i maiali in generale, e li considero tra le bestie più intelligenti. Mi piacciono il temperamento e l’atteggiamento del maiale verso le altre creature, soprattutto l’uomo. Non è sospettoso o timidamente sottomesso, come i cavalli, i bovini e le pecore; né impudente e strafottente come la capra; non è ostile come l’oca, né condiscendente come il gatto; e neppure un parassita adulatorio come il cane. Il maiale ci osserva da una posizione totalmente diversa, una specie di punto di vista democratico,
 Ci sono popoli più acculturati, avanzati e nobilitati dall’educazione di altri, ma non esistono razze più valide di altre, perché sono tutte egualmente destinate alla libertà.
Ci sono popoli più acculturati, avanzati e nobilitati dall’educazione di altri, ma non esistono razze più valide di altre, perché sono tutte egualmente destinate alla libertà.
 L’evoluzione non è lenta e uniforme come si vuol sostenere. Evoluzione e rivoluzione si alternano, e le rivoluzioni – i periodi cioè di evoluzione accelerata – appartengono all’unità della natura esattamente come i periodi in cui l’evoluzione è più lenta.
L’evoluzione non è lenta e uniforme come si vuol sostenere. Evoluzione e rivoluzione si alternano, e le rivoluzioni – i periodi cioè di evoluzione accelerata – appartengono all’unità della natura esattamente come i periodi in cui l’evoluzione è più lenta.
 La cultura in cui prevale una religione della morte o anche una religione dei morti esemplari. La cultura in cui si dichiara che esistono valori non discutibili, indicati da parole con l’iniziale maiuscola, innanzitutto Tradizione e Cultura ma anche Giustizia, Libertà, Rivoluzione. Una cultura insomma fatta di autorità e sicurezza mitologica circa le norme del sapere, dell’insegnare, del comandare e dell’obbedire. La maggior parte del patrimonio culturale, anche di chi oggi non vuole essere affatto di destra, è residuo culturale di destra.
La cultura in cui prevale una religione della morte o anche una religione dei morti esemplari. La cultura in cui si dichiara che esistono valori non discutibili, indicati da parole con l’iniziale maiuscola, innanzitutto Tradizione e Cultura ma anche Giustizia, Libertà, Rivoluzione. Una cultura insomma fatta di autorità e sicurezza mitologica circa le norme del sapere, dell’insegnare, del comandare e dell’obbedire. La maggior parte del patrimonio culturale, anche di chi oggi non vuole essere affatto di destra, è residuo culturale di destra.
 Il problema è che i socialisti hanno sempre nutrito una fiducia incondizionata nella razionalità degli uomini.
Il problema è che i socialisti hanno sempre nutrito una fiducia incondizionata nella razionalità degli uomini.
 Lo Stato non è qualcosa che si può distruggere con una rivoluzione, dato che esso esprime una condizione, una certa relazione tra gli esseri umani, una modalità del comportamento umano; lo possiamo distruggere solo contraendo altri tipi di relazioni, assumendo altri tipi di comportamento.
Lo Stato non è qualcosa che si può distruggere con una rivoluzione, dato che esso esprime una condizione, una certa relazione tra gli esseri umani, una modalità del comportamento umano; lo possiamo distruggere solo contraendo altri tipi di relazioni, assumendo altri tipi di comportamento. Passeggere: Quella vita ch’è una cosa bella, non è la vita che si conosce, ma quella che non si conosce; non la vita passata, ma la futura. Coll’anno nuovo, il caso incomincerà a trattar bene voi e me e tutti gli altri, e si principierà la vita felice. Non è vero?
Passeggere: Quella vita ch’è una cosa bella, non è la vita che si conosce, ma quella che non si conosce; non la vita passata, ma la futura. Coll’anno nuovo, il caso incomincerà a trattar bene voi e me e tutti gli altri, e si principierà la vita felice. Non è vero?
 Perché la memoria del male non riesce a cambiare l’umanità? A che serve la memoria?”
Perché la memoria del male non riesce a cambiare l’umanità? A che serve la memoria?”
 Non era della loro tribù, non poteva parlare il loro gergo, non poteva far finta di essere come loro. La maschera sarebbe stata scoperta e, per altro, le mascherate erano estranee alla sua natura.
Non era della loro tribù, non poteva parlare il loro gergo, non poteva far finta di essere come loro. La maschera sarebbe stata scoperta e, per altro, le mascherate erano estranee alla sua natura.
 Noi non possiamo vivere soltanto per noi stessi. Le nostre vite sono connesse da un migliaio di fili invisibili, e lungo queste fibre sensibili, corrono le nostre azioni come cause e ritornano a noi come risultati.
Noi non possiamo vivere soltanto per noi stessi. Le nostre vite sono connesse da un migliaio di fili invisibili, e lungo queste fibre sensibili, corrono le nostre azioni come cause e ritornano a noi come risultati. 

 La via più difficile alle cime più difficili è sempre la cosa giusta da tentare, mentre i pendii di sgradevole pietrisco vanno lasciati agli scienziati. Il Grépon merita di essere salito perché da nessuna altra parte l’alpinista troverà torrioni più arditi, fessure più selvagge, precipizi più spaventosi.
La via più difficile alle cime più difficili è sempre la cosa giusta da tentare, mentre i pendii di sgradevole pietrisco vanno lasciati agli scienziati. Il Grépon merita di essere salito perché da nessuna altra parte l’alpinista troverà torrioni più arditi, fessure più selvagge, precipizi più spaventosi. Sapere dove andare e sapere come andarci sono due processi mentali diversi, che molto raramente si combinano nella stessa persona. I pensatori della politica si dividono generalmente in due categorie: gli utopisti con la testa fra le nuvole, e i realisti con i piedi nel fango.
Sapere dove andare e sapere come andarci sono due processi mentali diversi, che molto raramente si combinano nella stessa persona. I pensatori della politica si dividono generalmente in due categorie: gli utopisti con la testa fra le nuvole, e i realisti con i piedi nel fango.
 Quelli che sognano ad occhi aperti sono pericolosi, perché non si rendono conto di quando i sogni finiscono.
Quelli che sognano ad occhi aperti sono pericolosi, perché non si rendono conto di quando i sogni finiscono.
 L’Anarchia è la più alta espressione dell’ordine.
L’Anarchia è la più alta espressione dell’ordine. 
 I ricordi sono come il vino che decanta dentro la bottiglia: rimangono limpidi e il torbido resta sul fondo. Non bisogna agitarla, la bottiglia.
I ricordi sono come il vino che decanta dentro la bottiglia: rimangono limpidi e il torbido resta sul fondo. Non bisogna agitarla, la bottiglia.  Domando tante volte alla gente: avete mai assistito a un’alba sulle montagne? Salire la montagna quando è ancora buio e aspettare il sorgere del sole. È uno spettacolo che nessun altro mezzo creato dall’uomo vi può dare, questo spettacolo della natura.
Domando tante volte alla gente: avete mai assistito a un’alba sulle montagne? Salire la montagna quando è ancora buio e aspettare il sorgere del sole. È uno spettacolo che nessun altro mezzo creato dall’uomo vi può dare, questo spettacolo della natura.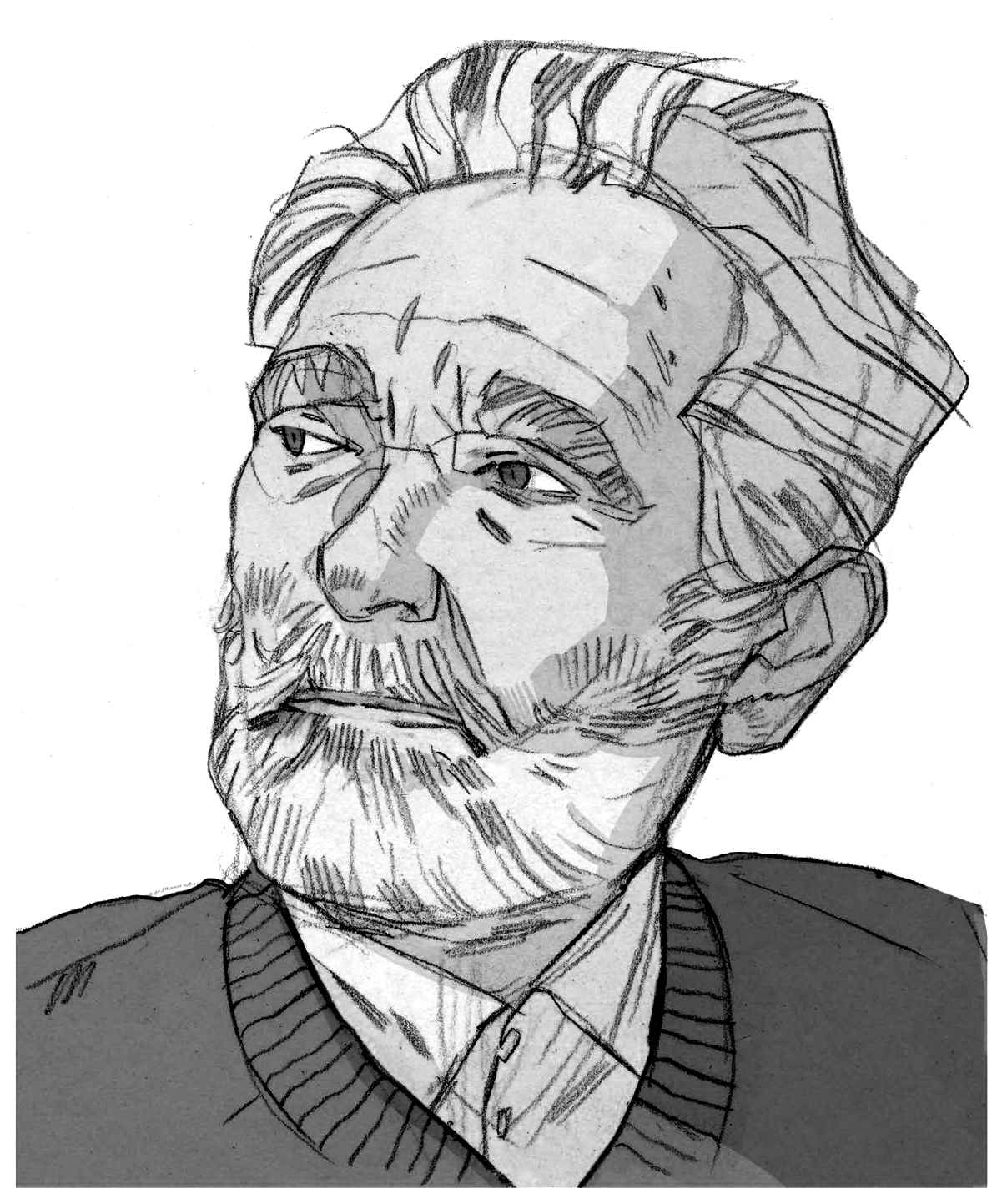 Il tempo, nella vita di un uomo, non si misura con il calendario ma con i fatti che accadono; come la strada che si percorre non è segnata dal contachilometri ma dalla difficoltà del percorso.
Il tempo, nella vita di un uomo, non si misura con il calendario ma con i fatti che accadono; come la strada che si percorre non è segnata dal contachilometri ma dalla difficoltà del percorso. Mio caro Mandibola – diceva quasi sempre Farandola terminando – abbandono definitivamente ogni idea di riforma sociale, e mi lancio con tutte le vele spiegate, nella più vasta industria. Gli affari, il commercio, ecco ciò che mi occorre; e dal momento che le grandi imprese sono necessarie alla mia salute, avanti con le gigantesche speculazioni commerciali!
Mio caro Mandibola – diceva quasi sempre Farandola terminando – abbandono definitivamente ogni idea di riforma sociale, e mi lancio con tutte le vele spiegate, nella più vasta industria. Gli affari, il commercio, ecco ciò che mi occorre; e dal momento che le grandi imprese sono necessarie alla mia salute, avanti con le gigantesche speculazioni commerciali! 
 Io sono una specie di paranoico alla rovescia. Sospetto le persone di complottare per rendermi felice.
Io sono una specie di paranoico alla rovescia. Sospetto le persone di complottare per rendermi felice. La più spiccata differenza tra la felicità e la gioia è che la felicità è un solido e la gioia è un liquido.
La più spiccata differenza tra la felicità e la gioia è che la felicità è un solido e la gioia è un liquido. Se potessi promettere qualcosa
Se potessi promettere qualcosa
 Il mondo è una sintesi delle nostre sensazioni, delle nostre percezioni e dei nostri ricordi. È comodo pensare che esista obiettivamente, di per sé. Ma la sua semplice esistenza non basterebbe, comunque, a spiegare il fatto che esso ci appare.
Il mondo è una sintesi delle nostre sensazioni, delle nostre percezioni e dei nostri ricordi. È comodo pensare che esista obiettivamente, di per sé. Ma la sua semplice esistenza non basterebbe, comunque, a spiegare il fatto che esso ci appare.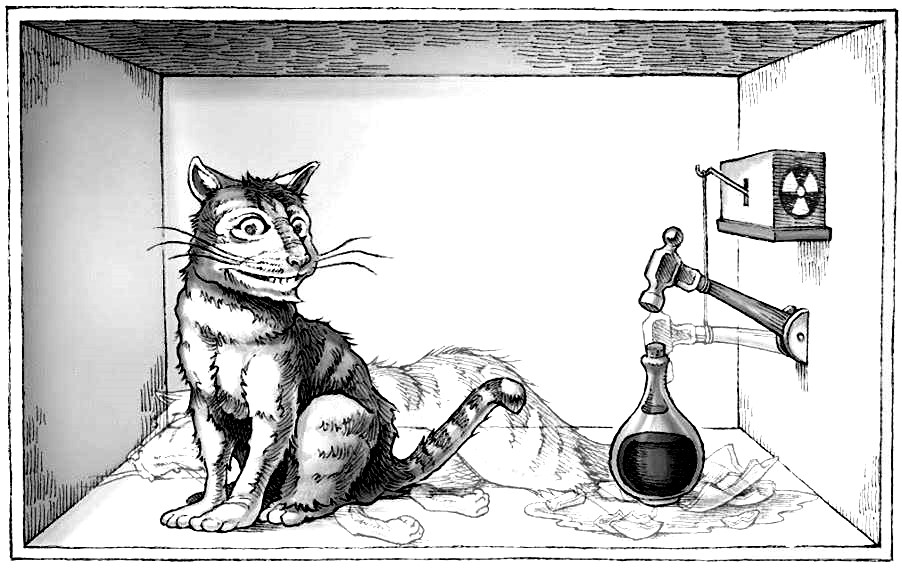
 Camminare è l’attività più libera e indipendente, niente vi è di peggio che star seduti troppo a lungo in una scatola chiusa.
Camminare è l’attività più libera e indipendente, niente vi è di peggio che star seduti troppo a lungo in una scatola chiusa. 

 Tutta la metafisica è un ramo della letteratura fantastica.
Tutta la metafisica è un ramo della letteratura fantastica.
 Non chiedo ricchezze, né speranze, né amore, né un amico che mi comprenda; tutto quello che chiedo è il cielo sopra di me e una strada ai miei piedi.
Non chiedo ricchezze, né speranze, né amore, né un amico che mi comprenda; tutto quello che chiedo è il cielo sopra di me e una strada ai miei piedi.
 Non c’è valore nella vita eccetto ciò che scegli di mettere in essa e nessuna felicità in nessun posto eccetto ciò che gli apporti tu.
Non c’è valore nella vita eccetto ciò che scegli di mettere in essa e nessuna felicità in nessun posto eccetto ciò che gli apporti tu.
 Scrivere significa svolgere un ragionamento che deve servire a illuminare un problema e a convincere delle intelligenze. Senza esibizioni, senza narcisismi, senza trucchi o effetti speciali. Seguendo la logica e le procedure della ragione, senza gli orpelli della retorica e senza gli appelli alle emozioni. Chi scrive offre al lettore la propria coerenza di ragionamento e lo invita ad analoga coerenza.
Scrivere significa svolgere un ragionamento che deve servire a illuminare un problema e a convincere delle intelligenze. Senza esibizioni, senza narcisismi, senza trucchi o effetti speciali. Seguendo la logica e le procedure della ragione, senza gli orpelli della retorica e senza gli appelli alle emozioni. Chi scrive offre al lettore la propria coerenza di ragionamento e lo invita ad analoga coerenza. Se cerco di immaginarmi il nuovo aspetto che il dispotismo potrà avere nel mondo, vedo una folla innumerevole di uomini eguali, intenti solo a procurarsi piaceri piccoli e volgari, con i quali soddisfare i loro desideri. Al di sopra di essi si eleva un potere immenso e tutelare, che solo si incarica di assicurare i loro beni e di vegliare sulla loro sorte. È assoluto, particolareggiato, regolare, previdente e mite. Rassomiglierebbe all’autorità paterna se, come essa, avesse lo scopo di preparare gli uomini alla virilità, mentre cerca invece di fissarli irrevocabilmente all’infanzia; ama che i cittadini si divertano, purché non pensino che a divertirsi. Non potrebbe esso togliere interamente loro la fatica di pensare e la pena di vivere?
Se cerco di immaginarmi il nuovo aspetto che il dispotismo potrà avere nel mondo, vedo una folla innumerevole di uomini eguali, intenti solo a procurarsi piaceri piccoli e volgari, con i quali soddisfare i loro desideri. Al di sopra di essi si eleva un potere immenso e tutelare, che solo si incarica di assicurare i loro beni e di vegliare sulla loro sorte. È assoluto, particolareggiato, regolare, previdente e mite. Rassomiglierebbe all’autorità paterna se, come essa, avesse lo scopo di preparare gli uomini alla virilità, mentre cerca invece di fissarli irrevocabilmente all’infanzia; ama che i cittadini si divertano, purché non pensino che a divertirsi. Non potrebbe esso togliere interamente loro la fatica di pensare e la pena di vivere?


 Questa progressione, per piccoli passi, in varie direzioni, ma sempre controllata ed equilibrata dalle condizioni necessarie, soggette alle quali solo l’esistenza può essere preservata, può, si crede, essere seguita in modo da concordare con tutti i fenomeni presentati da esseri organizzati, la loro estinzione e successione nelle epoche passate, e tutte le straordinarie modificazioni di forma, istinto e abitudini che esibiscono.
Questa progressione, per piccoli passi, in varie direzioni, ma sempre controllata ed equilibrata dalle condizioni necessarie, soggette alle quali solo l’esistenza può essere preservata, può, si crede, essere seguita in modo da concordare con tutti i fenomeni presentati da esseri organizzati, la loro estinzione e successione nelle epoche passate, e tutte le straordinarie modificazioni di forma, istinto e abitudini che esibiscono.




 di Paolo Repetto, 12 marzo 2020
di Paolo Repetto, 12 marzo 2020 5) Dovremo procedere, e in effetti lo stiamo già facendo, a una ridefinizione di valori considerati fino a ieri (sia pure ipocritamente: ho in mente il “tasso di perdite tollerabili” stabilito dal Pentagono) indiscutibili. Prima di tutto del valore di ogni singola vita, rispetto alla necessità di scelte inderogabili: sta accadendo, e sembra non suscitare particolare scandalo, negli ospedali al collasso che devono scegliere a chi assicurare le cure adeguate disponibili. Il problema è reale, e di fronte all’urgenza dei numeri non è nemmeno il caso di rivangare le recenti strette alla politica sanitaria: si porrebbe comunque, anche con qualche posto-letto in più. Ma tutto questo dovrebbe rimette in discussione, sotto una luce ben diversa, tematiche come quella dell’eutanasia e del diritto a decidere del proprio fine vita: più in generale, i termini in cui va concepito l’essere vivente (e quindi, aborto, accanimento terapeutico, ecc …). Per intanto, però, sta già certificando una valutazione utilitaristica della vita. Gli anziani, i malati, coloro che rappresentano un costo per la società, in una situazione di emergenza possono essere sacrificati. In Inghilterra addirittura si adotta il darwinismo sociale. Non a caso Spencer era inglese. Ha una sua logica, ma è il ritorno a una concezione e a una prassi che sino a ieri erano considerate appannaggio delle popolazioni primitive.
5) Dovremo procedere, e in effetti lo stiamo già facendo, a una ridefinizione di valori considerati fino a ieri (sia pure ipocritamente: ho in mente il “tasso di perdite tollerabili” stabilito dal Pentagono) indiscutibili. Prima di tutto del valore di ogni singola vita, rispetto alla necessità di scelte inderogabili: sta accadendo, e sembra non suscitare particolare scandalo, negli ospedali al collasso che devono scegliere a chi assicurare le cure adeguate disponibili. Il problema è reale, e di fronte all’urgenza dei numeri non è nemmeno il caso di rivangare le recenti strette alla politica sanitaria: si porrebbe comunque, anche con qualche posto-letto in più. Ma tutto questo dovrebbe rimette in discussione, sotto una luce ben diversa, tematiche come quella dell’eutanasia e del diritto a decidere del proprio fine vita: più in generale, i termini in cui va concepito l’essere vivente (e quindi, aborto, accanimento terapeutico, ecc …). Per intanto, però, sta già certificando una valutazione utilitaristica della vita. Gli anziani, i malati, coloro che rappresentano un costo per la società, in una situazione di emergenza possono essere sacrificati. In Inghilterra addirittura si adotta il darwinismo sociale. Non a caso Spencer era inglese. Ha una sua logica, ma è il ritorno a una concezione e a una prassi che sino a ieri erano considerate appannaggio delle popolazioni primitive. 6) La situazione ci costringe anche ad adottare modelli di computo diversi, ad avere una differente percezione delle cifre. Le migliaia, quando è possibile che ci includano, valgono molto più delle centinaia di migliaia di cui si ha notizia a distanza. Il rito serale inaugurato da un paio di settimane della conta dei morti ha l’effetto alone di rendere molto più concreti anche altri numeri, relativi ad altre situazioni. Quelli della guerra in Siria, ad esempio, o dei profughi inghiottiti dal Mediterraneo. Questo è, almeno per il momento, l’effetto che riscontro su di me. Il rischio è che sul lungo periodo e con numeri in crescita geometrica si crei assuefazione anche alla macabra contabilità domestica.
6) La situazione ci costringe anche ad adottare modelli di computo diversi, ad avere una differente percezione delle cifre. Le migliaia, quando è possibile che ci includano, valgono molto più delle centinaia di migliaia di cui si ha notizia a distanza. Il rito serale inaugurato da un paio di settimane della conta dei morti ha l’effetto alone di rendere molto più concreti anche altri numeri, relativi ad altre situazioni. Quelli della guerra in Siria, ad esempio, o dei profughi inghiottiti dal Mediterraneo. Questo è, almeno per il momento, l’effetto che riscontro su di me. Il rischio è che sul lungo periodo e con numeri in crescita geometrica si crei assuefazione anche alla macabra contabilità domestica. 8) Le consolazioni. Naturalmente qualcuno ha iniziato subito a parlare delle opportunità. Le famiglie per una volta riunite, l’occasione di fare insieme cose che non si erano mai fatte, di riscoprire modalità di rapporto da tempo scomparse. Non vorrei sembrare cinico, ma temo che la forzata coabitazione causerà invece una piccola catastrofe aggiuntiva. Nelle camere iperbariche che sono diventati i nostri appartamenti si verificherà un aumento dei divorzi, dei femminicidi, degli odi e degli screzi intergenerazionali, delle liti condominiali per il volume degli apparecchi televisivi. Persino i cani, poveracci, stanno pagando il loro tributo. Essendo rimasti l’ultima scusa per poter mettere fuori il naso sono costretti a corvée massacranti, per consentire a tutti i membri della famiglia di uscire, e accusano problemi di vescica sovrastimolata. C’è poi chi saluta l’occasione di una riscoperta della lettura. Ma come dicevo sopra, è dura anche leggere, o scrivere, con la mente che distratta dal pensiero di quel che accade, silenziosamente, là fuori. Anche questo piacere necessita di condizioni ambientali adeguate.
8) Le consolazioni. Naturalmente qualcuno ha iniziato subito a parlare delle opportunità. Le famiglie per una volta riunite, l’occasione di fare insieme cose che non si erano mai fatte, di riscoprire modalità di rapporto da tempo scomparse. Non vorrei sembrare cinico, ma temo che la forzata coabitazione causerà invece una piccola catastrofe aggiuntiva. Nelle camere iperbariche che sono diventati i nostri appartamenti si verificherà un aumento dei divorzi, dei femminicidi, degli odi e degli screzi intergenerazionali, delle liti condominiali per il volume degli apparecchi televisivi. Persino i cani, poveracci, stanno pagando il loro tributo. Essendo rimasti l’ultima scusa per poter mettere fuori il naso sono costretti a corvée massacranti, per consentire a tutti i membri della famiglia di uscire, e accusano problemi di vescica sovrastimolata. C’è poi chi saluta l’occasione di una riscoperta della lettura. Ma come dicevo sopra, è dura anche leggere, o scrivere, con la mente che distratta dal pensiero di quel che accade, silenziosamente, là fuori. Anche questo piacere necessita di condizioni ambientali adeguate.

 Lo scoop de “La Critica” era solo l’ennesimo capitolo di una diatriba che andava avanti da anni, non solo in Italia ma anche in Francia, con accuse (più che fondate) rivolte a D’Annunzio di trarre con eccessiva libertà ‘ispirazione’ dalle opere altrui, da quelle di Maupassant, di Zola, di Paul Bourget e di un sacco d’altri. Non conosco la reazione di Landor, non ne ho trovato traccia: probabilmente, se un po’ ho capito il personaggio, non ha dato grosso peso alla cosa, ci ha fatto su una risata e se ne è dimenticato.
Lo scoop de “La Critica” era solo l’ennesimo capitolo di una diatriba che andava avanti da anni, non solo in Italia ma anche in Francia, con accuse (più che fondate) rivolte a D’Annunzio di trarre con eccessiva libertà ‘ispirazione’ dalle opere altrui, da quelle di Maupassant, di Zola, di Paul Bourget e di un sacco d’altri. Non conosco la reazione di Landor, non ne ho trovato traccia: probabilmente, se un po’ ho capito il personaggio, non ha dato grosso peso alla cosa, ci ha fatto su una risata e se ne è dimenticato. I sensori si sono attivati già alla lettura della prima scheda, con la seconda è subentrata la certezza: quella roba l’avevo già letta. Infatti, non c’è voluto molto per risalire alla fonte: era la “Storia dell’America Latina” di Pierre Chaunu, un libricino sintetico, che abbracciava cinque secoli in poco più di cento pagine. I testi erano perfetti per il numero di schede previste, ma come oggetto di plagio risultavano decisamente poco azzeccati, dal momento che qualsiasi studente universitario avesse dato esami sull’argomento li conosceva. Per farla breve, dopo che l’editore si è convinto che a pubblicare roba del genere avrebbe perso ogni credibilità, e anche qualcos’altro, ho dovuto rifare di sana pianta più di un centinaio di schede storiche: e non solo, ho dovuto scrivere anche le didascalie esplicative di ciascuna immagine, ma prima ancora cercare le immagini stesse, perché per la parte relativa alla scoperta, alla conquista e al sistema coloniale non ne era stata selezionata e riprodotta una. Dovendo il volume uscire entro la metà di ottobre, in concomitanza con un convegno che avrebbe aperto con largo anticipo il carrozzone delle contro-celebrazioni colombiane, ed essendomi stato affidato il lavoro a fine giugno, ho trascorso per i successivi tre mesi tutti fine settimana girando da una biblioteca milanese all’altra, munito di speciali salvacondotti che mi hanno guadagnato l’odio imperituro del personale precettato, a scovare immagini in antichi e preziosissimi tomi di relazioni di viaggio e a inventarmi poi qualcosa che giustificasse le mie scelte.
I sensori si sono attivati già alla lettura della prima scheda, con la seconda è subentrata la certezza: quella roba l’avevo già letta. Infatti, non c’è voluto molto per risalire alla fonte: era la “Storia dell’America Latina” di Pierre Chaunu, un libricino sintetico, che abbracciava cinque secoli in poco più di cento pagine. I testi erano perfetti per il numero di schede previste, ma come oggetto di plagio risultavano decisamente poco azzeccati, dal momento che qualsiasi studente universitario avesse dato esami sull’argomento li conosceva. Per farla breve, dopo che l’editore si è convinto che a pubblicare roba del genere avrebbe perso ogni credibilità, e anche qualcos’altro, ho dovuto rifare di sana pianta più di un centinaio di schede storiche: e non solo, ho dovuto scrivere anche le didascalie esplicative di ciascuna immagine, ma prima ancora cercare le immagini stesse, perché per la parte relativa alla scoperta, alla conquista e al sistema coloniale non ne era stata selezionata e riprodotta una. Dovendo il volume uscire entro la metà di ottobre, in concomitanza con un convegno che avrebbe aperto con largo anticipo il carrozzone delle contro-celebrazioni colombiane, ed essendomi stato affidato il lavoro a fine giugno, ho trascorso per i successivi tre mesi tutti fine settimana girando da una biblioteca milanese all’altra, munito di speciali salvacondotti che mi hanno guadagnato l’odio imperituro del personale precettato, a scovare immagini in antichi e preziosissimi tomi di relazioni di viaggio e a inventarmi poi qualcosa che giustificasse le mie scelte. “E chi avrebbe mai pensato di trovare nello stesso elenco dei plagiari il nome dello scrittore franco-algerino Albert Camus, morto il 4 gennaio 1960 in un incidente automobilistico, dopo essere stato tre anni prima il più giovane Nobel per la Letteratura della storia? La pietra dello scandalo è rappresentata peraltro dal suo romanzo più acclamato, “La peste” (1947), le cui pagine, a un’attenta comparazione, risultano incredibilmente affini a quelle di un singolare romanzo di un autore italiano anticonformista e semidimenticato: “La peste a Urana” (apparso da Mondadori nel 1943) di Raoul Maria De Angelis, nato in provincia di Cosenza nel 1908 e morto a Roma nel 1990. Non è solamente il titolo del romanzo di Camus e i nomi delle città in cui si svolge la vicenda (Urana e Orano) a deporre a favore di un possibile plagio dal libro dello scrittore italiano, che il futuro premio Nobel avrebbe potuto conoscere in traduzione francese, ma l’intero impianto narrativo dell’opera. Lo stesso De Angelis, nel pieno della polemica, tra il 1948, anno della traduzione del romanzo di Camus da Bompiani, e il 1949, quando i giornali italiani titolavano “La Peste di De Angelis ha contagiato Camus”, fu il primo a parlare di «precedenti» e «somiglianze impressionanti» (ma mai di plagio), ed è indubbio che le due opere, pure sostanzialmente autonome e stilisticamente molto differenti, presentino ambientazioni ed episodi (e il finale) – diciamo così – «somiglianti». Sulla vicenda la querelle fra gli studiosi è aperta …
“E chi avrebbe mai pensato di trovare nello stesso elenco dei plagiari il nome dello scrittore franco-algerino Albert Camus, morto il 4 gennaio 1960 in un incidente automobilistico, dopo essere stato tre anni prima il più giovane Nobel per la Letteratura della storia? La pietra dello scandalo è rappresentata peraltro dal suo romanzo più acclamato, “La peste” (1947), le cui pagine, a un’attenta comparazione, risultano incredibilmente affini a quelle di un singolare romanzo di un autore italiano anticonformista e semidimenticato: “La peste a Urana” (apparso da Mondadori nel 1943) di Raoul Maria De Angelis, nato in provincia di Cosenza nel 1908 e morto a Roma nel 1990. Non è solamente il titolo del romanzo di Camus e i nomi delle città in cui si svolge la vicenda (Urana e Orano) a deporre a favore di un possibile plagio dal libro dello scrittore italiano, che il futuro premio Nobel avrebbe potuto conoscere in traduzione francese, ma l’intero impianto narrativo dell’opera. Lo stesso De Angelis, nel pieno della polemica, tra il 1948, anno della traduzione del romanzo di Camus da Bompiani, e il 1949, quando i giornali italiani titolavano “La Peste di De Angelis ha contagiato Camus”, fu il primo a parlare di «precedenti» e «somiglianze impressionanti» (ma mai di plagio), ed è indubbio che le due opere, pure sostanzialmente autonome e stilisticamente molto differenti, presentino ambientazioni ed episodi (e il finale) – diciamo così – «somiglianti». Sulla vicenda la querelle fra gli studiosi è aperta … con tanto di puntini è un modo pilatesco per dire: “Io non mi pronuncio, ma vi ho insinuato il tarlo e ho fornito gli indizi”. È insomma un modo vile per spargere veleno nella certezza dell’impunità. Dietro la ricerca del sensazionalismo di bassa lega c’è infatti un’operazione sottile di delegittimazione, nel caso specifico avviata nei confronti di un autore che alla destra per la quale Mascheroni scrive piace poco (ma qui l’ignoranza diventa abissale, perché Camus non ha mai goduto di eccessiva simpatia neppure presso la sinistra ‘ortodossa’, che fino a ieri e probabilmente anche oggi gli ha sempre preferito Sartre): ed è anche infine, verosimilmente, un mezzuccio per autoassolversi, appellandosi al “così fan tutti”. Proprio tutti no, Camus no senz’altro, Mascheroni certamente.
con tanto di puntini è un modo pilatesco per dire: “Io non mi pronuncio, ma vi ho insinuato il tarlo e ho fornito gli indizi”. È insomma un modo vile per spargere veleno nella certezza dell’impunità. Dietro la ricerca del sensazionalismo di bassa lega c’è infatti un’operazione sottile di delegittimazione, nel caso specifico avviata nei confronti di un autore che alla destra per la quale Mascheroni scrive piace poco (ma qui l’ignoranza diventa abissale, perché Camus non ha mai goduto di eccessiva simpatia neppure presso la sinistra ‘ortodossa’, che fino a ieri e probabilmente anche oggi gli ha sempre preferito Sartre): ed è anche infine, verosimilmente, un mezzuccio per autoassolversi, appellandosi al “così fan tutti”. Proprio tutti no, Camus no senz’altro, Mascheroni certamente. Questo vale anche per quella particolare pratica costituita dall’auto-plagio. Occupandomi disordinatamente di un po’ di tutto (per pura curiosità, e non per mestiere) ed essendo ormai avviato verso il rimbambimento senile, mi scopro talvolta a ripetere cose già scritte in precedenza. Dipende probabilmente dal fatto che vado molto d’accordo con le mie idee, e finisco per ribadirle quasi sempre nella stessa forma. Quando me ne accorgo taglio corto e ricorro sfacciatamente all’autocitazione, ma non sempre la memoria mi soccorre in tempo. In tal caso non danneggio nessuno, risulto soltanto noioso. Naturalmente però non funziona sempre così. C’è come abbiamo visto anche chi ricicla senza alcuno scrupolo più volte le stesse cose, cambiando semplicemente titoli e contesti, e se pure lo fa con materiale proprio è quanto meno poco corretto nei confronti del lettore e meno ancora nei confronti di se stesso.
Questo vale anche per quella particolare pratica costituita dall’auto-plagio. Occupandomi disordinatamente di un po’ di tutto (per pura curiosità, e non per mestiere) ed essendo ormai avviato verso il rimbambimento senile, mi scopro talvolta a ripetere cose già scritte in precedenza. Dipende probabilmente dal fatto che vado molto d’accordo con le mie idee, e finisco per ribadirle quasi sempre nella stessa forma. Quando me ne accorgo taglio corto e ricorro sfacciatamente all’autocitazione, ma non sempre la memoria mi soccorre in tempo. In tal caso non danneggio nessuno, risulto soltanto noioso. Naturalmente però non funziona sempre così. C’è come abbiamo visto anche chi ricicla senza alcuno scrupolo più volte le stesse cose, cambiando semplicemente titoli e contesti, e se pure lo fa con materiale proprio è quanto meno poco corretto nei confronti del lettore e meno ancora nei confronti di se stesso. Ma è cambiato anche il gusto, perché i lettori hanno cominciato ad apprezzare piuttosto l’originalità che non l’aderenza ad un modello. Nella letteratura non cercano più rassicurazione e conferme della stabilità del mondo, ma indizi del suo progresso e aperture a potenzialità nuove. E in quanto consumatori paganti non vogliono farsi rifilare merce di seconda mano. Acquistano un prodotto che reca stampigliato in copertina, in piena evidenza, prima ancora del titolo, il nome dell’autore, e a partire dai primi dell’Ottocento, nel frontespizio, persino il suo ritratto. Queste cose sono un marchio di fabbrica, sanciscono appunto una proprietà, un’esclusiva: ma dovrebbero anche essere garanzia di una ‘originalità controllata’.
Ma è cambiato anche il gusto, perché i lettori hanno cominciato ad apprezzare piuttosto l’originalità che non l’aderenza ad un modello. Nella letteratura non cercano più rassicurazione e conferme della stabilità del mondo, ma indizi del suo progresso e aperture a potenzialità nuove. E in quanto consumatori paganti non vogliono farsi rifilare merce di seconda mano. Acquistano un prodotto che reca stampigliato in copertina, in piena evidenza, prima ancora del titolo, il nome dell’autore, e a partire dai primi dell’Ottocento, nel frontespizio, persino il suo ritratto. Queste cose sono un marchio di fabbrica, sanciscono appunto una proprietà, un’esclusiva: ma dovrebbero anche essere garanzia di una ‘originalità controllata’. Diverso è il discorso per l’opera narrativa. La narrazione letteraria, e tanto più quella poetica, sono creazione più o meno ex-nihilo, e allora le idee e le parole per esprimerle sono soggette alla denominazione d’origine controllata. Appropriarsi delle une e delle altre e spacciarle per proprie è in questo caso un furto bello e buono e, peggio ancora, è un furto assolutamente stupido. Ma anche qui occorre fare delle distinzioni. Salgari e Verne copiavano intere voci dalle enciclopedie e paragrafi dai libri di viaggio per dare una credibile ambientazione alle loro storie, oltre che per cumulare pagine da tradurre in moneta. Anche per loro vale a mio giudizio la scusante di una utilità per il lettore. Di questo infatti ancora li ringrazio: ho imparato prima dei dieci anni che esiste il marabù, che l’Islanda è piena di vulcani e dove si trova l’isola di Tristan da Cunha, conoscenze che sono poi risultate fondamentali per la mia vita. D’Annunzio copiava invece Landor per ammantarsi di esotismo, per contrabbandare di sé un’immagine falsa e alimentare un mito. Sono due cose ben diverse.
Diverso è il discorso per l’opera narrativa. La narrazione letteraria, e tanto più quella poetica, sono creazione più o meno ex-nihilo, e allora le idee e le parole per esprimerle sono soggette alla denominazione d’origine controllata. Appropriarsi delle une e delle altre e spacciarle per proprie è in questo caso un furto bello e buono e, peggio ancora, è un furto assolutamente stupido. Ma anche qui occorre fare delle distinzioni. Salgari e Verne copiavano intere voci dalle enciclopedie e paragrafi dai libri di viaggio per dare una credibile ambientazione alle loro storie, oltre che per cumulare pagine da tradurre in moneta. Anche per loro vale a mio giudizio la scusante di una utilità per il lettore. Di questo infatti ancora li ringrazio: ho imparato prima dei dieci anni che esiste il marabù, che l’Islanda è piena di vulcani e dove si trova l’isola di Tristan da Cunha, conoscenze che sono poi risultate fondamentali per la mia vita. D’Annunzio copiava invece Landor per ammantarsi di esotismo, per contrabbandare di sé un’immagine falsa e alimentare un mito. Sono due cose ben diverse. Per come lo intendo io, il plagio va considerato prescindendo dall’esistenza o meno di ‘diritti di proprietà’ funzionali all’industria culturale, che ha regole e giurisdizioni delle quali francamente mi importa un fico secco. Chi scrive per passione genuina lo fa per sé prima che per gli altri: non si lega alla catena di montaggio e sa di non poter essere derubato della sua interiore soddisfazione. La questione si pone quindi sotto un profilo puramente etico (distinguerei anche da quello morale, per il quale il furto è comunque una colpa: ma qui si tratta di rispondere alla propria coscienza, non a quella collettiva).
Per come lo intendo io, il plagio va considerato prescindendo dall’esistenza o meno di ‘diritti di proprietà’ funzionali all’industria culturale, che ha regole e giurisdizioni delle quali francamente mi importa un fico secco. Chi scrive per passione genuina lo fa per sé prima che per gli altri: non si lega alla catena di montaggio e sa di non poter essere derubato della sua interiore soddisfazione. La questione si pone quindi sotto un profilo puramente etico (distinguerei anche da quello morale, per il quale il furto è comunque una colpa: ma qui si tratta di rispondere alla propria coscienza, non a quella collettiva). re parti il problema non si pone. Quanto a coscienza, collettiva o individuale, siamo molto più avanti. Da noi un caso simile è valso recentemente alla protagonista la promozione a ministra.
re parti il problema non si pone. Quanto a coscienza, collettiva o individuale, siamo molto più avanti. Da noi un caso simile è valso recentemente alla protagonista la promozione a ministra.

 I termini sono Storia e Filosofia, scritti in questo caso con la maiuscola. In genere quando li adoperiamo diamo per scontato di aver chiaro di cosa si sta parlando: e magari per noi, in quel particolare contesto, è così. Ma se li impieghiamo nella versione “nobile”, quella appunto con l’iniziale maiuscola, facciamo riferimento a significati che non dovrebbero valere solo per noi, andrebbero universalmente condivisi: e allora non è male verificare che davvero lo siano. Anche se la nostra è una trattazione alla buona, nella quale non si devono mettere in conto tutte le possibili declinazioni e sfumature, dovremmo supporre un accordo di massima almeno sull’accezione letterale, quella desumibile dall’etimologia. Di qui innanzi sarà più che sufficiente per intenderci.
I termini sono Storia e Filosofia, scritti in questo caso con la maiuscola. In genere quando li adoperiamo diamo per scontato di aver chiaro di cosa si sta parlando: e magari per noi, in quel particolare contesto, è così. Ma se li impieghiamo nella versione “nobile”, quella appunto con l’iniziale maiuscola, facciamo riferimento a significati che non dovrebbero valere solo per noi, andrebbero universalmente condivisi: e allora non è male verificare che davvero lo siano. Anche se la nostra è una trattazione alla buona, nella quale non si devono mettere in conto tutte le possibili declinazioni e sfumature, dovremmo supporre un accordo di massima almeno sull’accezione letterale, quella desumibile dall’etimologia. Di qui innanzi sarà più che sufficiente per intenderci. Cominciamo con Storia. Deriva dal greco istorein, che significa raccontare. La Storia fa proprio questo: racconta dei fatti. Veramente, ad essere pignoli, a raccontare i fatti è la storiografia, la scrittura della storia, mentre la Storia sarebbe l’insieme dei fatti in sé: ma non complichiamoci la vita con distinzioni che ci porterebbero troppo lontano, fino a chiederci se i fatti esistono indipendentemente dall’essere raccontati (che sembra una domanda idiota, ma non lo è), e se la Storia riguardi il mondo nel suo complesso o solo quel breve attimo della sua età che vede la presenza dell’uomo. Accontentiamoci dell’accezione più elementare, scolastica. Nel nostro discorso assumeremo dunque la Storia come narrazione (orale o scritta) di eventi che sono considerati universalmente rilevanti dal narratore e accolti come tali dal lettore o dall’ascoltatore. Ciò significa ad esempio che se una vicina di casa mi fa il resoconto dettagliato dei suoi malanni o delle intemperanze sentimentali di una comune conoscente, per quanto le due cose siano al centro dei suoi interessi, non sta costruendo Storia, mentre lo fa se racconta della fame e della paura e della confusione vissute in Genova, e in tutto il nord-Italia, durante l’ultima guerra, sotto l’occupazione tedesca. In questo caso dà un piccolo ma significativo contributo alla trasmissione e conservazione della corretta memoria di un periodo cruciale per l’umanità intera.
Cominciamo con Storia. Deriva dal greco istorein, che significa raccontare. La Storia fa proprio questo: racconta dei fatti. Veramente, ad essere pignoli, a raccontare i fatti è la storiografia, la scrittura della storia, mentre la Storia sarebbe l’insieme dei fatti in sé: ma non complichiamoci la vita con distinzioni che ci porterebbero troppo lontano, fino a chiederci se i fatti esistono indipendentemente dall’essere raccontati (che sembra una domanda idiota, ma non lo è), e se la Storia riguardi il mondo nel suo complesso o solo quel breve attimo della sua età che vede la presenza dell’uomo. Accontentiamoci dell’accezione più elementare, scolastica. Nel nostro discorso assumeremo dunque la Storia come narrazione (orale o scritta) di eventi che sono considerati universalmente rilevanti dal narratore e accolti come tali dal lettore o dall’ascoltatore. Ciò significa ad esempio che se una vicina di casa mi fa il resoconto dettagliato dei suoi malanni o delle intemperanze sentimentali di una comune conoscente, per quanto le due cose siano al centro dei suoi interessi, non sta costruendo Storia, mentre lo fa se racconta della fame e della paura e della confusione vissute in Genova, e in tutto il nord-Italia, durante l’ultima guerra, sotto l’occupazione tedesca. In questo caso dà un piccolo ma significativo contributo alla trasmissione e conservazione della corretta memoria di un periodo cruciale per l’umanità intera. La domanda successiva, a questo punto, potrebbe essere: siano o meno gli uomini interamente liberi di fare la Storia, lo svolgimento di quest’ultima dimostra un progresso dell’umanità? Qui dalla lettura si passa alla valutazione, e da letture anche completamente diverse può scaturire una valutazione simile. Negli ultimi tre secoli abbiamo avuto ad esempio l’interpretazione storicistica (Vico e i corsi e ricorsi), fatta propria poi da quella illuministica (“è in atto una razionalizzazione del mondo”) e da quella idealistica (la Storia narra il dispiegarsi dello Spirito assoluto), e quindi sviluppata in quella positivistica (la scienza è il motore del progresso) e in quella marxista (il materialismo storico), ecc…; e tutte concordavano sulla fiducia nelle magnifiche sorti e progressive dell’umanità. Attualmente queste concezioni mostrano un po’ la corda, e proprio i progressi della conoscenza, segnatamente di quella scientifica, mettono sempre più in forse la possibilità di una lettura teleologica della storia, e la rilevanza del ruolo della nostra specie. Ma anche le filosofie che si sono presentate come nichilistiche e negatrici del progresso, quel “pensiero debole” che si rifà a Nietzsche a Heidegger, continuano in realtà a “interpretare” la Storia.
La domanda successiva, a questo punto, potrebbe essere: siano o meno gli uomini interamente liberi di fare la Storia, lo svolgimento di quest’ultima dimostra un progresso dell’umanità? Qui dalla lettura si passa alla valutazione, e da letture anche completamente diverse può scaturire una valutazione simile. Negli ultimi tre secoli abbiamo avuto ad esempio l’interpretazione storicistica (Vico e i corsi e ricorsi), fatta propria poi da quella illuministica (“è in atto una razionalizzazione del mondo”) e da quella idealistica (la Storia narra il dispiegarsi dello Spirito assoluto), e quindi sviluppata in quella positivistica (la scienza è il motore del progresso) e in quella marxista (il materialismo storico), ecc…; e tutte concordavano sulla fiducia nelle magnifiche sorti e progressive dell’umanità. Attualmente queste concezioni mostrano un po’ la corda, e proprio i progressi della conoscenza, segnatamente di quella scientifica, mettono sempre più in forse la possibilità di una lettura teleologica della storia, e la rilevanza del ruolo della nostra specie. Ma anche le filosofie che si sono presentate come nichilistiche e negatrici del progresso, quel “pensiero debole” che si rifà a Nietzsche a Heidegger, continuano in realtà a “interpretare” la Storia.