Appunti per una storia sociale della barba
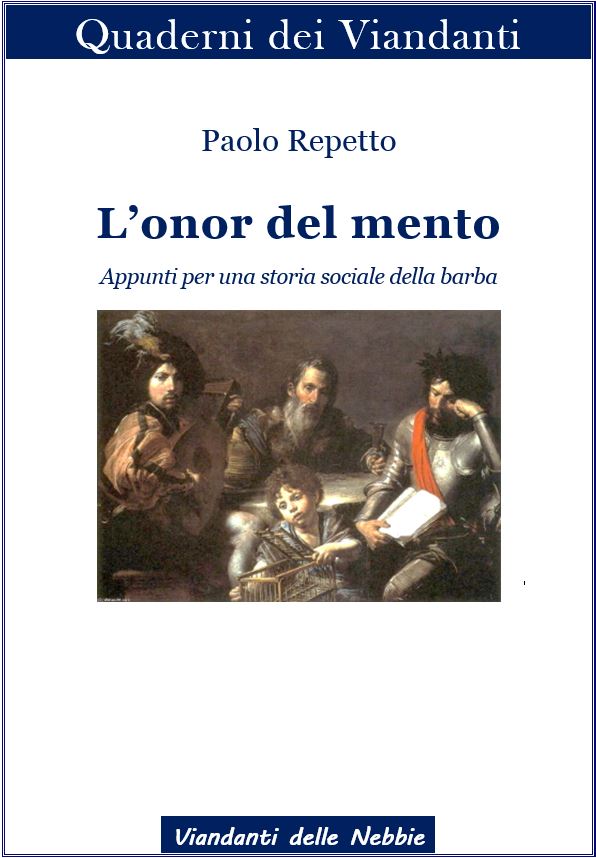 di Paolo Repetto, 30 luglio 2021
di Paolo Repetto, 30 luglio 2021
Prologo
Lanugine residua?
L’antichità: Barbe antiche; Barbe bibliche; Barbe classiche; Barbe latine; Barbe cristiane
Tavola 1 – Barbe antiche; Tavola 2 – Barbe classiche (I); Tavola 3 – Barbe classiche (II); Tavola 4 – Barbe latine; Tavola 5 – Barbe cristiane; Tavola 6 – Barbe monastiche; Tavola 7 – Barbe Pontificie; Tavola 8 – Barbe diaboliche
Il medioevo: Barbe monastiche; Barbe pontificie; Barbe diaboliche; Barbe ereticali; Barbe barbare; Barbe regali
Tavola 9 – Barbe ereticali; Tavola 10 – Barbe barbare; Tavola 11 – Barbe regali
L’età moderna: Barbe rinascimentali; Barbe controriformiste; Una temporanea eclisse
Tavola 12 – Rasature umanistiche; Tavola 13 – Barbe rinascimentali; Tavola 14 – Sbarbati illustri; Tavola 15 – Barbe protestanti; Tavola 16 – Barbe controriformiste; Tavola 17 – Barbe missionarie e conquistatrici; Tavola 18 – Volti illuminati
L’Ottocento: Barbe romantiche; Barbe rivoluzionarie
Tavola 19 – Barbe di transizione; Tavola 20 – Barbe letterarie; Tavola 21 – Barbe d’artista; Tavola 22 – Barbe anarchiche; Tavola 23 – Barbe comuniste; Tavola 24 – Barbe evoluzioniste
Barbe d’artista; Barbe borghesi; Barbe coloniali; Barbe d’oltreoceano
Tav. 25 – Barbe d’Oltreoceano (I); Tav. 26 – Barbe d’Oltreoceano (II); Tav. 27 – Barbe Sioniste (e non)
L’età contemporanea; No Barba!
Tavola 28 – Barbe antisemite; Tavola 29 – No Barba
Abbarbicati
Tavola 30 – Abbarbicati
Appendici: La barba di Freud; … e quella di Platone
Bibliografia
Prologo
Le idee migliori mi vengono al mattino,
mentre mi faccio la barba.
Da ciò deduco che gli uomini con la barba
non possono avere buone idee. (Dennis Gabor)
Qualche tempo fa, un mio intervento dal titolo La scimmia è l’essenza nasceva da una domanda apparentemente oziosa: perché mi rado la barba? Alla fine in quel pezzo parlavo un po’ di tutto, ma nel frattempo avevo perso di vista la domanda originaria, e quindi non mi davo una risposta. O forse la risposta era implicita nelle considerazioni cui mi ero abbandonato, che riguardavano il rapporto natura-cultura nei comportamenti umani. Questo non ha comunque soddisfatto la mia curiosità, e anzi, ha suscitato il desiderio di approfondire un po’ la cosa.
Ho così innanzitutto verificato che la domanda era meno peregrina di quanto poteva sembrare. Un sacco di gente si è interrogata su questo tema già a partire dall’antichità, tanto che esiste in proposito persino una branca specifica di studi, la pogonologia (dal greco pôgòn, che indica appunto la barba). Non esiste invece, o almeno non l’ho trovata, una trattazione che riesca insieme sintetica e sufficientemente esauriente: e già premetto che non saranno certo queste pagine a colmare il vuoto. L’argomento richiederebbe infatti un approccio ben più serio e ordinato di quello che avevo in mente io: ma a me a questo punto interessava solo mostrare come anche un quesito in apparenza piuttosto futile possa riservare piacevolissime sorprese. Nel mio caso il coinvolgimento è poi cresciuto quando ho deciso di approfondire la ricerca iconologica, che a sua volta ha spalancato ulteriori possibili campi di indagine. Insomma, come al solito la curiosità è sfuggita al controllo e mi ha portato a spasso nel tempo.
Questo scritto non ha dunque la minima pretesa “scientifica” o sistematica. Procede più sull’onda delle suggestioni dettate dalla documentazione cui mi sono affidato che da un’analisi rigorosa della stessa. Mi sono limitato quasi esclusivamente a giocare con lo sterminato repertorio delle immagini, e nella fattispecie dei ritratti e degli autoritratti, che è eloquentissimo ma del quale conosco anche le incertezze e le ambiguità, soprattutto per quanto concerne le epoche più lontane. Solo in qualche caso ho fatto ricorso alle fonti scritte, storiche o letterarie.
A proposito dei ritratti, che costituiscono la quasi totalità dell’apparato iconografico, questa lunga galleria di volti potrà apparire pleonastica, e forse ai fini dell’argomento che volevo trattare lo è davvero: assicuro però che non si tratta di un espediente per mascherare dietro la quantità dei dati la scarsa rilevanza qualitativa della trattazione. In realtà la cosa mi ha preso la mano quando, dopo una prima sommaria ricerca, mi sono reso conto che di buona parte dei personaggi che intendevo chiamare a testimoni delle vicissitudini della barba non mi ero mai preoccupato di conoscere l’aspetto fisico, e di altri davo per scontata un’immagine che non corrispondeva a quella reale. Per uno che ha maturato una sua personalissima teoria fisiognomica è grave. Sono così arrivate delle sorprese (ad esempio, il ribaltamento delle fattezze che attribuivo a Guicciardini e a Machiavelli) e alla luce di sembianti inattesi ho dovuto rimettere in discussione diverse mie convinzioni. Insomma, alla fine è diventato un gioco a sé, che mi ha sin troppo coinvolto.
A conti fatti, comunque, scontando le dovute tare, credo di aver colto le linee essenziali di questa particolare “storia”: le considerazioni che alla fine ne traggo vanno naturalmente accolte come frutto di una lettura molto personale. Ho aggiunto per una volta anche delle note, ma solo per chiarire alcuni passaggi senza appesantire ulteriormente il testo: e le note hanno di positivo che volendo le si può saltare a piè pari.
Se qualcuno poi trovasse che il discorso si è trascinato troppo per le lunghe, sappia che il testo che ha di fronte è forse un terzo di quello originario. Gli è già andata bene così.

Lanugine residua?
Ammetto subito che la domanda, pur non essendo così stupida, era senz’altro mal posta, perché la questione non riguarda solo me: tocca in un senso o nell’altro (magari nella formulazione al negativo, “perché non mi rado?”) tutti gli umani. In fondo in tutto il regno animale noi siamo l’unica specie che si rade. E questa non è una gran rivelazione: siamo anche l’unica che accende fuochi, che cuoce i cibi, che scrive e legge libri, che si muove in auto, che fa insomma cose che parrebbero extra o contro natura, e la spiegazione di tutte queste singolarità si chiama genericamente “cultura”[1]. Quindi, il dato da cui partire è che il radersi o meno la barba, come la stragrande maggioranza dei comportamenti umani, soprattutto di quelli attuali, non ha a che fare – almeno direttamente – con la natura, ma con la cultura. Almeno direttamente, ripeto, perché al di là delle mode, e in molti casi degli obblighi, anche l’usanza di portare barba e baffi risponde a istanze naturali originarie di competizione, di sopravvivenza e di successo riproduttivo.
Prima di vedere in che termini si manifesti questa “cultura” va dunque considerato ciò che le sta a monte: ovvero il fatto che noi umani siamo singolari già quanto a “natura”, perché tra i mammiferi, e più in particolare tra i primati e più specificamente ancora tra le antropomorfe, siamo gli unici la cui superfice corporea non è protetta dai peli. Siamo cioè una specie “nuda”: e non siamo tali da sempre, ma abbiamo perso la nostra naturale pelliccia nel corso dell’evoluzione. A dire il vero, non siamo nemmeno completamente spogli: salvo pochissime zone (labbra, palmi, ecc…) la nostra pelle è coperta interamente da una sottile lanugine, che è troppo rada e fine per assolvere a una funzione protettiva nei confronti del freddo, ma sufficiente a ricordarci da dove arriviamo.
A quanto sembra la nostra mutazione è avvenuta in conseguenza del passaggio dalle foreste alle savane, passaggio che ha comportato anche la trasformazione della dieta alimentare: da prevalentemente vegetariani siamo diventati per forza di cose onnivori, con una forte preferenza per le carni. L’uomo ha dunque cominciato a cacciare, e per procurarsi il cibo in spazi aperti e assolati – ma anche per sfuggire a sua volta alla caccia delle altre specie che dominavano questi spazi – ha dovuto imparare a correre sulle lunghe distanze. Tra i grandi predatori è in effetti quello in grado di mantenere il passo di corsa per intervalli di tempo più prolungati.
In questo tipo di attività una folta pelliccia lo avrebbe penalizzato, procurandogli un surriscaldamento, mentre la perdita del pelo ha favorito lo sviluppo di ghiandole sudoripare, e sudare è il modo più efficace per disperdere il calore. Questo “vantaggio” ha permesso all’uomo di assumere più calorie spendendo meno energie, condizioni necessarie per alimentare l’attività di un cervello sovradimensionato e particolarmente dispendioso. Non è un caso che nei film di fantascienza gli extraterrestri in visita sulla terra, naturalmente intelligentissimi (altrimenti non sarebbero arrivati sin qui), siano rappresentati con teste enormi e tronco e membra completamente glabri. E ciò a dispetto del fatto che non abbiano assolutamente più bisogno di correre e sudare per procacciarsi il cibo.
È presumibile comunque che l’epidermide dei nostri progenitori fosse ancora molto villosa, e che la selezione che ci ha portato ad essere scimmie nude abbia lavorato diversamente, ad esempio, nelle fasce tropicali e in quelle più lontane dall’equatore. Se l’origine della nostra specie è davvero da situarsi in Africa, è ipotizzabile che per i gruppi che hanno colonizzato latitudini più fredde i fattori naturali che hanno guidato quella selezione, tanto quelli interni come quelli esterni, siano stati un po’ differenti[2].
Butto lì queste cose a spanne, perché chi desidera approfondire ha a disposizione una vastissima letteratura scientifica. Ma a noi qui interessano i peli che fanno “ornamento” al volto, e di quelli voglio occuparmi.
Ho realizzato solo in un secondo tempo che prima ancora di interrogarmi sul perché li stavo tagliando avrei dovuto chiedermi perché crescono, che funzione hanno. Quando l’ho fatto, però, mi sono reso conto che persino la scienza è in proposito abbastanza vaga. Le spiegazioni offerte sono diverse, molto condizionate dall’angolatura disciplinare dalla quale arrivano: la nostra fisionomia è singolare anche sotto questo aspetto,per cui differiamo dai nostri parenti più prossimi, gli scimpanzé e i bonobo, che in pratica non hanno mento[3] e il cui muso è quasi totalmente glabro. È probabile comunque che nell’uomo la peluria facciale avesse a che fare originariamente con la protezione dal freddo, associata anche ad altre funzioni, ad esempio quella di nascondere certe reazioni emotive (l’arrossire) che possono evidenziare uno stato d’ira o di paura[4]. Sulla sua persistenza può poi aver agito anche quella che già Darwin chiamava selezione per scelta sessuale: ovvero è possibile che le femmine abbiano privilegiato le guance e i menti più irsuti perché la barba (così come gli altri peli residui), comparendo solo dopo la pubertà, era naturalmente associabile alla raggiunta virilità. Più barba, più ormoni[5]. Una selezione dello stesso tipo, ma di segno contrario, potrebbe aver agito invece nei loro confronti. Si tratta, ripeto, di ipotesi, ma sembrano abbastanza fondate.
La sostanza comunque rimane quella. La barba ce la troviamo, e questo attiene alla natura. Sta poi a noi decidere che farne: ciò che invece attiene alla cultura. Per cui, qui lasciamo la natura ed entriamo nello specifico “culturale”.

L’antichità
Barbe antiche
 È facilmente comprensibile come, proprio per la sua immediata associazione con la mascolinità, con una virilità matura, la barba abbia sempre goduto di un enorme prestigio presso tutte le popolazioni arcaiche (in particolare quelle “occidentali”), e sia stata esplicitamente investita di significati di “segnaletica” sociale, rispetto non solo al genere ma anche all’appartenenza a gruppi o classi particolari. Ma il carico simbolico di cui è stata oggetto, unito certamente a scelte di opportunità pratica, ha fatto sì che una semplice caratteristica naturale potesse diventare molto presto anche un problema. Pare infatti che sin dalla preistoria non sia stata considerata assolutamente intoccabile: diversi paleontologi interpretano come arnesi per la rasatura alcune pietre particolarmente affilate del paleolitico, e soprattutto certe lame dell’età del bronzo: ciò che farebbe risalire molto indietro nel tempo la pratica della rasatura. Senza dubbio comunque essa era presente ai primordi dei tempi storici, e i nostri più lontani antenati già si trovavano di fronte a una di quelle scelte che nel loro assieme hanno fatto di noi dei sapiens sapiens.
È facilmente comprensibile come, proprio per la sua immediata associazione con la mascolinità, con una virilità matura, la barba abbia sempre goduto di un enorme prestigio presso tutte le popolazioni arcaiche (in particolare quelle “occidentali”), e sia stata esplicitamente investita di significati di “segnaletica” sociale, rispetto non solo al genere ma anche all’appartenenza a gruppi o classi particolari. Ma il carico simbolico di cui è stata oggetto, unito certamente a scelte di opportunità pratica, ha fatto sì che una semplice caratteristica naturale potesse diventare molto presto anche un problema. Pare infatti che sin dalla preistoria non sia stata considerata assolutamente intoccabile: diversi paleontologi interpretano come arnesi per la rasatura alcune pietre particolarmente affilate del paleolitico, e soprattutto certe lame dell’età del bronzo: ciò che farebbe risalire molto indietro nel tempo la pratica della rasatura. Senza dubbio comunque essa era presente ai primordi dei tempi storici, e i nostri più lontani antenati già si trovavano di fronte a una di quelle scelte che nel loro assieme hanno fatto di noi dei sapiens sapiens.
Gli affreschi tombali e le stele egizie, ad esempio, presentano figure maschili appartenenti a tutte le classi sociali, anche a quelle più umili, sempre perfettamente sbarbate. Dietro questa usanza c’erano senz’altro motivazioni religiose, oltre a quelle pratiche o igieniche che possiamo cercare di immaginare: ma è anche da supporre che quello egizio fosse un popolo piuttosto glabro per natura, e che proprio per questo motivo la barba rivestisse in quella cultura un forte valore simbolico, fosse un attributo connesso all’autorità. In effetti nelle varie espressioni iconografiche i faraoni, e solo loro e le loro consorti, sono spesso raffigurati con barbe posticce, simbolicamente raccolte in cilindri aurei appesi sotto il mento.
Sembra che anche i Sumeri si accorciassero i capelli, ostentando però una barba molto curata e priva di baffi. In quanto segno di saggezza questa era riservata a pochi eletti, soprattutto nel periodo protodinastico (il terzo millennio a.C.). Anche nel loro caso, infatti, nelle stele e nelle tavolette d’argilla lavorate a bassorilievo popolani e servi sono rappresentati con la testa e il mento rasati. Solo più tardi l’uso accadico di portare la barba arricciata e tagliata quadrangolare si diffuse ai ceti non nobiliari e divenne un costume comune, quantomeno nelle classi dominanti. Venne poi ripreso da tutte le popolazioni che in ondate successive si riversarono lungo tre millenni nella Mezzaluna fertile, ed è andato a fissare un modello di rappresentazione iconografica arrivato sino a noi. Nei “peplum” che andavano di moda negli anni cinquanta e che seguivo da ragazzino bulimico di storia non avevo difficoltà alcuna a riconoscere immediatamente assiri, fenici, babilonesi e persiani dal taglio particolare delle loro barbe (e ad associare queste, da ideale combattente alle Termopili, all’idea della slealtà e del tradimento). (tav. 1)
Barbe bibliche
 Un’attenzione ancor più particolare veniva riservata alla barba dagli ebrei. Nel loro caso la testimonianza delle immagini non ci soccorre granché, visto che in quanto popolo a vocazione nomade ne ha prodotte pochissime, e anche quelle sono andate per la gran parte distrutte o disperse nel corso di una storia tragicamente movimentata. Ma, soprattutto, il divieto iconoclasta di rappresentare o di provare anche soltanto ad immaginare le fattezze divine ha impedito la nascita di un modello “superiore” di riferimento. Occorre quindi affidarci piuttosto alle testimonianze scritte, queste decisamente abbondanti. Già nel Levitico, ad esempio, all’interno del cosiddetto “codice di santità” si fa espressa proibizione di radere la barba. In realtà la prescrizione riguarderebbe certi eccessi nelle manifestazioni del lutto, come appunto lo strapparsi barba e capelli, considerati di origine “pagana”: e trae giustificazione dall’idea che l’uomo, creato ad immagine di Dio (ecco come si aggira il divieto di rappresentare la divinità!), non debba in alcun modo intervenire sul proprio corpo. Naturalmente poi la casta sacerdotale ne ha imposto l’interpretazione più restrittiva e a lei più conveniente, quella che assegna alla barba, acconciata secondo particolari regole, il ruolo di segno distintivo (tanto del popolo ebraico nei confronti degli altri quanto delle caste al suo interno). E in tal senso si può dire che gli Ebrei lo scopo lo hanno perfettamente raggiunto: purtroppo, però, in negativo, perché col tempo quel segno è stato convertito nello stereotipo della barba caprina.
Un’attenzione ancor più particolare veniva riservata alla barba dagli ebrei. Nel loro caso la testimonianza delle immagini non ci soccorre granché, visto che in quanto popolo a vocazione nomade ne ha prodotte pochissime, e anche quelle sono andate per la gran parte distrutte o disperse nel corso di una storia tragicamente movimentata. Ma, soprattutto, il divieto iconoclasta di rappresentare o di provare anche soltanto ad immaginare le fattezze divine ha impedito la nascita di un modello “superiore” di riferimento. Occorre quindi affidarci piuttosto alle testimonianze scritte, queste decisamente abbondanti. Già nel Levitico, ad esempio, all’interno del cosiddetto “codice di santità” si fa espressa proibizione di radere la barba. In realtà la prescrizione riguarderebbe certi eccessi nelle manifestazioni del lutto, come appunto lo strapparsi barba e capelli, considerati di origine “pagana”: e trae giustificazione dall’idea che l’uomo, creato ad immagine di Dio (ecco come si aggira il divieto di rappresentare la divinità!), non debba in alcun modo intervenire sul proprio corpo. Naturalmente poi la casta sacerdotale ne ha imposto l’interpretazione più restrittiva e a lei più conveniente, quella che assegna alla barba, acconciata secondo particolari regole, il ruolo di segno distintivo (tanto del popolo ebraico nei confronti degli altri quanto delle caste al suo interno). E in tal senso si può dire che gli Ebrei lo scopo lo hanno perfettamente raggiunto: purtroppo, però, in negativo, perché col tempo quel segno è stato convertito nello stereotipo della barba caprina.
Con la rasatura comunque gli ebrei non hanno mai avuto un buon rapporto, neppure per quanto concerneva i capelli. Secondo alcuni commentatori della Torah i capelli erano in grado di attrarre forze superiori, che davano capacità sovrumane. Sansone, la cui forza eccezionale dipendeva proprio dalla lunga capigliatura, diceva: “Se fossi rasato la mia forza si ritirerebbe da me, diventerei debole e sarei come un uomo qualunque”.
Sansone in realtà non era affatto uno qualunque: era un nazireo, ovvero un “consacrato”, e questo status comportava appunto la proibizione di radersi capelli e barba, oltre ad una serie di tabù alimentari. Nazirei erano anche gli Esseni, quelli dei rotoli del mar Morto. E l’appellativo di nazareno attribuito a Gesù ha probabilmente origine da questa appartenenza, piuttosto che dal presunto luogo di nascita.
Proprio un nazireo, Giovanni il Battista, fu il tramite di passaggio del culto ebraico della barba ai futuri cristiani, prima ancora che Cristo iniziasse la sua predicazione. Le più antiche testimonianze iconografiche, quelle bizantine, ce lo rappresentano con barba e capelli incolti e vestito di pelle di dromedario, in linea con la tradizione letteraria (soprattutto col vangelo di Marco).

Barbe classiche
Per tutti i popoli antichi la barba era insomma a vario titolo simbolo di potere, o quanto meno di autorevolezza: sia di quella intrinseca all’essere maschi che di quella che si acquisisce con l’età. Ciò valeva naturalmente anche per i Greci.
I ritratti che ci sono pervenuti dall’epoca della grandezza ellenica (attraverso busti, statue, bassorilievi, vasi o crateri, maschere mortuarie, monete, ecc.) mostrano tutti uomini barbuti. Tali erano già immaginati gli eroi omerici, e in epoca storica come tali sono stati poi rappresentati i filosofi (Platone, Socrate e Aristotele), gli uomini politici e i condottieri (Temistocle, Milziade, Leonida, Aristide, Pericle), nonché i letterati (Eschilo, Sofocle, Aristofane, Demostene, ecc). (tav. 2) Allo stesso modo gli dei maggiori della prima fase olimpica (Zeus, Kronos, Poseidone) esibiscono sempre una folta barba. (tav. 3) La stessa viene attribuita in alcune occasioni persino ad Atena, segno inequivocabile della sua potenza (anche oggi, ad una femmina vengono riconosciuti attributi maschili. Di altro tipo.)[6].
Plutarco testimonia che l’associazione tra barba e virilità, quest’ultima da misurarsi in valore militare e coraggio, era tale che a Sparta coloro che si fossero macchiati di codardia erano condannati a radersi solo un lato del viso, in modo da essere facilmente riconoscibili[7]. E i ritratti dicono anche che alla barba veniva dedicata una certa cura, non era lasciata incolta ma veniva fatta crescere e pettinata e acconciata in fogge molto diverse. L’unico busto “sbarbato” che mi risulti, relativo a un personaggio di questo periodo, è quello di Alcibiade: ma trattandosi di copie romane e di una figura particolarmente “discussa” è possibile che l’immagine sia stata falsata o reinventata.
A partire però da un periodo abbastanza precisamente databile, la seconda metà del quinto secolo, e dall’opera di Fidia, assistiamo a una svolta. Gli artisti iniziano a raffigurare eroi o atleti, ma anche alcune divinità maschili, come giovani sbarbati, e ad affidare piuttosto alla muscolatura il compito di evidenziarne la virilità. È probabile, ad esempio nel caso di Apollo o di Dioniso, visti i campi d’azione ai quali queste divinità erano riferibili (l’arte e la poesia per l’uno, la sfrenatezza e la sensualità per l’altro) che si volesse sottolinearne l’immortalità, l’eterna giovinezza, la vigoria sessuale, prima ancora che la potenza. Ma è anche possibile, come si può desumere ad esempio dai fregi del Partenone, che la particolare immagine giovanile e pulita fosse scelta in contrapposizione a ciò che di arcaico e di barbaro minacciava la cultura ellenica, come zavorra del passato dall’interno e come aggressione dell’ignoto dall’esterno. I greci uscivano dallo scontro pluridecennale con una civiltà orientale che al culto della barba era particolarmente legata, e dalla quale occorreva in tutti i modi prendere le distanze: anche attraverso la creazione di una propria immagine fisica diversa. Questo riesce evidente nelle metope in stile dorico che raccontano le guerre contro i giganti o contro i centauri, o la lotta mitica tra Atena e Poseidone per il predominio sull’Attica, con la quale si celebra la vittoria della civiltà sulla barbarie: ma soprattutto nel fregio ionico della cella interna, quello rappresentante le Panatenaiche, dove tutte le figure maschili risultano sbarbate. Comincia insomma a delinearsi un nuovo concetto di virilità, che ha a che fare con la ragione, con l’ordine, col “disciplinare” sotto ogni aspetto il corpo, anziché con la sua libera e individualistica espressione. Mirone e Policleto anticipano o accompagnano con la loro scultura il modello umano che Socrate suggerisce nei suoi estemporanei “seminari”.

La vulgata diffusa da alcuni storici, tra i quali il solito Plutarco[8], vuole che il nuovo modello maschile sia stato introdotto in realtà verso la fine del quarto secolo, nel mondo ormai ellenistico, da Alessandro Magno. È molto più probabile, a mio parere, che nella propria autorappresentazione Alessandro abbia voluto ispirarsi proprio alla statuaria greca tardo-classica, per trasmettere di sé una immagine che rimandasse a origini divine. Ed è altrettanto plausibile che avendo iniziato la sua carriera di conquistatore molto giovane, ancora imberbe, o forse essendo piuttosto glabro di natura, abbia fatto di necessità virtù, scegliendo di imporre un modello, anziché conformarsi a quello tradizionale.
La cosa interessante è però che Alessandro obbligò anche tutti i suoi ufficiali e soldati a radersi, almeno prima di ogni battaglia, motivando l’imposizione con ragioni militari (la barba poteva dare agli avversari un appiglio cui aggrapparsi per disarcionarli, o per costringerli al combattimento ravvicinato, cosa che in condizioni di costante inferiorità numerica risultava estremamente svantaggiosa): quel che voleva indurre nei suoi uomini, in realtà, era la percezione anche fisica di una differenza nei confronti dei nemici, di una superiorità che si manifestava anche nella cura di sé. E, soprattutto, l’abitudine al rispetto delle regole e della disciplina. I vantaggi furono dunque parecchi: in questo modo il condottiero mitigò l’attacco di zecche, pulci e pidocchi che potevano dimorare nelle lunghe, calde e umide barbe; fece in modo che, nel momento dello scontro, il nemico non potesse usare la barba del soldato greco per trattenerlo e trafiggerlo con più facilità; diede ai suoi guerrieri una diversa impronta di appartenenza, e quindi un ulteriore stimolo al cameratismo.
Dopo Alessandro la moda di radersi si diffuse rapidamente in tutto il mondo ellenistico, a dispetto delle resistenze che possiamo immaginare si siano levate in difesa della tradizione e delle simbologie di privilegio connesse alla barba. Non erano però solo le autorità, espressione delle vecchie classi dominanti, a promulgare – a quanto pare, inutilmente – leggi e divieti: l’opposizione più forte veniva quasi ovunque dai filosofi. Naturalmente, da quelli di scuola non socratica. Per gli stoici, per i cinici e per gli epicurei radersi era un gesto contro natura, dettato dalla vanità e da una cura eccessiva rivolta al corpo[9]. La barba cominciò così ad essere uno specifico connotato della militanza filosofica, così come i capelli lunghi: mantello, barba e chioma incolta divennero i simboli distintivi del pensatore, quasi contrassegni abituali, al punto che nel suo Manuale Epitteto ammoniva a non considerare uno come filosofo per come porta il mantello e barba e capelli lunghi, ma a giudicarlo per il comportamento[10].
Non radersi stava diventando ormai una scelta non solo estetica, ma di vita. Equivaleva ad una ostentazione di resistenza nei confronti della tirannide, singola o collettiva che quest’ultima fosse. E non era intesa come una resistenza solo metaforica. Il vero filosofo si sarebbe fatto tagliare la testa piuttosto che soggiacere all’imposizione della rasatura.
Barbe latine
Quando cominciarono a intensificare i contatti col mondo ellenistico anche i Romani adottarono la moda “alessandrina”. Durante il periodo della monarchia e nei primi secoli della repubblica la barba aveva goduto in Roma della stessa considerazione e dello stesso significato che aveva presso gli altri popoli. Tito Livio racconta che dopo la presa della città i Galli Senoni entrarono anche in Campidoglio, dove trovarono solo anziani senatori che ostentavano lunghe e onorate barbe e li guardavano in sdegnoso silenzio. Lo sgarbo di uno dei Galli, che tirò la barba di un senatore per accertarsi che fosse vivo, provocò la reazione stizzita di quest’ultimo, e conseguentemente il massacro di tutti i notabili.
Duecento anni dopo quel guerriero irrispettoso non avrebbe più trovato nell’Urbe una barba da tirare: con Scipione Africano era penetrata anche a Roma l’usanza di farsi radere, adottata persino dal suo avversario politico giurato, Catone il Censore. Ed erano stati mutuati anche i significati della rasatura: per i romani radersi significava riconoscere l’importanza della disciplina e conferire al loro aspetto un tocco particolare di “romanità”, ciò che li distingueva dai “barbari”: per i loro comandanti ribadire l’autorità. Cesare si faceva la barba ogni mattina, i suoi soldati lo imitavano, ma non per questo – come lui stesso sottolineava – erano meno temibili e coraggiosi in battaglia. Scipione non aveva la barba, e Annibale si. Alla fine vinse Scipione.
Al taglio della barba si cominciò anche a dare un significato rituale. La “depositio barbae” divenne il rito di passaggio dall’età puerile a quella da adulto. Andare dal barbiere era considerato diventare uomo. E il rito assumeva particolare rilevanza quando si occupavano in giovane età certe cariche pubbliche. Dopo la prima rasatura Augusto andò a depositare solennemente i suoi peli (la “lanugo”) nel tempio.
L’usanza della rasatura del mento divenne nella Roma del periodo tardo repubblicano e nei primi secoli di quella imperiale un vero e proprio obbligo sociale (persino per gli schiavi, che naturalmente si rasavano da soli o a vicenda), tanto da essere abbondantemente citata nella letteratura, soprattutto in quella satirica. Da Orazio a Marziale e a Giovenale è tutto un gioco di ammiccamenti, vuoi alla bravura o alla malagrazia dei tonsores, vuoi ai vezzi, alle manie e alle sofferenze del loro clienti. Il tonsor era un personaggio chiave della quotidianità romana: quelli alla moda accumulavano delle vere fortune, altri campavano più modestamente, male botteghe degli uni e degli altri, le tonstrinae, erano comunque i luoghi deputati per gli incontri, gli scambi di notizie, i pettegolezzi: veri salotti per i quali transitava, o nei quali sostava, una moltitudine di persone. È rimasto celebre, a testimonianza del rilievo sociale assunto da questa occupazione, un epitaffio dedicato da Marziale al tonsor Pantagato:
Terra, sii (a lui) propizia come è giusto, appagata e leggera,
(ma) non potrai esser più lieve della (sua) mano d’artista[11].
Ed altrettanto significativa è la stigmatizzazione che fa invece Seneca dei clienti delle tonstrinae nel De brevitate vitae: “Tu chiami liberi da impegni questi, affaccendati tra pettine e specchio?”
La sterminata ritrattistica scultorea romana non lascia alcun dubbio. Tutti i ritratti dei personaggi più eminenti, dal citato Scipione giù attraverso Mario, Silla, Cesare, Cicerone, e quelli degli imperatori sino ad Adriano, ci mostrano volti perfettamente sbarbati (con l’eccezione di Nerone: ma di lui gli storici malevoli dicono che fosse particolarmente brutto, e che la barba serviva a coprire un sottogola deforme). (tav. 4) Per questo le sporadiche ricomparse della barba sono estremamente significative dei mutamenti di atmosfera che caratterizzarono le vicende dell’impero.
Agli inizi del secondo secolo, quando ancora il cristianesimo a Roma non era particolarmente diffuso, a fare opinione negli ambienti più intellettualmente sofisticati erano le dottrine di matrice stoica. Il già citato Manuale di Epitteto predicava il ritorno alla naturalezza, la rinuncia ad ogni abbellimento in contrasto con le leggi naturali, ivi compresa la rasatura. Adriano era un seguace dello stoicismo: dopo di lui lo sarà Marco Aurelio. Entrambi si fecero ritrarre con la barba. La cosa strana è che i loro rimanessero casi isolati, anche perché l’esercito romano era reclutato ormai in gran parte tra i barbari, gli imperatori arrivavano anche dalle province più periferiche e la disciplina e la romanità che il taglio della barba significavano per i legionari di Cesare erano svaniti da un pezzo. Dopo il trionfo del cristianesimo, però, portare la barba assumerà anche un altro significato di non conformità: Giuliano l’Apostata esibisce nei busti che lo ritraggono e nelle monete coniate durante il suo breve impero una barba superba, interrompendo solo momentaneamente una lunga sequenza di sbarbati che data da Costanzo Cloro e si protrarrà sino a Romolo Augusto.

Barbe cristiane
Il rapporto del Cristianesimo con la barba è sin da subito molto controverso. La tradizione iconografica, segnatamente quella bizantina, attribuisce a Gesù la barba intera e i capelli lunghi: ma nei primi tempi della cristianizzazione sono ancora rintracciabili delle eccezioni. Nei mosaici del Buon Pastore del Duomo di Aquileia e in quello del mausoleo di Galla Placidia, ad esempio, Cristo non ha affatto la barba. È possibile che ciò dipenda dal fatto che gli artisti del tardo periodo imperiale tendevano ad adeguare i volti dei personaggi sacri alla moda occidentale, raffigurandoli talvolta sbarbati. Ma è anche vero che nel cristianesimo delle origini su questo tema si apre un accanito dibattito, che vede schierati da un lato i cultori della continuità con l’ebraismo, intenzionati a mantenerne vive la gran parte delle tradizioni e delle prescrizioni (è la chiesa di Giacomo, a Gerusalemme), nonché delle esclusioni, e dall’altro gli ellenizzanti, guidati da san Paolo, aperti al proselitismo presso i gentili. Paolo non a caso prende posizione in una lettera ai Corinzi contro le lunghe capigliature maschili: ha nel mirino soprattutto i nazirei, coloro che hanno abbracciato l’insegnamento di Cristo ma ne fanno una questione interna al popolo ebraico, e adeguano il nuovo credo alle pratiche e alle attese messianiche tradizionali. Riferendosi a Giacomo, ad esempio, uno storico dell’epoca riferisce che “la forbice non scese mai sulla sua testa”, e nelle fonti più antiche la descrizione fisica degli apostoli si rifà sempre al modello gerosolimitano, barbe e capelli inclusi.
In quelle più tarde, e soprattutto dopo il passaggio dall’Alto al Basso Medioevo, l’immagine andrà invece cambiando. La barba verrà concessa solo al Cristo e ai pochi fedelissimi. Più complessa è la vicenda di Giuda, che Giotto raffigura sbarbato, ma che in genere è contraddistinto da una folta barba tendente al rossiccio, o addirittura al rosso vivo. Questi caratteri, una pelosità in genere irsuta e il colore, conferiscono al personaggio una connotazione diabolica, coerente con uno stereotipo della malvagità che la teologia dualistica medioevale va elaborando.
Quanto a Paolo, la sua scarsa simpatia per i nazirei non lo porta sino a rifiutarne completamente il modello. Sa di non poterlo fare e tenta di mediare. Vuole piuttosto moderarne gli eccessi, “razionalizzarlo”, ma soprattutto tende a riservarlo come segno distintivo al clero, creando una netta distinzione nei confronti dei laici. E comunque, aprirsi al mondo dei gentili implica anche accettarne o tollerarne, almeno in parte, i costumi.
Proprio la vicenda della rappresentazione iconografica della figura di san Paolo rispecchia esemplarmente questo lavoro di mediazione, proseguito poi nell’organizzazione della nuova chiesa, quando ormai il contrasto originario si era composto, non per un compromesso ma per la sparizione, dopo la distruzione di Gerusalemme, della fazione più giudeofila. Un affresco scoperto pochi anni fa nelle catacombe romane di Santa Tecla, risalente al IV secolo, ci offre probabilmente la più antica raffigurazione di san Paolo giunta fino a noi: e i connotati fisici più significativi che gli sono attribuiti, destinati poi ad essere ripresi in tutta l’iconografia sacra successiva, sono la barba lunga e nera e il capo calvo. Dando per scontato che a tre secoli dalla sua scomparsa nessuno ricordasse più le fattezze del santo, quell’immagine non può essere casuale, ha un preciso significato.
In effetti rappresenta una soluzione salomonica, che concilia perfettamente le due istanze, e al tempo stesso conferisce al vero fondatore del cristianesimo moderno una patente di filosofo, avvalorata tra l’altro dalla straordinaria somiglianza con taluni busti di Socrate (ma anche con quelli di Plotino). La barba è la componente fideistica, il capo calvo quella razionale. Per uno cresciuto nella cultura dell’ellenismo, la sintesi ideale. (tav. 5)

Tavola 1 – Barbe antiche

Tavola 2 – Barbe classiche (I)

Tavola 3 – Barbe classiche (II)

Tavola 4 – Barbe latine

Tavola 5 – Barbe cristiane

Tavola 6 – Barbe monastiche

Tavola 7 – Barbe Pontificie

Tavola 8 – Barbe diaboliche

Il medioevo

Barbe monastiche
La questione però, come prevedibile, non è affatto chiusa: trova anzi costante alimento nel proliferare di interpretazioni le più svariate del messaggio cristiano. In oriente e in occidente si sviluppano ben presto due tradizioni monastiche molto dissimili. Il monachesimo che fiorisce nella Tebaide o alle pendici del Sinai, così come il proliferare di eremiti, stiliti, anacoreti nel Fayun, in Siria o in Palestina, nasce dalla necessità di sfuggire alle persecuzioni più pesanti (quella di Domiziano, in particolare, o quella di Teodosio), e si caratterizza subito come una scelta radicale di fuga dalla società. È un monachesimo molto individualistico, che non guarda al proselitismo o all’organizzazione religiosa ma all’ascesi e alla salvezza individuale e pratica un rifiuto radicale di tutto ciò che crea vincoli con la vita terrena, ereditando ed esasperando la tradizione nazirea. In alcuni casi chi lo abbraccia arriva addirittura agli estremi di rifiutare gli abiti, per coprirsi solo con la barba e i capelli lasciati totalmente incolti. I peli vanno a costituire in fondo una barriera, uno scudo che isola dal contatto con gli altri.
Questa tradizione sarà conservata, sia pure moderandone un po’ gli eccessi, dalle chiese ortodosse di osservanza greco-orientale. Nella Filocalia dei padri Nepticiad esempio le barbe maestose e le chiome fluenti degli antichi padri d’Egitto o del Sinai sono citate a segno di una grande esperienza spirituale.
Anche il modello monastico rimarrà prevalentemente quello. Già i primi esperimenti orientali di vita cenobitica, come quello di san Pacomio nella Tebaide, hanno alla base, più che l’ideale di una vita comunitaria, quello di una zona franca nella quale, in assenza di regole, è possibile dedicarsi individualmente all’ascesi. Nell’oriente bizantino il controllo della vita sociale rimane ancora saldamente nelle mani dell’autorità secolare; la vita religiosa ha, almeno nel primo millennio, un suo percorso collaterale, individualistico, indirizzato alla salvezza personale ed estraneo alla sfera politica.
Le cose vanno diversamente in occidente, dove la chiesa viene presto investita dei ruoli organizzativi che spettavano in precedenza all’autorità civile. Per supplire al venir meno dell’impero essa deve darsi un’organizzazione più centralizzata. Diventa importante unificare il messaggio, dare corpo ad una dottrina coerente: e quando si tracciano e si impongono delle linee dottrinali e dei comportamentali comuni si finisce ogni volta per tagliare fuori grosse fette degli adepti. In tal senso, è più che mai necessario disciplinarne in qualche modo anche la visibilità e il riconoscimento. Già nei primissimi secoli, ad esempio, le battaglie contro i “deviazionisti”, i marcioniti e i circumcellioni, si disputano a colpi di interdizioni relative anche all’aspetto fisico. Il monachesimo stesso ha qui origini più tarde, e prende immediatamente un’altra connotazione. Lo spazio per le pratiche di ascesi individuale è molto più ristretto: occorre supplire al disfacimento della vecchia amministrazione imperiale, porsi in alternativa e spesso in contrapposizione ad essa, e quindi guadagnarsi la fiducia e il rispetto della popolazione.
Quali che siano gli scenari, nei primi secoli, quando già il verbo cristiano è diffuso in tutto l’occidente ma l’apostolato interessa aree e gruppi pur sempre limitati, ed è ancora ben lontano dall’aver conquistato le comunità rurali più disperse, la barba continua comunque ad avere un ruolo simbolico e distintivo importante. Per san Girolamo barba e capelli lunghi e trascurati sono il segno distintivo di una vita consacrata. San Colombano, l’irlandese che percorse mezza Europa fondando monasteri, e tutti i discepoli che ne seguirono l’esempio, erano immediatamente riconoscibili per le lunghe barbe e i capelli lasciati incolti sulle spalle. Nelle più antiche miniature cassinesi i monaci di San Benedetto, e il santo stesso, appaiono con la barba, anche se in segno di umiltà praticano già la tonsura dei capelli. La distinzione non veniva meno anche quando si rivestivano i ruoli istituzionali più alti: san Gregorio Magno, papa e benedettino, portava una lunga barba.
In alcuni casi questa andava anzi a sottolineare ancor più nettamente il nuovo status. Alcuni episodi sono paradigmatici. Ad esempio: l’elezione a vescovo di san Martino di Tours, quello del taglio del mantello, fu molto 0steggiata da una parte del clero per via del suo aspetto trasandato e della barba e dei capelli incolti. Eppure Martino arrivava dai ranghi della guardia imperiale, per la quale vigeva la rasatura del volto, e la scelta di trascuratezza era legata proprio alla crisi che lo portò alla conversione e poi alla fondazione di un monastero. Stessa vicenda per Ambrogio, che prima dell’elezione vescovile era un magistrato dell’Impero romano, e quindi si radeva. Quando fu eletto vescovo dal popolo milanese (a quanto pare contro la sua volontà: sembra infatti non fosse nemmeno battezzato), si fece immediatamente crescere la barba per adeguarsi alla tradizione apostolica.
In difesa della scelta “naturista” vengono poi elaborate le più sottili interpretazioni allegoriche delle sacre scritture. Da Cassiodoro, da Alcuino, da Rabano Mauro la barba è intesa come simbolo della chiesa stessa, del collegio apostolico, delle sue diramazioni e dei suoi legami (e tagliarla significa quindi recidere questi legami, togliere efficacia e legittimità al ruolo sacerdotale). Mentre per san Pier Damiani, qual è il significato dalla barba “se non la fortezza della divinità?” Per Anselmo d’Aosta, infine, “l’assenza di giustizia in una società è indecorosa come l’assenza di barba in un uomo”.
La barba può avere però anche altre insospettabili funzioni: può costituire ad esempio una corazza a difesa della virtù. Ciò vale segnatamente per le donne. Nella penisola iberica Dio arriva addirittura ad eccepire alla natura, aiutando alcune giovani come santa Paula di Avila o a santa Liberata a sfuggire a pretendenti o aggressori col far loro crescere una bella barba fluente. Il fatto che siano state santificate come vergini certifica il buon esito dell’espediente divino. Fa comunque riflettere il fatto che, prima di essere destinate dalla società dello spettacolo ai circhi e alle fiere, le donne barbute godevano degli onori degli altari[12]. (tav. 6)
Barbe pontificie
Per tutto il periodo classico non è dunque certamente questione di mode, quanto di “modi” d’essere. Nel caso della chiesa occidentale la novità è che il portare o meno la barba non ha più solo un forte risvolto religioso e sociale, ma ne assume anche uno politico.
Tutto ciò di cui ho parlato sopra vale infatti fino a quando l’egemonia della chiesa romana in occidente non è consolidata. Quando però dalla fase dell’evangelizzazione si passa a quella dell’organizzazione, per il clero secolare, destinato ad essere lo strumento operativo della nascente struttura, le cose poco alla volta cambiano. La barba rimane il marchio di una scelta eminentemente contemplativa. Ho provato a scorrere alcuni elenchi di papi, da san Pietro a Francesco, corredati anche dai ritratti ufficiali, e li ho messi a confronto. Bene, fino alla fine del settimo secolo non c’è un pontefice senza barba, ed entro la fine del millennio i menti e le guance scoperti si contano ancora sulle dita di una mano. Il rapporto si inverte invece a partire dal XII secolo, con una netta prevalenza di papi sbarbati. Si tornerà alla barba solo dopo la metà del ‘500, con Paolo III, ma sarà un intermezzo di meno di un secolo. Nel ‘600 sopravvive qualche raro pizzetto, poi la barba sparisce, e non compare più. (tav. 7)
I papi sbarbati cominciano ad apparire quando la Chiesa, a partire dai tempi di Carlo Magno, si confronta in maniera apertamente conflittuale con l’autorità imperiale, su un livello ormai paritario: in palio c’è l’eredità dell’autorevolezza discendente dall’impero romano. A quel punto i suoi funzionari, il clero secolare nella fattispecie, devono sottolineare anche nell’aspetto esteriore la continuità con quella istituzione; inoltre devono distinguersi dal clero regolare, che mantiene le sue tendenze centrifughe e autonomistiche, e di lì a poco anche dai riformatori interni, gli eretici, che vagheggiando il ritorno alla chiesa primitiva tendono a rivestirne letteralmente i panni. Già nel 1073 Gregorio VII fa divieto al clero secolare di portare barba e baffi (e raccomanda di radersi anche ai laici). Nel 1096 l’arcivescovo di Rouen irroga la scomunica a coloro che portano la barba: e un provvedimento simile viene adottato anche a Venezia dalle autorità ecclesiastiche nel 1102[13].L’appartenenza deve essere chiaramente testimoniata ed evidenziata già nell’aspetto immediato.
Barbe diaboliche
Il calo digradimento della barba all’interno della Chiesa è fedelmente documentato nelle immagini di ammonimento o di esemplarità che dall’inizio del secondo millennio cominciano ad apparire nei luoghi di culto. In esse non compaiono più soltanto simbologie identitarie, ma fa la sua comparsa anche il nemico, il diavolo. Ha prevalso infine nel cristianesimo occidentale l’opzione dualistica, quella che vede contrapposti in una lotta eterna il bene e il male, e mutua direttamente da una tradizione pagana mai del tutto soffocata, attraverso una sofisticata operazione di riciclaggio, tutto un pantheon di santi e di figure intermedie, funzionale a rendere più agevole la comunicazione con un dio unico, lontano e tremendamente indaffarato. Inoltre, il cattolicesimo romano, dopo aver sconfitto i diretti rivali almeno nella gran parte del mondo occidentale, serra le fila volgendosi al nemico interno, identificabile di volta in volta in ogni forma di dissidenza e di devianza.
Ora, Checché ne pensassero i padri della chiesa e gli apologeti provenienti dal mondo monastico, la barba, che pure viene attribuita allo stesso creatore, a suo figlio e ai primi apostoli, non è concepibile per le figure angeliche, che stanno a rappresentare una natura umana trascesa e dominata: mentre si presta benissimo a caratterizzare l’esatto contrario, la materialità e la natura animale, o meglio ancora bestiale, che ha prevalso sullo spirito. Finisce dunque tra i connotati fissi attribuiti al demonio e a tutti i suoi accoliti. La troviamo infatti già nei mosaici antecedenti il Mille, a Torcello, e torna immancabilmente in ogni raffigurazione del demonio dei successivi Giudizi Universali, e più tardi in quelle dedicate alle tentazioni portate direttamente a Cristo o ai vari santi e anacoreti (di fronte a resistenze particolarmente ostinate l’offerta assume carattere sessuale, e allora il tentatore assume le sembianze di una bella fanciulla – o di un baldo cavaliere, se ad essere tentata è una santa. Ma anche in questi casi qualcosa che gira storto, e provocalo smascheramento e la fuoruscita della barba, c’è sempre).
L’apparentamento diabolico alla barba – o anche più genericamente alla pelosità – è destinato ad una grossa fortuna nell’immaginario occidentale, e attraverserà anche le stagioni dei revival piliferi. Sarà successivamente trasferita nelle versioni laiche del “male”, nei cattivi delle fiabe, nei sovversivi, negli ebrei, o semplicemente riproposta in termini sempre più raffinati nella letteratura (dal Mefistofele di Faust al Mephisto di Tex Willer). E fin da subito verrà accreditato ai nemici esterni (islamici, vichinghi, mongoli), e a quelli interni (gli eretici) della cristianità. (tav.8)
Barbe ereticali
Non esistono raffigurazioni dei Bogomili e dei Catari che possano essere considerate attendibili, ma essendo il rifiuto di ogni cura del corpo uno dei precetti fondamentali del loro credo è presumibile che non perdessero affatto tempo a rasarsi. Lo stesso vale per tutte le altre sette ereticali. I ritratti che rimangono di Pietro Valdo e di fra Dolcino ce li mostrano infatti provvisti di barbe foltissime, e sottolineano una netta contrapposizione rispetto ai loro persecutori, a partire da Bernardo di Chiaravalle fino a san Domenico. Paladini strenui del modello “viso pulito” sono proprio i domenicani, i cacciatori di eretici più zelanti e i più convinti fautori della struttura dottrinale e gerarchica che contribuiscono in buona parte a definire (vedi Tommaso d’Aquino).
L’altro ordine creato da Innocenzo III in funzione antiereticale, quello francescano, mantiene invece in proposito posizioni più sfumate. In fondo il poverello di Assisi è stato recuperato all’ortodossia in extremis, con alcune concessioni bilanciate da altrettante limitazioni, e rimarrà sino alla fine dei suoi giorni ai margini di ciò che per la chiesa è tollerabile. La barba cortissima con la quale Giotto lo raffigura è una soluzione di compromesso paragonabile alla pelata di san Paolo. Dopo la sua morte, nel conflitto che scoppierà all’interno dell’ordine tra conventuali e spirituali, le barbe torneranno ad infoltirsi, fino a diventare d’uso comune presso i successivi ordini minori di figliazione francescana, primo tra tutti i cappuccini (anche questi, non a caso, ripescati per il bavero all’epoca della riforma protestante da Clemente VII – che tra l’altro si era fatto crescere la barba dopo il sacco di Roma da parte dei Lanzichenecchi, e la sfoggiò in occasione dell’incoronazione di Carlo V). Riesce un po’ strana invece l’immagine completamente sbarbata che Paolo Uccello ci ha tramandato di Jacopone da Todi. L’autore delle Laudiera apertamente schierato con gli spirituali, ed è quindi probabile che portasse la barba: ma a quanto pare per accoglierlo tra i beati si imponeva una “normalizzazione” del suo aspetto. (tav. 9)
Il declino dell’uso della barba nella chiesa è legato però anche ad altre contrapposizioni. La prima è naturalmente quella col cristianesimo orientale. Nel 1054 il patriarca di Costantinopoli Michele Cerulario, andando anche contro il volere dell’imperatore Costantino IX, rompe definitivamente i rapporti con la Chiesa latina. A provocare lo scisma ci sono annosi problemi di carattere teologico e dottrinario, ma c’è anche la questione della barba. Gli ambasciatori inviati da Leone IX per tentare di comporre il dissidio non vengono neppure ricevuti dal patriarca perché sono sbarbarti, segno interpretato come una manifestazione di disprezzo nei confronti del clero orientale, che portava la barba lunga per imitare Cristo (il Cristo tramandato dall’arte bizantina, perché nei vangeli non si fa mai cenno al suo aspetto fisico). La risposta è immediata: in occasione dell’anatema pronunciato nel luglio 1054 contro Michele si afferma: “portando barbe e capelli lunghi voi (i cristiani di rito orientale) rifiutate il legame di fratellanza con il clero romano, dal momento che questo si rade la barba e si taglia i capelli”. Non tutto, evidentemente, dal momento che come abbiamo già visto qualche anno dopo Gregorio VII ritiene necessario emanare in proposito un esplicito precetto sulla rasatura: ma ormai i due modelli sono chiaramente fissati, e continueranno a pesare per il futuro. Quasi quattro secoli dopo il cardinale Bessarione, un ortodosso convertitosi alla confessione romana, si vede sbarrata la strada al pontificato dal fatto di portare la barba, cosa che suscita sospetti sulla sincerità della sua conversione (in realtà, alle spalle di questa preclusione ci sono l’eccezionale intelligenza del cardinale, pericolosa in contesto di faide interne che aveva già portato all’elezione in contemporanea di tre diversi papi, e la sua volontà di tentare una riappacificazione con la chiesa orientale, invisa soprattutto al clero francese. Al suo posto viene eletto Callisto III Borgia, spagnolo, sbarbato e grande tessitore di intrighi).
Il confronto è aperto però anche con un ennesimo e sempre più temibile nemico, l’Islam, che la barba la impone a prescindere a tutti i suoi fedeli. Non a caso, a marcare la differenza, durante le crociate le milizie cristiane sfoggiano di preferenza volti perfettamente rasati.
Tra i costumi ispirati al presunto esempio di Maometto e raccolti nella sunnah c’è quello di una barba accorciata fino alla lunghezza di una spanna, al più sfoltita, ma mai rasa. Naturalmente anche tra il clero musulmano c’è chi affida ad una barba lunga e folta la propria autorevolezza e la testimonianza di fedeltà al presunto costume originario (e non a caso questa particolare immagine è riproposta con insistenza ed enfatizzata dall’effetto mediatico negli attuali rigurgiti di integralismo).Il precetto islamico ha in realtà radici molto antiche,che affondano nella tradizione delle popolazioni arabe e mediorientali, piuttosto che in caratteristiche o esigenze religiose particolari: ma dal momento in cui è entrato nel canone scritturale non lascia spazio a scelte alternative. La storia musulmana della barba è quindi molto più lineare di quella cristiana.
Barbe barbare
Torniamo però in Occidente, e andiamo finalmente a vedere cosa accade nel frattempo nel mondo laico, cercando di raccapezzarci in una documentazione ricca, ma spesso assai contraddittoria.
Dopo il crollo dell’impero romano le cose si sono complicate anche per quanto riguarda il “decoro” facciale. L’irruzione delle popolazioni “barbariche” ha rimescolato i costumi. Per i Germani la barba aveva grande importanza, la sua lunghezza segnava in pratica l’appartenenza alle diverse gerarchie sociali, la sua assenza era segno di schiavitù. Ma l’incontro con i romani, nei confronti dei quali un certo senso di inferiorità le popolazioni d’oltralpe continuavano a provarlo, non aveva tardato a influenzare anche i loro costumi. E questo torna ad accadere di volta in volta per tutti i popoli che vengono a contatto con l’impero, arrivino essi dal nord o dalle pianure pannoniche.
Non abbiamo immagini d’epoca relative ad Attila, ma uno degli ambasciatori inviati da Teodosio II ad incontrarlo lo descrive così: “Basso di statura, con un largo torace e una testa grande; i suoi occhi erano piccoli, la sua barba sottile e brizzolata; e aveva un naso piatto e una carnagione scura”. Un profilo chiaramente mongolico, nel quale la barba non ha in fondo grande rilevanza. Per Alarico invece disponiamo di un’unica raffigurazione frontale su un sigillo, e in essa il sovrano visigoto compare perfettamente sbarbato e presenta quei “tratti gentili” dei quali gli storici dell’epoca lo accreditavano. In effetti, a quanto risulta Alarico non voleva affatto contrapporsi al costume romano, ma ambiva anzi ad essere riconosciuto come un ufficiale dell’esercito imperiale, e le sue vicende e la sua ferocia nacquero proprio dal rifiuto di questo riconoscimento. Di Teodorico rimane invece un ritratto con barba (peraltro anche questo smentito poi dalla numismatica). La cosa mi sembra significativa, perché da parte del re dei Goti la contrapposizione nei confronti del potere imperiale (di Bisanzio) è già esplicita, e va ad infrangere una continuità di immagine che bene o male, sia pure solo formalmente,sino ad allora persisteva[14].
Anche gli invasori successivi, i Longobardi e i Franchi, sono in genere raffigurati con la barba. I primi dalle loro lunghe barbe pare prendessero addirittura il nome. Il loro codice prevedeva pene specifiche per chi osasse tirare la barba ad un guerriero (a quanto pare era un divertimento in voga), e anche dopo la conversione al cattolicesimo il costume in proposito rimase invariato, come testimonia il ritratto barbuto del loro ultimo re, Desiderio. I Franchi invece in genere non portavano la barba, ma amavano piuttosto i baffi sottili, anche se i sovrani della dinastia Merovingia sono ancora ritratti con barbe e chiome fluenti. C’è una formella rappresentante un barbuto Clodoveo che si converte al cattolicesimo nella quale è esemplificato perfettamente il processo di “normalizzazione” dei barbari. Attorno al sovrano, immerso nella fonte battesimale, gli ecclesiastici e i dignitari sono tutti rigorosamente sbarbati. Il capitolo successivo sembra dunque essere inevitabilmente l’adozione del costume romano, con la rinuncia alla barba, o almeno col suo disciplinato contenimento.
Non sarà tuttavia un passaggio immediato: nelle raffigurazioni di Carlo Magno la barba ricompare spesso (non sempre: ad esempio, in una moneta d’argento coniata nell’812 l’imperatore appare completamente sbarbato, e piuttosto in carne, e questa immagine corrisponde a quella tramandata dal suo biografo Eginardo). Nei suoi successori, a partire da Ludovico il Pio, appare però sempre più sottile e curata. La “romanizzazione” corre.
Lo stesso vale più tardi per i Normanni. Come i Longobardi[15], questi portavano la barba ad imitazione del loro dio guerriero e barbuto, Odino. Malgrado la conversione al cristianesimo e l’incontro con la cultura latina, che avviene soprattutto nell’Italia meridionale, conservano immutati molti aspetti del loro costume. Tanto che ancora a metà del XII secolo Ruggero II d’Altavilla promulga delle leggi che favoriscono chi porta la barba e multano chi la taglia. (tavola 10)
Contemporaneamente, nel mondo bizantino, per il quale possiamo fare riferimento ad una iconografia musiva abbastanza ricca e credibile, i laici, primi tra tutti dignitari, funzionari imperiali e ufficiali dell’esercito, hanno seguitato a conformarsi al modello latino. Le ragioni sono quelle accennate sopra: la necessità di una distinzione del mondo religioso da quello laico e di contrapposizione alle popolazioni non latine che premono da nord-est prima e da sud est poi. Giustiniano compare nei mosaici di Ravenna perfettamente sbarbato. Ma a partire dal VII secolo e dal regno di Eraclio si realizza una sempre maggiore “grecizzazione” dell’impero, accompagnata dalla riscoperta di un particolare valore identitario della barba. Uno dei successori di Eraclio, Costante II, viene addirittura soprannominato il “Pogonato”, ovvero il barbuto. Questo modello verrà adottato ininterrottamente, e segnatamente dopo lo scisma del 1054, da tutte le dinastie successive, fino ai Lascaris e ai Paleologi. Tra i nemici cui contrapporsi figurano infatti ormai anche gli eredi dell’impero occidentale.
Barbe regali
Non voglio forzare troppo l’interpretazione dei dati iconografici, ma come in quello dei papi, anche nel caso delle diverse dinastie che danno vita alle moderne monarchie occidentali le sequenze dei ritratti si rivelano molto eloquenti, fanno intravvedere linee e curve di tendenza abbastanza uniformi e significative.
Il passaggio al secondo millennio segna in Europa e nella fattispecie in Italia il definitivo prevalere dei volti sbarbati anche ai vertici del potere civile. I sovrani stranieri per le cui mani passa il potere sulla penisola sembrano via via adeguarsi. Ad esempio, mentre il Barbarossa porta con orgoglio addirittura nel soprannome il carattere maggiormente distintivo del suo aspetto, e il figlio Enrico VI ne segue con minor fortuna le tracce, già il nipote, Federico II, costruisce perfettamente la sua immagine di stupor mundi facendosi effigiare negli affreschi e nel dritto degli augustali perfettamente sbarbato.
L’imperatore italo-svevo aveva ben compreso già ottocento anni fa l’importanza dell’immagine quale mezzo di governo. In ogni raffigurazione risalente all’epoca, e di conseguenza poi in tutte quelle successive, il suo potere non appare più associato alla forza, ma all’intelligenza, alla sapienza. Alla forza ci si può contrapporre, all’intelligenza non ci si può che inchinare e tributarle omaggio. Con la proposta di un volto pulito, sereno, il sovrano si accredita di una compostezza e di un equilibrio che hanno qualcosa di sacrale: non vuole incutere timore (quando è il caso, sa usare altri mezzi) ma conquistare la fiducia e la devozione quasi religiosa del suo popolo. E chiede ai suoi baroni e ai dignitari di conformarsi al suo stile.
Federico fa scuola: anche i suoi successori, compresi gli avversari, come Carlo d’Angiò, ne adottano il modello, e lo perpetueranno poi sino agli albori del Rinascimento. E ciò che vale per l’impero vale naturalmente anche per le diverse monarchie nascenti.
Ripetendo l’operazione già compiuta per papi e imperatori e facendo scorrere ad esempio l’elenco dei sovrani francesi, si constata che tra i merovingi e i primi venti capetingi, a partire da Meroveo sino a Luigi VII, solo un paio presentano il volto rasato: mentre dopo la metà del XII secolo, da Filippo II Augusto in poi, sino ad arrivare a Francesco I, a Cinquecento ormai inoltrato, non ce n’è più uno che porti la barba. E anche la concessione a quella che sarà la moda rinascimentale dura pochissimo: dopo il 1560, e fino alla caduta della monarchia, si torna al modello sbarbato (con la sola eccezione di Enrico IV di Navarra: forse dovuta al fatto che proveniva dal mondo protestante). (tav. 11)
Un quadro pressoché analogo lo si ottiene d’altronde facendo scorrere altre dinastie, ad esempio quelle inglesi e quelle iberiche.

Tavola 9 – Barbe ereticali

Tavola 10 – Barbe barbare

Tavola 11 – Barbe regali

L’età moderna

Barbe rinascimentali
La moda “rinascimentale” cui accennavo fa riadottare la barba nell’Europa occidentale anche dai vertici politici e religiosi: e la definisco una “moda” perché a partire dal Cinquecento la presenza o meno della barba appare sempre più sganciata dagli originari significati simbolici e legata invece a fluttuazioni dettate da scelte estetiche e da un diverso tipo di appartenenze.
 La ricomparsa nel Rinascimento dei volti incorniciati della barba non ha motivazioni politiche. Nasce piuttosto dal rinnovamento del pensiero che si produce in seno all’umanesimo, a partire da quello italiano. Si potrebbe parlare in proposito di una secolarizzazione, e più ancora di una personalizzazione individualistica, del modello di virilità. In altre parole: nel corso del medioevo la società laica ha costantemente cercato di conformarsi all’immagine della classicità: in maniera più o meno consapevole e voluta era prigioniera della pesantissima eredità della civiltà romana, nei confronti della quale provava un complesso di inferiorità. Con l’umanesimo questa soggezione viene meno: i nani sono saliti sulle spalle dei giganti, e guardano oltre. Ma per farlo devono liberare e riabilitare anche ogni espressione di naturalezza, di diversità e di individualità dei singoli corpi, ivi compresa la barba: ciò che invece era sacrificato, nel modello latino (e nel suo adattamento cristiano), al primato della “civitas”, della appartenenza ad un superiore contesto nel quale l’individuo si riconosceva e si annullava.
La ricomparsa nel Rinascimento dei volti incorniciati della barba non ha motivazioni politiche. Nasce piuttosto dal rinnovamento del pensiero che si produce in seno all’umanesimo, a partire da quello italiano. Si potrebbe parlare in proposito di una secolarizzazione, e più ancora di una personalizzazione individualistica, del modello di virilità. In altre parole: nel corso del medioevo la società laica ha costantemente cercato di conformarsi all’immagine della classicità: in maniera più o meno consapevole e voluta era prigioniera della pesantissima eredità della civiltà romana, nei confronti della quale provava un complesso di inferiorità. Con l’umanesimo questa soggezione viene meno: i nani sono saliti sulle spalle dei giganti, e guardano oltre. Ma per farlo devono liberare e riabilitare anche ogni espressione di naturalezza, di diversità e di individualità dei singoli corpi, ivi compresa la barba: ciò che invece era sacrificato, nel modello latino (e nel suo adattamento cristiano), al primato della “civitas”, della appartenenza ad un superiore contesto nel quale l’individuo si riconosceva e si annullava.
Il passaggio è come sempre perfettamente scandito dall’iconografia. Lungo tutto il periodo che potremmo definito pre-umanistico (grosso modo, il XIV secolo) e in quello che ha visto fiorire l’umanesimo fiorentino (XV secolo), i volti dei maggiori letterati, da Dante a Petrarca, a Boccaccio, fino a Poliziano, quelli degli artisti, da Giotto a Botticelli, ma anche quelli dei filologi e dei pensatori, da Marsilio Ficino a Leon Battista Alberti a Pico della Mirandola, appaiono perfettamente rasati. (tav. 12)
Nel Giudizio universale dipinto da Giotto per la cappella degli Scrovegni il pittore si auto ritrae in mezzo a persone nella quasi totalità sbarbate (le sole eccezioni sono costituite dal Cristo stesso e da alcuni apostoli). Danno il loro contributo all’immagine di politezza e di uniformità anche le schiere angeliche, che sembrano uscite da una pubblicità di lamette da barba. Non meno significativo in questo senso appare il Corteo dei Magi di Benozzo Gozzoli, e persino gli anacoreti che popolano la Tebaide del Beato Angelico sono per la stragrande maggioranza accuratamente sbarbati. Il tardo-gotico interpreta liberamente e con molta fantasia le situazioni e i costumi, ma i volti puliti rimangono evidentemente quelli della quotidianità, o almeno, ne rispecchiano una ideale. Li ritroviamo poi tali ancora agli albori del Rinascimento, ad esempio nella cappella Tornabuoni affrescata da Domenico Ghirlandaio in Santa Maria Novella, nella Camera degli sposi del Mantegna e nei ritratti di Antonello da Messina.
Con Masaccio però le cose già cambiano. L’Adamo della Tentazione nella Cappella Brancacci ha la barba: e come lui quasi tutti gli apostoli che compaiono ne Il tributo, o i carnefici della Decapitazione di san Giovanni. È difficile stabilire quanto questo cambiamento sia da attribuire ad una sorta di realismo “ricostruttivo” e quanto invece ad una presa diretta: di fatto, nell’immaginario iconografico la barba sta rientrando.
Di questo ritorno Masaccio è però solo un sintomo, e piuttosto precoce, perché i maggiori protagonisti della politica italiana del secondo Quattrocento, da Lorenzo de’ Medici a Federico di Montefeltro, da Ludovico il Moro ai Gonzaga, continuano poi ad essere rappresentati con volti perfettamente puliti, sia nei grandi affreschi celebrativi o allegorici, sia nei ritratti su tela o su tavola. Anche i loro oppositori, come il Savonarola, rimangono conformi al modello latino. Modello che ritroviamo ancora, nei primi decenni del secolo successivo, nei ritratti di intellettuali come Machiavelli e Guicciardini. Questi ultimi però già appaiono in ritardo rispetto alla moda sopraggiunta nel frattempo: in entrambi evidentemente ancora la vince un attaccamento profondo alla civiltà romana. (tav. 14)
Già attorno alla metà del Quattrocento tuttavia altri personaggi cominciano ad ostentare barbe importanti. La prima categoria sociale ad adottare il nuovo stile è naturalmente quella degli artisti. Paolo Uccello, ad esempio, nella tavola del Louvre (Cinque maestri del Rinascimento fiorentino, del 1450) che lo vede in compagnia di Giotto, Donatello, Manetti e Brunelleschi, sembra tornare direttamente al modello ebraico (d’altro canto, proprio in questo periodo si diffonde l’interesse per la lingua ebraica antica, fino ad allora praticamente sconosciuta in Europa, che darà vita alla revisione delle traduzioni bibliche e soprattutto agli studi sulla qabbalàh e all’esoterismo alchemico). L’unico suo collega barbuto in questo caso è Donatello.
Poi, agli inizi del Cinquecento, la nuova moda esplode. L’abbracciano sia gli artisti (Leonardo, Michelangelo, Raffaello, Tiziano) che i letterati (Boiardo, Ariosto), ma è oltremodo significativo il fatto che lo facciano anche coloro che dettano le nuove regole del costume (Castiglione, Bembo, Della Casa). Immediatamente a seguire vengono poi, come abbiamo già visto, imperatori, principi, papi. (tav. 13)
Da dove nasce questa trasformazione? È accaduto che dopo la metà del XV secolo (ma il fenomeno era iniziato già almeno un trentennio prima) la caduta di Costantinopoli e la fine dell’impero bizantino hanno spinto in occidente un gran numero di filologi e pensatori legati alla cultura greca, che portano con sé la lingua ma anche un patrimonio di opere preziose e praticamente sconosciute, assieme a un grande repertorio di immagini. Una cosa analoga avviene, a fine secolo, con la cacciata degli ebrei dalla penisola iberica, che produce una straordinaria migrazione intellettuale. La nuova attenzione alla grecità e all’ebraismo, il rapporto stesso con persone che praticano il modello orientale, diffondono anche un diverso approccio estetico: alla razionalità pratica romana si sostituiscono la pensosità filosofica greca e il messianismo esoterico. Platone e Aronne hanno la meglio su Tommaso d’Aquino, anche nell’immagine.
Il fenomeno dilaga, ma (almeno nella prima metà del ‘500) non si lega alle contrapposizioni politiche e religiose. La barba non rientra nelle rivendicazioni dei maggiori riformatori, né di quelli laici come Erasmo o né di quelli religiosi come Lutero[16], Melantone e Zwingli, che continuano ad essere tutti perfettamente sbarbati (l’unica eccezione è rappresentata da Calvino): questi ultimi l’hanno addirittura in sospetto, visto che era stata caratteristica, tra i loro precursori, delle correnti più libertarie (Wycliff e Huss), e che viene ora adottata prontamente dall’ala più estremista (Socino, Giovanni di Leida). (tav. 15)
La barba non rappresenta più comunque un inequivocabile simbolo distintivo. Durante le guerre di religione in Francia, ad esempio, la troviamo equamente distribuita tra le due fazioni contrapposte. Enrico IV di Borbone sfodera una barba fluente, così come molti altri esponenti degli Ugonotti, ma questo vale anche per i Guisa, per gli Angiò e per i Lorena, che appartengono al partito del cattolicesimo intransigente. Allo stesso modo in Inghilterra la portano sia l’anglicano Enrico VIII che il cattolico Thomas More. Pare che quest’ultimo, fatto condannare dal re alla pena capitale, un attimo primo di essere decapitato abbia sollevato il capo dal ceppo e abbia raccolto la folta barba avanti a sé, in modo che non fosse sfiorata dalla scure, dicendo: “This hath not offended the king” (“Questa non ha tradito il re”)[17].

Barbe controriformiste
Il processo di “domesticazione” della barba occupa il secolo che va dalla metà del Cinquecento a quella del Seicento. Accompagna la reazione agli sconvolgimenti “rivoluzionari” di quello precedente. È un moto di assestamento, ma al tempo stesso è la spia di una importante novità: il diverso rapporto con la natura. Testimonia infatti visivamente, in maniera straordinariamente immediata, che persino una delle manifestazioni più evidenti del potere di quest’ultima sull’uomo, sul suo aspetto, può essere disciplinata, irreggimentata, costretta in schemi geometrici. È una cosa diversa dalle barbe squadrate dei mesopotamici o dalle finte barbe cilindriche degli egizi: diversa sia per ciò che sta a simboleggiare che per i modi in cui lo fa. Il paradosso è che, almeno sul piano fisico, la resistenza più forte a questo processo di razionalizzazione sembra venire proprio da coloro che su quello spirituale lo stanno portando avanti.
Ancora una volta possiamo infatti constatare come, quando la moda della barba comincia a tramontare, negli decenni finali del XVI secolo, gli ultimi a rimanerle fedeli siano gli uomini di scienza e i filosofi (Bernardino Telesio, Giovanni Keplero, Giordano Bruno, John Dee, Francesco Bacone, Galileo Galilei). Quasi che la “filosofia della natura” che in un modo o nell’altro tutti quanti professano trovi un riscontro nella “naturalezza” dell’aspetto. E infatti quest’ultimo sembra inquietare, al pari delle loro idee, le istituzioni religiose ufficiali, siano esse quella cattolica, quella luterana o quella anglicana: ragion per cui le istituzioni corrono ai ripari. Mezzo secolo dopo nessuno tra i maggiori filosofi e scienziati, da Cartesio a Spinoza, a Pascal, a Newton, porterà la barba. E i letterati li hanno preceduti nel riallinearsi: la barba di Tasso è già molto più timida e curata, a confronto con quelle di Ariosto e Boiardo, e in Giovanbattista Marino è ridotta alla combinazione “essenziale” di baffi e mosca sul mento. (tav. 16)
In che modo la Chiesa della Controriforma corra ai ripari è noto per le vicende di Bruno e di Galilei: ma lo si evince altrettanto bene, per quel che concerne il nostro specifico discorso, da una vicenda particolare, quella del cardinale Carlo Borromeo, titolare della gigantesca statua di Arona (e parente del Federico manzoniano). Il Borromeo, che aveva sempre portato la barba, comincia a raderla in segno di penitenza negli ultimi anni della sua vita, a seguito dell’ennesima epidemia di peste: ma non si limita a questo. In qualità di arcivescovo di Milano emana nel 1576 una lettera pastorale, De barba radenda, con la quale impone il volto rasato a tutti i sacerdoti della sua diocesi. Le motivazioni addotte sono le più diverse (il vino e il pane consacrati che possono essere dispersi, ecc), ma la sostanza è che occorre educare ex novo una classe di sacerdoti dai quali l’abdicazione al “comune ornamento del volto” sia vissuta come rinuncia ad ogni ostentazione, vanità mondana e superbia. C’è soprattutto il convincimento che “con l’habito differente da gl’altri habbiamo sempre una singolar conversatione di vita, che sia degna del stato, et professione nostra”. L’iniziativa di Carlo Borromeo suscita scarso entusiasmo, e anzi, incontra una decisa presa di distanza nella curia romana: ma non viene ufficialmente smentita, e poco alla volta verrà adottata da tutte le diocesi dell’Italia settentrionale e d’oltralpe.
C’è però un’eccezione, ed è costituita come sempre dagli ordini regolari, anche da quelli che nascono proprio dallo spirito controriformista, a partire dai Gesuiti, dagli Scolopi e dai Teatini: tutti i fondatori di questi ordini (Ignazio di Loyola, Giuseppe Calasanzio, Gaetano Thiene) sfoggiano la barba (Thiene la manterrà anche quando sarà nominato papa) e lo stesso faranno i loro confratelli. Nel caso dei gesuiti l’eccezione riguarda quasi esclusivamente coloro che svolgono opera missionaria in Asia o nelle Americhe, come Francesco Saverio o Matteo Ricci. Operando in mezzo a popolazioni naturalmente molto glabre, sono in qualche modo autorizzati a sfruttare il fascino e il timore che la barba ha esercitato su queste sin dai primi contatti con gli europei (come del resto fanno gli esploratori e i conquistadores, da Vespucci a Magellano, da Cortés a Pizarro, con la sola eccezione di Colombo) per la sua naturale associazione alla saggezza e alla virilità ma, in questo caso, soprattutto per quella alla potenza e alla superiorità tecnologica (tav. 17).
Questi ordini, così come quelli che nascono dalla riforma di altri preesistenti – vedi i cappuccini – non sfuggono affatto al controllo: dimostrano al contrario quanto la Chiesa sappia essere duttile di fronte all’insorgere di situazioni nuove, come già aveva saputo esserlo tre secoli prima con i francescani. Sono camere di decompressione che permettono di non disperdere energie riformatrici altrimenti poco disciplinabili. Se poi queste energie possono essere incanalate in paesi lontani, tanto di guadagnato.

Una temporanea eclisse
Ordine e disciplina sono caratteristiche che cominciano ad essere richieste nella seconda metà del XVI secolo non solo ai sacerdoti, ma anche ad un’altra categoria, quella dei militari. Oltre a rinnovare le modalità di addestramento delle milizie e a rivoluzionare le strategie, lo statolder Maurizio di Nassau impone per primo alle sue truppe (pressappoco negli stessi anni in cui Carlo Borromeo lo fa coi suoi sacerdoti) l’adozione di una divisa uguale per tutti e l‘uniformazione delle acconciature, riproponendo e adeguando alle nuove tecnologie quello che già era stato l’intento di Alessandro Magno. Uomini che vestono tutti allo stesso modo e presentano tutti lo stesso aspetto saranno uniti non più in una solidarietà di banda, ma nella compattezza di un esercito. In questa prospettiva di irreggimentazione e di modernizzazione il problema della barba non è secondario (anche se poi il riformatore stesso esibisce una bella barba rossiccia). Entrano in ballo le innovazioni tecnologiche. L’uso di armi da fuoco che funzionano con meccanismi di accensione ad acciarino, a miccia o a pietra focaia rende la barba non solo ingombrante ma anche pericolosa, per il rischio costante che vada a fuoco.
Per le fanterie della guerra moderna la rasatura diventa in pratica una necessità, che verrà tradotta immediatamente in obbligo: e l’obbligo verrà poco alla volta esteso a tutti quanti i corpi in tutti gli eserciti (con strane eccezioni: presso l’esercito borbonico, ad esempio, i militari del genio erano tenuti a portare la barba). Se verso la metà del Seicento i soldati de La ronda di notte di Rembrandt mostrano ancora pizzetti e in qualche caso barbe, sia pure molto curate e tagliate corte, quelli raffigurati da Pieter van Bloemen alla fine del secolo sono completamente sbarbati. Agli inizi del Settecento i Soldati che giocano a carte di Giacomo Ceruti ci confermano che il look è ormai cambiato, e la splendida ricostruzione ambientale operata da Kubrick in Barry Lyndon, filologicamente accuratissima e basata sulla pittura dell’epoca, ci mostra quale effettivamente era l’aspetto dei militari settecenteschi.
 Più ancora di qualsiasi obbligo vale però stavolta il dettame della moda, nel quale giocano fattori che davvero rientrano nell’imponderabile (e creano forti dubbi sulla possibilità di iscrivere i fenomeni sociali entro schemi razionali di lettura, e quindi sul lavoro stesso che sto facendo). Così come erano tornate, nel volgere di un secolo le barbe spariscono: e sono sostituite, a partire dalla metà del Seicento, dal trionfo delle parrucche. Sembrerà paradossale, ma la nuova svolta estetica non è in contraddizione con quanto dicevo sopra. Il XVII secolo è infatti particolarmente inquieto, e la situazione di continua belligeranza educa a uno stile militaresco e mascolino anche nell’aspetto: come racconta Manzoni nell’episodio del duello dell’Innominato, la litigiosità non è prerogativa solo delle grandi dinastie, ma è diffusa nella quotidianità da piccoli o grandi potenti e prepotenti, e questo atteggiamento impone di esibire un particolare phisique du role. Negli abiti prevale il cuoio, con grossi cinturoni cui vengono appese lunghe spade e con stivali pesanti a gamba alta e a tacco rialzato, abbondano i mantelli, che ingrossano la figura, e riesce opportuno a questo punto enfatizzare anche le dimensioni del capo con enormi cappelli a larga tesa e con una abbondante peluria, a minaccioso segnale di grande virilità.
Più ancora di qualsiasi obbligo vale però stavolta il dettame della moda, nel quale giocano fattori che davvero rientrano nell’imponderabile (e creano forti dubbi sulla possibilità di iscrivere i fenomeni sociali entro schemi razionali di lettura, e quindi sul lavoro stesso che sto facendo). Così come erano tornate, nel volgere di un secolo le barbe spariscono: e sono sostituite, a partire dalla metà del Seicento, dal trionfo delle parrucche. Sembrerà paradossale, ma la nuova svolta estetica non è in contraddizione con quanto dicevo sopra. Il XVII secolo è infatti particolarmente inquieto, e la situazione di continua belligeranza educa a uno stile militaresco e mascolino anche nell’aspetto: come racconta Manzoni nell’episodio del duello dell’Innominato, la litigiosità non è prerogativa solo delle grandi dinastie, ma è diffusa nella quotidianità da piccoli o grandi potenti e prepotenti, e questo atteggiamento impone di esibire un particolare phisique du role. Negli abiti prevale il cuoio, con grossi cinturoni cui vengono appese lunghe spade e con stivali pesanti a gamba alta e a tacco rialzato, abbondano i mantelli, che ingrossano la figura, e riesce opportuno a questo punto enfatizzare anche le dimensioni del capo con enormi cappelli a larga tesa e con una abbondante peluria, a minaccioso segnale di grande virilità.
Non tutti però questa “virilità” sono in grado di esibirla: la sifilide, arrivata dalle Americhe nel secolo precedente e diffusasi in un baleno in tutto il continente, si manifesta anche con la caduta a chiazze dei capelli. È il meno tragico dei suoi effetti, anche se è uno dei più evidenti e imbarazzanti: ed è possibile ovviarvi solo adottando una parrucca.
La moda secentesca è agli inizi prevalentemente maschile, e presenta anche degli aspetti di praticità. Consente ad esempio di difendersi meglio dalla invadenza dei pidocchi (una coabitazione trascurata in genere dalla storiografia, ma che ha fortemente condizionato la vita quotidiana sino a meno di un secolo fa), le cui uova posso essere più facilmente rimosse da una parrucca che dai capelli naturali, e contribuisce paradossalmente a migliorare una igiene personale che pativa ancora diversi tabù rispetto agli effetti e alle frequenze dei lavacri. Naturalmente, le parrucche, quelle confezionate con capelli naturali (il che tra l’altro crea un vero e proprio mercato, e assicura un piccolissimo cespite anche alle fanciulle più povere) sono costose, se le possono permettere solo i nobili e i benestanti, e questo ne fa un altro segno di distinzione. I più poveri devono accontentarsi infatti di toupet confezionati con peli di capra, crine di cavallo o code di bue.
 La barba però non si combina affatto con l’uso delle parrucche: ne evidenzia clamorosamente l’artificiosità, rendendole grottesche, un po’ troppo persino per un gusto come quello barocco che il grottesco lo apprezza. Indossare la parrucca comporta quindi la rasatura completa e costante del viso, che al più lascia spazio al vezzo di un paio di baffi e di un pizzetto sottili (il modello reso famoso dai tre moschettieri). Il cambiamento di modello trova riscontro persino nell’uso linguistico: l’antico “barbiere” diventa il moderno “parrucchiere”.
La barba però non si combina affatto con l’uso delle parrucche: ne evidenzia clamorosamente l’artificiosità, rendendole grottesche, un po’ troppo persino per un gusto come quello barocco che il grottesco lo apprezza. Indossare la parrucca comporta quindi la rasatura completa e costante del viso, che al più lascia spazio al vezzo di un paio di baffi e di un pizzetto sottili (il modello reso famoso dai tre moschettieri). Il cambiamento di modello trova riscontro persino nell’uso linguistico: l’antico “barbiere” diventa il moderno “parrucchiere”.
A traghettare la parrucca da rimedio di fortuna a vera e propria moda è la corte parigina. Già Luigi XIII ne aveva adottata una in tarda età: il figlio, il Re Sole, deve ricorrervi già a diciassette anni, dopo che una malattia lo ha lasciato totalmente calvo. Uno dei suoi primi atti, una volta salito al trono, è l’approvazione di una cinquantina di licenze per artigiani parigini creatori di parrucche. Naturalmente i cortigiani si adeguano, soprattutto quelli che a Versailles convivono quotidianamente col sovrano: ma non solo loro. I miei eroi delle prime guerre indiane, ad esempio, Robert De La Salle e Henri de Tonti, si fanno ritrarre con fluenti cascate di riccioli (nel secondo abbinate alla mano di ferro che lo rese famoso tra gli Irochesi). Non credo girassero così conciati per le foreste dei Grandi Laghi o sulle rive del Mississippi, ma certamente sfoderavano le loro parrucche in occasione degli incontri con i capi delle nazioni indiane. Dalla Francia, all’epoca considerata arbitra del costume, la moda si diffonde poi velocemente in tutta l’Europa. Lo stesso sovrano Carlo II se ne fa promotore, per motivi analoghi a quelli di Luigi XIV, in Inghilterra.

Tavola 12 – Rasature umanistiche

Tavola 13 – Barbe rinascimentali

Tavola 14 – Sbarbati illustri

Tavola 15 – Barbe protestanti

Tavola 16 – Barbe controriformiste

Tavola 17 – Barbe missionarie e conquistatrici

Tavola 18 – Volti illuminati

Nel diciottesimo secolo però l’affermazione della virilità lascia il posto alla ricerca della stravaganza, della raffinatezza. L’effetto cui si mira non è più quello del guerriero ma quello del cicisbeo. Le parrucche si coprono di cipria, si colorano, si ingentiliscono. Diventano un normale capo d’abbigliamento, e quindi sono soggette al variare del gusto, anziché a quello delle situazioni. Mozart e Marivaux ne vanno pazzi, e ne cambiano una al mese. Ma nemmeno filosofi e pensatori professionisti della trasgressione (intendo: che sulla trasgressione hanno costruito le loro fortune) come Voltaire e Rousseau vi rinunciano. Non mi sembra un caso che ad apparire in tutti i ritratti sempre a capo nudo sia Diderot, che dalla trasgressione guadagna invece la galera. Ad apprezzare le parrucche sono in realtà ormai soprattutto le donne, ma ciò non toglie che anche i maschi continuino a farne uso per tutto il secolo, fino a quando la rivoluzione francese le spazzerà via assieme alle teste che le indossano, senza che alcun ghigliottinato possa ripetere il gesto di sir Thomos More.
Tra obblighi, divieti e mode, nel corso del Seicento e del Settecento la ripulitura dei volti è quindi pressoché totale. Persino i rivoluzionari rinunciano a quello che per tutto il medioevo e oltre era rimasto un segno distintivo delle dissidenze: tra i protagonisti delle rivoluzioni inglesi seicentesche non ce n’è uno, nemmeno tra i Livellatori e i Diggers, che porti la barba (si concedono al più i soliti curatissimi baffetti); tra quelli delle rivoluzioni settecentesche (compresa quella americana) le guance rasate saranno la regola fissa. Del resto, il riferimento storico ideale dei rivoluzionari francesi è ancora la repubblica romana, alla quale si ispirano direttamente, ad esempio, anche i modelli istituzionali: consoli e tribuni non ricompaiono a caso. Persino gli estremisti dell’egualitarismo, come Saint-Just prima e poi Babeuf e Filippo Buonarroti, rimangono su quella falsariga. Così come lo sono, all’altro estremo, gli alfieri della reazione: Wellington, Constant, De Maistre, Chateaubriand, hanno il volto rasato come Robespierre, come Danton e come Napoleone. (tav. 15)
La barba rimane piuttosto un tratto distintivo degli “esclusi”, dei marginali e degli irregolari. Sia quella letteraria di Robinson Crusoe, siano quelle reali (il terribile Barbanera) raccontate dallo stesso De Foe nelle Vite di Pirati, o dai viaggiatori del Gran Tour che percorrono remote vallate alpine e incappano nei briganti calabresi, dai rarissimi temerari che si inoltrano nei Balcani o nel Caucaso, dai disgraziati naviganti abbordati dai corsari barbareschi (come accade a Cervantes), l’abbinamento è comunque sempre a mondi selvaggi e ad una umanità semi-primitiva o degenerata.
In queste categorie rientrano anche i barbuti delle fiabe, che conservano una più o meno ravvicinata parentela con l’immagine diabolica. Sono rappresentati con barbe ispide e malauguranti gli orchi delle fiabe nordiche, i malvagi tenebrosi come Barbablu, la gran parte dei protagonisti negativi: e continueranno ad esserlo anche dopo, sia nella letteratura per l’infanzia, come il Mangiafuoco di Collodi, che in quella popolare, come il Fagin di Dickens.Il messaggio trasmesso tanto ai bambini che agli adulti è: diffidate dell’uomo con la barba.
Questo messaggio rimarrà invariato sia nel corso dell’Ottocento, quando le quotazioni della barba torneranno decisamente a salire, che nel secolo successivo, quando scenderanno ai minimi storici, e quando i cattivi delle fiabe saranno sostituiti da quelli dei fumetti o del cinema[18]. Probabilmente sull’immaginario popolare pesa, oltre retaggio delle paure religiose, il ricordo di lontane terribili esperienze, gli antichi popoli invasori, o quello più recente delle soldataglie che imperversano a margine di ogni guerra, o delle prepotenze e nefandezze nobiliari: e su questi ricordi fa leva l’ostracismo decretato alla barba dalla modernità. Ma va anche tenuto presente che, si tratti di un reverenziale timore o di una minacciosa paura, è in fondo questo l’effetto che chi porta la barba intende suscitare.
Con l’ingresso nell’età moderna l’ornamento pilifero del viso ha perso dunque le sue tradizionali valenze simboliche e lascia spazio alla funzionalità. Il volto sbarbato è funzionale in primo luogo al nuovo modo di produzione. Nel XVIII secolo il decollo della rivoluzione industriale e il trasferimento di quelle che erano attività artigianali in grandi opifici, pieni di macchinari complessi, di ingranaggi e di cinghie di trasmissione, di polvere e di fumo, rende prioritario il problema della sicurezza e dell’igiene. La barba può rappresentare un pericolo, e costituisce comunque un impedimento, oltre ad essere associabile ad un sospetto di scarsa disciplina. Inoltre, dopo che van Leeuwenhoek ha scoperto l’esistenza dei batteri, si fa sempre più pressante il sospetto che i peli ne costituiscano il naturale ricettacolo, e quindi siano decisamente insalubri.
La rasatura poi è funzionale anche allo spirito dell’emergente stato nazionale, nel quale tanti cittadini devono ottemperare alle stesse leggi, parlare la stessa lingua, condividere le stesse tradizioni, magari create ex novo. Torna il modello latino, riadattato ai tempi e alle nuove circostanze. Il riferimento non è più quello verticale, ad un sovrano, ma quello orizzontale ad un patto sociale, ad una convenzione di coesistenza. E più i contraenti sono simili anche nell’aspetto, più si “uniformano”, maggiore sarà la probabilità che si riconoscano, si fidino e si rispettino reciprocamente.
C’è anche, senza dubbio, nelle guance pulite l’affermazione di un significato simbolico che aveva cominciato a circolare già con Cartesio (ma molto prima ancora, in termini più sfumati, con Socrate): la razionalità che trionfa sulla natura, lo spirito di geometria, come l’avrebbe definito Pascal, che diventa la chiave di lettura del mondo: e la geometria postula superfici lisce, tratti lineari e scoperti. Lichtenberg affermava che “È impossibile portare la fiaccola della verità tra la folla senza bruciare qua e là una barba o una parrucca”.
Infine, come abbiamo visto, ha un peso ben più significativo che non nelle epoche precedenti l’esigenza di conformarsi alla “moda”. L’assolutismo propone modelli di riferimento forti, e crea centri che dettano le regole del costume, mentre la nascita di una nutrita pubblicistica provvede a diffondere queste ultime. La rasatura è entrata a far parte del codice di buone maniere dei gentiluomini. Quella che era una scelta etica diventa una questione di etichetta. E come tale, per una serie di ricadute che non sono ostacolate da differenze di ceto e di educazione, si diffonde più facilmente e più universalmente.
Ecco perché nelle opere di Joshua Reynolds e in quelle di William Hogarth, alle quali Kubrick si è rifatto per le ricostruzioni ambientali, non compare mai alcun personaggio con la barba: e se il primo ritrae il mondo aristocratico e alto borghese, più sensibile ai dettami della moda, il secondo ci offre dei realistici spaccati di vita popolana nei quartieri operai: eppure, anche dove regna la miseria più nera, i volti appaiono tutti più o meno accuratamente sbarbati.
Insomma: riforme religiose, rivoluzione militare, rivoluzione scientifica, rivoluzione industriale, nascita dell’igiene, rivoluzioni politiche e sociali, i grandi rivolgimenti che segnano l’ingresso del mondo occidentale nella modernità, sono tutti accomunati da un progressivo rifiuto delle lanugini ornamentali.
Dove poi questi cambiamenti tardano a realizzarsi spontaneamente, per l’esistenza di una tradizione radicata, provvede il potere ad accelerarli. Alla scadenza del XVII secolo lo zar Pietro, reduce da un lungo e istruttivo viaggio per l’Europa, decide di dare inizio ad un’era di modernizzazione del suo paese, e comincia simbolicamente proprio dalla barba (che sino a quel momento lui stesso portava). A pochissimi giorni dal suo rientro, nell’agosto del 1698, emette un ukaz dal titolo “Sull’uso dell’abito tedesco, sulla rasatura delle barbe e dei baffi e sulla circolazione degli scismatici con l’abito per essi indicato”, col quale impone ai sudditi, tra le altre cose, la rasatura completa[19]. Affinché il concetto sia chiaro riunisce a corte gli esponenti delle più importanti dinastie nobiliari e provvede personalmente a sbarbarli con un paio di forbicioni.
È l’inizio di un braccio di ferro violentissimo, al termine del quale la nobiltà si troverà non solo sbarbata ma inquadrata disciplinatamente nei nuovi ranghi voluti dal monarca. I costi umani sono altissimi: sommosse, migliaia di arresti, torture, esecuzioni. Pietro ci va giù con mano pesante. Una volta affermato il principio vengono poi concesse delle esenzioni, ma a prezzo di una pesante penale pecuniaria, che dal 1705 si trasforma in una vera e propria tassa sulla barba. La reazione più dura arriva naturalmente dal clero (che è comunque tra i soggetti esentati, a pagamento), perché la barba è il segno dell’appartenenza all’Ortodossia: obbedire a questo ordine equivale a un ripudio della fede dei padri. Ma non obbedire significa perdere tutti i propri averi o addirittura la testa: per cui il popolo russo, con l’eccezione dei Vecchi Credenti, si sottomette abbastanza rapidamente alla legge del rasoio.
Ancora una volta sono i ritratti e gli autoritratti a riassumere nella maniera più eloquente le tappe della trasformazione. Tra gli artisti dell’età barocca Caravaggio, Velazques, Rembrandt, Salvator Rosa, ma anche Bernini e Borromini, esibiscono ancora un accenno di baffi e pizzo, mentre nel secolo successivo Goya, Fragonard, De la Tour, Hogarth e Reynolds sono già completamente sbarbati, e lo saranno ancora, agli inizi dell’800, William Blake, Turner e David. Pochissimi azzardano scelte diverse: Friedrich si concede vistosi favoriti, Delacroix solo i baffi (ma in qualche autoritratto neppure quelli), Gericaul è l’unico che prima di morire prematuramente (a 34 anni) si autoritrae con la barba.
Nemmeno i filosofi offrono più resistenza. Con l’esclusione di Hobbes, che porta baffi e pizzo, si radono completamente Pascal, Cartesio, Spinoza, Newton, e nel secolo successivo non ce n’è uno che mostri un filo di barba: Locke, Hume, Vico, Lessing, Montesquieu, D’Alembert, Voltaire e Rousseau, naturalmente, Kant, e addirittura, nella prima metà dell’800,Fichte, Hegel e Schelling, sono tutti clienti quotidiani del barbiere, e nella sua bottega potrebbero incrociare letterati come Metastasio, Parini, Goldoni e Alfieri e musicisti come Vivaldi, Haydn, Bach, Mozart e Beethoven.Non è un caso che il personaggio forse più famoso di questo periodo sia Figaro, il barbiere di Siviglia inventato da Beaumarchais e reso universalmente celebre da Rossini[20]. (tav. 18)

L’Ottocento

Barbe romantiche
Almeno dagli scrittori e dei poeti del primo Romanticismo (e qui sconfiniamo nel secolo successivo) ci si attenderebbe un look più trasgressivo. Sono quelli che raccontano di spiriti liberi e tormentati, di eroi solitari, di ribelli, di individualisti che cercano di sottrarsi all’omologazione crescente. E invece da Walter Scott a Lamartine, da Merimée a Nerval, da Coleridge a Wordsworth, su su fino a De Vigny e agli antesignani del decadentismo come Baudelaire, continuiamo a trovarevolti rasati, dai quali sono scomparsi anche i baffi.
Per non parlare di Leopardi, che anche volendo avrebbe avuto difficoltà a ornare le guance, il labbro o il mento. Ma che non ne ha affatto a cogliere i segni del suo tempo. Proprio Leopardi, infatti, segnala sarcasticamente come il vento stia ancora una volta cambiando. Nella Palinodia al marchese Gino Capponi, del 1835, scrive che:
“giá, della nova
felicitá principio, ostenta il labbro
de’ giovani, e la guancia, enorme il pelo”.
Nell’Ottocento barbe e baffi tornano in auge, stavolta come labari del fermento sociale. La prima metà del secolo vede la fase aurorale di un credo liberal-progressista che promette che “Universale amore, / ferrate vie, moltiplici commerci, / vapor, tipi e cholèra i piú divisi / popoli e climi stringeranno insieme”. E i suoi profeti indossano, come sottolinea con malizia il poeta, i costumi di scena, a partire dalla mascheratura pelosa del volto.
Il ritorno di barbe e baffi annuncia una nuova felicità dal sapore ancora messianico: è in fondo la buona novella cristiana secolarizzata. A partire dagli anni venti, con i “socialisti utopisti” alla Saint-Simon e Fouriero come Robert Owen, il sogno illuministico di una emancipazione dalle leggi della natura diventa sogno romantico di emancipazione dai vincoli, dall’oppressione e dalla iniquità delle leggi umane. Questo sogno si esprime dapprima in termini politici, attraverso massonerie e sette carbonare, come nascita di una “coscienza” nazionale, di una appartenenza identitaria forte (patria, unità nazionale, indipendenza): si colora poi di istanze più genericamente “liberali” e costituzionaliste (democrazia, repubblicanesimo): e assume infine una valenza spiccatamente sociale, con la nascita dei movimenti dei lavoratori (giustizia sociale, egualitarismo). Anche in questa versione più radicale non viene però messa in discussione l’idea di progresso, quanto piuttosto il suo risolversi nel modo di produzione capitalistico, in un asservimento totale sia del lavoro umano che delle risorse naturali.
Nel Romanticismo si mescolano tuttavia, e a volte in maniera assai contradditoria, svariate altre componenti. Per alcuni la critica al progresso si spinge oltre, sottende un richiamo nostalgico alle epoche del passato, in particolare, quando è coniugata alla ricerca di una identità forte, al medioevo, età nella quale hanno cominciato a delinearsi (o a essere inventati) i tratti delle culture nazionali, soprattutto di quelle nordiche. Per altri la nostalgia identitaria ha un carattere soprattutto religioso, e si rifà ad un cristianesimo di stampo germanico, piuttosto che latino, claustrale piuttosto che ecclesiastico. Per altri ancora, soprattutto nell’ambito della cultura anglosassone, e segnatamente in quella d’oltreoceano, che non ha alle spalle una tradizione cui appellarsi e ne sta giusto inventando una con il mito del West, la riscoperta riguarda una concezione della natura tutt’altro che leopardiana: la natura benigna, accogliente, garante di libertà. Una natura che va quindi difesa dall’invadenza industriale, e della quale dobbiamo tornare a sentirci parte. Infine c’è una istanza più generalizzata alla valorizzazione dell’individualità, che si esprime o nella volontà virile dell’autoaffermazione o nel rifiuto dei valori borghesi, del perbenismo e dell’omologazione. Il modello latino-illuministico, quello ancora propugnato dai pensatori che al romanticismo avevano aperto la strada, come Goethe, non ha risposte per nessuna di queste nuove domande di senso.
Nessuno dei socialisti utopisti torna però alla barba. Sono ancora molto legati allo spirito dell’Illuminismo. La constatazione di Leopardi riguarda piuttosto i “patrioti”, coloro che ragionano in termini di “nazione”, piuttosto che di “umanità”. Il “pelo enorme” sulla guancia assurge ancora una volta a manifesto di una rottura, ma questa avviene prima di tutto con il quadro politico uscito dal congresso di Vienna. È la resistenza alla restaurazione dell’ancien règime, che assumerà poi, soprattutto presso i popoli che non hanno problemi di dominazione straniera, significati più ampi: ritorno alla natura, rifiuto dell’omologazione, espressione di rinnovata virilità (in contrasto con il settecento “effeminato”). E infine, dal momento che per sua natura la barba è anche democratica, perché cresce a tutti, essa diverrà anche un emblema del rinnovamento sociale.
Al solito, il ritorno procede per gradi. Primi a comparire sono i favoriti, la grande novità dell’800, adottati anche dal Foscolo e da Manzoni. E ben presto i favoriti si uniscono sotto il mento in barbe a collare, quelle che caratterizzano i giovani carbonari e i militari “progressisti” (i modelli sono Gioacchino Murat e Guglielmo Pepe in Italia, Piotr Wysocki in Polonia, i decabristi in Russia, ecc… In Francia uno dei primi ad adottarla è Stendhal). Sono barbe che incorniciano il volto, ma lasciano scoperte le guance. Marcano una differenza contenuta: sono indipendentiste o costituzionaliste, ma non ancora pienamente rivoluzionarie. Sono già comparse sulle barricate in Francia nel 1830, al fianco de La Libertà che guida il popolo, e per tutto il successivo ventennio andranno infoltendosi di pari passo con la radicalizzazione delle idee. (tav. 19)
È emblematica l’evoluzione dell’immagine dei mazziniani. Gli esponenti di maggiore spicco della Giovane Italia portano tutti orgogliosamente barbe complete, inizialmente più disciplinate, ispirate a quella del fondatore (Aurelio Saffi, i fratelli Ruffini), poi sempre più folte mano a mano che gli affiliati assumono posizioni più autonome (i Bandiera, Garibaldi, Felice Orsini), fino ad arrivare alla rottura e al modello più radicale (Carlo Pisacane).
Nel frattempo anche i moderati si adeguano timidamente alla moda. Mentre i neo-guelfi come Gioberti e Cesare Balbo rimangono ostinatamente rasati (l’uno in omaggio alla sua condizione sacerdotale, l’altro alla sua formazione illuministica), Cattaneo, D’Azeglio, Ricasoli e Rattazzi si concedono già i baffi, e Cavour la barba a collare. Persino i sovrani, sia Carlo Alberto che Vittorio Emanuele II si accodano. E lo stesso avviene in tutta Europa: Nicola I, Napoleone III, Alberto di Sassonia-Coburgo (il marito di Vittoria), non disdegnano l’ornamento del labbro. Poco alla volta però i baffi, soprattutto se educati a manubrio, diventano simbolo di conservazione, mentre la barba, tanto più se lasciata incolta, almeno fino agli anni settanta è sinonimo di spirito rivoluzionario. Non è un caso che l’unico a portarla sul trono del secondo reich tedesco sia lo sfortunato Federico III, imperatore per soli cento giorni, di spiriti liberali: attorno a lui in terra germanica si coltivano solo mustacchi (quelli di Bismarck e di Guglielmo II) o asburgici favoriti (Guglielmo I e Francesco Giuseppe).
Rapidamente però, soprattutto verso il volgere del secolo, anche la barba viene “normalizzata”, tanto da essere orgogliosamente adottata dai più reazionari tra i sovrani, dallo zar Alessandro II a Leopoldo II del Belgio e ad Edoardo VII d’Inghilterra. (tav. 19)

Barbe rivoluzionarie
Carlo Pisacane, come abbiamo visto, ci traghetta direttamente in un’altra area, quella della rivoluzione sociale, intesa sia nella versione anarchica, più libertaria, che in quella socialista, più egualitaria. Il confronto tra le barbe di Marx e di Bakunin è eloquente: imponente, ma curata, la prima: incolta e trascurata la seconda, in perfetta coerenza non solo con altre componenti del sembiante dei due quali ci sono state tramandate dai biografi, ma anche e soprattutto con le loro idee.
Quello della barba, e più in generale dell’aspetto trasandato, diverrà uno stereotipo nella raffigurazione ottocentesca del militante anarchico (e in qualche misura è sopravvissuta sino ad oggi). È l’immagine che meglio si giustappone a quella dell’efficientismo produttivistico, alla omologazione spersonalizzante che passa anche per la lama del rasoio. Bakunin ne è il prototipo esemplare, col suo fisico e col suo barbone giganteschi incute paura ai borghesi persino nell’aspetto: ma proprio la sua figura si presta anche a cogliere le contraddizioni di un radicalismo per molti versi di superfice, che guarda sin troppo alla propria spettacolarizzazione. Non è comunque il primo: già Proudhon aveva aperto la strada, seguito da Cipriani e dai fratelli Reclus: a seguire Kropotkin, Cafiero, Malatesta.
Verso la fine del secolo però la tendenza muta. La generazione degli attentatori individuali (Bresci, Pietro Gori) preferisce i baffi, anche per garantirsi un certo anonimato e per non esporsi ad una facile identificazione. La tradizione della barba persiste, dopo la prima guerra mondiale, solo tra gli anarchici “resistenti”, quelli più propensi a predicare una redenzione piuttosto che una rivoluzione (Landauer, Muhsam), mentre quelli “combattenti”, votati comunque all’azione diretta e impegnati in prima fila, ad esempio nella guerra civile spagnola, di preferenza si rasano (Buenaventura Durruti, Camillo Berneri). Nel caso di Berneri, come di tutti gli altri fuorusciti dall’Italia fascista, c’è evidentemente una motivazione di sicurezza, la necessità di passare il più possibile inosservati: ma ci sono anche ragioni di praticità e di riconduzione all’ordine della congerie ideologica che sta sotto l’anarchismo[21]. (tav. 22)
Per le barbe socialiste il discorso è diverso. Si parte da quella di Marx e di Engels, che per tutto l’ultimo quarto dell’Ottocento sono imitate dai seguaci e anche dagli oppositori interni alla Seconda Internazionale, da Kautsky a Bernstein, da Turati a Plechanov: ma nel nuovo secolo e col trasferimento in Russia si ridimensionano nei baffi e pizzo di Lenin, Trotsky, Bucharin, Kamenev, sfumano nei baffoni di Stalin e di Gorkij e spariscono con Zinoviev, per non tornare mai più in auge nel socialismo reale o nei partiti comunisti occidentali (nessuno dei fondatori del partito comunista italiano, né Gramsci, né Bordiga né Togliatti, porta barba o baffi). (tav. 23)
Le barbe andranno invece a caratterizzare, con una forte valenza simbolica, le lotte rivoluzionarie fuori d’Europa: già le annunciano i baffi a manubrio di Zapata e quelli di Pancho Villa, ma poi esplodono nel look leninista di Ho-Chi-Min, in quello dei “barbudos” per eccellenza, Fidel Castro, e Che Guevara, nella lanugine mal rasata di Arafat. Di lì torneranno, come vedremo, in Occidente, nel periodo della contestazione giovanile.


In sostanza, non appena si polarizzano le due nuove categorie politiche tipiche della modernità, la destra e la sinistra, guance e mento più o meno pelosi assumono nuovi significati di appartenenza, apparentemente confusi, in realtà abbastanza interpretabili e tutto sommato in continuità con quelli delle epoche precedenti. La barba diventa elemento distintivo tanto delle destre (se “scolpita”) quanto delle estreme sinistre, che hanno in comune, anche quando si presentano come rivoluzionarie, l’idea della conservazione e la critica del progresso: il viso pulito indica invece una appartenenza moderata o liberal-progressista, riformista, fiduciosa nel progresso scientifico e nella sua influenza su quello sociale. Queste connotazioni si definiranno, sia pure con tutte le varianti del caso, nel corso del Novecento.
A partire dai primi anni quaranta dell’Ottocento, inoltre, entra in gioco un nuovo fattore: la fotografia. Ciò comporta naturalmente un aumento esponenziale della documentazione ritrattistica, ma anche un radicale cambiamento nella sua qualità. I ritratti fotografici vanno letti in maniera diversa da quelli dipinti.
Almeno inizialmente, per quanto concerne la resa realistica, la “veridicità” dell’immagine, cambia poco (salva naturalmente la maggiore possibilità di “addolcire” certi tratti o certi difetti, che i pittori avevano). I primi ritratti fotografici che possediamo non sono mai delle istantanee, sono il corrispettivo di quelli dipinti, frutto di scelte studiate di luce e di posture, con tempi di posa che riescono di poco inferiori a quelli necessari per lo schizzo preparatorio di un quadro e con costi quasi analoghi. Si tratta pur sempre di immagini per le quali i soggetti si preparano accuratamente, scegliendo di farsi ritrarre nell’aspetto più “pulito” possibile: allo stesso modo in cui si preparavano per posare nello studio di un pittore.
Nella seconda metà del secolo, invece, con i rapidi progressi della tecnica fotografica nasce anche una ritrattistica “di servizio”, più diffusa, meno accurata, alla quale accedono anche i ceti meno abbienti. In alcuni casi addirittura è tutt’altro che gradita ai soggetti rappresentati: ad esempio quella introdotta dalle autorità di polizia a fini identificativi. Ora, soprattutto quest’ultimo caso riguarda elementi che hanno tutto l’interesse a non essere riconoscibili, per cui si verifica che gli stessi soggetti compaiano a breve distanza di tempo in foto segnaletiche con la barba o senza, e comunque con volti molto meno rasati. Questo ha poco a che vedere con le mode o con i significati simbolici, ma mi obbliga a riflettere sul fatto che quasi tutte le immagini che sino ad ora ho preso in considerazione avevano un carattere “ufficiale”, e narravano non la quotidianità, ma l’immagine che di sé volevano lasciare i soggetti. Non è un particolare irrilevante. Voglio dire che al di là del mutare delle tecniche, del passaggio dalla scultura alla pittura alla fotografia, quella che i ritratti raccontano, e che io ho cercato attraverso essi di ricostruire, è pur sempre la storia dei vincitori, o quanto meno di coloro il cui nome compare nei titoli di coda.

Tavola 19 – Barbe di transizione

Tavola 20 – Barbe letterarie
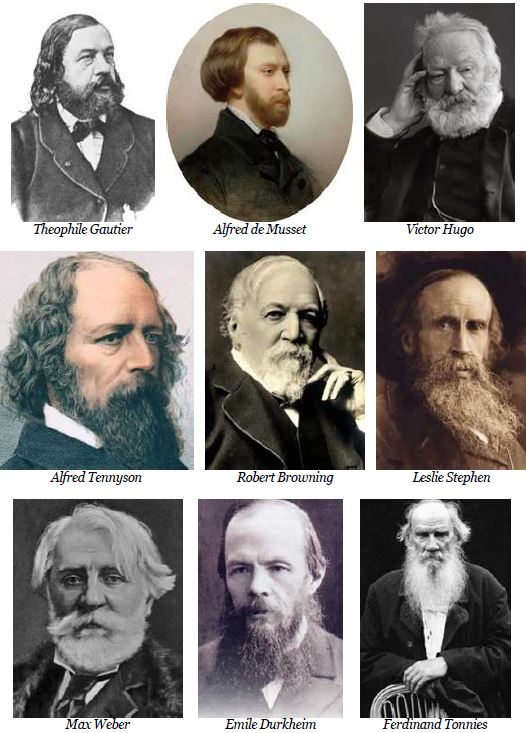
Tavola 21 – Barbe d’artista

Tavola 22 – Barbe anarchiche

Tavola 23 – Barbe comuniste

Tavola 24 – Barbe evoluzioniste

Barbe d’artista
Assieme alle barbe rivoluzionarie si infittiscono tra la metà e la fine dell’Ottocento anche quelle letterarie e artistiche, alle quali soprattutto continuo a fare riferimento perché mi sembrano particolarmente significative. In Francia le adottano già prima della metà del secolo i Romantici, come Gautier, De Musset eHugo, e successivamente i positivisti come Verne e i naturalisti come Zola. In Inghilterra a farne sfoggio sono poeti come Alfred Tennyson e Robert Browning, o saggisti come W. H. Hudson e Leslie Stephen. Vanno molto di moda tra i sociologi, Émile Durkheim, Max Weber e Ferdinand Tonnies, mentre lo sono meno, e la cosa mi ha sorpreso, tra gli antropologi. In Italia quella più famosa, una vera barba cattedratica, e temutissima dagli studenti, orna il viso d Carducci, mentre gli scapigliati, Tarchetti e Arrighi in testa, imitano piuttosto quella di Giuseppe Rovani. (tav. 21)
Insomma: dopo la metà del secolo tra i letterati è difficile trovare visi spogli. La preferenza in assoluto va però ai baffi, coltivati in varie fogge e dimensioni da Nievo, Verga, Capuana, Pascoli, De Amicis, Maupassant, Flaubert, Dumas padre[22], Jules Renard, e qualche volta abbinati al pizzo (Collodi, D’Annunzio).
Una particolare attenzione meritano però le barbe russe. Nell’impero zarista, dove, verrebbe da dire “in barba” a Pietro il Grande, nel clero ortodosso la tradizione è sopravvissuta, i volti degli scrittori tornano a riempirsi di pelo molto precocemente. Pusckin coltiva enormi favoriti, e se Lermontov e Gogol azzardano solo un po’ di peluria sotto il naso, i grandi del secolo, Turgenev, Dostoevskij, e Tolstoj esibiscono barbe importanti, così come Leskov (in una versione però più coltivata). Ma anche in Russia con la fine dell’Ottocento si torna alle guance pulite. Gorkij si allinea a Stalin anche nello spessore dei baffi, Bulgakov e Pasternak già presentano un volto completamente rasato.
I tedeschi, c’era da aspettarselo, sono più “disciplinati”. Schiller, Holderlin, Heine, Novalis, Kleist, Buchner, Grimm sono ancora perfettamente rasati: solo nella seconda metà del secolo Fontane e Wedekind adottano i baffi, così come Burckardt e Nietzsche.Per trovare barbe autorevoli occorre arrivare a fine Ottocento, col filosofo Franz Brentano, o sconfinare oltre, con Husserl e Freud. (tav. 19)
La stessa parabola troviamo tra i musicisti. Mentre i volti di Bellini, Rossini, Schumann, Schubert, Brahms, Mendelssohn, Lisz erano levigati dal rasoio, appena superata la metà del secolo ci imbattiamo in quelli incorniciati dal pelo di Verdi, Debussy, Dvořàk e Gounod, o nei vistosi favoriti di Wagner e di Offenbach.
Per i pittori va fatta una ulteriore considerazione. Adottano immediatamente il nuovo stile sia i realisti (Courbet, Millet) che gli impressionisti (Monet, Manet, Renoir) e i post-impressionisti di varia scuola (Cezanne e Van Gogh, Segantini e Pellizza, fino a Modigliani). Ma le barbe trovano spazio in genere solo negli autoritratti.
Ciò si spiega senz’altro col fatto che gli impressionisti si dedicano prevalentemente alla rappresentazione paesaggistica, e poco alla ritrattistica: ma anche la pittura realistica di un Millet, che predilige scene di vita rurale, non ci mostra mai contadini barbuti. Allo stesso modo, nei dipinti dei preraffaelliti, anche in quelli a soggetto biblico, o medioevale, o sociale, dove pure dovrebbero avere spazio, le barbe non compaiono mai: mentre adornano copiosamente i volti degli autori, di Dante Gabriel Rossetti, di William Hunt e di William Morris. Persino il loro mentore, John Ruskin, dopo l’ingresso nella terza età si converte. Per trovare volti non rasati anche nei dipinti occorre attendere l’inizio del nuovo secolo, e Pellizza da Volpedo. (tav. 21)

Barbe borghesi
Eppure nella quotidianità il ritorno della barba lo si registra molto prima. Quando l’implicazione sovversiva che le era attribuita viene meno, dopo il fallimento delle rivoluzioni del Quarantotto e della Comune parigina, il suo uso non rimane più riservato agli eccentrici o ai rivoluzionari, ma torna a voler significare e sprigionare autorevolezza. Tra l’ultimo quarto del secolo e la prima guerra mondiale fioriscono pertanto le barbe professorali e quelle dirigenziali. Si trincera dietro la barba chi vuol marcare una differenza di status (un po’ come avviene secondo Veblen per la moda della cravatta), e afferma visivamente non solo il proprio ruolo dirigente, ma anche l’autorevolezza che lo giustifica. Nel mondo scolastico, ad esempio, a farne sfoggio sono, oltre gli accademici, soprattutto direttori didattici, presidi, i temutissimi ispettori ministeriali, che propendono in genere per il pizzo d’ordinanza, quello che verrà poi definito “alla Balbo” (ma quando vogliono far sospettare, sotto l’aspetto burbero, una vena artistica, o sono davvero convinti di possederla, adottano anche barbe fluenti). Nei piccoli centri saranno le figure “di prestigio”, il medico, il farmacista, l’avvocato. Portare la barba in un contesto nel quale essa caratterizza anche gli irregolari (lingere, vagabondi, anarchici) o più semplicemente gli originali, è un lusso che ci si può permettere solo se il proprio ruolo “superiore”, la propria rispettabilità sono ben definiti e universalmente riconosciuti. Anche se poi, alla lunga, quando la moda si diffonde troppo, può rovesciarsi in un vezzo stucchevole
La barba borghese può essere letta in realtà come la reazione ad un disagio serpeggiante nell’universo maschile ma più specificamente avvertito dai maschi appartenenti ai ceti medio-alti. L’ordine sociale scaturito dall’età napoleonica, nel quale grandi e piccoli borghesi avevano trovato una collocazione e una stabilizzazione gerarchica, è già messo in discussione dalle rivendicazioni sociali dei lavoratori e da quelle di genere dei primi movimenti femministi. A questo disagio contribuisce in maniera ambigua, e più ancora alla reazione che innesca, la rivoluzione darwiniana. La selezione del “più adatto”, accolta nella formulazione di Herber Spencer piuttosto che in quella di Darwin, sembra trovare nei peli del volto una foresta di simboli: quello di una autonomia decisionale in una società sempre più propensa al controllo, quello della naturalezza in un mondo sempre più artificiale, e soprattutto quello di una innegabile evidenza della superiorità maschile: una superiorità non solo fisica, ma anche spirituale, dal momento che la barba era tradizionalmente associata all’idea della virilità, della forza, ma anche a qualità mentali superiori. Essa afferma dunque visivamente una ‛naturale’ forza d’animo che conferisce all’uomo l’autorità in famiglia (e, per estensione, a certi uomini – o a certe razze –il diritto di costruire imperi).
Tutto ciò tradisce la crescente preoccupazione riguardo l’aumento del potere delle donne (o perlomeno, della loro richiesta di partecipazione), ma spiega anche come mai l’uso della barba si diffonda quasi esclusivamente presso i ceti urbani e borghesi, e non invece nelle campagne. Nelle famiglie contadine il diritto assoluto del maschio al potere domestico non è ancora in discussione. Millet riproduceva davvero fedelmente la realtà rurale.

Barbe coloniali
Sino ad orami sono volutamente limitato a parlare della storia europea della barba, e continuerò a farlo. Ma nell’Ottocento gli europei viaggiano più che mai, e dopo aver scoperto ogni angolo del globo si dedicano ora a conquistarlo. Si portano appresso le armi, la religione, la tecnica: e la barba. Come già accadeva nella prima età delle scoperte, agli avventurieri e ai missionari che partono alla conquista di terre, di ricchezze e di anime fuori d’Europa la barba offre dei vantaggi. Intanto sembra tornare liberamente a crescere appena ci si stacca dal patrio suolo, dalla famiglia, dalla cerchia delle conoscenze. Ci sono ovvie esigenze di carattere pratico, perché le condizioni in cui nell’ottocento ancora si viaggia, si esplora, si fa apostolato non sono certo favorevoli ad una cura particolare dell’aspetto: toccati tutti i possibili approdi, ora si penetra all’interno, tra disagi, pericoli e malattie, e radersi è l’ultimo dei pensieri.
Giocano però anche motivazioni psicologiche, perché indubbiamente fuori dalle mura e dalle convenzioni domestiche trova più facilmente sfogo ogni sorta di rifiuto, e gli esploratori sono in genere personaggi in fuga, per motivi diversi e spesso inconfessati, dal conformismo rigido della società vittoriana. Infine rimane ancora rilevante l’impatto che barbe fluenti hanno sulle popolazioni, asiatiche, africane e americane, in genere molto più glabre. Anche quando tale impatto è negativo, e genera sospetto e rifiuto, non è mai disgiunto da un timore reverenziale per la potenza che alla barba è associata.
I viaggiatori ed esploratori europei che si muovono per il mondo nei primi decenni dell’Ottocento arrivano tuttavia ancora da una formazione illuministica, e sembrano attraversare mari e continenti senza rinunciare alla pulizia del volto: Humboldt, Mungo Park, Franklin appaiono perfettamente sbarbati (anche se, almeno per gli ultimi due, è da dubitare che abbiano sempre potuto fare toeletta durante le loro avventure: per Humboldt invece è certo. Non avrebbe rinunciato a radersi neppure in mezzo al deserto). Livingstone e Stanley già si concedono, almeno nelle foto ufficiali, dei semplici baffi, mentre Burton, Speke e Grantostentano folte barbe. Tra gli esploratori italiani, Giovanni Miani, Carlo Piaggia e Romolo Gessi sarebbero da ricordare non fosse altro per le loro barbe incredibili: e l’immagine tradizionale è ricalcata anche dai più “coltivati” Pellegrino Matteucci e Giacomo Bove.
Al ritorno dalle loro spedizioni gli scienziati-viaggiatori adottano volentieri quelle che potremmo definire barbe “evoluzionistiche”. Sono autorizzati dal loro passato. Darwin e Wallace lasciano libero corso alla natura (e offrono il destro alle caricature), creando quasi uno stile specifico. Il traduttore di Darwin in Italia, Michele Lessona, ne adotta oltre che le idee anche il look. Ernst Haeckel, che è tedesco, lascia invece crescere la barba, ma la tiene sempre disciplinatamente sotto controllo. Spencer e Thomas Huxley, più sedentari ed accademici, esibiscono invece incredibili favoriti, supporto visivo di convincimenti che non ammettono contradditorio. Anche nel secolo successivo la barba incornicia volentieri i volti degli studiosi della natura umana (Lorenz, Levi-Strauss, J.P. Gould). (tav. 24)
Lontano dalla madrepatria la prescrizione del viso rasato viene meno anche per gli uomini in divisa. Sulle riviste illustrate di viaggi, o nelle illustrazioni dei libri di Melville e di Verne, compare sempre più spesso la barba da lupo di mare, quella oggi tanto amata dalle pubblicità di surgelati, e colonizza velocemente l’immaginario avventuroso dei salotti borghesi. Le più famose sono quelle di Nemo e del capitano Achab. Mi riesce invece più difficile spiegare con motivi di praticità immediata perché gli alpinisti continuino a propendere per il viso rasato (Wymper, Mummery, Mallory, Preuss).

Barbe d’oltreoceano
Ma non sono solo i marinai a infrangere i tabù della moda settecentesca. Sull’estrema frontiera occidentale, al di là dell’Atlantico, i militari sembrano considerare la barba un complemento indispensabile della loro divisa e della loro autorità. Non troviamo un solo protagonista della guerra civile americana sbarbato: Lincoln, Grant, Lee, “Stonewall” Jackson, ostentano tutti barbe importanti. Un generale unionista, Ambrose Burnside, ha addirittura dato il suo nome ad un particolare modello di acconciatura dei basettoni. I loro omologhi europei sono invece più conservatori. Negli stessi anni della guerra di secessione gli stati maggiori degli eserciti che combattono la seconda e la terza guerra italiane d’indipendenza danno spazio al massimo al pizzo, ma in generale prediligono i baffi (fa eccezione solo lo sventurato Massimiliano I d’Asburgo, che non a caso va a morire fucilato in America).
Non so quanto le barbe delle alte cariche militari americane rispecchino il costume popolare diffuso: dalle numerosissime foto rimaste (la guerra civile americana è la prima ad essere testimoniata fotograficamente) si direbbe che anche nella truppa le barbe fossero decisamente tollerate. Non credo sia casuale: i combattenti per il nord e per il Sud erano tutti volontari, inquadrati in milizie regionali, ciascuna con le proprie tradizioni e i propri costumi, spesso addirittura con le proprie divise. I combattenti erano quindi meno vincolati che non quelli europei al rispetto di una disciplina ferrea.
Quegli uomini venivano da frontiere aperte su territori immensi, da minuscoli insediamenti dispersi in mezzo a boschi, praterie e montagne, e coltivavano una filosofia particolare della libertà consentita loro dallo spazio e dall’isolamento. Quella di essere “socialmente presentabili” era l’ultima delle loro preoccupazioni, ma non solo: si trattava di gente che aveva volutamente tagliato i ponti con la società europea e con le sue convenzioni. I suoi eroi erano personaggi come Jim Bridger e John Fremont, i suoi cantori poeti come Walt Whitman, narratori come Melville, proto-ecologisti come Thoreau o John Muir, pittori come John Singer Sargent. (tav. 26)
Eppure, anche in America la barba come modello virile si afferma solo a Ottocento inoltrato. Il più famoso dei trapper, Jedediah Smith, il cantore delle guerre indiane, James Feminore Cooper, David Crockett, filosofi come Ralph Waldo Emerson, si fanno ancora ritrarre sbarbati. Sfoggiano invece i baffi Nathaniel Hawthorne, Mark Twain, Albert Bierstad, Kit Carson, Amboise Bierce. Il famosissimo William Cody (Buffalo Bill) oltre ai baffi ha il pizzo. Ma con lui già si varca il secolo. (tav. 25)
Agli inizi di quello successivo sarà Jack London, sempre sbarbato, a incarnare il nuovo americano. La barba sopravvive solo nei suoi libri, sui volti de “Il lupo dei mari” o dei cercatori d’oro di “Zanna bianca”.
Anche nella successiva costruzione della mitologia western, operata dal cinema hollywoodiano sin dai suoi esordi, la barba sparisce. Soprattutto tra gli anni trenta e la fine dei cinquanta del Novecento gli eroi di celluloide sembrano vaccinati contro la crescita del pelo sulle guance (ma anche nel resto del corpo). Attraversano deserti e foreste e sopportano agguati, assedi e sparatorie sempre perfettamente sbarbati. Le poche volte che li sorprendiamo a radersi lo fanno con le lame dei coltelli da caccia, ma sui loro volti non compaiono mai cicatrici (del resto, nemmeno quando fanno a cazzotti).
Le prime lanugini facciali sono introdotte dal western all’italiana, da Leone e da Clint Eastwood: in breve diverranno istituzionali, e saranno riprese in grande stile dai western americani del tramonto, quelli di fine secolo. In linea perfetta con la ricomparsa della barba del nuovo millennio, e probabilmente anche corresponsabili della sua promozione.
I protagonisti di questa stagione crepuscolare sono “uomini veri”, “uomini duri”, lontani dai dubbi, dai rimorsi e dalle crisi di coscienza che travagliavano i loro predecessori: e soprattutto lontani da ogni sudditanza nei confronti del genere femminile. Dei prototipi di virilità pelosa.
Le locandine cinematografiche parlano davvero da sole. Scompaiono non solo gli accostamenti guancia a guancia con l’eroina co-protagonista, ma addirittura i volti femminili. Come vedremo, qualcosa significa.

Tav. 25 – Barbe d’Oltreoceano (I)

Tav. 26 – Barbe d’Oltreoceano (II)

Tav. 27 – Barbe Sioniste (e non)

L’età contemporanea

No Barba!
Se il XIX si può considerare il secolo della barba per antonomasia, il XX è uno dei più sbarbati della storia. Almeno sino alla fine degli anni sessanta dominano i volti puliti. Per un sacco di motivi.
Intanto, c’è una grossa novità di ordine pratico. Nel 1904 King C. Gillette brevetta il rasoio di sicurezza, dando il via a una rivoluzione nella cura dell’aspetto che verrà portata a compimento un quarto di secolo dopo con la comparsa del rasoio elettrico. Tutti possono accedere ora ad un livello di cura personale che in precedenza era riservato solo ai nobili o all’alta borghesia. Non è più necessario recarsi dal barbiere, radersi diventa un’operazione semplice e veloce.
Nel frattempo è mutata anche la considerazione della barba sotto il profilo igienico-sanitario. Dopo la scoperta che i microrganismi causano malattie (Pasteur), scienziati e medici tornano a indicare il pelo sul volto come un possibile rifugio di batteri, riprendendo le posizioni settecentesche e ribaltando l’opinione corrente nel XIX secolo, secondo la quale barba e baffi aiutavano a proteggere la pelle dal sole e dal freddo, e a filtrare la polvere e l’aria.
Questo cambiamento di attitudine è poi strettamente connesso alla “rivoluzione igienica”[23] di fine Ottocento, che vede affermarsi, dopo secoli di ostracismo e le sempre più frequenti esplosioni di devastanti epidemie coleriche, un rapporto nuovo con le pratiche di pulizia personale. La scienza produce le giustificazioni sanitarie di questo rapporto: le istituzioni lo promuovono e dove possibile lo impongono, con massicci interventi sull’igiene pubblica e con forti pressioni su quella privata (si pensi ad esempio al ruolo svolto dalle scuole nell’educazione al “pulito”). Dietro l’una e le altre si muovono poi naturalmente enormi interessi economici.
Il tutto è improntato ad una concezione del mondo che già Ernst Bloch indicava come caratteristica della nuova era, quella della levigatezza e della lavabilità[24], rappresentate simbolicamente dalla stanza da bagno e dal gabinetto, “opere d’arte che determinano tutte le altre”. E la stanza da bagno è il luogo nel quale, e a misura del quale, si levigano anche i volti. Trionfa insomma il motto “pulito è bello”, coniato dalla scienza medica e fatto immediatamente proprio dalla politica e dall’economia.
La pressione sociale viene esercitata sia attraverso l’imposizione di regole d’igiene personale in tutti gli ambiti lavorativi, sia promuovendo attraverso ogni possibile veicolo di persuasione dei modelli di mascolinità tirati perfettamente a lucido.
Si vogliono educare lavoratori sempre più adatti all’impiego aziendale e professionale, efficienti e dinamici, affidabili e disciplinati, e soldati sempre più obbedienti, perfettamente inquadrati e uniformi nell’aspetto, facilmente manovrabili. Nei regolamenti aziendali come in quelli scolastici e in quelli delle caserme si insiste sulla pulizia del volto, sul taglio ordinato dei capelli, sulla cura nell’abbigliamento. Quando non vengono direttamente e brutalmente puniti, come ancora accadeva nell’Ottocento nei college inglesi, le stravaganze o gli eccessi di originalità sono soffocati istigando la messa al bando da parte del gruppo. La rasatura si dimostra un’utile pratica culturale nel definire su parametri completamente nuovi l’identità maschile.
Questo progetto di condizionamento è infatti a sua volta connesso alla svolta “giovanilistica” che ha luogo a cavallo del secolo, e che determina un cambiamento nel concetto e nell’immagine della virilità. La “gioventù” viene riconosciuta non più semplicemente come una condizione transitoria, di apprendistato, ma come “classe sociale”: e dietro questa attenzione tutta nuova c’è sì la risposta all’effettivo emergere di uno spontaneo attivismo giovanile che caratterizza il primo decennio del Novecento, ma c’è soprattutto la corsa ad incanalare tale fermento in una direzione “produttiva” e ad irreggimentare gli adolescenti in quella politica nazionalistica che nei due conflitti mondiali ne farà strage, dopo aver fornito loro simbologie e rituali in cui riconoscersi (Giovinezza! Giovinezza!) e modelli cui ispirarsi.
Il modello giovanilistico ha però anche un valore retroattivo, nel senso che finisce per condizionare le scelte di autorappresentazione di ogni classe d’età. I maschi europei del XX secolo abbracciano lo sport e il culturismo per le stesse ragioni per cui in quello precedente si facevano crescere la barba, per affermare una propria immagine virile: ma affidano questa non più all’autorevolezza della maturità, quanto piuttosto alla freschezza e alla forza della gioventù. Se in precedenza volevano apparire più anziani, ora aspirano a sembrare eternamente giovani. A supporto e in conseguenza di questo atteggiamento sono riesumate le competizioni olimpiche, si affermano gli sport, individuali e di gruppo, dal rugby al calcio, al ciclismo, al tennis, al nuoto, al pugilato. E in tutti questi sport, più o meno tacitamente, la barba non ha spazio, costituisce solo un ostacolo.
La virilità non è dunque più testimoniata dalla barba, ma da una muscolatura elastica, potente e armoniosa e dalle guance pulite. Il testimonial più formidabile di questa concezione è il cinema, anch’esso un prodotto degli inizi del nuovo secolo; e agli standard proposti dal cinema si adegua immediatamente ogni altro strumento di persuasione, prima tra tutte la pubblicità. Hollywood bandisce la barba[25], che fino agli anni sessanta è presente sullo schermo solo in funzione antagonistica e malvagia. John Wayne, tra le icone massime della settima arte, non l’ha mai esibita in nessuno degli oltre centocinquanta film interpretati, e diceva: “Il solo vantaggio della barba è che si vede meno viso”. (Tav. 29)
La trasgressione massima consentita sono baffi curatissimi e sottili, alla Clark Gable o alla Errol Flinn, che non a caso interpretano sempre personaggi compostamente ribelli(Rhett Butler e Zorro), in lotta con le convenzioni sociali, ma tutt’altro che rivoluzionari.
Ancora una volta la ritrattistica è lì a testimoniare questo disamore per la barba. Gli attori più famosi (John Wayne, Gary Cooper, Humprey Bogart, Glenn Ford, Alain Delon, Marcello Mastroianni) e gli sportivi più amati (Piola, Meazza, Coppi, Bartali, Carnera, Rivera) sono tutti rigorosamente sbarbati, gli intellettuali e gli scrittori (Montale, Pavese, Calvino, Sartre, Camus) lo sono nella stragrande maggioranza (le eccezioni si contano sulle dita di una mano: Hemingway, Ezra Pound, Pirandello, oppure gli ebrei, Freud, Martin Buber, Sholem), e anche gli artisti, che pure si dividono (Picasso, Dalì, Kandinski, Chagall, Pollock sbarbati – Klee, Klimt, Matisse con barba), in genere si attengono al modello liscio.
Più significativo ancora appare il quadro della politica. Nella nomenklatura sovietica i volti hanno cominciato a ripulirsi fin dai tempi di Stalin, e a dispetto dei suoi baffoni: in quelle occidentali, dopo la dissoluzione degli imperi centrali barbe e baffi scompaiono rapidamente. I dittatori tra le due guerre (Hitler, Mussolini, Salazar) e quelli postbellici (Tito, Franco) si radono, così come i leader delle democrazie (Roosveelt, Churcill, Adenauer, De Gaulle, Kennedy). Nei manifesti elettorali, sino alla fine del XX secolo difficilmente compariranno visi barbuti.
Qualche concessione viene fatta, ad esempio dal fascismo, a barbe d’ordinanza (Balbo, De Bono, Gentile) simili a quelle borghesi di inizio secolo, o a baffi ottocenteschi (De Vecchi). Il nazismo è più rigido: fatta eccezione per le mosche sotto il naso di Hitler e Himmler, per gli altri, e in ispecie per le SS, vige l’obbligo della rasatura completa.
Non è affatto casuale che gli ideologi principali del razzismo (e dell’antisemitismo) adottino tutti, sin dalla fine dell’Ottocento, un look perfettamente pulito. Se si eccettua De Gobineau, che è un pre-darwiniano, tutti gli altri, da Huston Chamberlain a Rosenberg, da Evola a Giovanni Preziosi e a Celine, sembrano considerare la barba un elemento distintivo delle razze inferiori. E questa convinzione si traduce poi nell’iconografia di propaganda dei regimi totalitari. Dai manifesti balzano fuori mascelle perfettamente levigate, forgiate nell’acciaio. Il cinema di Louis Trenker e di Leni Riefenstahl propone atleti dal corpo scultoreo e assolutamente glabro. Persino i colonizzati vengono adeguatamente ripuliti. (tav. 28)
D’altro canto, nel linguaggio stesso sono ormai associati all’immagine dalla barba soprattutto significati negativi. Il senzatetto o il vagabondo sono identificati come barboni, una persona anziana mezzo rimbambita e brontolona è un vecchio barbogio (ma si usa anche barbagianni, da barba nel significato di zio), un interlocutore prolisso e monotono è barboso, un barbassore è un saccente, uno che si dà un sacco di arie, il marito violento è un barbablu, una persona gretta, meschina, o una brutta figura, è barbina. Abbarbicarsi significa mettere radici, ma nell’accezione figurata implica in genere una stolida ostinazione. Anche i modi di dire, come fare la barba al palo, o farla in barba a qualcuno, o servire di barba e capelli, mantengono sempre un significato ambiguo, connesso a un rischio, a una rivalsa, a un fallimento o a un raggiro.
Tavola 28 – Barbe antisemite

Tavola 29 – No Barba

Abbarbicati
E arriviamo finalmente all’ultimo mezzo secolo. Dove tutto per un verso si complica, ma per un altro si semplifica. Si complica perché in sostanza le barbe cessano di simboleggiare una appartenenza, politica, religiosa, di classe o più genericamente culturale. Ne Il pendolo di Foucault (1988), Umberto Eco scrive: “Ancora all’inizio degli anni sessanta la barba era fascista − ma occorreva disegnarne il profilo, rasandola sulle guance, alla Italo Balbo – nel sessantotto era stata contestataria, e ora stava diventando neutra e universale, scelta di libertà. La barba è sempre stata maschera (ci si mette una barba finta per non essere riconosciuti), ma in quello scorcio d’inizio anni settanta ci si poteva camuffare con una barba vera. Si poteva mentire dicendo la verità, anzi, rendendo la verità enigmatica e sfuggente, perché di fronte a una barba non si poteva più inferire l’ideologia del barbuto […]. La barba risplendeva anche sui volti glabri di chi, non portandola, lasciava capire che avrebbe potuto coltivarla e vi aveva rinunciato solo per sfida”.
Il brano riassume molto bene, sia pure alla maniera di Eco, sempre un po’ sibillina, il veloce ed effimero percorso di rientro della barba nel costume occidentale a partire dalla metà degli anni Sessanta (con qualche anticipazione nel mondo della beat generation – Allen Ginsberg, Lawrence Ferlinghetti – e col traino dei gruppi musicali – Beatles, Nomadi, ecc.).
Il decennio successivo è dunque caratterizzato da due tipi di barbe, quelle genericamente libertarie (con una preminente attenzione alla liberazione sessuale – gli hippies) e quelle politicizzate. Le prime hanno alle spalle negli USA, dove il fenomeno nasce e si esaurisce (gli echi europei sono solo patetiche imitazioni), una tradizione ormai secolare, che risale a Muir, agli hobo e al proto-ecologismo, e che si è tramandata lungo il Novecento attraverso innumerevoli sette e comunità para-religiose. Le barbe terzomondiste prendono invece a modello principalmente la rivoluzione cubana, e i barbudos che ne sono protagonisti (Guevara, Castro). Negli altri focolai di guerriglia latinoamericani, alimentati soprattutto da combattenti di origine india, prevalgono i volti glabri. Questo secondo modello ha un qualche seguito nella fase iniziale, quella eminentemente teorica, della contestazione, ma trova poi pochi riscontri negli anni di piombo, per gli stessi motivi che consigliavano un look il più possibile anonimo ai terroristi anarchici di fine ottocento. Le barbe compaiono o si infoltiscono soprattutto dopo le catture, nelle galere. Salvo poi sparire nuovamente all’inizio degli anni Ottanta. (tav. 30)
Segue infatti un altro ventennio di pausa. La moda yuppie impone un aspetto efficientista, visi tirati a lucido, plastificati dalle creme e dai lifting, e rassicuranti. Sopravvivono in questo periodo solo alcune barbe intellettuali. Poi, al volgere del secolo e del millennio, c’è il ritorno in grande stile delle guance pelose, enfatizzato dall’esplosione dell’integralismo islamico (la barba di Bin Laden). Dopo l’undici settembre è tutto un fiorire contradditorio di barbe che partono come messaggio identitario e finiscono come fenomeno modaiolo. E diventa assai difficile tenere distinte le due dimensioni.
 In realtà, il gioco si semplifica se assumiamo che ormai a dettare l’acconciatura del volto è solo il capriccio della moda (che è poi un capriccio per modo di dire, in quanto è guidato a creare sempre a nuove tipologie di consumo). Ma nemmeno questo è del tutto vero, perché i dettami della moda a loro volta intercettano bisogni, paure e disagi collettivi diffusi (e li alimentano, quando addirittura non li creano). Quindi, come in passato, ma attraverso un filtro diverso, sui volti degli uomini, e dal fatto che siano sbarbati o meno, si può leggere la condizione dei nostri tempi. O almeno, come sarà nel mio caso, se ne possono trarre alcune considerazioni.
In realtà, il gioco si semplifica se assumiamo che ormai a dettare l’acconciatura del volto è solo il capriccio della moda (che è poi un capriccio per modo di dire, in quanto è guidato a creare sempre a nuove tipologie di consumo). Ma nemmeno questo è del tutto vero, perché i dettami della moda a loro volta intercettano bisogni, paure e disagi collettivi diffusi (e li alimentano, quando addirittura non li creano). Quindi, come in passato, ma attraverso un filtro diverso, sui volti degli uomini, e dal fatto che siano sbarbati o meno, si può leggere la condizione dei nostri tempi. O almeno, come sarà nel mio caso, se ne possono trarre alcune considerazioni.
La prima delle paure di cui sopra riguarda la spersonalizzazione. È un problema squisitamente moderno. Gli uomini dell’antichità e del medioevo si percepivano come parte di una comunità “organica”, strutturata su vari livelli, all’interno della quale ciascuno ricopriva il ruolo che la nascita gli aveva assegnato: si riconoscevano in una identità collettiva, teoricamente magari molto ampia (la grecità, l’ebraismo, il cristianesimo …), in realtà ristretta al gruppo, alla tribù, al villaggio. La modernità ha disgregato questa identità, ha affermato la convenzionalità dei rapporti, ha sostituito l’organizzazione all’organismo, ha atomizzato il tessuto sociale in una miriade di individui. Non ci si riconosce più in una identità, ma se ne cerca a tutti i costi una, che sia il più possibile rassicurante ma offra allo stesso tempo l’impressione di una certa esclusività. In altre parole: ciascuno di noi diventa sempre più invisibile e irrilevante mano a mano che cresce la massa di individui coi quali almeno virtualmente entra in relazione, e in mezzo ai quali si confonde. Questo spinge a cercare conforto e solidarietà e sicurezza in gruppi di consimili coi quali si condivida un qualsivoglia valore, dal tifo per una squadra di calcio alla particolare militanza politica o all’infatuazione per un gruppo musicale: e contemporaneamente la visibilità, l’uscita dall’anonimato cui si aspira pare resa possibile solo dalla trasgressione.
In un contesto del genere, portare la barba può dare l’illusione di una appartenenza e al tempo stesso di una trasgressione, come già accadeva nella prima metà dell’Ottocento. Si trasgredisce in fondo alle regole novecentesche di pulizia del volto, si rivendica la naturalezza in un mondo reso asettico e levigato, ci si sente solidali con altri che stanno maturando la stessa ribellione. Le cose però non stanno affatto così. Il potenziale significato trasgressivo della barba, quello di cui potevano essere accreditati per il passato filosofi o monaci che resistevano ad una immagine in qualche modo imposta loro con la coercizione diretta o con una forte pressione morale, è venuto meno (semmai vale il contrario). Nel mondo islamico, ad esempio, la barba è un segno di allineamento. Le popolazioni soggette alle dittature dei Talebani o dell’Isis ne sanno qualcosa: e non a caso appena queste sono cadute si sono riaperte le barberie e c’è stata la corsa a radersi. Ciò vale anche per l’emisfero occidentale. Il ritorno alla barba nelle comunità islamiche, soprattutto tra gli immigrati di seconda o terza generazione, è tutt’altro che spontaneo. Chi non si adegua ai modelli predicati dagli iman più radicali è emarginato dal gruppo, e al tempo stesso trova enormi difficoltà ad integrarsi in una società già di per sé disintegrata e resa sempre più diffidente. L’imitazione occidentale di questa acconciatura, poi, è addirittura patetica. Fatti salvi i casi di menti fuori controllo che aderiscono in maniera incondizionata alla jihad, è solo la dimostrazione di quanto può la moda. Anche se, almeno in una primissima fase, non si può negare che inconsciamente entri in gioco una sorta di invidia, la nostalgia per un mondo che conserva certezze tali da rendere giustificabili la lotta o il martirio.
Sotto questa adesione si nasconde tuttavia a mio giudizio soprattutto un’altra paura, quella riguardante la presenza sempre più “ingombrante” e arrembante delle donne. Nel corso della storia dell’umanità, in fondo, ogni segnale di riscossa da parte femminile è stato seguito da una forte reazione negativa. È accaduto nella Grecia classica, poi agli esordi del cristianesimo, quindi alla fine del Rinascimento, persino durante la Rivoluzione francese, e da ultimo nella seconda metà dell’Ottocento. In ciascuno di questi frangenti la rivendicazione di uno spazio diverso, se non addirittura della parità, da parte femminile è stata soffocata immediatamente e duramente (si pensi al teatro di Aristofane, alle lettere di San Paolo, alla caccia alle streghe, alla decapitazione di Olimpia de Gouges, ecc…). E ogni volta a fianco degli interventi politici o religiosi o delle giustificazioni teoriche del patriarcato sono scattati atteggiamenti, scelte estetiche, intesi a marcare la differenza e la superiorità maschile, a sottolineare la virilità. In tal senso la barba è da sempre uno degli elementi più palesemente identificativi. E vien da pensare che il bisogno di affermare questa appartenenza forte nasca prima ancora che dalla paura delle donne dalla paura della parte femminile che ogni uomo porta in sé, e che di norma, per carattere o per condizionamenti culturali, non vuole riconoscere e non vuole lasciare trapelare.
 Nel ritorno alla barba si può però anche leggere semplicemente la riproposta di un antico richiamo sessuale, quello che fa leva sull’equivalenza “volto peloso-testosterone alto”, e quindi virilità matura. Il che si ricollega a quanto dicevo prima, perché la differenza ostentata dalla barba implica anche l’affermazione di una gerarchia tradizionale nella coppia. Come a dire: se mi vuoi virile, poi mi riconosci come dominante. Il fatto comunque che le femmine prediligano gli uomini barbuti, proprio in ragione di quanto sopra, è in realtà piuttosto controverso. Studi diversi hanno dato risultati del tutto opposti. Probabilmente esiste una correlazione tra il numero di uomini che la portano e la percentuale di donne che ne sono attratte[26]. Non appena questo numero divenisse maggioritario, la tendenza si invertirebbe.
Nel ritorno alla barba si può però anche leggere semplicemente la riproposta di un antico richiamo sessuale, quello che fa leva sull’equivalenza “volto peloso-testosterone alto”, e quindi virilità matura. Il che si ricollega a quanto dicevo prima, perché la differenza ostentata dalla barba implica anche l’affermazione di una gerarchia tradizionale nella coppia. Come a dire: se mi vuoi virile, poi mi riconosci come dominante. Il fatto comunque che le femmine prediligano gli uomini barbuti, proprio in ragione di quanto sopra, è in realtà piuttosto controverso. Studi diversi hanno dato risultati del tutto opposti. Probabilmente esiste una correlazione tra il numero di uomini che la portano e la percentuale di donne che ne sono attratte[26]. Non appena questo numero divenisse maggioritario, la tendenza si invertirebbe.
Credo poi che per molti valga l’associazione della barba con la creatività, probabilmente desunta dal fatto che gli artisti e i filosofi, ma anche molti scienziati, ne hanno fatto spesso una divisa. È un concetto di creatività stiracchiato un po’ in tutte le direzioni e applicato alle sfere più assurde, per cui ha perso ogni significato: ma in assenza di altri titoli specifici di merito essere un “creativo” e indossarne almeno l’uniforme serve a riempire un poco il vuoto. In questo caso poi la barba si associa in genere ad un look finto trasandato, a gusti musicali e artistici di nicchia, a scelte alimentari rigidamente salutiste, a una sensibilità ecologica ostentata (nei mezzi di trasporto, ad esempio). È un modo di essere cool muovendosi in controtendenza: il conformismo dell’anticonformismo.
C’è infine, ed è questo oggi il fenomeno dilagante, quello che balza agli occhi, la barba più esplicitamente modaiola, da rivista patinata, che si associa a giacca e cravatta o ai capi firmati, e viene curata in barberie rifiorite a nuova vita o nei centri benessere. La barba trendy, per rimanere negli anglicismi. Qui le simbologie tradizionali, le appartenenze o le trasgressioni, non c’entrano assolutamente più. La trasvalutazione dei valori è compiuta. Mentre nelle epoche che abbiamo fatto scorrere la barba rappresentava comunque un concetto, un’idea, e non semplicemente un vezzo, e portarla o meno definiva dei ruoli o segnava la demarcazione tra membri dello stesso gruppo sociale, e addirittura il suo trascolorare diveniva espressione di saggezza acquisita con l’esperienza, oggi è ridotta ad accessorio in una autorappresentazione di tipo solo spettacolare. Quella natura che i peli volevano assecondare (e che con la loro rimozione si voleva controllare e trascendere), è negata piuttosto dalle creme, dai balsami, dagli unguenti, dai coloranti, dalle bizzarrie del taglio.
 Venuto meno il valore simbolico, rimane solo quello documentario. È evidente che i maschi, quanto meno quelli occidentali, sono in questo momento in gran confusione. Si sta sgretolando sotto i loro occhi tutto un mondo di convinzioni e di convenzioni, e non ce n’è in vista un altro pronto a sostituirlo. Essendo venute meno le autorità culturali uniche che un tempo definivano i parametri della mascolinità per tutti, e in assenza di qualsivoglia indicazione univoca su cosa implichi essere un uomo, gli uomini si sbizzarriscono a rappresentare se stessi sotto sempre nuovi mascheramenti. A dispetto della sua naturalezza, in fondo la barba è sempre stata in qualche modo anche una maschera: raderla significava strapparsela di dosso, mettersi a nudo.
Venuto meno il valore simbolico, rimane solo quello documentario. È evidente che i maschi, quanto meno quelli occidentali, sono in questo momento in gran confusione. Si sta sgretolando sotto i loro occhi tutto un mondo di convinzioni e di convenzioni, e non ce n’è in vista un altro pronto a sostituirlo. Essendo venute meno le autorità culturali uniche che un tempo definivano i parametri della mascolinità per tutti, e in assenza di qualsivoglia indicazione univoca su cosa implichi essere un uomo, gli uomini si sbizzarriscono a rappresentare se stessi sotto sempre nuovi mascheramenti. A dispetto della sua naturalezza, in fondo la barba è sempre stata in qualche modo anche una maschera: raderla significava strapparsela di dosso, mettersi a nudo.
Di per sé, in questa affermazione non c’è alcun giudizio di valore: ho portato barba e baffi per più di cinque lustri, senza mai chiedermi in realtà perché lo facessi, che significato particolare intendessi dare al mio aspetto, cosa volessi trasmettere. Non stavo rispettando convenzioni legate alla religione, alle idealità politiche, al mio ruolo o alla mia posizione nella scala sociale: semplicemente, mi andava così. Mi riusciva comodo, ma allo stesso modo in cui oggi mi sembra naturale e non mi costa alcuno sforzo radermi ogni mattina. Ciò non toglie che dietro le mie scelte ci siano magari state motivazioni recondite, che non ho mai indagato, ma mi induce anche a pensare che si possa decidere di portare o meno la barba per un semplice capriccio, per pigrizia, per noia. La cosa è un po’ diversa, però, quando l’acconciatura della barba o dei baffi diventa un impegno, quando il significante diventa esso stesso unico significato. Perché dietro, allora, c’è davvero il nulla.
In definitiva, credo che per la storia della barba valga quello che penso della storia dell’arte. In fondo la barba, come i tatuaggi, il culturismo, la Body art, o come certe manipolazioni chirurgiche, di lifting, è una forma di “artificio” esercitata su un supporto straordinario, in questo caso il proprio corpo, e l’artificio consiste nel raderla, o nell’acconciarla in un certo modo. Comunque, come per l’arte credo si possa individuare una linea evolutiva, che va dalle grotte di Lascaux all’impressionismo, così per la barba ce n’è una che va dagli egizi, dagli ebrei e dai greci fino alle barbe ottocentesche, rivoluzionarie o borghesi, e fino all’invenzione del rasoio di sicurezza da parte di Gillette. Lungo questa linea la barba ha mantenuto primordiali significati o ne ha acquisiti col tempo di nuovi, ha rappresentato l’ostentazione visibile di particolari scelte, ha costituito un elemento identificativo o un fattore identitario. Si può dire che i suoi apologeti abbiano grosso modo fatto sempre riferimento ad una immagine maschile basata sulla fisicità. Erano il corpo maschile, sostenevano, e le forze mentali e morali latenti al suo interno, a giustificare la rivendicazione maschile dell’autorità e del dominio. L’alternativa a questa idea era la nozione opposta per cui la vera virilità si basa su idealità che trascendono il sé, siano queste di volta in volta Dio, la comunità, la nazione o l’azienda. Rasare via la barba significava pertanto cancellare simbolicamente il peccato originale, la debolezza e la corruzione della nostra natura fisica. Il rasoio era la razionalità.
Il confine tra questi due atteggiamenti si è spostato poi più volte nel corso del tempo, è diventato sovente molto confuso, come dimostra il rapporto ambiguo con la barba maturato dal cristianesimo, o dal pensiero libertario. Ma anche quando non ha corso linearmente, in linea di massima lo spartiacque ideologico è rimasto visibile. O almeno, io ho creduto in questo pasticciatissimo excursus di poterlo identificare.
Di fronte al panorama attuale ciò non è più possibile. Quel che viene dopo è Novecento: è trionfo della società dello spettacolo su ogni altra motivazione. Bacone direbbe che gli idòla fori e gli idòla theatri hanno prevalso sugli idòla tribus e su quelli specus. O, se si vuole, è postmodernità, nella sua versione più elementare di dissacrazione e decontestualizzazione spettacolarizzata di ogni portato della cultura umana precedente, e nella fattispecie di qualsivoglia esito della “civilizzazione” occidentale.
La linea che bene o male consentiva di interpretare i fenomeni risulta interrotta, e assistiamo all’esplosione di supernove che appaiono in maniera del tutto indipendente (o quasi), e poi collassano altrettanto velocemente.
Per questo, se state coltivando l’onor del mento, non buttate via lamette e rasoi: già domani potrebbero tornare di moda.

Tavola 30 – Abbarbicati

Appendici
Aggiungo un paio di appendici, tratte dal materiale raccolto per questa storia e poi scartato (a questo punto, dopo sessanta pagine, penso di potermi permettere tutto).
La barba di Freud …
Freud dà della barba una singolare interpretazione[27]. Lui stesso ne è un cultore, e quella che esibisce nei suoi ritratti, soprattutto in quelli della tarda maturità, è una barba molto ebraica, che sembra crescere dal profondo, come riemersione dell’inconscio. Ma non è della sua barba che parla, quanto di quella del Mosè michelangiolesco. Nella statua il profeta viene mostrato mentre volge il capo a sinistra, ma la sua mano, quella del braccio dal quale sono rette le tavole della legge, sembra tirare a sé la barba, che infatti non cade perpendicolare al mento. Secondo Freud Mosè si è girato di scatto, mosso da un impeto d’ira (ha appena constatato che il popolo ebraico ha cominciato a venerare un vitello d’oro, e i suoi occhi e i suoi muscoli tesi trasmettono tutta la sua rabbia), e si sta tirando la barba per domare il proprio sentimento (la propria libido) e per salvaguardare le tavole con i Comandamenti. In realtà sembra che questi ultimi stiano già scivolando lentamente dalla sua presa, e il loro destino sarà comunque quello di andare in frantumi. La barba avrebbe quindi un ruolo nella rimozione della libido: come a dire che la cura, il disciplinamento dei nostri aspetti naturali, ci permette di avere il controllo delle nostre passioni senza ricorso all’artificio (la psicanalisi vuole essere alternativa alle cure farmacologiche). Il finale della storia però lo contraddice: nella versione originale le tavole sono fatte a pezzi da Mosé scagliandole contro una roccia. La barba non basta.
… e quella di Platone
Qualche volta, anzi, è di troppo. In un suo famoso saggio il filosofo Willard Quine, esponente di spicco della filosofia analitica, contrappone alla barba di Platone al rasoio di Occam, che dovrebbe limitarne la crescita scomposta. Il “rasoio di Occam” è il principio metodologico che indica di scegliere, tra più ipotesi per la risoluzione di un problema, a parità di risultati, quella più semplice. È quindi in grado di tagliare la barba a Platone, ovvero di riportare il dibattito filosofico all’essenziale, cancellando con un sol colpo le complessità introdotte da una teoretica troppo arzigogolata e futile.
In tempi recenti il rasoio è stato rispolverato da alcuni filosofi italiani (tra i quali Carlo Augusto Viano e Maurizio Ferraris) per dare un taglio alle elucubrazioni nelle quali è scaduto il “pensiero debole” dei post-modernisti. In sostanza, il tema è l’esistenza o meno di una realtà oggettiva. Esiste il mondo? C’è qualcosa qui fuori di me? Ferraris lo dimostra con l’esperimento della ciabatta. Immaginiamo, dice, che un uomo, dopo aver visto un paio di ciabatte poggiate sopra un tappeto, chieda ad un altro di passargliele. L’altro lo fa senza difficoltà e senza necessità di ulteriori spiegazioni. “Banale fenomeno di interazione, che però mostra come, se davvero il mondo esterno dipendesse anche solo un poco, non dico dalle interpretazioni e dagli schemi concettuali, ma dai neuroni, la circostanza che i due non possiedano gli stessi neuroni dovrebbe vanificare la condivisione della ciabatta”.
Cosa c’entra tutto questo con la barba? Più di quanto crediamo, e magari va anche a mettere in forse tutte (o almeno in parte) le interpretazioni che ho cercato di dare e di darmi di un aspetto della nostra quotidianità col quale facciamo i conti da sempre. L’unica certezza, ma fondamentale, è che la barba cresce a tutti noi maschi, chi più chi meno. Sulle interpretazioni, come abbiamo visto, ci sarebbe molto da discutere.
E il problema dovremmo semmai porcelo il giorno in cui dovessimo renderci conto che non ci cresce più.
Bibliografia
Non essendo questo uno studio scientifico non mi sento in obbligo di fornire una bibliografia ragionata sull’argomento, Mi limito dunque a ricordare alcune tappe significative degli studi pogonologici, a partire dall’età moderna.
Nel 1513 l’umanista bellunese Pierio Valeriano pubblica un libretto intitolato Defensio pro Sacerdotum Barbis (che viene tradotto persino in inglese). In linea con la svolta rinascimentale, giustifica il diritto del clero all’adozione della barba.
Quasi un secolo dopo, nel 1603, Marco Antonio Olmo, professore di medicina all’Università di Bologna, pubblica Physiologia Barbae Humanae. Propone una spiegazione medico-teologica della barba. Se scopo del corpo è servire l’anima, così anche i peli, che del corpo sono parte, hanno questo scopo. Forniscono infatti un segno esterno degli ‛spiriti genitali’ e della maturazione virile dell’anima maschile.
Anche Jean Baptiste van Helmont fisiologo fiammingo, considera barba e baffi una questione morale o teologica, in Ortus medicinae, vel opera et opuscula omnia (1668).
Nel 1690 Samuel Theodor Schönland, pastore luterano di Lommatzsch, pubblica un discorso sul positivo contributo della barba alla virtù maschile, e nel 1698 un professore dell’Università di Wittenberg, Georg Caspar Kirchmaier, denuncia gli “odiatori di barbe” affermando che la natura ha dato agli uomini la barba come segno di onore e supremazia.
L’illuminista Giuseppe Valeriano Vannetti presenta nel 1759, in Barbalogia. Ragionamento intorno alla barba, un’esplorazione accurata delle consuetudini di ebrei, greci, macedoni, romani e uomini medievali, condizionati dal loro credo, dal potere, dal contesto sociale, e quindi intenti a sbarbarsi oppure a fare sfoggio di abbondante peluria.
Sei anni dopo, il gesuita francese Francis Oudin pubblica Recherches sur la barbe (sul Mercure de France) e nel 1774 l’erudito abate Augustin Fangé scrive Mémoires pour servir à l’histoire de la barbe de l’homme. Nel 1786, Jacques Antoine Dulaure, storico e politico, pubblica Pogonologie, ou Histoire philosophique de la barbe.
Thomas S. Gowing sviluppa nel 1854, in Filosofia della barba, una divertente e informata apologia di questa caratteristica del corpo maschile.
Infine Christopher Oldstone-Moore, professore di storia alla Wright State University, in un suo recentissimo libro (Of Beards and Men, del 2017) ha studiato le ragioni evolutive per cui gli uomini hanno la barba.
In italiano esistono comunque pochissime opere specifiche sull’argomento qui trattato. Fondamentale, documentatissima e dettagliata rimane la voce BARBA, redatta da Ugo Enrico Paoli, Carlo Alberto Petrucci e Carlo Cecchelli per l’Enciclopedia Italiana Treccani (edizione 1930). L’avessi consultata prima, probabilmente mi sarei risparmiato tutto questo lavoro.
Tra le opere più recenti, interessante, almeno per quanto concerne le implicazioni religiose, La barba di Aronne. I capelli lunghi e la barba nella vita religiosa, scritto da un monaco, Guidalberto Bormolini, ed edito da Libreria Editrice Fiorentina nel 2010.
Note
[1] Philippe Meyer, ne I progressi del progresso (1998) indica altre caratteristiche peculiari: “L’uomo si distingue dagli animali da parecchi tratti notevoli. Paga le tasse, ascolta rock and roll, si rade i peli del viso e cucina buona parte del suo cibo”.
[2][2] I “criteri” dell’azione selettiva sono particolarmente complessi. Ad esempio, il minore tasso di villosità che caratterizza molte popolazioni dell’estremo oriente è stato recentemente spiegato con la scoperta di una mutazione, verificatasi circa 35.000 anni fa in Cina, del gene EDAR 370A, Questo gene, comune anche agli Europei e agli Africani, nella maggior parte degli individui asiatici orientali e nei nativi americani presenta delle variazioni, che determinano delle caratteristiche fisiche diverse. Oltre che del diverso spessore e della diversa densità di peli facciali, peli corporei e capelli, è ritenuto infatti anche il responsabile determinante della diversa conformazione dentale, di un numero maggiore di ghiandole sudoripare e di un minore sviluppo del seno nelle femmine.
[3] Così come non lo avevano i Neanderthal e l’Homo erectus. La biologia evolutiva non ha ancora dato una risposta sull’esistenza di questo carattere particolare.
[4] Il più celebre medico della tarda antichità, Galeno, nel De Usu partium (II secolo d.C.) ne dà questa interpretazione: “I peli che crescono sulle guance non soltanto le riparano, ma le completano accorciandole in modo ordinato. Essi infatti danno un tocco di veneranda mascolinità all’individuo, soprattutto con il passare degli anni e soprattutto se ricoprono tutte le guance in ogni loro punto e per bene. Per lo stesso motivo la natura ha lasciato privi di peli e spogli i cosiddetti pomi e il naso. Diversamente, il volto dell’uomo assumerebbe un aspetto selvatico e ferino, e dunque per niente appropriato a un essere mansueto e socievole”.
Con largo anticipo su Darwin, e con la sua consueta delicatezza, Schopenhauer ne Il mondo come volontà e rappresentazione (1819) la spiega invece così: “La barba degli uomini: io ne suppongo la causa finale in ciò, che i caratteri patognomici, cioè il rapido mutamento dei tratti del viso che rivela ogni intimo moto dell’animo, divengono visibili principalmente sulla bocca e nella parte circostante; per sottrarre quindi queste alterazioni, in quanto spesso pericolose, nelle trattative o negli avvenimenti improvvisi, allo sguardo indagatore della controparte, la natura (che sa che homo homini lupus) ha dato la barba all’uomo. Invece la donna ha potuto farne a meno, dato che la dissimulazione e la padronanza di sé sono in lei innate”.
[5] Un proverbio africano recita: “Quando compare la barba scompare l’infanzia”.
[6] È testimoniato nell’isola di Cipro (da Pausania e da Macrobio), un culto di Afrodito, divinità raffigurata con una forma femminile e vestiti come quelli di Afrodite, ma anche con un fallo e con una lunga barba.
[7] È uno dei casi, in realtà abbastanza rari, nei quali, se acconciata in un determinato mo-do, la barba suggerisce una colpa o un vizio di cui si è macchiato colui che la porta. Con significato ben diverso questo uso è stato ripreso da un atleta italiano, il saltatore in alto Gianmarco Tamberi.
[8] Che fa dire ad Alessandro: “Forse non sai che nelle battaglie non esiste nulla di più comodo che afferrare gli avversari per la loro barba?”.
[9] Col diffondersi del modello macedone nasce anche una categoria di artigiani specializ-zati nell’uso del rasoio, per gli usi più diversi (anche chirurgici), e i negozi di barberia diventano naturalmente luoghi di scambio di opinioni e informazioni, collegati, ma an-che contrapposti, in qualche modo alternativi, al pubblico dibattito che si svolge nell’agorà. Per questo sono particolarmente invisi alla classe intellettuale.
[10] Il suo contemporaneo Aulo Gellio, nelle Notti attiche, scriveva: “Vedo la barba e il mantello, ma non il filosofo”. (Video barbam et pallium; philosophum nondum video). E anche Plutarco, nelle Opere Morali, ribadiva che “La barba non fa il filosofo”. Un altro loro coetaneo, Luciano di Samosata, ci andava giù pesante: “Se i filosofi si misurassero in base alla barba, il primo posto spetterebbe alle capre.” (Dialoghi)
[11] “Sis licet, ut debes, tellus, placata levisque, Artificis levior non potes esse manu.”
[12] Steinbeck osservava che “Al giorno d’oggi, farsi crescere la barba è l’unica cosa che una donna non può fare meglio di un uomo, e se può, il suo successo è assicurato solo in un circo”.
[13] In questo caso l’intreccio con la politica è immediato. Venezia è l’antagonista dell’impero bizantino per l’egemonia sul mediterraneo orientale (finanzia la quarta cro-ciata, che porterà al sacco di Costantinopoli) e usa l’arma religiosa offerta dallo scisma per combattere l’avversario.
[14] L’uso dei profili sbarbati impressi sulle monete ha però forse una giustificazione emi-nentemente pratica, data dalla estrema difficoltà di scolpire le barbe in matrici di conio così piccole.
[15] Che secondo alcuni storici portavano lunghi baffi e una folta barba come segno di ve-nerazione verso il dio della guerra Wotan.
[16] Che anzi, in Degli ebrei e delle loro menzogne da antisemita viscerale l’associa a “questi velenosi vermi avvelenati”.
[17] I ritratti ufficiali di More, quelli a lui contemporanei, ce lo mostrano in realtà accura-tamente sbarbato. Pare abbia iniziato a farsi crescere la barba nella Torre di Londra.
[18] Oggi però, i protagonisti di moderne epopee fiabesche come Gandalf, Obi Wan Kenobi e Albus Silente hanno ribaltato l’immagine negativa dell’uomo con la barba.
[19] “Io desidero trasfigurare i caproni civili, ossia i cittadini, e il clero, ossia i monaci e i pope. I primi, affinché essi se ne vadano in giro senza barba come fanno gli europei, e i secondi, affinché essi, ancorché con la barba, insegnino ai parrocchiani le virtù cristiane, così come io ho udito fare dai pastori in Germania”.
[20] A questo proposito, è da notare che dopo i fasti dei tonsores romani la considerazione per l’attività dei barbieri ridiscende molto nel medioevo, anche se ad essa continua ad essere associata una rudimentale licenza chirurgica (nel palo che un tempo era tipico delle barberie, la fascia rossa sta a rappresentare il sangue venoso e quella bianca le fasciature usate per chiuderlo) Ancora nel Galateo Monsignor Della Casa li accomuna sprezzantemente a cavadenti e castraporci. Il suo disprezzo è spia dell’irritazione degli intellettuali per il ruolo “culturale”, a livello popolare, che le botteghe di barbiere svolgono. Non è un caso che Cervantes affianchi al curato un barbiere nel tentativo di far rinsavire Don Chisciotte dalle sue ossessioni: e che il nostro eroe, in mancanza di un elmo, si calchi sul capo proprio la sua bacinella professionale. Nel ‘700 poi il barbiere rappresenta una vera autorità laica, spesso contrapposta a quella religiosa del curato, e la sua bottega diventa luogo di libera discussione, di lettura del giornale e di diffusione delle nuove idee laiche e illuministiche, al pari delle caffetterie. Questa autorevolezza sociale dei barbieri suscita l’ironia di Foscolo: “Suonatori di corni e di trombo-ni, / Comici, cavadenti, parrucchieri, / Birri, gendarmi, sindaci, lenoni, / Si chiamano per burla cavalieri” (epigramma attribuito).
Eppure il loro ruolo sociale è ormai talmente riconosciuto che il più antico giornale francese (tuttora in pubblicazione) nasce nel 1826 col titolo “Le Figaro”, e si impone come il giornale politico e letterario per eccellenza.
[21] Soprattutto, la barba resiste, in forza di una tradizione, ma con significato rivoluzionario, nell’ambito dell’ebraismo. Portano barbe foltissime ad esempio, i maggiori rappresentanti del movimento sionista, da Theodor Herzl a Martin Buber a Max Nordau. (tav. 27)
[22] Ne “Il conte di Montecristo” compaiono però grandi barbe associate alla giustizia e alla vendetta, quelle dell’abate Faria e di Edmond Dantes. Il romanzo esce quasi contemporaneo all’edizione definitiva de “I promessi sposi”, dove il giusto per eccellenza è l’unico protagonista con la barba, padre Cristoforo.
[23] Da non confondersi con l’“igienismo”, che è una filosofia dell’osservanza delle leggi naturali che arriva a negare la teoria batterica.
[24] “Oggi regna sovrana la lavabilità. È come se l’acqua scendesse dovunque lungo le pareti e l’incanto dei moderni impianti sanitari entra impercettibilmente, come apriori della mente meccanica finita, negli odierni prodotti industriali più pregiati ed accurati.” (Ernst Bloch, Spirito dell’Utopia)
[25] E non si tratta solo di una tacita convenzione. Ancora nei primi anni settanta la Disney ha vietato rigorosamente barba e baffi ai propri impiegati (cosa abbastanza paradossale, visto che il fondatore aveva sempre portato i baffi) e ha allentato le sue regole solo nel 2012, permettendo di farsi crescere delle barbe “pulite e professionali”.
[26] Un gruppo di scienziati australiani ha scritto che più uomini portano la barba, minore è la percentuale di donne che dice di esserne attratta. Attualmente, secondo questi scienziati, è stato raggiunto un “picco delle barbe”: il numero di donne che le apprezza sta diminuendo e la maggior parte di loro dice di preferire gli uomini che si radono.
[27] Opere di Sigmund Freud (OSF) Vol 7. Totem e tabù e altri scritti 1912-1914, Torino, Bollati Boringhieri, 2000
 Le “ariette” che postiamo dovrebbero essere, negli intenti del loro estensore, «un contrappunto leggero e ironico alle corpose riflessioni pubblicate di solito sul sito. Un modo per dare un piccolo contributo “laterale” al discorso».
Le “ariette” che postiamo dovrebbero essere, negli intenti del loro estensore, «un contrappunto leggero e ironico alle corpose riflessioni pubblicate di solito sul sito. Un modo per dare un piccolo contributo “laterale” al discorso».








 Ma nel monologo interiore, in che lingua parliamo? Le variazioni nelle lingue dipendono quasi certamente da un utilizzo diverso dell’insieme dei meccanismi mentali, non dall’esistenza di dispositivi diversi. Per questo è importante comprendere che origine abbia il sostrato comune.
Ma nel monologo interiore, in che lingua parliamo? Le variazioni nelle lingue dipendono quasi certamente da un utilizzo diverso dell’insieme dei meccanismi mentali, non dall’esistenza di dispositivi diversi. Per questo è importante comprendere che origine abbia il sostrato comune. Il dibattito in proposito è vivacissimo, costantemente alimentato dalle scoperte paleontologiche, ma soprattutto da quelle neurofisiologiche. Non è un dibattito ozioso, perché suppone interpretazioni molto divergenti del posto dell’uomo nella natura, dalle quali scaturiscono letture completamente opposte della nostra storia. È comunque viziato a parer mio da alcune pregiudiziali, a volte ideologiche (è senz’altro il caso di Chomsky, di Marshall Shalins, ma anche di Steven Pinker), più spesso dettate proprio dal tipo di approccio professionale (Dennett, Fodor, ecc…). Un cognitivista, un paleontologo, un neuroscienziato, un antropologo, partono da punti di vista completamente diversi, e per quanti sforzi facciano di essere interdisciplinari si portano sempre appresso lo stigma del punto di partenza.
Il dibattito in proposito è vivacissimo, costantemente alimentato dalle scoperte paleontologiche, ma soprattutto da quelle neurofisiologiche. Non è un dibattito ozioso, perché suppone interpretazioni molto divergenti del posto dell’uomo nella natura, dalle quali scaturiscono letture completamente opposte della nostra storia. È comunque viziato a parer mio da alcune pregiudiziali, a volte ideologiche (è senz’altro il caso di Chomsky, di Marshall Shalins, ma anche di Steven Pinker), più spesso dettate proprio dal tipo di approccio professionale (Dennett, Fodor, ecc…). Un cognitivista, un paleontologo, un neuroscienziato, un antropologo, partono da punti di vista completamente diversi, e per quanti sforzi facciano di essere interdisciplinari si portano sempre appresso lo stigma del punto di partenza. Non ho competenze sufficienti per entrare nel merito. Quella che a naso più mi convince è però la tesi della natura coevolutiva del linguaggio, che oltretutto si presta perfettamente alla prosecuzione del mio percorso. Chi la sostiene
Non ho competenze sufficienti per entrare nel merito. Quella che a naso più mi convince è però la tesi della natura coevolutiva del linguaggio, che oltretutto si presta perfettamente alla prosecuzione del mio percorso. Chi la sostiene
















 Durante il mio recente viaggio a Napoli all’inizio ho fatto fatica a risintonizzarmi sulle frequenze della mia città del cuore. Poi mi hanno riassestato certi incontri al Quartiere Sanità, certi occhi al Rione Forcella, certi Caravaggio e Gentileschi al Museo di Capodimonte. Inutile sforzarsi di tenere separati alto e basso, miseria e nobiltà, sublime e sordido. Inutile tentare di difendersi dal disagio con la spada del Giudizio. Giudica l’occhio del colonialista, che sa già in anticipo cosa si aspetta di trovare. Il senso del viaggio è forse altro, e ce lo ricorda il primo esule Dante/Ulisse, quando afferma che a ripartire da Itaca lo spinse “l’ardore / ch’i ebbi a divenir del mondo esperto, / e delli vizi umani e del valore”. Vizi e valore sullo stesso piano dell’esperienza. Allora, in questo breve viaggio che è la vita, meglio sentirsi esuli su questo pianeta rotante e fragile. Meglio assumere il rischio che anche la nostra nave si perda nel vortice incomprensibile della complessità di ciò che è. Può darsi che alla fine ci sarà dolce naufragare in questo mare.
Durante il mio recente viaggio a Napoli all’inizio ho fatto fatica a risintonizzarmi sulle frequenze della mia città del cuore. Poi mi hanno riassestato certi incontri al Quartiere Sanità, certi occhi al Rione Forcella, certi Caravaggio e Gentileschi al Museo di Capodimonte. Inutile sforzarsi di tenere separati alto e basso, miseria e nobiltà, sublime e sordido. Inutile tentare di difendersi dal disagio con la spada del Giudizio. Giudica l’occhio del colonialista, che sa già in anticipo cosa si aspetta di trovare. Il senso del viaggio è forse altro, e ce lo ricorda il primo esule Dante/Ulisse, quando afferma che a ripartire da Itaca lo spinse “l’ardore / ch’i ebbi a divenir del mondo esperto, / e delli vizi umani e del valore”. Vizi e valore sullo stesso piano dell’esperienza. Allora, in questo breve viaggio che è la vita, meglio sentirsi esuli su questo pianeta rotante e fragile. Meglio assumere il rischio che anche la nostra nave si perda nel vortice incomprensibile della complessità di ciò che è. Può darsi che alla fine ci sarà dolce naufragare in questo mare. Ma insomma cosa vogliono da noi gli dei della Grecia? Perché li ritroviamo dappertutto, cos’hanno ancora da dirci questi meravigliosi fiori recisi dalla loro terra, dal loro tempo? Per anni mi sono chiesto il motivo di questa inspiegabile passione per la mitologia greca, cresciuta quasi a dispetto della mia formazione kantiana. Solo da poco i pezzi del puzzle sono andati a posto. Esistono, spiega Aristotele, i philòsophos, gli amanti della sapienza. E poi ci sono i philòmythos, gli amanti dei miti. La differenza? I primi partono dallo stupore, raggiungono filosofando le vette della sapienza e a quel punto si stupiscono solo del fatto che si possa dubitare di ciò che è. Anche gli amanti dei miti partono dallo stupore, ma nello stupore permangono. Sembrerebbero non esserci dubbi su quale sia il livello di conoscenza più alto. Ma Nietzsche il dionisiaco ci ha spiegato “come il mondo vero finì per diventare favola”, nel meriggio di Zarathustra che ha spazzato via in un colpo solo il mondo “vero” e il mondo “apparente”. Cosa resta allora, dopo oltre un secolo di relativismo e nichilismo? Restano gli dei della Grecia e le loro storie, che sono metamorfosi, natura, eros, festa del presente. Presenze ancora vive e reali attorno a noi, che si manifestano attraverso la grande arte, che in infiniti tempi e forme si è nutrita dei loro segreti. Resta, per fortuna, la possibilità di permanere nello stupore di fronte a tutto ciò, di permanere in questa saggezza bambina che profuma di felicità.
Ma insomma cosa vogliono da noi gli dei della Grecia? Perché li ritroviamo dappertutto, cos’hanno ancora da dirci questi meravigliosi fiori recisi dalla loro terra, dal loro tempo? Per anni mi sono chiesto il motivo di questa inspiegabile passione per la mitologia greca, cresciuta quasi a dispetto della mia formazione kantiana. Solo da poco i pezzi del puzzle sono andati a posto. Esistono, spiega Aristotele, i philòsophos, gli amanti della sapienza. E poi ci sono i philòmythos, gli amanti dei miti. La differenza? I primi partono dallo stupore, raggiungono filosofando le vette della sapienza e a quel punto si stupiscono solo del fatto che si possa dubitare di ciò che è. Anche gli amanti dei miti partono dallo stupore, ma nello stupore permangono. Sembrerebbero non esserci dubbi su quale sia il livello di conoscenza più alto. Ma Nietzsche il dionisiaco ci ha spiegato “come il mondo vero finì per diventare favola”, nel meriggio di Zarathustra che ha spazzato via in un colpo solo il mondo “vero” e il mondo “apparente”. Cosa resta allora, dopo oltre un secolo di relativismo e nichilismo? Restano gli dei della Grecia e le loro storie, che sono metamorfosi, natura, eros, festa del presente. Presenze ancora vive e reali attorno a noi, che si manifestano attraverso la grande arte, che in infiniti tempi e forme si è nutrita dei loro segreti. Resta, per fortuna, la possibilità di permanere nello stupore di fronte a tutto ciò, di permanere in questa saggezza bambina che profuma di felicità.
 “Essere o non essere”? Il dubbio amletico si incide nella nostra pelle davanti ai resti del teschio di nostro padre, o di nostro nonno. Non uno dei mille anonimi teschi “memento mori” dei quadri napoletani o dei sotterranei siciliani: un teschio che aveva nome e cognome, che apparteneva a chi abbiamo amato. Penso ai nostri progenitori che, nel buio delle grotte, oltre al resto, dovevano imparare a gestire anche questa assurdità della scomparsa dei corpi. Nessuno mi leva dalla testa che la nascita dell’arte e di ogni forma di platonismo possibile nasca dalla necessità di elaborare in qualche modo questo scandalo originario, affrontato e risolto brillantemente da buddhismo e cristianesimo con le due opzioni obbligate della reincarnazione e della resurrezione integrale. Qualcosa era, e poi non è mai più. Tutte le meraviglie della cultura, della spiritualità e dell’arte sono forse state costruite in migliaia di anni per occultare questa semplice verità, o per provare a spiegarla. Soli, di fronte a quelle ossa, queste maestose impalcature del pensiero e dell’azione tradiscono le loro strutture di sostegno. Armati di un milione di risposte possibili, restiamo al fondo senza risposte, ancora e sempre atterriti, nel buio della nostra grotta. E allora? L’arte, ancora e sempre: “Dormire, forse sognare”.
“Essere o non essere”? Il dubbio amletico si incide nella nostra pelle davanti ai resti del teschio di nostro padre, o di nostro nonno. Non uno dei mille anonimi teschi “memento mori” dei quadri napoletani o dei sotterranei siciliani: un teschio che aveva nome e cognome, che apparteneva a chi abbiamo amato. Penso ai nostri progenitori che, nel buio delle grotte, oltre al resto, dovevano imparare a gestire anche questa assurdità della scomparsa dei corpi. Nessuno mi leva dalla testa che la nascita dell’arte e di ogni forma di platonismo possibile nasca dalla necessità di elaborare in qualche modo questo scandalo originario, affrontato e risolto brillantemente da buddhismo e cristianesimo con le due opzioni obbligate della reincarnazione e della resurrezione integrale. Qualcosa era, e poi non è mai più. Tutte le meraviglie della cultura, della spiritualità e dell’arte sono forse state costruite in migliaia di anni per occultare questa semplice verità, o per provare a spiegarla. Soli, di fronte a quelle ossa, queste maestose impalcature del pensiero e dell’azione tradiscono le loro strutture di sostegno. Armati di un milione di risposte possibili, restiamo al fondo senza risposte, ancora e sempre atterriti, nel buio della nostra grotta. E allora? L’arte, ancora e sempre: “Dormire, forse sognare”. Calasso, il Grande Elleno che da poco ha smesso di scrivere, ci ricorda che la scrittura è stata donata agli uomini da Cadmo, il fenicio che aveva salvato Zeus, e sembra questione che ci riguarda poco, se dimentichiamo che l’Italia del Sud a quei tempi si chiamava Grecia. La prima colonia in Italia l’hanno fondata a Ischia nell’VIII secolo a.C. i greci dell’Eubea. Il loro alfabeto era una variante di quello attico, e le loro lettere si sono poi diffuse in Lazio, fornendo il modello per l’alfabeto etrusco, per quello latino, e poi a seguire per quello italiano e inglese, insomma in realtà parliamo sempre di noi. Tutto questo per arrivare alla “Coppa di Nestore”. L’hanno trovata in una sepoltura ad Ischia, ed è il messaggio più antico nella “nostra lingua” finora riemerso dagli abissi della storia. Raccomanda i valori della poesia, della convivialità e dell’amore: “Io sono la bella coppa di Nestore, chi berrà da questa coppa subito lo prenderà il desiderio di Afrodite dalla bella corona”. Forse Cadmo l’ha voluta salvare dalle ingiurie del tempo per avvisarci, per salvarci ancora.
Calasso, il Grande Elleno che da poco ha smesso di scrivere, ci ricorda che la scrittura è stata donata agli uomini da Cadmo, il fenicio che aveva salvato Zeus, e sembra questione che ci riguarda poco, se dimentichiamo che l’Italia del Sud a quei tempi si chiamava Grecia. La prima colonia in Italia l’hanno fondata a Ischia nell’VIII secolo a.C. i greci dell’Eubea. Il loro alfabeto era una variante di quello attico, e le loro lettere si sono poi diffuse in Lazio, fornendo il modello per l’alfabeto etrusco, per quello latino, e poi a seguire per quello italiano e inglese, insomma in realtà parliamo sempre di noi. Tutto questo per arrivare alla “Coppa di Nestore”. L’hanno trovata in una sepoltura ad Ischia, ed è il messaggio più antico nella “nostra lingua” finora riemerso dagli abissi della storia. Raccomanda i valori della poesia, della convivialità e dell’amore: “Io sono la bella coppa di Nestore, chi berrà da questa coppa subito lo prenderà il desiderio di Afrodite dalla bella corona”. Forse Cadmo l’ha voluta salvare dalle ingiurie del tempo per avvisarci, per salvarci ancora.
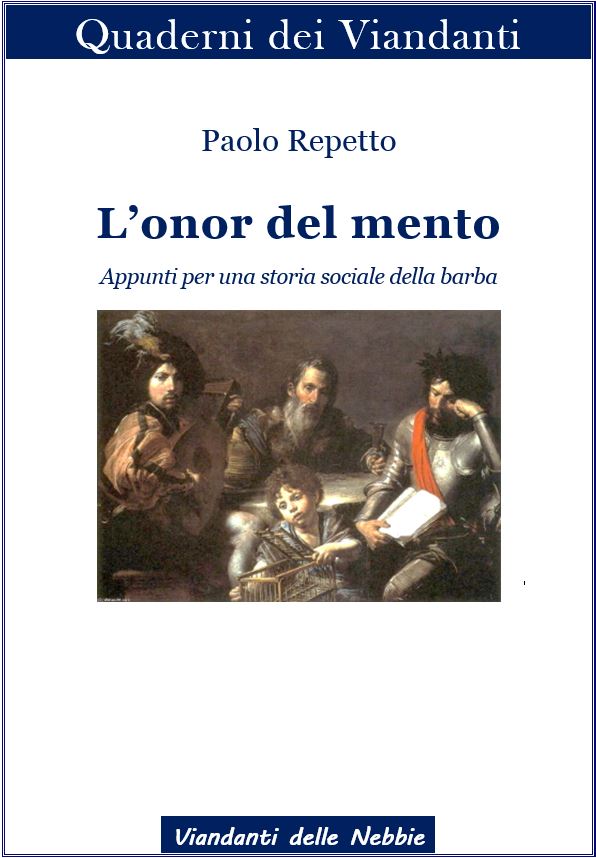


 È facilmente comprensibile come, proprio per la sua immediata associazione con la mascolinità, con una virilità matura, la barba abbia sempre goduto di un enorme prestigio presso tutte le popolazioni arcaiche (in particolare quelle “occidentali”), e sia stata esplicitamente investita di significati di “segnaletica” sociale, rispetto non solo al genere ma anche all’appartenenza a gruppi o classi particolari. Ma il carico simbolico di cui è stata oggetto, unito certamente a scelte di opportunità pratica, ha fatto sì che una semplice caratteristica naturale potesse diventare molto presto anche un problema. Pare infatti che sin dalla preistoria non sia stata considerata assolutamente intoccabile: diversi paleontologi interpretano come arnesi per la rasatura alcune pietre particolarmente affilate del paleolitico, e soprattutto certe lame dell’età del bronzo: ciò che farebbe risalire molto indietro nel tempo la pratica della rasatura. Senza dubbio comunque essa era presente ai primordi dei tempi storici, e i nostri più lontani antenati già si trovavano di fronte a una di quelle scelte che nel loro assieme hanno fatto di noi dei sapiens sapiens.
È facilmente comprensibile come, proprio per la sua immediata associazione con la mascolinità, con una virilità matura, la barba abbia sempre goduto di un enorme prestigio presso tutte le popolazioni arcaiche (in particolare quelle “occidentali”), e sia stata esplicitamente investita di significati di “segnaletica” sociale, rispetto non solo al genere ma anche all’appartenenza a gruppi o classi particolari. Ma il carico simbolico di cui è stata oggetto, unito certamente a scelte di opportunità pratica, ha fatto sì che una semplice caratteristica naturale potesse diventare molto presto anche un problema. Pare infatti che sin dalla preistoria non sia stata considerata assolutamente intoccabile: diversi paleontologi interpretano come arnesi per la rasatura alcune pietre particolarmente affilate del paleolitico, e soprattutto certe lame dell’età del bronzo: ciò che farebbe risalire molto indietro nel tempo la pratica della rasatura. Senza dubbio comunque essa era presente ai primordi dei tempi storici, e i nostri più lontani antenati già si trovavano di fronte a una di quelle scelte che nel loro assieme hanno fatto di noi dei sapiens sapiens. Un’attenzione ancor più particolare veniva riservata alla barba dagli ebrei. Nel loro caso la testimonianza delle immagini non ci soccorre granché, visto che in quanto popolo a vocazione nomade ne ha prodotte pochissime, e anche quelle sono andate per la gran parte distrutte o disperse nel corso di una storia tragicamente movimentata. Ma, soprattutto, il divieto iconoclasta di rappresentare o di provare anche soltanto ad immaginare le fattezze divine ha impedito la nascita di un modello “superiore” di riferimento. Occorre quindi affidarci piuttosto alle testimonianze scritte, queste decisamente abbondanti. Già nel Levitico, ad esempio, all’interno del cosiddetto “codice di santità” si fa espressa proibizione di radere la barba. In realtà la prescrizione riguarderebbe certi eccessi nelle manifestazioni del lutto, come appunto lo strapparsi barba e capelli, considerati di origine “pagana”: e trae giustificazione dall’idea che l’uomo, creato ad immagine di Dio (ecco come si aggira il divieto di rappresentare la divinità!), non debba in alcun modo intervenire sul proprio corpo. Naturalmente poi la casta sacerdotale ne ha imposto l’interpretazione più restrittiva e a lei più conveniente, quella che assegna alla barba, acconciata secondo particolari regole, il ruolo di segno distintivo (tanto del popolo ebraico nei confronti degli altri quanto delle caste al suo interno). E in tal senso si può dire che gli Ebrei lo scopo lo hanno perfettamente raggiunto: purtroppo, però, in negativo, perché col tempo quel segno è stato convertito nello stereotipo della barba caprina.
Un’attenzione ancor più particolare veniva riservata alla barba dagli ebrei. Nel loro caso la testimonianza delle immagini non ci soccorre granché, visto che in quanto popolo a vocazione nomade ne ha prodotte pochissime, e anche quelle sono andate per la gran parte distrutte o disperse nel corso di una storia tragicamente movimentata. Ma, soprattutto, il divieto iconoclasta di rappresentare o di provare anche soltanto ad immaginare le fattezze divine ha impedito la nascita di un modello “superiore” di riferimento. Occorre quindi affidarci piuttosto alle testimonianze scritte, queste decisamente abbondanti. Già nel Levitico, ad esempio, all’interno del cosiddetto “codice di santità” si fa espressa proibizione di radere la barba. In realtà la prescrizione riguarderebbe certi eccessi nelle manifestazioni del lutto, come appunto lo strapparsi barba e capelli, considerati di origine “pagana”: e trae giustificazione dall’idea che l’uomo, creato ad immagine di Dio (ecco come si aggira il divieto di rappresentare la divinità!), non debba in alcun modo intervenire sul proprio corpo. Naturalmente poi la casta sacerdotale ne ha imposto l’interpretazione più restrittiva e a lei più conveniente, quella che assegna alla barba, acconciata secondo particolari regole, il ruolo di segno distintivo (tanto del popolo ebraico nei confronti degli altri quanto delle caste al suo interno). E in tal senso si può dire che gli Ebrei lo scopo lo hanno perfettamente raggiunto: purtroppo, però, in negativo, perché col tempo quel segno è stato convertito nello stereotipo della barba caprina.

















 La ricomparsa nel Rinascimento dei volti incorniciati della barba non ha motivazioni politiche. Nasce piuttosto dal rinnovamento del pensiero che si produce in seno all’umanesimo, a partire da quello italiano. Si potrebbe parlare in proposito di una secolarizzazione, e più ancora di una personalizzazione individualistica, del modello di virilità. In altre parole: nel corso del medioevo la società laica ha costantemente cercato di conformarsi all’immagine della classicità: in maniera più o meno consapevole e voluta era prigioniera della pesantissima eredità della civiltà romana, nei confronti della quale provava un complesso di inferiorità. Con l’umanesimo questa soggezione viene meno: i nani sono saliti sulle spalle dei giganti, e guardano oltre. Ma per farlo devono liberare e riabilitare anche ogni espressione di naturalezza, di diversità e di individualità dei singoli corpi, ivi compresa la barba: ciò che invece era sacrificato, nel modello latino (e nel suo adattamento cristiano), al primato della “civitas”, della appartenenza ad un superiore contesto nel quale l’individuo si riconosceva e si annullava.
La ricomparsa nel Rinascimento dei volti incorniciati della barba non ha motivazioni politiche. Nasce piuttosto dal rinnovamento del pensiero che si produce in seno all’umanesimo, a partire da quello italiano. Si potrebbe parlare in proposito di una secolarizzazione, e più ancora di una personalizzazione individualistica, del modello di virilità. In altre parole: nel corso del medioevo la società laica ha costantemente cercato di conformarsi all’immagine della classicità: in maniera più o meno consapevole e voluta era prigioniera della pesantissima eredità della civiltà romana, nei confronti della quale provava un complesso di inferiorità. Con l’umanesimo questa soggezione viene meno: i nani sono saliti sulle spalle dei giganti, e guardano oltre. Ma per farlo devono liberare e riabilitare anche ogni espressione di naturalezza, di diversità e di individualità dei singoli corpi, ivi compresa la barba: ciò che invece era sacrificato, nel modello latino (e nel suo adattamento cristiano), al primato della “civitas”, della appartenenza ad un superiore contesto nel quale l’individuo si riconosceva e si annullava.

 Più ancora di qualsiasi obbligo vale però stavolta il dettame della moda, nel quale giocano fattori che davvero rientrano nell’imponderabile (e creano forti dubbi sulla possibilità di iscrivere i fenomeni sociali entro schemi razionali di lettura, e quindi sul lavoro stesso che sto facendo). Così come erano tornate, nel volgere di un secolo le barbe spariscono: e sono sostituite, a partire dalla metà del Seicento, dal trionfo delle parrucche. Sembrerà paradossale, ma la nuova svolta estetica non è in contraddizione con quanto dicevo sopra. Il XVII secolo è infatti particolarmente inquieto, e la situazione di continua belligeranza educa a uno stile militaresco e mascolino anche nell’aspetto: come racconta Manzoni nell’episodio del duello dell’Innominato, la litigiosità non è prerogativa solo delle grandi dinastie, ma è diffusa nella quotidianità da piccoli o grandi potenti e prepotenti, e questo atteggiamento impone di esibire un particolare phisique du role. Negli abiti prevale il cuoio, con grossi cinturoni cui vengono appese lunghe spade e con stivali pesanti a gamba alta e a tacco rialzato, abbondano i mantelli, che ingrossano la figura, e riesce opportuno a questo punto enfatizzare anche le dimensioni del capo con enormi cappelli a larga tesa e con una abbondante peluria, a minaccioso segnale di grande virilità.
Più ancora di qualsiasi obbligo vale però stavolta il dettame della moda, nel quale giocano fattori che davvero rientrano nell’imponderabile (e creano forti dubbi sulla possibilità di iscrivere i fenomeni sociali entro schemi razionali di lettura, e quindi sul lavoro stesso che sto facendo). Così come erano tornate, nel volgere di un secolo le barbe spariscono: e sono sostituite, a partire dalla metà del Seicento, dal trionfo delle parrucche. Sembrerà paradossale, ma la nuova svolta estetica non è in contraddizione con quanto dicevo sopra. Il XVII secolo è infatti particolarmente inquieto, e la situazione di continua belligeranza educa a uno stile militaresco e mascolino anche nell’aspetto: come racconta Manzoni nell’episodio del duello dell’Innominato, la litigiosità non è prerogativa solo delle grandi dinastie, ma è diffusa nella quotidianità da piccoli o grandi potenti e prepotenti, e questo atteggiamento impone di esibire un particolare phisique du role. Negli abiti prevale il cuoio, con grossi cinturoni cui vengono appese lunghe spade e con stivali pesanti a gamba alta e a tacco rialzato, abbondano i mantelli, che ingrossano la figura, e riesce opportuno a questo punto enfatizzare anche le dimensioni del capo con enormi cappelli a larga tesa e con una abbondante peluria, a minaccioso segnale di grande virilità. La barba però non si combina affatto con l’uso delle parrucche: ne evidenzia clamorosamente l’artificiosità, rendendole grottesche, un po’ troppo persino per un gusto come quello barocco che il grottesco lo apprezza. Indossare la parrucca comporta quindi la rasatura completa e costante del viso, che al più lascia spazio al vezzo di un paio di baffi e di un pizzetto sottili (il modello reso famoso dai tre moschettieri). Il cambiamento di modello trova riscontro persino nell’uso linguistico: l’antico “barbiere” diventa il moderno “parrucchiere”.
La barba però non si combina affatto con l’uso delle parrucche: ne evidenzia clamorosamente l’artificiosità, rendendole grottesche, un po’ troppo persino per un gusto come quello barocco che il grottesco lo apprezza. Indossare la parrucca comporta quindi la rasatura completa e costante del viso, che al più lascia spazio al vezzo di un paio di baffi e di un pizzetto sottili (il modello reso famoso dai tre moschettieri). Il cambiamento di modello trova riscontro persino nell’uso linguistico: l’antico “barbiere” diventa il moderno “parrucchiere”.














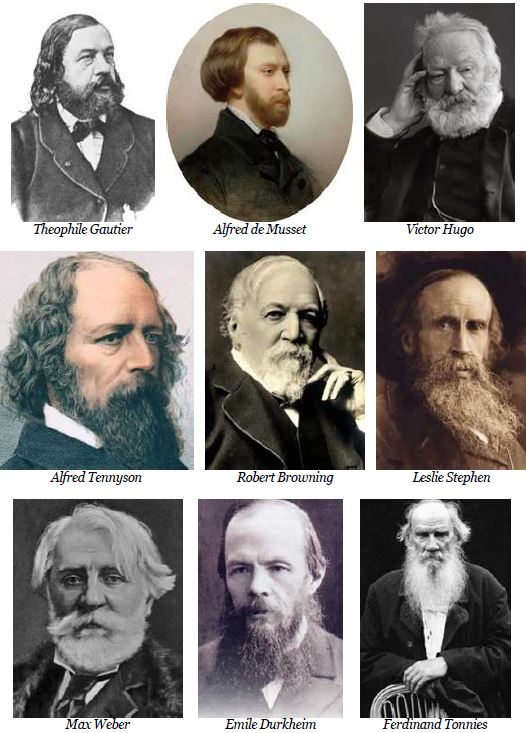














 In realtà, il gioco si semplifica se assumiamo che ormai a dettare l’acconciatura del volto è solo il capriccio della moda (che è poi un capriccio per modo di dire, in quanto è guidato a creare sempre a nuove tipologie di consumo). Ma nemmeno questo è del tutto vero, perché i dettami della moda a loro volta intercettano bisogni, paure e disagi collettivi diffusi (e li alimentano, quando addirittura non li creano). Quindi, come in passato, ma attraverso un filtro diverso, sui volti degli uomini, e dal fatto che siano sbarbati o meno, si può leggere la condizione dei nostri tempi. O almeno, come sarà nel mio caso, se ne possono trarre alcune considerazioni.
In realtà, il gioco si semplifica se assumiamo che ormai a dettare l’acconciatura del volto è solo il capriccio della moda (che è poi un capriccio per modo di dire, in quanto è guidato a creare sempre a nuove tipologie di consumo). Ma nemmeno questo è del tutto vero, perché i dettami della moda a loro volta intercettano bisogni, paure e disagi collettivi diffusi (e li alimentano, quando addirittura non li creano). Quindi, come in passato, ma attraverso un filtro diverso, sui volti degli uomini, e dal fatto che siano sbarbati o meno, si può leggere la condizione dei nostri tempi. O almeno, come sarà nel mio caso, se ne possono trarre alcune considerazioni. Nel ritorno alla barba si può però anche leggere semplicemente la riproposta di un antico richiamo sessuale, quello che fa leva sull’equivalenza “volto peloso-testosterone alto”, e quindi virilità matura. Il che si ricollega a quanto dicevo prima, perché la differenza ostentata dalla barba implica anche l’affermazione di una gerarchia tradizionale nella coppia. Come a dire: se mi vuoi virile, poi mi riconosci come dominante. Il fatto comunque che le femmine prediligano gli uomini barbuti, proprio in ragione di quanto sopra, è in realtà piuttosto controverso. Studi diversi hanno dato risultati del tutto opposti. Probabilmente esiste una correlazione tra il numero di uomini che la portano e la percentuale di donne che ne sono attratte
Nel ritorno alla barba si può però anche leggere semplicemente la riproposta di un antico richiamo sessuale, quello che fa leva sull’equivalenza “volto peloso-testosterone alto”, e quindi virilità matura. Il che si ricollega a quanto dicevo prima, perché la differenza ostentata dalla barba implica anche l’affermazione di una gerarchia tradizionale nella coppia. Come a dire: se mi vuoi virile, poi mi riconosci come dominante. Il fatto comunque che le femmine prediligano gli uomini barbuti, proprio in ragione di quanto sopra, è in realtà piuttosto controverso. Studi diversi hanno dato risultati del tutto opposti. Probabilmente esiste una correlazione tra il numero di uomini che la portano e la percentuale di donne che ne sono attratte Venuto meno il valore simbolico, rimane solo quello documentario. È evidente che i maschi, quanto meno quelli occidentali, sono in questo momento in gran confusione. Si sta sgretolando sotto i loro occhi tutto un mondo di convinzioni e di convenzioni, e non ce n’è in vista un altro pronto a sostituirlo. Essendo venute meno le autorità culturali uniche che un tempo definivano i parametri della mascolinità per tutti, e in assenza di qualsivoglia indicazione univoca su cosa implichi essere un uomo, gli uomini si sbizzarriscono a rappresentare se stessi sotto sempre nuovi mascheramenti. A dispetto della sua naturalezza, in fondo la barba è sempre stata in qualche modo anche una maschera: raderla significava strapparsela di dosso, mettersi a nudo.
Venuto meno il valore simbolico, rimane solo quello documentario. È evidente che i maschi, quanto meno quelli occidentali, sono in questo momento in gran confusione. Si sta sgretolando sotto i loro occhi tutto un mondo di convinzioni e di convenzioni, e non ce n’è in vista un altro pronto a sostituirlo. Essendo venute meno le autorità culturali uniche che un tempo definivano i parametri della mascolinità per tutti, e in assenza di qualsivoglia indicazione univoca su cosa implichi essere un uomo, gli uomini si sbizzarriscono a rappresentare se stessi sotto sempre nuovi mascheramenti. A dispetto della sua naturalezza, in fondo la barba è sempre stata in qualche modo anche una maschera: raderla significava strapparsela di dosso, mettersi a nudo.








 Faccio un esempio banalissimo. Le scelte iconografiche che corredano oggi i libri di testo delle elementari, giustificate con l’intento di educare gli allievi ad un rapporto e a una dimestichezza precoci con le “fonti documentali”, ottengono l’effetto opposto. Il valore evocativo di un dagherrotipo d’epoca che ritrae Nino Bixio è infinitamente minore rispetto a quello che aveva un tempo la figurina disegnata di un garibaldino, o di Bixio stesso, con la sua brava camicia rossa: illustrazione che avrebbe potuto essere trasposta di sana pianta in uno dei fumetti di capitan Miki o di Tex, o presa da esso, e che rimandava alla dimensione dell’avventura (alimentando peraltro la voglia di andare più tardi a scoprire che faccia aveva davvero quel garibaldino, e di cercare quindi il dagherrotipo). È evidente che oggi le stesse immagini non evocherebbero più nulla, perché nessun ragazzino legge più Miki o Tex, ma ciò che è andato a sostituirle non ha assolutamente un altrettale potere di suggestione, e non potrebbe averlo anche se usato nel migliore dei modi: semplicemente perché su quel versante la mente dei ragazzini è già colonizzata da ben altri effetti speciali.
Faccio un esempio banalissimo. Le scelte iconografiche che corredano oggi i libri di testo delle elementari, giustificate con l’intento di educare gli allievi ad un rapporto e a una dimestichezza precoci con le “fonti documentali”, ottengono l’effetto opposto. Il valore evocativo di un dagherrotipo d’epoca che ritrae Nino Bixio è infinitamente minore rispetto a quello che aveva un tempo la figurina disegnata di un garibaldino, o di Bixio stesso, con la sua brava camicia rossa: illustrazione che avrebbe potuto essere trasposta di sana pianta in uno dei fumetti di capitan Miki o di Tex, o presa da esso, e che rimandava alla dimensione dell’avventura (alimentando peraltro la voglia di andare più tardi a scoprire che faccia aveva davvero quel garibaldino, e di cercare quindi il dagherrotipo). È evidente che oggi le stesse immagini non evocherebbero più nulla, perché nessun ragazzino legge più Miki o Tex, ma ciò che è andato a sostituirle non ha assolutamente un altrettale potere di suggestione, e non potrebbe averlo anche se usato nel migliore dei modi: semplicemente perché su quel versante la mente dei ragazzini è già colonizzata da ben altri effetti speciali. Allo stesso modo, un piccolo excursus sulle simbologie negative del rosso o del giallo può diventare intrigante, e al tempo stesso, se ben pilotato, sgombrare il terreno da pregiudizi popolari radicati. Quando è associato a tratti morfologici, come il colore dei capelli o della pelle, il rosso connota tradizionalmente una disposizione negativa. Sono rossi i capelli e la barba di Giuda, ad esempio, così come ricorrono nella pittura medioevale (e sopravvivono in quella successiva), ma anche quelli di numerosissimi personaggi biblici o mitologici, o dei reprobi dei poemi cavallereschi, fino a quelli della letteratura romantica, e oltre (il Rosso Malpelo di Verga). Ora, questa valenza simbolica negativa ha un’origine facilmente identificabile: presso quasi tutte le etnie del mondo, con la parziale eccezione dei popoli scandinavi, gli individui di pelo rossiccio rappresentano delle esigue minoranze, e sono quindi percepiti immediatamente come dei “diversi”, alla stessa stregua ad esempio dei mancini. Non a caso, nella rappresentazione iconografica (ancora Giuda) e letteraria i due attributi marciano spesso di conserva. Il rosso diventa quindi per antonomasia il colore che connota, in progressione negativa, una differenza, una anomalia, un pericolo, il male. Diventa il colore di Satana. E l’identificazione simbolica finisce alla lunga per prescindere dal suo movente originario, al punto da imporsi anche presso quelle culture (le nordiche di cui sopra) nelle quali la motivazione della differenza morfologica non ha senso.
Allo stesso modo, un piccolo excursus sulle simbologie negative del rosso o del giallo può diventare intrigante, e al tempo stesso, se ben pilotato, sgombrare il terreno da pregiudizi popolari radicati. Quando è associato a tratti morfologici, come il colore dei capelli o della pelle, il rosso connota tradizionalmente una disposizione negativa. Sono rossi i capelli e la barba di Giuda, ad esempio, così come ricorrono nella pittura medioevale (e sopravvivono in quella successiva), ma anche quelli di numerosissimi personaggi biblici o mitologici, o dei reprobi dei poemi cavallereschi, fino a quelli della letteratura romantica, e oltre (il Rosso Malpelo di Verga). Ora, questa valenza simbolica negativa ha un’origine facilmente identificabile: presso quasi tutte le etnie del mondo, con la parziale eccezione dei popoli scandinavi, gli individui di pelo rossiccio rappresentano delle esigue minoranze, e sono quindi percepiti immediatamente come dei “diversi”, alla stessa stregua ad esempio dei mancini. Non a caso, nella rappresentazione iconografica (ancora Giuda) e letteraria i due attributi marciano spesso di conserva. Il rosso diventa quindi per antonomasia il colore che connota, in progressione negativa, una differenza, una anomalia, un pericolo, il male. Diventa il colore di Satana. E l’identificazione simbolica finisce alla lunga per prescindere dal suo movente originario, al punto da imporsi anche presso quelle culture (le nordiche di cui sopra) nelle quali la motivazione della differenza morfologica non ha senso. Dal canto suo, anche il giallo ha conosciuto una associazione simbolica negativa, solo appena più sfumata. Nell’iconografia medioevale, ma anche in quella successiva, è il colore del tradimento e della menzogna, come tale identificato non tanto nei tratti morfologici (ché, anzi, dopo le conquiste normanne il colore biondo dei capelli diventa il tratto distintivo della nuova nobiltà di spada) quanto nell’abbigliamento (dietro il quale, appunto, ci si nasconde). La veste di Giuda è spesso gialla, così come gialla è la stella identificativa degli ebrei, e tali sono molti capi di abbigliamento degli ebrei stessi, o dei buffoni di corte e dei saltimbanchi. In questo caso ad essere sottolineata è una diversità non “naturale”, ma sociale e culturale.
Dal canto suo, anche il giallo ha conosciuto una associazione simbolica negativa, solo appena più sfumata. Nell’iconografia medioevale, ma anche in quella successiva, è il colore del tradimento e della menzogna, come tale identificato non tanto nei tratti morfologici (ché, anzi, dopo le conquiste normanne il colore biondo dei capelli diventa il tratto distintivo della nuova nobiltà di spada) quanto nell’abbigliamento (dietro il quale, appunto, ci si nasconde). La veste di Giuda è spesso gialla, così come gialla è la stella identificativa degli ebrei, e tali sono molti capi di abbigliamento degli ebrei stessi, o dei buffoni di corte e dei saltimbanchi. In questo caso ad essere sottolineata è una diversità non “naturale”, ma sociale e culturale. Ecco, suggestioni di questo tipo sono, come dicevo, materia estremamente delicata, e vanno trasmesse assieme alla consapevolezza che si tratta di possibili modalità di lettura della storia, e non di chiavi magiche che aprono al suo senso: e che ogni angolo prospettico va confrontato con gli infiniti altri, non per contraddirli o negarli, ma anzi, per trarne conforto e ulteriori stimoli. È una cosa meno facile di quanto possa sembrare: le idee forti, i modelli interpretativi ad alto tasso di assertività esercitano un’indubbia attrattiva sulle menti adolescenziali (e non solo su quelle), che hanno bisogno di spiegazioni semplici, di un “senso” all’interno del quale e in funzione del quale collocare gli eventi storici. Ma d’altro canto queste suggestioni “integraliste” sono una tappa obbligata nel cammino di chi va alla scoperta della storia. Importante è che non rimangano l’ultima: cosa che invece accade quando le alternative offerte non sono altrettanto seducenti.
Ecco, suggestioni di questo tipo sono, come dicevo, materia estremamente delicata, e vanno trasmesse assieme alla consapevolezza che si tratta di possibili modalità di lettura della storia, e non di chiavi magiche che aprono al suo senso: e che ogni angolo prospettico va confrontato con gli infiniti altri, non per contraddirli o negarli, ma anzi, per trarne conforto e ulteriori stimoli. È una cosa meno facile di quanto possa sembrare: le idee forti, i modelli interpretativi ad alto tasso di assertività esercitano un’indubbia attrattiva sulle menti adolescenziali (e non solo su quelle), che hanno bisogno di spiegazioni semplici, di un “senso” all’interno del quale e in funzione del quale collocare gli eventi storici. Ma d’altro canto queste suggestioni “integraliste” sono una tappa obbligata nel cammino di chi va alla scoperta della storia. Importante è che non rimangano l’ultima: cosa che invece accade quando le alternative offerte non sono altrettanto seducenti.