di Paolo Repetto, 16 settembre 2022
Non sono un appassionato ermeneuta di programmi elettorali. Voto da quasi sessant’anni e non ne avevo mai letto uno. Questa volta l’ho fatto. Si potrebbe pensare ad un tardivo soprassalto di responsabilizzazione civica, ma in realtà sono stato mosso da semplice curiosità: volevo verificare quanto spazio vi fosse riservato ai problemi della scuola. La mia è senz’altro una deformazione professionale: capisco che con questi chiari di luna, tra guerre, emergenze ambientali, pandemie, recessioni economiche, il degrado della scuola possa apparire ai più un problema secondario, ma per fortuna non sono l’unico a pensarla diversamente. Lo spunto per queste righe è arrivato infatti da alcune osservazioni di Nico Parodi, che ha sempre operato in tutt’altro settore e della mia deformazione non soffre.
Giorni fa Nico mi raccontava lo sconcerto di una sua nipote per il fatto che nei testi scolatici dei figli (entrambi esordienti in nuovi cicli di studi) le immagini prevalgono sulla parte scritta. Alla fine ha commentato: «Ormai si studia sulle didascalie. La conoscenza che si acquisisce è solo un cumulo di frammenti estremamente volatili, che non attivano una linea di pensiero e non abituano ai passaggi logici. Anche di questi tempi il primo problema dovrebbe essere “il modo” in cui trasmettiamo la cultura, e invece pare che di questo freghi niente a nessuno». Ha ragione, e lo dimostra l’assenza totale di questo tema dallo sciagurato “dibattito” elettorale in corso. Il primo vero problema da affrontare, quello che dovrebbe aprire ogni programma, riguarda il ruolo e la “qualità” della scuola, il tipo di cultura che trasmettiamo, perché da quest’ultima dipende poi la capacità di comprendere e affrontare qualsiasi situazione: ma nessuno se lo pone.
Non è una novità. L’ultima riforma scolastica che esplicitava una “idea” del ruolo della cultura, e di conseguenza delle finalità della scuola, risale giusto a sessant’anni fa. Fu un mezzo disastro, perché quell’idea era equivoca, si era in pieno boom economico e la scuola veniva piegata a rispondere pedissequamente alle esigenze della “crescita”, dietro la facciata della democratizzazione e della promozione sociale; ma almeno testimoniava una consapevolezza del mutare dei tempi e una sia pure confusa volontà di affrontare il problema. I continui aggiustamenti venuti dopo non hanno fatto che accelerare la deriva: si sono persi completamente di vista la realtà scolastica e lo spirito che dovrebbe informarla.
Mi importava però capire se di quella consapevolezza rimane qualche traccia negli odierni programmi elettorali. Li ho dunque sfogliati e confrontati, limitandomi ovviamente a quelli dei partiti o dei raggruppamenti percentualmente più significativi, almeno a dar retta ai sondaggi. Ho trovato quello che era prevedibile, ovvero il nulla, ma cucinato in salse diverse. Ne do schematicamente conto qui di seguito, a beneficio di altri improbabili pignoleschi esegeti della letteratura propagandistica. Potranno tranquillamente risparmiarsi la fatica e la noia.
Nota tecnica. Nella disamina procedo in senso orario, a partire dalla estrema sinistra, come da rappresentazione classica dei posizionamenti parlamentari. La collocazione sui lati o al centro non è esattamente quella rivendicata dai diversi schieramenti, ma quella che io percepisco.
Alleanza Verdi-Sinistra. Il documento consta di 38 pagine. Si apre con un’ampia dichiarazione d’intenti, poi passa alla “politica verde” (si a rinnovabili, no a nucleare e trivelle; incentivi per la coltivazione della canapa, ecc…) ai diritti civili (cittadinanza femminile), al fisco, alla biodiversità, alla protezione degli animali (riduzione dell’aliquota IVA su cibo per animali e prestazioni veterinarie, oggi soggetti a tassazione come “beni di lusso”), alle migrazioni e all’accoglienza. Metà del testo è dedicata alle recriminazioni rispetto alle politiche dei famigerati governi di Draghi e di Renzi. Curiosamente non viene mai citato il doppio mandato di Conte.
La scuola arriva solo a pagina 22, e occupa tre pagine. Si parte bene: “Occorre ribaltare la funzione prevalentemente produttivistica del sapere, nel linguaggio come nella sostanza; una logica aziendalista nella gestione, una quantificazione esecutiva nelle metodologie, un prevalente economicismo nelle finalizzazioni”. Ma poi non viene chiarito in che direzione dovrebbe andare il ribaltamento, se non affermando che “La formazione e la ricerca, la loro libertà, la qualità e le finalità che le orientano sono una grande questione democratica. Sono, anzi, componente essenziale delle democrazie”. Infatti. Ma allora occorre spiegare a cosa si sta pensando quando si scrive che “È necessario far sì che la scuola torni a essere un vettore di mobilità sociale e non che certifichi, cristallizzi o addirittura moltiplichi le disuguaglianze in essere”. Quello di “mobilità sociale” è un concetto che si presta a interpretazioni ambigue: ciò che qui si intende è chiaro, ma rischia di degradare la scuola a veicolo per il successo. Se questo è il tipo di riscatto inteso dalla sinistra-sinistra (odio questa auto-rappresentazione presuntuosa, mi ricorda l’uso di sapiens sapiens per indicare un livello più alto dell’evoluzione), temo che abbiamo sempre parlato lingue diverse.
Non va meglio quando si passa dai propositi alle proposte. La “riduzione a un massimo di 15 alunni per classe e il recupero di spazi pubblici per le nuove aule” sono più che condivisibili, così come “l’estensione del tempo scuola (tempo pieno e tempo prolungato, a seconda dei diversi ordini di scuola) in tutte le scuole del territorio nazionale”. Tutte bellissime cose. Non fosse che per applicarle sarebbe necessario disporre di un organico ad occhio e croce almeno doppio rispetto a quello attuale, e il problema non si risolverebbe “assumendo un numero molto più ampio di docenti a tempo indeterminato,” e meno che mai “stabilizzando coloro che insegnano precariamente da più tempo”. L’uno e l’altro provvedimento inciderebbero solo in senso quantitativo (e comunque, quanti insegnanti si potrebbero assumere, se già oggi si fatica a reperirli anche andando a raschiare il fondo delle graduatorie?), mentre il problema è di ordine qualitativo. Le assunzioni indiscriminate di docenti che “insegnavano precariamente da più tempo” sono già state fatte, anche recentemente, col governo Renzi: il risultato è stata l’immissione in ruolo di un sacco di gente che vantava requisiti di anzianità anziché di competenza. La distorsione ottica della sinistra riemerge sempre: la “mission” della scuola non è quella di creare posti di lavoro, ma di educare persone e cittadini responsabili.

Insieme per un’Italia democratica e progressista. (Ma “insieme” a chi?) Il programma del PD occupa 35 pagine fitte fitte, suddivise in quarantaquattro schede tematiche. Undici di queste pagine sono dedicate a un preambolo e a una “Cornice” che incorniciano davvero di tutto, dall’Europa alle amministrazioni comunali. Il tono è decisamente volitivo (Vogliamo proteggere, vogliamo riaffermare, vogliamo approvare, vogliamo impedire, ecc). Quando è assertivo non si scosta dalle formule rituali (Due devono essere i protagonisti del rilancio del Paese: le donne e i giovani).
In compenso la scuola arriva solo a pag 22 (come sopra) e occupa una paginetta scarsa. “La nostra proposta sulla scuola come motore del Paese parte da qui (era ora). Vogliamo rimettere al centro la scuola e restituire al mestiere dell’insegnante la dignità e centralità che merita, garantendo una formazione adeguata e continua e allineando, entro i prossimi cinque anni, gli stipendi alla media europea”. Quindi, la dignità e la centralità dell’insegnante si garantisce con la formazione continua. Altra ricetta magica, e segreta e vaga come quelle della perbureira e della lotta all’evasione fiscale. Ora, chi come il sottoscritto ha lavorato nella scuola per oltre quattro decenni sa benissimo a cosa si riduce la formazione continua: quando va bene vengono fornite due nozioni basilari per l’uso di nuove tecnologie, che diventano obsolete nel giro di un paio d’anni e che i docenti davvero motivati acquisiscono in genere per conto proprio, con largo anticipo sulle tardive proposte ministeriali: quando va male, piovono mappazzoni propinati da pedagogisti, psicologi, sociologi, di tutto esperti tranne che di pratica didattica, che spiegano come ci si rapporta con gli allievi problematici: in sostanza assecondandone tutte le ribalderie e le furbate, loro e dei loro genitori. A meno che non rientrino tacitamente negli intenti degli estensori anche i corsi di difesa personale contro le aggressioni. In mancanza di questi ultimi, si compensa con l’adeguamento degli stipendi.
A non essere mai presa in considerazione è l’idea che la dignità al loro “mestiere” gli insegnanti veri, quelli che hanno i requisiti per essere davvero tali, sono in grado di restituirla da soli, purché si consenta loro di farlo. E questo non dipende dall’entità dello stipendio (che sarà pure da fame, ma non diversamente da quelli di tutti gli altri dipendenti), quanto piuttosto dal fatto che ad un aumento esponenziale delle loro responsabilità non didattiche (devono farsi carico anche di quelle un tempo demandate a una varietà di agenzie educative, la famiglia, la chiesa, ecc…) ha corrisposto la graduale spoliazione di ogni strumento di correzione e di controllo. In un clima ambientale normale l’autorevolezza fa a meno dell’autorità, ma chi opera oggi nella scuola sa benissimo che il clima non è affatto normale, sia per la diseducazione dei giovani coi quali ci si confronta, sia per le interferenze incrociate dall’interno e dall’esterno dell’istituzione. Insomma, se in Inghilterra alcune scuole private sono arrivate al punto di reintrodurre le punizioni corporali (a quanto pare incontrando il gradimento dell’utenza parentale, che si è tradotto in un notevole aumento delle iscrizioni) un motivo ci sarà.
Di questi problemi (non delle eventuali punizioni corporali, ma nemmeno del disagio profondo da impotenza vissuto dai docenti), nel documento non si fa minimamente cenno. Si va giù invece con le proposte e le promesse, da quelle sensate ma economicamente insostenibili (l’accesso universale e gratuito di bambine e bambini alle mense scolastiche, l’aumento dei docenti di ruolo di sostegno per affiancare nel percorso scolastico tutte le persone con disabilità, l’estensione del tempo pieno, con particolare attenzione al Sud – dove peraltro sarebbe già un successo realizzare il tempo ordinario), a quelle decisamente peregrine (Fondo nazionale per i viaggi-studio, le gite scolastiche, il tempo libero nel doposcuola e l’acquisto di attrezzature sportive e strumenti musicali), per arrivare al rilancio del vecchio sogno del ministro Berlinguer – un computer su ogni banco, quando i banchi mancavano – (permettere l’acquisto di un computer a tutti gli studenti delle scuole (medie e superiori) e delle Università). Dimenticando che durante due anni di scuola a distanza tutti gli alunni hanno già operato attraverso il computer, il che fa presumere che ne siano già in possesso.
Applicando il modello veltroniano di infausta memoria (così, ma anche …) dopo il colpo al cerchio viene quello alla botte. La scuola digitale strizza l’occhio al vecchio mondo cartaceo e si rispolverano antichi menù. «Occorre rafforzare il “Piano nazionale per la promozione della lettura”, favorendo virtuose sinergie tra reti di scuole, biblioteche, archivi e luoghi della cultura». Ho partecipato ad un progetto analogo nel 2000, lanciato con grandi squilli di fanfare e abortito dopo neanche un anno nella più totale indifferenza (cfr. La gran crollo del muro di carta). Per l’occasione è stato ripreso letteralmente perfino il refrain: favorendo virtuose sinergie, ecc…. Nel frattempo, con le restrizioni da Covid che sembrano essere rimaste in piedi solo per le biblioteche, le sinergie da virtuose che erano sono diventate addirittura frigide. Provate a frequentare una biblioteca oggi: nemmeno Fort Knox è così blindato.
Il resto è ancora peggio. Si annaspa a vanvera per insaporire cibi già scaduti da un pezzo o scongelati momentaneamente ad ogni tornata elettorale (far ripartire i “Giochi della Gioventù”, favorire l’utilizzo delle palestre scolastiche in orario extra-curricolare o quando le scuole sono chiuse).
Insomma per tagliar corto: poiché “conoscere è potere”, “via a un piano da 10 miliardi con aumento degli stipendi agli insegnanti, edilizia scolastica sostenibile, libri, mense e trasporti pubblici gratis per gli studenti con redditi medi e bassi”. I dieci miliardi, sempre ammesso che poi si trovino, non basterebbero nemmeno per mettere a norma gli edifici esistenti, e dubito comunque che quel tipo di interventi, se non agganciati ad una idea di ciò che la scuola deve essere e rappresentare, sposterebbero di una virgola il problema.

Azione-Italia viva. Il movimento creato dalla strana coppia Calenda-Renzi distende il proprio programma addirittura su 68 pagine e lo suddivide in venti punti. Anche in questo caso, neanche a farlo apposta, la parte relativa alla scuola arriva a pagina 22. È il solo punto in comune coi due programmi precedenti: per il resto, le priorità sono decisamente diverse.
Si va subito al sodo. “1. A scuola fino a 18 anni e tempo pieno per tutti. Proponiamo un riordino complessivo dei cicli scolastici ed in particolare: portare l’obbligo scolastico da 16 a 18 anni, al termine del percorso di scuola superiore. Rivedere i cicli scolastici a parità di tempo scuola frequentato: da 13 a 12 anni, con termine delle superiori a 18 anni e anticipo dell’ingresso dei giovani all’università e nel mondo del lavoro, allineandoci agli standard europei.” Se ho capito bene, si tratta di ridurre a quattro i cinque attuali anni di frequenza delle superiori, aumentando di un quarto il monte ore di ciascun anno. Spalmare questo monte ore sui sette precedenti non avrebbe infatti alcun senso (e non sarebbe fattibile). Ora, se lo scopo ultimo della scuola fosse certificare la frequentazione per un certo periodo delle aule e dei banchi, potrebbe andare benissimo. Se invece la sua funzione è leggermente meno prosaica, Calenda ha fatto i conti con i fagioli. Non è necessario un computer per arrivarci. Attualmente il monte-giorni minimo di frequenza è di duecento l’anno, distribuiti su circa nove mesi. Aggiungerne cinquanta significa portare il monte a duecentocinquanta giorni frequentati, pari a 50 settimane “corte” (sette ore per cinque giorni), ai quali ne vanno sommati altri 100 di fine settimana, più 8 (o 9) di festività infrasettimanali religiose o civili. Il totale dà 358 giorni, che ne lasciano liberi ben 7, comprensivi però degli attuali giorni di vacanza agganciati alle feste natalizie e alla Pasqua. Una pacchia.
Distribuire invece le ore in più sugli orari esistenti sarebbe altrettanto demenziale, dal momento che già adesso, con la scelta scellerata del sabato libero compiuta dalla quasi totalità degli istituti, gli allievi frequentano di norma per sette ore al giorno. E anche ripristinando la settimana di sei giorni, le sei ore quotidiane diverrebbero sette. Il sistema non reggerebbe nemmeno considerando definitivamente la scuola come un parcheggio.
Il problema vero è però un altro. Sta nel fatto che a nessuno sembra passare per l’anticamera del cervello la necessità di considerare l’efficacia della didattica in certe condizioni. Ragazzi che hanno soglie di attenzione più brevi di uno spot televisivo sono già refrattari ad assimilare qualsiasi conoscenza dopo un paio d’ore, figuriamoci dopo cinque o sei. Ed eventuali rientri pomeridiani, con tempo pieno alla svedese o alla danese, al di là dei problemi logistici che creerebbero, se anche fossero accettati dagli studenti (cosa impensabile, non si concilierebbe con i vari impegni extrascolastici, sportivi o di qualsivoglia altro genere, cui sono avviati sin dall’infanzia) potrebbero essere dedicati solo allo studio o a eseguire gli esercizi assegnati, attività che oggi svolgono tra le mura domestiche, e non ad un ulteriore aggravio didattico.
Si prosegue poi con “2. Sistema nazionale di valutazione. Va ripreso il percorso interrotto dai governi Conte, perché non può esserci autonomia senza valutazione. E solo un sistema nazionale di valutazione efficace può consentire di individuare le aree su cui è necessario migliorare”. È molto significativo dell’idea di scuola che sta a monte. Valutazione efficace significa in questo caso essenzialmente valutazione dell’efficacia. Ma quali sono i parametri? Le prove Ocse, che nella loro “oggettività” ci piazzano regolarmente agli ultimi posti in ogni graduatoria, ma sono poi smentite ad esempio dai successi all’estero dei nostri ricercatori; il numero di allievi che arrivano al diploma, che è troppo basso, o quello dei promossi alla maturità, che è troppo alto? E una volta fatte le valutazioni, come si interviene? La valutazione presenta un sacco di ambiguità, già nella concezione, che preconizza un clima concorrenziale da libero mercato in uno spazio in cui il mercato non dovrebbe entrare affatto, ma anche nell’ambito di quella stessa visione, nei modi in cui applicarla. Ad esempio: migliorare come? Elargendo più finanziamenti a chi è indietro? In questo caso si arriverebbe al paradosso di premiare le scuole che funzionano peggio.
Gli altri otto punti non meritano commenti. Sono proposte già sentite, che ricorrono ritualmente in tutte le dichiarazioni di intenti relative alla scuola, ma reinterpretate con un occhio di riguardo sempre all’efficienza “produttiva”.
Un’ultima considerazione. Come tutto il resto del documento, la sezione dedicata alla scuola tende decisamente alla prolissità. Il che è anche comprensibile, dal momento che Azione si presenta come la “novità” che viene a scuotere la politica, e deve costruirsi una identità. Quella che vien fuori di qui è però sostanzialmente una identità per l’appunto solo “prolissa”.
Movimento Cinque Stelle. I grillini – ormai dovremmo dire i contiani – hanno scelto una modalità comunicativa più articolata. Esistono due versioni del programma, quella completa (250 pagine, in formato slide) e quella breve (13 pagine). Nella sostanza la prima non dice molto di più della seconda. Anzi, in quella breve nell’intestazione di ogni pagina campeggia lo slogan Cuore e Coraggio per l’Italia di domani, mentre a piede di pagina viene ribadito Capo della forza politica Giuseppe Conte. È un abstract elettorale, ma serve giusto anche a chiarire i ruoli recentemente ridefiniti.
Va da sé che della versione completa ho letto solo la parte concernente la scuola (6 pagine). Mi ha colpito il fatto che dopo le solite proposte rituali e un azzardo quasi originale (“Scuola dei mestieri. Spingere affinché le aziende dei medesimi settori si mettano in rete e creino le scuole dei mestieri, con l’obiettivo di incentivare i giovani a sviluppare l’expertise artigianale e a mantenere il savoir-faire tradizionale”), venisse un capitoletto dal titolo: “Strategia per la Cultura”.
L’esordio era promettente: “Risulta fondamentale un nuovo umanesimo che ponga il benessere dell’Uomo e del pianeta al centro di ogni politica. Ciò presuppone che accanto alla transizione ecologica e digitale si sviluppi di pari passo una transizione culturale che ci indichi la strada per un nuovo modo di co-abitare il pianeta e affrontare pacificamente i cambiamenti”.
E subito sotto: “La cultura è dunque politica laddove è la politica a immaginare un futuro, forte della conoscenza del passato, la cui eredità va protetta, conservata e trasmessa alle generazioni future”.
Sino ad arrivare a: “Proponiamo, accanto allo sviluppo di capacità legate al problem solving e ai meccanismi di ricerca, una maggiore attenzione per l’insegnamento della lingua italiana, della storia e della geografia anche come elementi che favoriscono la coesione e l’integrazione sociale”.
Mi sono detto: “Alè, ci siamo”: ma l’allerta è rientrata subito. Intanto non ho trovato una volta, nelle cinque paginette dedicate, il sostantivo responsabilità, l’aggettivo responsabile e il verbo responsabilizzare (né nella forma transitiva né in quella forma riflessiva). Poi mi sono reso conto che al dunque le strategie diventano quelle virtuali del Risiko. “È importante istituire una dote educativa in sinergia con i patti di comunità educanti (!?) Le comunità educanti possono diventare una misura strutturale di contrasto alla povertà educativa e culturale, con esperienze dirette di outdoor, con le discipline sportive, le competenze artistico-creative, educazione civica e professionale”. Ah, ecco, volevo ben dire. Ma non basta: “Occorre creare equipe di psicologi, educatori e pedagogisti a scuola che, dismettendo la loro funzione in modalità sportello, diventino figure strutturali a supporto della comunità scolastica”. Mancano i docenti e i bidelli, oltre che gli spazi, ma potremo sempre ovviare con le equipe di psicologi. “Proponiamo il potenziamento del tempo pieno (5 giorni la settimana) su tutto il territorio nazionale, con un investimento che ampli l’offerta pomeridiana e di mense, affiancando ciò ad un adeguato programma di educazione ad una corretta alimentazione”. Lì ti volevo, si va verso le mense vegane.
Ora, tutto questo e altro che non sto a riportare rientra piuttosto nelle soluzioni tattiche che non nel disegno strategico. E la strategia? Vola molto più alto. «La “Strategia per la Cultura” del M5S “ si articola lungo tre pilastri che attraversano tre grandi questioni quali la sostenibilità, il contrasto, la mitigazione e l’adattamento all’impatto dei cambiamenti climatici sul paesaggio e sui beni culturali; le competenze, le infrastrutture sociali, digitali e le risorse umane necessarie per consentire a tutti i territori di valorizzare e gestire il patrimonio culturale in chiave sostenibile e con l’obiettivo di generare benessere sociale ed economico; le tutele per i lavoratori e la valorizzazione delle nuove professioni culturali e creative legate alle competenze digitali, tecnologiche e ambientali».
Col che tanti saluti al recupero delle competenze “tradizionali” e delle modalità tradizionali della loro trasmissione. Infatti: “Incentivare le case editrici a realizzare versioni digitali dei testi necessari allo studio e alla formazione e fornire agli istituti i formati eBook dei testi scolastici ed universitari attraverso la formula del prestito digitale. Bisognerebbe concedere un contributo ad ogni studente per l’acquisto di dispositivi e-reader”. Non so cosa sia l’e-reader, ma so che non mi piace.
Nell’insieme, questa parte del programma non sembra essere stata molto curata. Forse dipende dal rapporto conflittuale che sin dall’inizio i pentastellati hanno avuto con l’istruzione e la cultura in genere, avvertiti come strumenti subdoli del dominio e della mistificazione. Non a caso quelli che nel frattempo hanno “studiato”, sia pure con esiti tutti da verificare (vedi Di Maio), sono stati bollati come corpi estranei ed allontanati.
L’attenzione per la scuola è comunque una novità in assoluto. Nel programma elettorale del 2018, quando capo del movimento figurava lo stesso Di Maio, questa voce proprio non c’era, non compariva in alcuna delle quarantotto pagine, tutte dedicate alla difesa, all’immigrazione, alla sicurezza, alla giustizia e allo smantellamento della troika. Un confronto tra i due testi sarebbe interessante (lo lascio fare ad altri), ma per quel che riguarda lo specifico del mio assunto manca del tutto la materia con cui confrontarsi.

Centro Destra. Il testo di “Per l’Italia –Accordo quadro di programma per un Governo di centrodestra” è il più stringato in assoluto. Trattandosi di un documento comune, stilato da tre forze politiche tenute assieme solo dalla convenienza elettorale, è normale che rimanga molto sul generico, senza dare troppe spiegazioni. In 15 pagine sono sviluppati in maniera telegrafica, sotto forma di slides, quindici punti.
Scuola, università e ricerca arrivano al quattordicesimo, e vedono in mezzo alle consuete litanie (formazione e aggiornamento dei docenti, ammodernamento e nuove realizzazioni di edilizia scolastica, eliminazione del precariato, ecc…) un paio di proposte che danno il tocco caratterizzante, ci avvertono che stiamo camminando in territorio di Destra.
Si parla infatti di “Rivedere in senso meritocratico e professionalizzante il percorso scolastico” (sul come siamo lasciati nell’incertezza) e di “Valorizzare e promuovere le scuole tecniche professionali volte all’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro”.
Tutto qui. Per saperne qualcosa di più ho dovuto rivolgermi direttamente ai programmi dei singoli partiti facenti parte della coalizione.
Il programma di Fratelli d’Italia ha un titolo che la dice lunga sulle aspettative di chi è alla guida del partito. Un bel Pronti fa da didascalia ad un accattivante primo piano della Meloni. Sono 40 pagine, piuttosto sobrie, per non dire generiche (ma un codice qr rimanda per ciascun tema agli Approfondimenti), due delle quali sono dedicate a scuola e università. Una particolarità: nel testo, fatta eccezione per il preambolo, non vengono usati i verbi, o vengono coniugati solo all’infinito. Sembra un manifesto futurista: concretezza e velocità.
Molta concretezza. “La scuola prepara il futuro di una Nazione, l’ingresso nel mondo del lavoro dei giovani, la crescita economica e la consapevolezza di essere cittadini e parte di una comunità.” L’ordine in cui sono esposte le finalità della scuola parla da solo.
Poi si va nello specifico, almeno per quel che concerne le linee guida. “Rimettere il merito al centro del sistema scolastico e universitario, per alunni e corpo docente”. Di per sé è un’idea che andrebbe riconsiderata, ma esposta così ricorda i toni di certi slogan scritti in nero che campeggiavano sui muri quasi un secolo fa (e che ogni tanto riemergono dagli intonaci scrostati).
“Valorizzazione degli Istituti tecnici e riforma dei Percorsi trasversali per le competenze e l’orientamento (Pcto). Ripristinare gli indirizzi di studio abilitanti al lavoro. Istituzione del liceo del Made in Italy.” Un po’ di praticità, perdio. Meno filosofia, più competenze artigianali.
“Raggiungimento dell’obiettivo della piena padronanza della lingua inglese per tutti gli studenti”. Quella dell’italiano è probabilmente data per scontata, visto che non se ne parla. O forse per obsoleta. Il che in realtà mal si concilia con la vocazione “nazionalista” del movimento.
“Verificare la praticabilità di ridurre di un anno il percorso di studio scolastico, a parità di monte ore totale, per consentire ai giovani italiani di diplomarsi a 17-18 anni.” Ci risiamo. E per che fare dopo?
“Acquisto e utilizzo dei libri di testo in formato elettronico per diminuire il costo sostenuto dalle famiglie”. La famiglia è giustamente il terzo valore della famosa triade (la più citata negli slogan di cui sopra) e va coinvolta con un occhio di riguardo. Per questo il programma di Fratelli d’Italia si apre proprio col “Sostegno alla natalità e alla famiglia”, e per questo tra i principi da affermare nella scuola è importante includere “che la formazione si svolge principalmente in aula e che i compiti a casa devono essere gestiti con misura e buonsenso”.
Sottolineo una dimenticanza strana, o che almeno mi è parsa tale per un partito che del passato vorrebbe nutrirsi. Manca qualsiasi riferimento all’insegnamento della storia. Ma forse non è una stranezza. La crescita recente di questo partito può spiegarsi proprio con l’ignoranza, o meglio ancora col rifiuto, della storia. In compenso si promette “Più sport nelle scuole, con nuovi impianti, piscine e palestre”. Altro che Giochi della Gioventù: tornano i Littoriali.
Bisogna ammettere che la Lega non ha badato a spese. Presenta un programma di 200 pagine, sia pure piuttosto smilze, nel quale l’Istruzione arriva a pagina 108 (e occupa tre paginette).
“Il nostro programma per la scuola prevede cinque interventi fondamentali: • sviluppare gli istituti professionali come scuole di alta specializzazione; • conciliare inclusione e valutazione studenti; • prevenzione sanitaria, mai più didattica a distanza; • garantire specializzazione sostegno; • superare il precariato, coprire carenza personale docente e Ata, adeguare gli stipendi.”
Queste cose più o meno le abbiamo già viste tutte altrove, magari complete di articoli e preposizioni. Più caratterizzanti sono invece altre proposte. Ad esempio: “Riorganizzare il curricolo di studi dell’istruzione tecnica e professionale potenziando laboratori e prevedendo un’area territoriale, che consenta di adattare il percorso di studi alle esigenze del contesto territoriale e delle filiere produttive che lo caratterizzano”. Vale a dire, se vivi in un territorio che produce patate sarà bene che la scuola ti insegni in primo luogo a produrre patate.
Oppure: “Inserire l’educazione finanziaria in tutto il sistema di istruzione e formazione”. Ovvero: anche il produttore di patate che ha imparato a lavorare bene ed è entrato nella filiera deve poter allargare i suoi orizzonti, diventare trader di se stesso e azzardare qualche speculazione (se poi andrà male, ci penserà lo stato a rimborsarlo). O tenere in proprio la contabilità aziendale e fiscale, realizzando a livello individuale quel massimo di autonomia che a livello istituzionale rimane un sogno nel cassetto. L’emancipazione economica come finalità priorità.
Da notare che nei paragrafi meno “dedicati” tornano i modi verbali: o meglio, tornano soprattutto l’indicativo e il gerundio, perché il congiuntivo è usato con estrema parsimonia (è scivoloso) e il condizionale proprio non è previsto.
Il programma di Forza Italia (36 pagine, senza indice) esordisce giustamente coi temi del fisco (Per una seria riforma fiscale) e della giustizia (Per una giustizia imparziale). Prima di tutto sistemiamo le grane di casa. Della scuola si occupa alle pagine 18 e 19, con proposte perfettamente in linea con la visione del mondo che rappresenta.
- Campus di scuole secondarie superiori con laboratori scientifici, centri sportivi.
- libertà di scelta delle famiglie attraverso il buono scuola.
- Formazione di una nuova generazione di docenti (più tutor e più coach).
- Introduzione del coding e della didattica digitale, con copertura con la banda larga.
- Più formazione professionale (sistema duale) e più tecnologi del futuro.
- Istituzione della figura dello psicologo scolastico e dello psicologo per l’assistenza primaria.
- Introduzione nel programma scolastico di un’ora curricolare di educazione emotiva utile per avere un confronto con i genitori non solo sulla didattica ma anche sulla personalità degli alunni
- Potenziamento dell’Orientamento dei giovani in età scolare con particolare attenzione all’incontro tra domanda e offerta di lavoro.
Questo si chiama parlare chiaro. Dritti alla sostanza, scompare anche l’infinito verbale. Altro che storia e geografia e filosofia. Formazione professionale, orientamento calibrato sulla domanda-offerta, didattica digitale, meno docenti e più tutor, coach e psicologi, tecnologi. Persino l’educazione emotiva, per controllare e indirizzare produttivamente anche le emozioni. Oggettivamente, gli estensori di questo programma non si sono sprecati granché. E hanno fatto bene, perché erano consapevoli del fatto che nessuno si sarebbe mai preso la briga di andare a leggerlo (non avevano previsto il sottoscritto, ma io costituisco un’anomalia). Gli elettori di Forza Italia il programma lo scaricano quotidianamente, da una batteria di canali televisivi che nemmeno più fingono un salto tra gli spot commerciali diffusi e lo spottone esistenziale continuativo (e di questo va reso loro merito. Bando all’ipocrisia).

Ormai lanciato, volevo dare un’occhiata anche alle schegge impazzite della destra, e non ho trovato di meglio che il programma di ITALEXIT. Devo ammettere che é frutto di uno sforzo intellettuale notevole (122 pagine, delle quali cinque riservate alla scuola), reso ancora più meritorio dalla evidentemente scarsa dimestichezza dell’estensore o degli estensori con la grammatica e la sintassi. Al di là di questo, però (lo so che non è un particolare di scarso rilievo, ma da un movimento no vax, no green pass, no Europa, no OMS, no Ucraina, ecc. ti devi anche aspettare il no alle concordanze dei generi e dei numeri e quello alla costruzione sensata dei periodi), è l’unico programma nel quale venga adombrata una certa idea del ruolo della scuola. Non dà le risposte che darei io, anzi, non ne dà proprio, ma almeno pone le domande.
Dice infatti: “Un punto critico riguarda il fatto che la scuola deve preparare i ragazzi per una società in cui vivranno in futuro, senza sapere esattamente come evolverà la società. Ciò pone un primo grande dilemma, con ricadute importantissime sulla stessa organizzazione concreta dei curricoli, delle materie da insegnare, di quali competenze sviluppare, delle metodologie innovative da introdurre”. Il che sostanzialmente è vero. Ma allora occorre riflettere sull’importanza di una linea di continuità culturale, di un filo d’Arianna che consenta di procedere in avanti ma anche eventualmente di tornare indietro quando la direzione imboccata risulti un vicolo cieco.
È quanto il programma del movimento creato da Paragone sembra perseguire nella pars destruens: “Riteniamo indispensabile rivedere gli aspetti normativi delle riforme scolastiche: Berlinguer, Moratti, Gelmini e legge107 di Renzi, che hanno impresso una dimensione aziendalistica e dirigistica, determinando la diffusione di una cultura solipsistica e sempre più performativa, con la progressiva disumanizzazione degli operatori dell’istruzione e dei loro stessi utenti finali. Ripristino delle materie di studio funzionali al percorso formativo che sono state tolte o ridotte nell’orario”.
E ancora: “Non siamo d’accordo con l’uso sempre più pervasivo della tecnologia digitale, che riduce la relazione nella dimensione fisico-corporea, fondamentale per le persone in crescita e rischia di favorire disturbi da iperconnessione che colpiscono i giovanissimi, ai (?) rischi del ritiro sociale, al senso di insicurezza fino agli attacchi di panico.(sic) Vogliamo ridurre l’inutile e ridondante burocrazia (Ptof, Pdp, Clil, Rav) che hanno (sic) standardizzato e spersonalizzato la funzione docente”. (copyright Cinquestelle)
Oppure: “I sistemi valutativi basati su quesiti a risposta multipla allenano solo la capacità di risolvere quesiti di questo tipo e insinuano il pericoloso concetto che per ogni situazione vi sia sempre e solo un limitato numero di opzioni e una sola risposta semplice ed esatta, che rappresentano solo meri adempimenti burocratici”.
Quella construens parte bene: “Va ricostruito un clima scolastico serio e propositivo, va tutelata la figura dell’insegnante, vanno migliorati i programmi sia in direzione di un recupero della nostra cultura umanistica e civica. (? sic) […]. Bambini e bambine, ragazzi e ragazze si trovano a essere posti di fronte a scelte importanti, difficili e a volte controverse eticamente. Essi devono, perciò, essere aiutati a individuare un’etica che serva come bussola durante le loro vite, come esseri umani, cittadini, elettori, lavoratori. ) […] I bambini e i ragazzi devono poter sviluppare la capacità di diventare consapevoli dei problemi, delle contraddizioni e delle manipolazioni: costruire, cioè, uno sguardo avvertito e critico sul mondo”.
Ma poi si ferma lì. Il ghostwriter che ha scritto queste cose non se l’è sentita di specificare quali siano le materie di studio formative eliminate dagli orari, di azzardare un’ipotesi di “conservazione intelligente”: il committente, Paragone, probabilmente non lo sa nemmeno. Nel suo caso quelle materie sembrano non essere servite a molto.

Bene, questo è il panorama. Il bilancio complessivo è quello di una sconfortante povertà di idee, anche spicciole, dell’assoluta mancanza di una visione realistica della scuola e, peccato originale, dell’incapacità di concepire la cultura come valore a sé, come promozione individuale non finalizzata, di autocoscienza, di autoresponsabilizzazione. Chi volesse maggiori dettagli può andarseli a cercare. Nella rete c’è tutto. E non credo di dover aggiungere altri commenti. Come intendo io la scuola l’ho già ripetuto e spiegato in più occasioni (in particolare cfr. Sul futuro delle nostre scuole, La scuola al tempo della crisi, Una modesta proposta, Il supplente nella neve).
Si è rivelata comunque un’indagine pericolosa, nel senso almeno che rischio perla prima volta di non andare a votare. Se dicessi che è stata anche divertente mentirei, ma interessante si, lo è stata: per arginare la noia delle identiche formulette che si ripetevano ho cercato di leggere il più possibile tra le righe. Ne è venuto fuori un romanzo dell’orrore, il quadro inquietante della più verosimile delle distopie, e della più prossima.
Ci siamo già dentro.

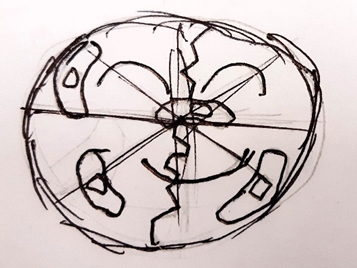




























 Ciascuno cresce solo se sognato (a Danilo Dolci)
Ciascuno cresce solo se sognato (a Danilo Dolci)








 Faccio un esempio banalissimo. Le scelte iconografiche che corredano oggi i libri di testo delle elementari, giustificate con l’intento di educare gli allievi ad un rapporto e a una dimestichezza precoci con le “fonti documentali”, ottengono l’effetto opposto. Il valore evocativo di un dagherrotipo d’epoca che ritrae Nino Bixio è infinitamente minore rispetto a quello che aveva un tempo la figurina disegnata di un garibaldino, o di Bixio stesso, con la sua brava camicia rossa: illustrazione che avrebbe potuto essere trasposta di sana pianta in uno dei fumetti di capitan Miki o di Tex, o presa da esso, e che rimandava alla dimensione dell’avventura (alimentando peraltro la voglia di andare più tardi a scoprire che faccia aveva davvero quel garibaldino, e di cercare quindi il dagherrotipo). È evidente che oggi le stesse immagini non evocherebbero più nulla, perché nessun ragazzino legge più Miki o Tex, ma ciò che è andato a sostituirle non ha assolutamente un altrettale potere di suggestione, e non potrebbe averlo anche se usato nel migliore dei modi: semplicemente perché su quel versante la mente dei ragazzini è già colonizzata da ben altri effetti speciali.
Faccio un esempio banalissimo. Le scelte iconografiche che corredano oggi i libri di testo delle elementari, giustificate con l’intento di educare gli allievi ad un rapporto e a una dimestichezza precoci con le “fonti documentali”, ottengono l’effetto opposto. Il valore evocativo di un dagherrotipo d’epoca che ritrae Nino Bixio è infinitamente minore rispetto a quello che aveva un tempo la figurina disegnata di un garibaldino, o di Bixio stesso, con la sua brava camicia rossa: illustrazione che avrebbe potuto essere trasposta di sana pianta in uno dei fumetti di capitan Miki o di Tex, o presa da esso, e che rimandava alla dimensione dell’avventura (alimentando peraltro la voglia di andare più tardi a scoprire che faccia aveva davvero quel garibaldino, e di cercare quindi il dagherrotipo). È evidente che oggi le stesse immagini non evocherebbero più nulla, perché nessun ragazzino legge più Miki o Tex, ma ciò che è andato a sostituirle non ha assolutamente un altrettale potere di suggestione, e non potrebbe averlo anche se usato nel migliore dei modi: semplicemente perché su quel versante la mente dei ragazzini è già colonizzata da ben altri effetti speciali. Allo stesso modo, un piccolo excursus sulle simbologie negative del rosso o del giallo può diventare intrigante, e al tempo stesso, se ben pilotato, sgombrare il terreno da pregiudizi popolari radicati. Quando è associato a tratti morfologici, come il colore dei capelli o della pelle, il rosso connota tradizionalmente una disposizione negativa. Sono rossi i capelli e la barba di Giuda, ad esempio, così come ricorrono nella pittura medioevale (e sopravvivono in quella successiva), ma anche quelli di numerosissimi personaggi biblici o mitologici, o dei reprobi dei poemi cavallereschi, fino a quelli della letteratura romantica, e oltre (il Rosso Malpelo di Verga). Ora, questa valenza simbolica negativa ha un’origine facilmente identificabile: presso quasi tutte le etnie del mondo, con la parziale eccezione dei popoli scandinavi, gli individui di pelo rossiccio rappresentano delle esigue minoranze, e sono quindi percepiti immediatamente come dei “diversi”, alla stessa stregua ad esempio dei mancini. Non a caso, nella rappresentazione iconografica (ancora Giuda) e letteraria i due attributi marciano spesso di conserva. Il rosso diventa quindi per antonomasia il colore che connota, in progressione negativa, una differenza, una anomalia, un pericolo, il male. Diventa il colore di Satana. E l’identificazione simbolica finisce alla lunga per prescindere dal suo movente originario, al punto da imporsi anche presso quelle culture (le nordiche di cui sopra) nelle quali la motivazione della differenza morfologica non ha senso.
Allo stesso modo, un piccolo excursus sulle simbologie negative del rosso o del giallo può diventare intrigante, e al tempo stesso, se ben pilotato, sgombrare il terreno da pregiudizi popolari radicati. Quando è associato a tratti morfologici, come il colore dei capelli o della pelle, il rosso connota tradizionalmente una disposizione negativa. Sono rossi i capelli e la barba di Giuda, ad esempio, così come ricorrono nella pittura medioevale (e sopravvivono in quella successiva), ma anche quelli di numerosissimi personaggi biblici o mitologici, o dei reprobi dei poemi cavallereschi, fino a quelli della letteratura romantica, e oltre (il Rosso Malpelo di Verga). Ora, questa valenza simbolica negativa ha un’origine facilmente identificabile: presso quasi tutte le etnie del mondo, con la parziale eccezione dei popoli scandinavi, gli individui di pelo rossiccio rappresentano delle esigue minoranze, e sono quindi percepiti immediatamente come dei “diversi”, alla stessa stregua ad esempio dei mancini. Non a caso, nella rappresentazione iconografica (ancora Giuda) e letteraria i due attributi marciano spesso di conserva. Il rosso diventa quindi per antonomasia il colore che connota, in progressione negativa, una differenza, una anomalia, un pericolo, il male. Diventa il colore di Satana. E l’identificazione simbolica finisce alla lunga per prescindere dal suo movente originario, al punto da imporsi anche presso quelle culture (le nordiche di cui sopra) nelle quali la motivazione della differenza morfologica non ha senso. Dal canto suo, anche il giallo ha conosciuto una associazione simbolica negativa, solo appena più sfumata. Nell’iconografia medioevale, ma anche in quella successiva, è il colore del tradimento e della menzogna, come tale identificato non tanto nei tratti morfologici (ché, anzi, dopo le conquiste normanne il colore biondo dei capelli diventa il tratto distintivo della nuova nobiltà di spada) quanto nell’abbigliamento (dietro il quale, appunto, ci si nasconde). La veste di Giuda è spesso gialla, così come gialla è la stella identificativa degli ebrei, e tali sono molti capi di abbigliamento degli ebrei stessi, o dei buffoni di corte e dei saltimbanchi. In questo caso ad essere sottolineata è una diversità non “naturale”, ma sociale e culturale.
Dal canto suo, anche il giallo ha conosciuto una associazione simbolica negativa, solo appena più sfumata. Nell’iconografia medioevale, ma anche in quella successiva, è il colore del tradimento e della menzogna, come tale identificato non tanto nei tratti morfologici (ché, anzi, dopo le conquiste normanne il colore biondo dei capelli diventa il tratto distintivo della nuova nobiltà di spada) quanto nell’abbigliamento (dietro il quale, appunto, ci si nasconde). La veste di Giuda è spesso gialla, così come gialla è la stella identificativa degli ebrei, e tali sono molti capi di abbigliamento degli ebrei stessi, o dei buffoni di corte e dei saltimbanchi. In questo caso ad essere sottolineata è una diversità non “naturale”, ma sociale e culturale. Ecco, suggestioni di questo tipo sono, come dicevo, materia estremamente delicata, e vanno trasmesse assieme alla consapevolezza che si tratta di possibili modalità di lettura della storia, e non di chiavi magiche che aprono al suo senso: e che ogni angolo prospettico va confrontato con gli infiniti altri, non per contraddirli o negarli, ma anzi, per trarne conforto e ulteriori stimoli. È una cosa meno facile di quanto possa sembrare: le idee forti, i modelli interpretativi ad alto tasso di assertività esercitano un’indubbia attrattiva sulle menti adolescenziali (e non solo su quelle), che hanno bisogno di spiegazioni semplici, di un “senso” all’interno del quale e in funzione del quale collocare gli eventi storici. Ma d’altro canto queste suggestioni “integraliste” sono una tappa obbligata nel cammino di chi va alla scoperta della storia. Importante è che non rimangano l’ultima: cosa che invece accade quando le alternative offerte non sono altrettanto seducenti.
Ecco, suggestioni di questo tipo sono, come dicevo, materia estremamente delicata, e vanno trasmesse assieme alla consapevolezza che si tratta di possibili modalità di lettura della storia, e non di chiavi magiche che aprono al suo senso: e che ogni angolo prospettico va confrontato con gli infiniti altri, non per contraddirli o negarli, ma anzi, per trarne conforto e ulteriori stimoli. È una cosa meno facile di quanto possa sembrare: le idee forti, i modelli interpretativi ad alto tasso di assertività esercitano un’indubbia attrattiva sulle menti adolescenziali (e non solo su quelle), che hanno bisogno di spiegazioni semplici, di un “senso” all’interno del quale e in funzione del quale collocare gli eventi storici. Ma d’altro canto queste suggestioni “integraliste” sono una tappa obbligata nel cammino di chi va alla scoperta della storia. Importante è che non rimangano l’ultima: cosa che invece accade quando le alternative offerte non sono altrettanto seducenti.