 Orgoglio e Pregiudizio in salsa bernese
Orgoglio e Pregiudizio in salsa bernese
di Paolo Repetto, 30 maggio 2019
A proposito di sogni e di stereotipi
L’accoglienza
Il formidabile esercito svizzero
Sull’educazione e sui suoi effetti collaterali
* la salsa bernese è preparata con burro chiarificato, tuorlo d’uovo, scalogno, dragoncello e cerfoglio. Il colore è giallo paglierino, la consistenza è densa e cremosa. Si armonizza con tutto, con la carne e col pesce, ma mantiene una sua tenace autonomia di gusto. Anche se l’origine, a dispetto del nome, non è propriamente svizzera, lo spirito è quello.

A proposito di sogni e di stereotipi
Mi opprimeva la sensazione che tutto era, ai miei occhi, estraneo, e comprendevo benissimo che quell’essere tutto estraneo mi uccideva. Rammento di essermi sottratto a questa prostrazione e a quel buio la sera in cui, giunto a Basilea, misi piede sul suolo svizzero per la prima volta… (Dostoevskij)
Nel 1923 Corto Maltese si rifugia in Svizzera (Le Elvetiche-Rosa alchemica). Arriva da trent’anni di vagabondaggi in ogni angolo del globo, all’inseguimento di (o inseguito da) guerre, rivoluzioni, tesori e avventure. Ora si prende una vacanza. È una scelta molto crepuscolare, poco in sintonia con l’immagine di chi sembra non poter stare lontano dai guai: in Svizzera non ci sono guerre da almeno duecento anni, è il paese più ordinato e tranquillo del mondo. E invece io credo che questa scelta risponda perfettamente alla voglia di Svizzera che è in tutti noi, o che almeno sopravviene col trascorrere degli anni.
Il soggiorno svizzero di Corto in realtà è tutt’altro che noioso: assieme ad un vecchio amico, il professor Steiner (questo nome sarà casuale?), va ad incontrare niente di meno che Hermann Hesse. Nella casa di quest’ultimo Corto legge il Parzifal, si abbiocca e finisce in una sarabanda di fantasticherie sconclusionate, in bilico costante tra l’incubo e il sogno. Si ritrova insomma in una dimensione che più surreale non si può, popolata di volti, luoghi, fatti e sentimenti che mescolano assieme l’esperienza quotidiana e la suggestione delle letture, facendo saltare tutti gli schemi logici e temporali[1]. Come a dire che le avventure si possono vivere anche tra quattro mura, in una biblioteca: perché in realtà, anche se fingiamo di inseguirle, le abbiamo tutte già in testa. Cosa questa che meriterebbe di essere approfondita, ma non è il tema di queste pagine: non è di Corto che voglio parlare, ma della Svizzera.
Nulla potrebbe sembrare meno interessante. La seconda metà del ‘900, la mia epoca, non ha mai tenuto la Svizzera in grande stima. Al contrario, la nomea ancora oggi corrente è quella di una nazione egoista e sfruttatrice, sede delle mafie finanziarie e delle multinazionali della chimica e delle armi. Un luogo dove dietro le austere facciate dei palazzi si consumano traffici d’armi, speculazioni, imbrogli e intrallazzi, non più rifugio di avventurieri ma di capitali in fuga (per gli italiani “portare i soldi in Svizzera” è stato per anni uno sport da ricchi, come il golf – e per la stragrande maggioranza è stato almeno un sogno).
A costruire questa immagine hanno contribuito anche molti suoi intellettuali, come Friedrich Dürrenmatt, Jean Ziegler e Max Frish, spietatamente critici nei confronti del perbenismo meschino della società svizzera. Incombe inoltre il sospetto (e anche qualcosa di più) che il paese abbia lucrato sulla spoliazione e sullo sterminio nazista degli ebrei, nascondendo nei suoi caveau i tesori ad essi sottratti. Insomma, un’immagine non proprio accattivante.
Non è sempre stato così, però. Intendo dire che l’immagine non è sempre stata quella, e che forse non lo è nemmeno la realtà. È un’ipotesi che mi piacerebbe verificare, per riordinare un po’ le idee e perché a me tutto sommato a me gli svizzeri non sono mai risultati così antipatici. Come probabilmente non lo erano ad Hugo Pratt, non fosse altro perché sono loro ad aver inventato il fumetto, con Töpffer, cento anni prima degli americani[2].

Ho potato pesantemente, ma forse non a sufficienza, la versione originale di questo testo, nata a sua volta da una breve conferenza. Al solito, mi aveva preso la mano. Non volendo però buttare tutto ho inserito alcuni ritagli come note in calce, anche a costo di dare all’ insieme una parvenza di eccessiva “seriosità”. D’altro canto, non volevo riuscire noioso, ma serio ho cercato di esserlo, almeno nell’impegno.
Le note comunque hanno di positivo che uno può tranquillamente ignorarle. Anche se a volte sono più interessanti del testo stesso.

La natura
«Fra le belle cose del mondo, due sono perfette e senza pari.
Il bello è il lago di Ginevra, con la sua nobile e grande armonia; il sublime è il lago di Lucerna… In Svizzera, paese della luce, questo lago è la luce stessa». (J. Michelet)
Per constatare quanto l’immagine della Svizzera fosse un tempo diversa, quasi diametralmente opposta rispetto a quella attuale, è sufficiente tornare indietro di un paio di secoli e risalire poi sino al primo ventennio del Novecento. Dalla fine del Settecento e per tutto il secolo successivo la Confederazione ha costituito addirittura un modello politico e sociale per tutto il resto dell’Europa. E le sue montagne hanno ispirato un nuovo paradigma estetico.
Partiamo proprio da quest’ultimo. La “scoperta” naturalistica della Svizzera esplode in età romantica, ma è anticipata già nel Settecento dalla moda del Grand Tour e dall’inizio della corsa alle vette alpine. I precursori sono, al solito, gli inglesi: sono loro a smentire la fama di paese noioso e privo di interesse che la caratterizzava. Si possono addirittura fissare delle date-simbolo di questo mutamento della percezione. Nel 1671 un teologo, Thomas Burnet, durante l’attraversamento delle Alpi è folgorato dalla maestosità della natura che gli si para di fronte. E al ritorno in patria non solo formula una nuova teoria sull’origine del mondo, ma con le sue descrizioni suscita un interesse diverso, positivo, per quelle plaghe. Luoghi considerati in precedenza di nessun pregio o addirittura repulsivi, e per sovrappiù popolati da creature mostruose e malvage – tanto che nelle mappe antiche erano liquidati con l’indicazione “Qui ci sono i draghi” – cominciano ad incuriosire e a diventare attraenti.
Sulle orme di Burnet muove pochi anni dopo (1688) John Dennis, un critico letterario e drammaturgo che davanti alle pareti strapiombanti, ai picchi scoscesi, ai precipizi, va addirittura in deliquio: “Il senso di tutto ciò produceva in me differenti moti, cioè un delizioso orrore, una gioia terribile, e nel momento stesso in cui provavo un piacere infinito, tremavo”. È una delle primissime, forse la prima in assoluto, esperienza moderna, diretta e testimoniata, del “sublime”.
All’inizio del secolo successivo queste sensazioni cominciano ad essere trasmesse anche al grande pubblico attraverso il poligrafo Joseph Addison, che in Svizzera soggiorna per diversi mesi: anche lui è affascinato dalla bellezza e dalla maestosità degli scenari alpini, ma apprezza allo stesso modo il panorama di valle (i laghi soprattutto) ed è colpito anche dalle istituzioni politiche, dalla pacifica convivenza delle diverse usanze, tradizioni, culture, nonché degli idiomi e delle religioni che incontra nei vari cantoni e che racconta poi ai lettori dello Spectator[3].
Il capovolgimento definitivo della vecchia immagine lo opera tuttavia un indigeno, Albrecht Von Haller, fisiologo prima ancora che poeta (è considerato il fondatore della fisiologia moderna) che pubblica nel 1729, all’età di ventun anni, il poema Die Alpen, resoconto in versi di una lunga camminata per i monti[4]. Nessuno prima di Haller aveva presentato il mondo della montagna in termini così appassionati[5]. Anche lui è colpito dalla sindrome di Dennis, e alla vista del Monte Bianco esclama: “Questa mescolanza di orrido e di piacevole ha un fascino che quanti sono indifferenti alla natura non possono capire”. Si muove all’interno dell’estetica del pittoresco, equilibrata però da una sensibilità per la natura di tipo ancora arcadico. Ma va oltre: sfata l’antico pregiudizio circa l’inabitabilità delle alte vallate, e soprattutto introduce il rispetto per una vita di duro lavoro, che si svolge lontano dalla corruzione delle città e dagli agi materiali, e fortifica lo spirito. A dispetto dell’ingenuità di questa visione l’entusiasmo giovanile di Haller è contagioso, e suscita una gran voglia di ricalcarne i passi.
Infatti. I primi ad imitarlo sono gli alpinisti, in genere inglesi, e con loro arrivano gli scienziati (questi, di norma, svizzeri o francesi)[6]. Anche quando non sono d’accordo con Haller sul carattere dei montanari (pochi anni dopo William Windham – un giovane naturalista, da non confondere con l’uomo politico – li bolla come imbroglioni, ostili e poco amanti della fatica) sono comunque affascinati dell’ ambiente alpino.
Le descrizioni delle vallate come incantati paradisi terrestri si moltiplicano, e conoscono una grande diffusione qualche decennio dopo, con Rousseau e con uno scienziato-alpinista, Horace-Bénédict de Saussure. Se le ricerche scientifiche portano ad una riscoperta della montagna come laboratorio in cui studiare le origini della Terra, sono tuttavia gli scrittori e i poeti (nonché i pittori) a “inventare” questo nuovo spazio dell’immaginario collettivo[7]. Gli alpinisti si incamminano verso le cime con il fardello di barometri e altimetri, ma i turisti che affluiscono sempre più numerosi sulle Alpi sono alla ricerca di luoghi incontaminati, di grandiosi scenari, di rustica autenticità, e hanno in tasca una copia di Die Alpen o della Nouvelle Héloïse, le guide perfette per una fruizione sentimentale dei nuovi spazi naturali.
Di lì a poco, poi, il cambiamento dell’opinione medica sulla cura delle malattie polmonari porterà un nuovo tipo di turismo, quello della disperazione, descritto da Stevenson per personale esperienza, e più tardi da Thomas Mann. Da luogo invivibile la montagna svizzera diventa in questo caso, se non un paradiso, almeno un limbo, l’ultima spiaggia per chi si aggrappa alla vita.
Il fascino paesaggistico della Svizzera non colpisce soltanto i viaggiatori d’oltremanica. Anche Goethe nel 1775 fa correre lo sguardo dal San Gottardo su uno spettacolo naturale splendido, e ne è talmente conquistato da tornare poi in Svizzera a più riprese, soprattutto per coltivare i suoi interessi per la mineralogia[8].
Qualche anno dopo, nel 1777, Alessandro Volta, che era corrispondente di Saussure e in uno dei suoi viaggi aveva anche incontrato Haller, lascia un’ammirata descrizione dei ghiacciai di Grindelwald: “Un’ora prima di arrivare alle ghiacciaie si cominciano a vedere. Sono due grandi valli riempite di massi enormi di ghiaccio ammonticchiati. Da lungi non sembrano gran cosa; ma discesi alle falde, che spettacolo sorprendente e terribile! Spaccature nel ghiaccio, che son caverne, anzi abissi: rumore d’un fiume di acqua torbida che ne vien fuori, scorrendo sotto archi e ponti della istessa massa soda di ghiaccio: monti, creste, torri, cocuzzoli di ghiaccio, qua bianco, là verdognolo (che tale è il colore che prende ove il sole dà nelle fenditure). Maraviglia il contrasto dei siti, del caldo e del freddo, che si trovano in piccolissima estensioni di paese. Bei pascoli circonvicini: poi, immediatamente prima del ghiacciaio, un boschetto di pochi passi in cui raccogliemmo fragole e alcuni fiorellini, e dove si sentiva vero caldo”[9].
La differenza tra queste immagini e quelle trasmesse da Foscolo agli inizi del secolo successivo testimonia che è nel frattempo intercorso un profondo mutamento della sensibilità: “Là giù è il Roja, – scrive il poeta – un torrente che quando si disfanno i ghiacci precipita dalle viscere delle Alpi, e per gran tratto ha spaccato in due questa immensa montagna. V’è un ponte presso alla marina che ricongiunge il sentiero. Mi sono fermato su quel ponte, e ho spinto gli occhi sin dove può giungere la vista; e percorrendo due argini di altissime rupi e di burroni cavernosi, appena si vedono imposte su le cervici dell’Alpi altre Alpi di neve che s’immergono nel Cielo e tutto biancheggia e si confonde – da quelle spalancate Alpi cala e passeggia ondeggiando la tramontana, e per quelle fauci invade il Mediterraneo. La Natura siede qui solitaria e minacciosa, e caccia da questo suo regno tutti i viventi”[10].
Il rapporto con il paesaggio si è drammatizzato, ma accade esattamente l’opposto di quanto Foscolo sostiene: gli “orridi” della natura svizzera sembrano attirare gli spiriti irrequieti non meno delle istituzioni libere del suo popolo. I romantici per eccellenza in Svizzera ci passano tutti, uomini e donne[11]. Nel 1817 Mary Shelley, in fuga d’amore col suo Percy, racconta così il primo impatto: “Il paesaggio di questo nuovo giorno di viaggio era magnifico: montagne ricoperte di pini, rocce brulle e chiazze di vegetazione che superavano ogni immaginazione. Le Alpi innevate […] erano ad un centinaio di miglia di distanza, ma svettavano così in alto nel cielo da assomigliare a quegli ammassi nuvolosi di un bianco abbagliante che si dispongono all’orizzonte durante l’estate. La loro immensità scuote l’immaginazione e supera di gran lunga ogni possibile rappresentazione mentale, tanto da doversi rendere necessario uno sforzo dell’intelletto per poter credere che davvero siano parte della terra”[12].
Trent’anni dopo il suo connazionale Dickens conosce le stesse emozioni: “Eravamo appunto sulla cima della montagna e davanti a noi si ergeva la rozza croce di legno che ne indica la massima altezza sul livello del mare, quando la luce del sole sorgente rischiarò ad un tratto il deserto di neve, colorando questa di rosso scuro. La solitaria bellezza della scena era allora al massimo dello splendore. Nessuno può immaginare uno spettacolo più grandioso […]”. E poco dopo: “Si aprono allo sguardo regioni più calde, aria più quieta, un paesaggio più dolce dove nella rugiada rischiarata dal sole e scintillante come oro e argento si alzavano i tetti di una città svizzera”.
Non tutti, naturalmente, condividono appieno questa fascinazione. Chateaubriand, ad esempio, compie nell’estate del 1832 un viaggio nella zona del Gottardo, che racconta poi nelle Memorie d’oltretomba, mescolando ricordi personali, descrizioni paesaggistiche e considerazioni di carattere storico e politico. Gli piace quasi tutto, ma non è particolarmente suggestionato dalle Alpi: anzi, col suo Voyage au Mont-Blanc si guadagnerà il titolo di “ennemi des montagnes”, perché lancia una vera propria invettiva nei confronti del Monte Bianco e degli scenari alpini in generale. C’entra senz’altro una buona dose di sciovinismo francese, ma è soprattutto il cambiamento tardoromantico degli umori a dettare impressioni meno positive. Nell’Oberman di Senancour si raccontano escursioni in Svizzera e perfino una scalata ai Dents du Midi, ma la vista delle montagne è velata dall’ennui, il male del secolo, che impedisce di sperimentare l’inebriante corrispondenza con la natura provata dalle precedenti generazioni: “Perché la natura non contiene quasi mai ciò che la nostra fantasia immagina per rispondere ai nostri desideri?” si chiede l’eroe.
Diverso ancora è il caso di Alexandre Dumas (padre). Dumas è mosso da un interesse eminentemente giornalistico, cerca lo scoop e immagini sensazionali da offrire al pubblico, piuttosto che la contemplazione estetica o la crescita interiore. Nel 1833 pubblica le Impressions de voyage en Suisse, reportage di un viaggio compiuto un anno prima e già apparso a puntate sulla “Revue des Deux Mondes”. Il suo occhio è già al turismo nascente e il resoconto delle sue avventure diventa più o meno intenzionalmente uno spudorato spot pubblicitario, indirizzato a quell’alta borghesia europea che ambisce ad una villeggiatura elitaria e socialmente molto qualificante[13].
Del tutto prevedibile è invece lo sprezzo per le montagne manifestato da Hegel nel corso di un suo viaggio nell’Oberland. Nel Diario di viaggio sulle Alpi bernesi la natura alpina è vista solo come accidentalità e necessità. I ghiacciai non hanno per lui niente di particolarmente affascinante. In una lettera a Schelling (2 novembre 1800) scrive: “Si può solo dire che è un nuovo tipo di veduta, che però non offre assolutamente nessun’alta occupazione allo spirito se non la constatazione di trovarsi nel pieno della calura estiva a così breve distanza da masse di ghiaccio che un caldo simile non riesce a fondere se non in misura trascurabile”. Neppure la vista delle Alpi lo commuove: “La ragione nel pensiero della durata di queste montagne, o nel tipo di sublimità che si ascrive loro, non trova nulla che le si imponga e le strappi stupore e meraviglia. La vista di questi massi eternamente morti a me non ha offerto altro che la monotona rappresentazione, alla lunga noiosa, del: è così”[14].
Hegel però non fa testo: non lo interessava nulla che non fosse frutto dello spirito umano o assoggettabile ad esso. L’esatto contrario di quanto invece attraeva, oltre che i letterati, i pittori romantici. La Svizzera offriva loro una natura di eccezionale bellezza e di grande varietà: rocce, nevai e ghiacciai, valli strette e profonde tagliate da ponti a strapiombo, laghi solcati da battelli, cascate, boschi, aria nitida, colori limpidi. Per i vedutisti era un paradiso, dove il Sublime sperimentato negli orridi e di fronte alle pareti immense conviveva con una natura “quotidiana” tranquilla e ordinata[15]. Questo spiega perché Turner vi sia tornato a più riprese e Albert Bierstadt addirittura sei volte, spostandosi dall’America, e vi fossero praticamente di casa Gustave Doré, Corot, Courbet e Segantini. E giustifica il commento di John Ruskin, che nel 1833 scriveva: “Quando ebbi superato il passo dello Spluga, vidi come la nebbia si andava diradando, lasciandomi libero lo sguardo su un mondo che era scomparso. Solo quando i veli tra cielo e terra si furono allontanati, emerse alla luce tutta la bellezza. Che cosa accadrebbe se una volta anche il cielo venisse spostato da parte e ci apparisse in una bellezza inimmaginabile, in tutta la sua magnificenza e spaventosità? Gradevole al massimo per gli iniziati, insopportabile per i profani[16].
Sarebbe comunque ozioso proseguire in questa rassegna. La chiudo quindi con le parole di Nietzsche, che nell’Engadina trovò per un lungo periodo un po’ di requie ai suoi malanni fisici e psicologici: “Amo il carattere graziosamente severo dei colli, dei laghi e delle foreste di questo altipiano, che si stende senza paura vicino all’orrore delle nevi eterne, qui dove Italia e Finlandia hanno fatto alleanza e sembra trovarsi la patria di tutti gli argentei toni di colore della natura”.

La libertà
Tutti i viaggiatori che hanno visitata o attraversata la Svizzera ne hanno tratto una impressione vivida, magari non sempre del tutto positiva, ma comunque forte. E tutti i letterati e gli scienziati che se ne sono occupati hanno associato la bontà e l’eccezionalità delle sue istituzioni e le caratteristiche psicologiche dei suoi abitanti all’ambiente naturale. Su questo concorda persino Hegel: “In zone di alta montagna, in cui la riduzione del calore e la povertà del suolo rendono inospitale ogni soggiorno, si dimostra la “nobilitate” della specie umana, capace non solo di abitarvi, ma anche di ricavare ingegnosamente il rifugio e il sostentamento da quel poco che trovano e che riescono a strappare alla natura”.
L’idea che s’impone, destinata a sopravvivere anche al tramonto del romanticismo, almeno fino a metà del XX secolo, è che la moralità dei montanari e dei contadini delle Alpi sia in primo luogo espressione di una reale, totale libertà. Una libertà che si respira assieme all’aria pura e ai profumi discreti della vegetazione alpina. Nel 1839 Victor Hugo scriveva: “Il paesaggio è mozzafiato.[…] Non è solo un segmento del globo che abbiamo sotto gli occhi, è anche un segmento della storia. Il turista vi viene a cercare un punto di vista; un pensatore vi trova un libro immenso dove ogni roccia è una lettera, dove ogni lago è una frase, dove ogni paese è un accento, e da dove escono alla rinfusa come un fumo duemila anni di ricordi.” E Montale, un secolo dopo: “L’evasione dai limiti più fastidiosi della fisicità umana terrena, può essere completa; qui si può veramente respirare la vita lasciando cadere ogni altro legame e dimenticando persino la propria maschera, storica, concreta, determinata”[17].
In quelle valli sono sedimentati secoli di ostinata resistenza ad ogni soggezione. “Un libro immenso”, appunto. La Confederazione comincia dunque molto presto ad essere associata, oltre che all’estetica del sublime, all’etica di una coraggiosa e responsabile autonomia. A partire dalla metà del Settecento i giovani inglesi la inseriscono nei loro tour europei anche per questo motivo. Magari sono alla ricerca di emozioni estetiche, come avviene per la formidabile coppia Thomas Grey e Horace Walpole, ma vogliono anche toccare con mano il miracolo di una realtà politica unica. William Coxe, ad esempio, dopo aver soggiornato nel 1776 in Svizzera scrive Sketches of the Natural, Civil, and Political State of Swisserland (1779) e dipinge la confederazione come un modello di civile convivenza. E solo un anno dopo William Beckford osserva a proposito degli Svizzeri: “Il loro precipuo interesse risiede nel mantenere una rigorosa neutralità di fronte ai litigi dei loro vicini, e nel vivere in perfetta pace con tutti”.
Non sono comunque i primi ad apprezzare quelle istituzioni e quei costumi: già a metà del quattordicesimo secolo (nel 1357) Petrarca scriveva: “La nobile e quasi latina città di Basilea […] La vidi lo scorso anno e notai che fra tutte le città barbare aveva un non so che d’italica gentilezza tanto che, fosse questa dovuta alla vicinanza o fosse una naturale disposizione degli abitanti, la permanenza d’un mese per aspettare l’imperatore romano non solo non mi fu uggiosa, ma mi fu per giunta gradita”; e agli inizi del sedicesimo (nel 1507) Machiavelli notava come gli Svizzeri “godonsi, senza distinzione alcuna di uomini, una libera libertà”. Nel XII capitolo del Principe, dedicato alle milizie mercenarie, li descrive come avversari temibili e feroci, molto stimati come combattenti dai sovrani stranieri. Quando dice che “E svizzeri sono armatissimi e liberissimi “ si riferisce al fatto che la vera libertà si ha là dove c’è un popolo pronto a dare tutto sul campo di battaglia, non fosse altro per il timore di essere accusato di viltà.
Altrettanto positiva è l’impressione riportata da Benvenuto Cellini, che in un capitolo della sua autobiografia ci offre la prima vera relazione di un viaggio in Svizzera (compiuto nel 1537). Pochi anni dopo, nel 1547, Francesco Negri pubblica la Rhetia sive de situ et moribus Rhetorum, un elogio umanistico (e molto partigiano: Negri manifestava forti simpatie luterane) della libertà e della tolleranza religiosa nei Grigioni. E appena dopo la metà del secolo Ascanio Marso, ambasciatore di Carlo V, nel Discorso de i sguizzeri (1558) indica il tipo elvetico come residuo modello di un’antica virtus civile, e la Svizzera come patria della libertà.
Va precisato che queste espressioni di ammirazione rimanevano piuttosto isolate, perché nell’opinione diffusa gli svizzeri continuavano ad essere considerati un popolo di montanari molto tosti ma decisamente rozzi, addirittura un po’ selvatici, induriti da un ambiente aspro ed ostile. O al contrario, per alcuni, selvatici a dispetto della natura benigna che li circondava.
Lo pensavano, e lo dicevano, gli intellettuali elvetici stessi. Nella “Guida per visitare la Svizzera nel modo più proficuo e piacevole” (1809) Johann Gottfried Ebel scriveva che quel lembo di paradiso era toccato dalla benedizione del cielo ma abitato da gente misera, pigra e senza cultura. Allo stesso modo Karl von Bonstetten, cosmopolita illuminato e scrittore raffinatissimo, percorrendo la via da Locarno a Bellinzona annotava: “La campagna è poco coltivata, e tuttavia è assai varia, e forse non è terra più rigogliosa e ricca, lavorata da abitanti più poveri, di questa […] Una riprova di quanto l’ordine possa ben più della natura: il mais, o il granoturco, era alto in molti luoghi oltre 12 piedi; le viti avevano più grappoli che foglie; i castagni erano stracarichi di frutti; e i prati recavano le erbe migliori. Ma gli abitanti di questo paradiso sono pallidi, vestiti a metà, e solo di cenci. Neppure un maiale della Svizzera tedesca entrerebbe in alcune di queste abitazioni.” È da tenere presente che von Bonstetten era originario di Berna, e non era tenero con i suoi “meridionali”.
Madame de Staël, che aveva origini elvetiche e in Svizzera dimorò a lungo, riunendo attorno a se “gli Stati Generali del pensiero europeo” (lo diceva Stendhal), affermava che “gli Svizzeri non formano una nazione poetica, perché non sono forniti di quel brio che distingue altri popoli e non hanno assordato l’universo con le rovine di città e di provincie straniere”. Ammetteva che “l’amor della patria, la concordia tra le opinioni e i sentimenti, brillano più vivaci nella Svizzera che nell’Alemagna”, ma ribadiva poi che “l’angustia degli stati svizzeri e la povertà del paese non vi animano in alcun modo gli ingegni”. Probabilmente si riferiva all’assenza di committenti, senza dubbio poco compatibili con le abitudini spartane sulle quali si reggeva il paese. L’avversione romantica per il Barocco le impediva comunque di prendere in considerazione ingegni come quello del Borromini, mentre Füssli le offriva il perfetto esempio di un artista costretto al volontario esilio per potersi esprimere.
Sempre nei primi decenni dell’Ottocento un altro viaggiatore liquidava gli elvetici così: “una nazione … aliena da ogni studio; insensibile a qualunque nobile passione; priva dei piaceri e dei comodi della vita e della società; somigliante nella sua apatia alle gelate cime dei monti, che la circonda”[18]. Questa immagine era rafforzata dalla particolare diffusione, proprio nelle regioni alpine svizzere, del cretinismo infantile, una sindrome deformante dovuta sia ad un ipotiroidismo congenito che alla carenza di iodio nelle acque potabili. Il cretinismo aveva cominciato ad essere studiato scientificamente solo alla fine del Settecento, e all’epoca veniva ancora attribuito alla pessime condizioni igieniche delle abitazioni e all’abbandono dei neonati per gran parte della giornata da parte dei genitori impegnati nel lavoro.
Persino Victor Hugo, che come abbiamo visto era entusiasta del paesaggio, non si sottrae al facile stereotipo del contrasto tra la bellezza della natura e la miseria di chi ne è testimone: “Non dimenticherò mai questo episodio. In un anfratto della roccia, seduto con le gambe penzolanti su di una grossa pietra, un idiota, un rozzo, dal corpo fragile e dalla faccia enorme, rideva di un riso stupido, il viso in pieno sole, e guardava a caso davanti a lui. O abîme! Le Alpi erano lo spettacolo, lo spettatore era un cretino”
L’impressione riportata da Tolstoj durante un viaggio del 1857 è ancora più pesante. “I bambini sporchi e stracciati, una grande croce al bivio del villaggio, le scritte sulle case, su un pozzo una statuina di Madonna dagli orridi colori, un vecchio gonfio con un ragazzetto pieno di pustole che mi hanno chiesto l’elemosina”. Senza trascurare di sottolineare le ripugnanti caratteristiche fisiche attribuite ai montanari: “Una svizzera col gozzo ha portato i nostri sacchi in due camerette linde”. (E non fa sconti neppure alla natura: “Sono rimasto del tutto freddo alla vista del gelido panorama del monte Jaman; non mi è passato neanche per la testa di fermarmi”).
Da uno che arrivava dalla Russia, la stessa Russia piena di miseria, di derelitti e di vagabondi descritta da Gorkij, il giudizio suona un po’ strano. Ma deve essere proprio un problema dei russi: Dostoevskij più che i costumi degli svizzeri ama in realtà l’atmosfera dei loro Casinò, dove scialacqua tutto il suo denaro e anche la dote della sua fresca e disperatissima moglie, mentre a Gogol l’aria della Confederazione, dove soggiorna per alcuni mesi nel 1836 e scrive una parte de “Le anime morte”, non piace affatto: “Il pensiero di rivedere l’Italia agì in modo tale che io abbandonai la Svizzera, come il prigioniero abbandona la prigione”. Quanto a Tolstoj, come Hegel è portato a vedere solo ciò che conferma i suoi pregiudizi, i suoi umori e i suoi interessi: le disuguaglianze sociali e l’involgarimento dei costumi. “La Svizzera, sono negozi e panorami a pagamento.” Con qualche eccezione per le grazie giovanili: “Bellezze dappertutto, con i seni bianchi”, e “Bel popolo, le donne. Mendicanti. Pioggia. […]. La cameriera mi mette in agitazione”[19].
Più tardi la percezione (quella relativa al popolo, non quella delle donne) si capovolge. Mark Twain, che soggiorna in Svizzera nel 1878 e ne è così entusiasta da tornarvi poi più volte, percorrendone lunghi tratti a piedi e piccandosi addirittura di imparare il tedesco per entrare in completa sintonia, fa ancora diverse concessioni ai luoghi comuni: ma anziché l’arretratezza stigmatizza, alla sua maniera colorita, l’eccessiva disinvoltura con la quale gli svizzeri sfruttano l’attrattiva turistica e incentivano la presenza di chiassose comitive inglesi. Per coerenza e per tenersi lontano dal gregge dei turisti decide di non servirsi del trenino a cremagliera che sale al monte Rigi, pensando di poter compiere l’ascesa a piedi in tre ore. Si perde nella nebbia e ci impiega tre giorni
E tuttavia, a dispetto della sopravvivenza degli stereotipi negativi, nell’Ottocento l’immagine letteraria risultava molto diversa. Aveva iniziato a ricodificarla proprio Haller: nel Die Alpen incontrava, anziché potenziali mercenari pronti a tutto per sfamarsi o arricchirsi, dei frugali montanari nei quali sopravvivevano le antiche virtù. Scopriva il buon selvaggio tra le vette, dove ancora non erano arrivati i guasti della civiltà: e dove questi viveva libero come nessun altro in Europa.
La consacrazione del mito della Svizzera come luogo della libertà ha un’origine illuministica, ma è essenzialmente romantica. Lo stesso Rousseau vi contribuisce solo in parte, perché se in un primo momento difende le istituzioni ginevrine dalle critiche degli illuministi, poi critica quel modello di vita nelle Lettere scritte dalla montagna. L’idea è comunque ormai quella: nelle vallate alpine si trovano ancora popolazioni “primitive” che non sono state corrotte della civiltà, e che sono i crogiuoli della libertà. Schiller nel suo Guglielmo Tell porta gli svizzeri a modello per richiamare i suoi connazionali alle virtù civiche fondamentali: al senso di dignità e umanità, all’odio per l’oppressore e all’amore per la libertà. Racconta di una nazione nella quale tutti i cittadini – vincolati da una reciproca solidarietà –sono disposti a morire per difendere l’indipendenza della patria e l’autonomia propria. E di lì a poco questa immagine trova una formidabile cassa di risonanza mediatica nella traduzione in musica del dramma operata da Rossini.
Dicevo comunque degli inglesi. Nel 1790 Wordsworth ed un amico attraversano a piedi tutta la Francia per andare a conoscere la più compiuta espressione di un governo libero. Siamo in piena rivoluzione francese, ma per il momento non sono i fermenti francesi ad interessarli, quanto piuttosto la realtà ormai consolidata di un popolo che sta dando prova da secoli di sapersi autogovernare[20].
Altri britannici approdano alla stessa conclusione per una via più drammatica. La poetessa Helen Maria Williams, ad esempio, una giovane talmente entusiasta della rivoluzione da convincere tutta la sua famiglia a trasferirsi in Francia, dopo i massacri del settembre 1792 e dopo aver conosciuto le prigioni del Lussemburgo cerca rifugio proprio in Svizzera. Nel 1798 pubblica A Tour in Switzerland, che al racconto dei suoi viaggi nella confederazione unisce un commentario politico, e il poemetto “A Hymn Written Amongst the Alps”. Le fanno compagnia personaggi come l’editore John Hurford Stone, anche lui già sostenitore della rivoluzione e costretto molto presto a filarsela (Stone tornerà in Francia dopo l’avvento di Napoleone, riprenderà la sua attività e finirà in bancarotta per aver editato i trenta volumi dell’opera di Humboldt).
Quanto allo stesso Wordsworth, che a suo tempo aveva aderito con entusiasmo agli ideali rivoluzionari, tornando in Francia nel 1791-92 deve prendere atto della loro deriva cruenta, e finisce col ripudiarli.
Alla fine, la più attenta all’indole e ai costumi degli svizzeri, tra i viaggiatori d’oltremanica, è proprio Mary Shelley, che a dispetto della giovanissima età (o forse proprio per quella) riassume esemplarmente l’opinione corrente: “Riuscivamo a scorgere la cappella di Tell. Questo era il villaggio da dove egli aveva maturato l’idea della cospirazione destinata a rovesciare il tiranno dal suo paese. E davvero questo amabile lago, con le sue sublimi montagne e selvagge foreste, sembrava la giusta culla per una mente che ambiva a nobili avventure ed eroiche imprese. Eppure, non riscontrammo alcun barlume del suo spirito nei suoi odierni compatrioti. Allora gli svizzeri ci apparivano come un popolo lento nella comprensione e nell’azione, opinione questa che ci fu confermata in seguito da altre esperienze; ma l’abitudine li ha resi tanto inadatti alla schiavitù che, non ho alcun dubbio, si difenderebbero con coraggio contro un qualsiasi violatore della loro libertà”[21].
A dispetto dell’apparente delusione, ha colto una cosa essenziale: la libertà non è un diritto naturale, non è iscritta d’ufficio nei nostri geni: è un habitus inculcato dall’ educazione. Una “abitudine”, appunto, che può funzionare anche in soggetti “lenti alla comprensione e all’azione”. E che una volta acquisita, agisce poi in tutti i nostri campi comportamentali.

L’accoglienza
I rifugiati non possono essere rinviati né estradati in uno Stato in cui sono perseguitati.
Nessuno può essere rinviato in uno Stato in cui rischia la tortura o un altro genere di trattamento o punizione crudele o inumano.
(Art. 25 della Costituzione federale)
La tradizione libertaria della Svizzera risale al medioevo. La sua democrazia è preceduta per anzianità solo da quella dell’Islanda. Ha avuto il tempo per radicarsi, negli animi dei singoli come nelle istituzioni. E assieme alla strenua difesa della libertà propria, gli svizzeri hanno imparato, da almeno trecentocinquant’anni, a coltivare il rispetto di quella altrui, tanto che Colbert li citava come “cattivi maestri”: “Le repubbliche fanno delle conquiste, non con le armi ma con i cattivi esempi della loro libertà; come la Svizzera, per esempio”.
Dal suo punto di vista aveva senz’altro tutte le ragioni: la Svizzera era il luogo in cui venivano accolti o almeno tollerati tutti coloro che nel resto del continente non trovavano spazio. In effetti, per poter fare fronte comune contro le ingerenze dell’Impero i diversi cantoni avevano dovuto sviluppare precocemente un’attitudine di ampia reciproca tolleranza, dapprima rispetto agli usi e ai linguaggi, e in seguito rispetto alle professioni religiose e agli orientamenti politici. Come scrive ancora Foscolo nel 1815: “In questo paese l’amor di patria contiene con fede leale e perpetua concordi tanti generi d’uomini diversi di lingue, di usi e di dogma»
Proprio qui volevo arrivare. Senza ripercorrere la storia della Confederazione elvetica (che comunque è pochissimo conosciuta), mi piacerebbe ricordarne almeno alcuni aspetti troppo spesso dati per scontati. Perché, per il motivo egregiamente sintetizzato da Colbert, la Svizzera è stata davvero a lungo il luogo per antonomasia della libertà.
Intanto può essere considerata a pieno titolo la culla della moderna libertà religiosa. Nel 1525, a pochissimi anni dal pronunciamento luterano, nasce a Zurigo l’anabattismo, e nel 1527 a Sciaffusa vengono dettati i suoi principi fondamentali: primo tra tutti quello per cui la vera chiesa si fonda sulla parola di Cristo e sull’amore fraterno, senza la mediazione di alcuna autorità. In questo modo l’anabattismo contrappone la libera scelta e la responsabilizzazione individuale alle nuove ortodossie che sono state immediatamente imposte dai riformatori, si chiamino essi Lutero, Calvino o Zwingli. Di conseguenza finisce da subito nel mirino di chiunque detenga il potere, religioso o civile, nei paesi di osservanza cattolica come quelli protestanti: e in quel mirino rimarrà a lungo. Nella stessa Svizzera gli anabattisti non avranno vita facile: ma qui si gettano le radici per crescita di uno spirito davvero libertario, destinato ad esprimersi poi in una consuetudine unica di accoglienza.
Per tutta l’età moderna trovano infatti rifugio nella confederazione i perseguitati delle più diverse confessioni religiose. Dare asilo ai propri correligionari è un dovere morale per ciascun cantone, ma è anche funzionale a creare una rete di solidarietà e reciprocità ed è una prassi politica di mantenimento degli equilibri demografici. Per questo cantoni e comuni difenderanno sempre con i denti, di fronte alle successive trasformazioni istituzionali, le loro prerogative di discrezionalità nell’accogliere i profughi.
La prima ondata immigratoria risale al XVI secolo, quando la spaccatura confessionale in Europa porta qui i protestanti perseguitati in Francia, Italia, Germania e Inghilterra. Prima della fine del secolo la sola Ginevra apre le porte a circa ottomila rifugiati, la metà dei quali si stabilisce nella città, andando a costituire il 30% della popolazione ginevrina.
Nel 1685 la revoca dell’editto di Nantes spinge in Svizzera oltre sessantamila ugonotti. Si diffondono un po’ ovunque nei cantoni protestanti del paese, ma vanno a popolare soprattutto il Giura, portandosi appresso le competenze che creeranno la tradizione degli orologiai, e anche lo spirito che farà di questo cantone la patria degli anarchici (oltre alla mania per la precisione e per i meccanismi miniaturizzati). Nel frattempo hanno già trovato rifugio nella Confederazione i Valdesi, che a più riprese sono costretti a sfuggire ai massacri perpetrati da Carlo Emanuele II (nelle Pasque piemontesi del 1655) e a quelli di Amedeo II trent’anni dopo.
I rifugiati vengono ripartiti tra i vari cantoni in ragione sia della loro appartenenza religiosa che delle esigenze di sviluppo economico dei diversi territori. Berna, ad esempio, che è il cantone meno industrializzato, se ne accolla quasi la metà. Le autorità cantonali distribuiscono poi i rifugiati tra i vari comuni, e i cittadini sono tenuti a contribuire all’accoglimento fornendo cibo e alloggio.
L’ospitalità non è però riservata solo ai perseguitati religiosi. Ne godono anche quelli politici, indipendentemente dalle loro convinzioni. Nel corso della rivoluzione francese e nel successivo periodo napoleonico si incrociano e convivono paradossalmente sul suolo svizzero gli esuli giacobini (tra cui lo storico Carlo Botta) e quelli monarchici. Subito dopo, durante la Restaurazione, la stessa terra offre rifugio ai molti fuorusciti che, come Foscolo, non intendono giurare fedeltà ai sovrani restaurati. Malgrado gli ex-ufficiali napoleonici ufficialmente non siano accetti, Foscolo può dimorare in Svizzera quasi due anni: il che dimostra quanto blandi siano i controlli e disattesi i divieti.
Una nuova ondata di profughi (tra i quali un alessandrino, Francesco Romagnoli) si riversa in Svizzera dopo i moti del 1820-21. L’ospitalità naturalmente è concessa dietro impegno della cessazione di ogni attività cospirativa, perché la scelta della neutralità non salvaguarda completamente l’autonomia politica del paese, e in verità la Svizzera pullula di agenti dei paesi confinanti. In vari casi, ad esempio, il consiglio municipale di Ginevra si trova costretto a giustificare la protezione concessa agli esuli italiani di fronte ai rappresentanti diplomatici asburgici. E comunque questo non impedisce di garantire la salvezza dei primi. A dispetto infatti di tutto il loro attivismo (fondano ad esempio la tipografia di Capolago, nella quale sono stampati i testi proibiti per essere poi contrabbandati in Italia), e delle espulsioni decretate ogni tanto in risposta alle pressioni austriache e piemontesi, nessuno viene rimpatriato. E quando nel 1848 Carlo Alberto concede l’amnistia, non uno torna in patria. Solo in casi particolari gli individui troppo esposti sono inviati a riprendere quanto prima la strada, come accade a Santorre di Santarosa al suo arrivo nel cantone del Vaud nel 1821.
La repressione che segue i moti rivoluzionari europei del 1848 spinge in Svizzera altre decine di migliaia di profughi politici, la gran parte provenienti dalla Germania, dalla Lombardia e dai possedimenti asburgici. Tra questi c’è anche Carlo Cattaneo, e il legame che Cattaneo instaura con la sua nuova patria, nella quale arriverà a ricoprire importanti incarichi (relativi soprattutto alla riforma dell’istruzione e alle scelte economiche) e ad essere un ispiratore del liberalismo politico e del federalismo, è emblematico del clima di simpatia e di rispetto di cui gli esuli godono. Nel frattempo, tuttavia, le autorità asburgiche adottano nei confronti della Confederazione misure economiche pesanti, come un blocco commerciale e l’espulsione dei lavoratori ticinesi dalla Lombardia, ciò che determina una crisi economica e fa emergere nella popolazione i primi dubbi su una politica di accoglienza quasi indiscriminata.
A dispetto di questo incipiente malcontento, il fenomeno di una immigrazione politica di massa si ripete ancora venti anni dopo, con numeri anche maggiori, a seguito della caduta del secondo impero francese e del soffocamento nel sangue della rivoluzione comunarda. Ormai, con la nascita delle organizzazioni internazionaliste e la diffusione della conflittualità sociale in tutta Europa, lo stillicidio migratorio, soprattutto dalla Germania e dalla Russia, diventa continuo. Ma di questo si riparlerà.
È invece da sottolineare subito che nel periodo del quale stiamo parlando la Svizzera non è il paese di Bengodi, conosce gli stessi problemi economici comuni a tutti gli altri paesi europei. Tra il 1850 e il 1888 emigrano dalla Confederazione 330.000 persone (molte delle quali verso gli Stati Uniti). Sono soprattutto contadini ridotti alla fame dalla perdita ripetuta del raccolto di patate, loro principale sostentamento, causata dalla stessa ruggine che ha provocato una devastante carestia in Irlanda. Ma anche nelle prime fabbriche le condizioni sono disumane e il lavoro è precario. E se gli esuli accolti in territorio svizzero nella prima metà dell’800 appartenevano in genere ai ceti aristocratici o borghesi, quindi godevano di una certa autonomia economica, quelli della generazione di fine secolo sono in maggioranza artigiani o operai, e si pongono in concorrenza diretta con la forza lavoro locale, creando una situazione conflittuale.
Le ondate migratorie sono condizionate anche da queste situazioni, si accompagnano a grandi trasformazioni e hanno ricadute economiche e sociali importanti: ad esempio, la costruzione della rete ferroviaria tra il 1890 e il 1910 richiama in Svizzera oltre 260 mila stranieri, in maggioranza italiani, tedeschi e francesi (diventa straniero il 12% della forza lavoro nazionale), e al tempo stesso offre opportunità ad una miriade di fuorusciti.
Sarà così anche per la prima parte del ventesimo secolo, ma con implicazioni ancor più problematiche. Allo scoppio della prima guerra mondiale rivoluzionari, obiettori di coscienza e disertori di mezza Europa si rifugiano in Svizzera per evitare la coscrizione obbligatoria e poter diffondere le idee contro la guerra. Tra loro ci sono tantissimi anarchici, specialmente italiani, come Ugo Fedeli e Bruno Misefari, che trovano collocazione in una economia comunque galvanizzata dal conflitto. Ma appena terminata la guerra la rivoluzione bolscevica fa affluire nella confederazione un’altra marea di esuli, nobili, borghesi, anarchici e dissidenti di ogni colore, tutti egualmente perseguitati e spesso difficilmente integrabili. Poi, negli anni Venti e Trenta, senza alcuna soluzione di continuità, il fascismo prima e il nazismo e il franchismo subito dopo creano nuovi esodi e pongono grossi problemi alla politica svizzera in materia di asilo. Nel frattempo è esplosa a partire dal ‘29 anche la prima crisi economica globale, la Grande Depressione, e le pressioni dall’interno per un contenimento dell’accoglienza e per la ridefinizione dei suoi criteri adesso si fanno pesanti, soprattutto da parte del ceto operaio e dei commercianti.
Un adeguamento alla nuova situazione è inevitabile. Di fronte alla crescita continua dei flussi nel 1933 la legislazione che regola l’entrata dei rifugiati civili introduce una distinzione restrittiva tra profughi politici e altri rifugiati, Qualche anno dopo, nel 1938, si adotta il principio del respingimento dei rifugiati privi di visto. In pratica si elimina quella discrezionalità nell’accoglienza che era precedentemente demandata ai singoli comuni.
La guerra porta la situazione al limite del collasso e fa saltare tutti i criteri. Con la caduta della Francia la Confederazione si ritrova completamente accerchiata dalle potenze dell’Asse, e deve accettare compromessi che comportano anche la chiusura delle frontiere agli ebrei adulti in fuga dai paesi limitrofi. Una direttiva federale del 1942 impone di “dissuadere i profughi”: su come sia stata poi applicata, la questione è ancora oggi controversa. Un precedente studio che parlava di 24.000 ebrei respinti alle frontiere[22] è stato recentemente confutato da nuove ricerche (condotte proprio da studiosi ebrei) che hanno ridimensionato la cifra a non più di 3500.
Nel frattempo, in ottemperanza alla Convenzione sui diritti e i doveri delle Potenze neutrali che ha sottoscritto nel 1907 alla Conferenza di pace dell’Aia, è tenuta ad accogliere i rifugiati militari e a confinarli in campi di internamento sino al cessazione delle ostilità. Sono decine e decine di migliaia, francesi soprattutto, ma anche polacchi. La seconda pesante ondata giunge dopo l’armistizio italiano dell’8 settembre 1943. Nel solo autunno di quell’anno circa ventimila militari italiani e oltre diecimila civili varcano la frontiera e vengono internati. Altri diciottomila uomini lo saranno nel corso dell’anno successivo, ed entro la fine della guerra la Confederazione accoglierà circa quarantacinquemila rifugiati italiani. Si creano dei campi di smistamento, dove i rifugiati sono suddivisi per categoria e ripartiti successivamente nei vari campi d’internamento. Il termine internamento potrebbe suonare un po’ sinistro, ma occorre ricordare che per i più era l’alternativa soft all’interramento.
C’è poi, finita la guerra, l’esodo degli sconfitti. Ce l’avesse fatta, con loro sarebbe arrivato anche Mussolini, con tutto lo staff dei fedelissimi. In questo caso però la Svizzera ha solo il ruolo di luogo di transito, di rifugio temporaneo per gli ufficiali e i gerarchi nazisti fatti fuggire, con la copertura del Vaticano, verso il Sudamerica. È un po’ difficile leggere la cosa come “accoglienza umanitaria”, ma in fondo per gli svizzeri, dal loro punto di vista neutrale, anche quei criminali erano dei perseguitati politici e, soprattutto se fossero finiti nelle mani dei russi, dei candidati alla fucilazione.
Di queste cifre gli svizzeri hanno tenuto il conto, con la precisione e la meticolosità che li contraddistinguono: per cui sono inconfutabili. Dall’inizio alla fine della guerra hanno chiesto ospitalità alla Svizzera e sono stati accolti nel suo territorio 293.773 rifugiati e internati provenienti da tutta Europa. Circa 60.000 sono civili perseguitati (dei quali 28’000 ebrei), ai quali si aggiungono i circa 60.000 bambini e i 66.000 profughi provenienti dai paesi limitrofi, e 104.000 tra militari, disertori, renitenti alla leva e prigionieri di guerra evasi.
Va detto che a partire dal 1940, per far fronte alla carenza di manodopera dovuta alla mobilitazione, gli internati sono utilizzati nei lavori agricoli e nella realizzazione delle opere di difesa. Ma va anche aggiunto, per avere un quadro più chiaro di cosa significhi per gli svizzeri accoglienza, che appena la situazione lo consente, a partire dal 1943, a quelli che avevano interrotto i loro studi a causa della guerra o della fuga viene data la possibilità di proseguire in Svizzera la loro formazione, e a tal fine sono apprestati sia alcuni campi universitari, sia campi di studi superiori per i liceali italiani.
Di tutta questa vicenda, la parte più conosciuta dal grande pubblico è quella riguardante i respingimenti di ebrei durante il conflitto. Che è un episodio senz’altro vergognoso, perché per la gran parte quei poveretti ha significato quasi certamente la morte: ma che andrebbe anche visto da un’angolazione meno preconcetta. Intanto i respingimenti hanno riguardato non solo gli ebrei ma anche migliaia di altri civili, e non erano dettati quindi da pregiudizi razziali (altrimenti non si spiegherebbe perché un numero sei volte superiore di ebrei siano stati accolti), ma da una situazione di equilibri politici delicatissimi. Durante tutta la durata della guerra la Svizzera è rimasta costantemente in armi, attendendosi ogni giorno, soprattutto nei primi tre anni, l’invasione tedesca, e attuando tutti gli accorgimenti possibili per non fornire pretesti e per scongiurarla. Non erano certo gli accordi stipulati con Hitler sulla collaborazione economica (banche) e sulle forniture alimentari, oltre a quelli sul respingimento dei profughi, a garantirne le frontiere.
In una situazione tanto delicata la Confederazione non ha aperto indiscriminatamente le sue porte, ma ha comunque attuato un enorme sforzo (trecentomila rifugiati da mantenere a fronte di una popolazione di quattro milioni non sono uno scherzo). A sconcertare è il fatto che le critiche sui respingimenti possano arrivare da paesi e da popoli che nello stesso periodo i profughi li producevano, gli ebrei li deportavano direttamente o li consegnavano ai nazisti. Dall’Italia, ad esempio, che non si è mai seriamente interrogata sul proprio passato coloniale, sulle deportazioni attuate in Libia, sulle condizioni semischiavili create in Etiopia, sulle leggi razziali, ecc.
A differenza di noi (e di pressoché tutti gli altri), gli svizzeri hanno cominciato a riconsiderare il loro passato, quasi a volersi liberare di un malessere che li affliggeva. Quando le organizzazioni ebraiche hanno accusato la Confederazione di avere incamerato i beni delle vittime dei nazisti e di avere respinto molti rifugiati, il governo ha istituito una Commissione, ha prodotto un rapporto giudicato esemplare nella sua onestà dagli stessi accusatori, e ha stanziato a favore delle vittime e dei loro eredi cifre considerevoli[23]. Questo gesto non ha riportato in vita i respinti né è valso per la Svizzera a lavarsi la coscienza, ma ha dimostrato almeno che il paese sa assumersi le sue responsabilità. Cosa che altri non fanno affatto[24].
Può essermi sfuggito qualcosa, ma a parte qualche episodio legato alle guerre di religione cinquecentesche non ho mai sentito parlare di profughi o di esuli in fuga dalla Svizzera. La storia ha sempre marciato nella direzione opposta.
E non è ancora finita. Nemmeno oggi il mondo conosce la pace, e i profughi continuano ad affluire in Svizzera. Sono arrivati nel dopoguerra dall’Indocina e dal Tibet, dall’Ungheria prima e dalla Cecoslovacchia poi, dal Cile di Pinochet e dal Ruanda. Negli anni novanta hanno trovato accoglienza 83 mila persone, provenienti dall’ex Jugoslavia, di cui 53 mila kosovari: e altrettante negli ultimi vent’anni sono arrivate dalla Siria e dall’Eritrea. Se tutti popoli fossero egoisti come quello elvetico il problema dei rifugiati sarebbe mezzo risolto.
Anzi, probabilmente non si porrebbe nemmeno.

Gli anarchici
Ho riservato agli anarchici e ai socialisti rivoluzionari in genere un capitolo particolare, perché la tolleranza politica della Confederazione si misura a mio giudizio soprattutto sull’atteggiamento tenuto nei loro confronti nella seconda metà dell’800. A partire dal 1866, dopo la fondazione della Prima Internazionale e con punte altissime al momento della repressione della Comune parigina e della creazione del Secondo Reich, in Svizzera si riversa una marea di fuorusciti provenienti da mezza Europa. Bakunin è tra questi il più famoso ma, solo per restare agli italiani, ci finiscono anche Gori e Cafiero, Costa e Malatesta. Herzen, che già aveva vissuto qui da esule nel 1849, e vi aveva incontrato Mazzini e Pisacane, torna in Svizzera per pubblicare la rivista Kolokol (la campana), il primo organo dell’opposizione allo zarismo, che esce a Ginevra dal 1865 fino alla chiusura nel 1867.
Proprio a Ginevra nel 1867 ha luogo il “Congresso per la pace”, che vede Herzen, Bakunin, Garibaldi, Ogarjef, Louis Blanc alò tavolo di presidenza, e Dostoevskij e Turgenev come spettatori. Il movimento anarchico nasce proprio qui. Una prima teorizzazione dell’anarchia era già stata enunciata da Proudhon, ma non esistevano gruppi anarchici, né un movimento anarchico. Esistevano invece nel Giura delle società di resistenza e di organizzazione autonoma create dagli operai orologieri, che alla fine degli anni sessanta vengono contagiate dall’incontro con Bakunin.
Nel 1872 la loro Federazione convoca a Saint-Imier i delegati dei gruppi antiautoritari che contestano la gestione centralistica della Prima internazionale, quella imposta al congresso dell’Aja da Marx ed Engels. Bakunin e altri anarchici sono appena stati espulsi dall’organizzazione, e in precedenza era stata la volta dei mazziniani. Il congresso rispecchia l’antica tradizione svizzera di opposizione al potere centrale: quindi lo spirito che lo anima è innanzitutto antiautoritario e federalista. Ma già vengono chiaramente formulati quelli che saranno i principi cardine dell’anarchismo. Ogni persona è autonoma, e aderisce a un gruppo su base volontaria. Il gruppo si unisce con altri gruppi in forma federalista, ma conserva la sua autonomia a tutti i livelli. La federazione serve a sviluppare i contatti, a permettere la solidarietà in caso di sciopero o di insurrezione. Lo scopo è “la creazione di un’organizzazione economica assolutamente libera e di un regime federativo basato sul lavoro e sull’eguaglianza e del tutto indipendente da ogni governo politico”. L’aspetto maggiormente positivo è che, al contrario di quanto accadrà in Italia, ma anche in Francia e in Spagna, l’opzione insurrezionalista propugnata da Bakunin rimane in secondo piano, mentre prevale l’attenzione per l’auto-organizzazione e per la responsabilità individuale e di gruppo.
Il fatto stesso che il congresso possa avere luogo testimonia del clima di tolleranza del quale gli anarchici possono godere. Quando quattro anni dopo tenteranno di convocarne uno in Italia, a Scandicci, saranno braccati e inseguiti dalla polizia sino nei boschi. E anche il fatto che Bakunin abbia potuto vivere così a lungo in Svizzera (c’è rimasto anche dopo la morte, è sepolto vicino a Berna) malgrado fosse reclamato dalle polizie di quattro o cinque stati, abbia potuto comprare una casa presso Locarno (la Baronata, pagata coi soldi di Cafiero) e abbia potuto ospitare qui la sua famiglia e incontrare ogni sorta di fuorusciti, la dice lunga. Così come anche il flusso ininterrotto di questi ultimi dalla Russia: Ginevra e Zurigo diventano i luoghi in cui si incontrano gli esponenti del populismo in fuga dalla reazione scatenata dallo zar Alessandro II, e dove maturano i piani del terrorismo anarchico che porterà proprio all’assassinio di quest’ultimo.
A Lugano trova rifugio nel 1872 anche Elisée Reclus, comunardo e geografo, spedito in esilio. Vi risiederà per diciotto anni. É stato preceduto da Benoît Malon, altro elemento di spicco della Comune, e sarà raggiunto qualche anno dopo (nel 1878) da Piotr Kropotkin, fuggito dalle carceri zariste, che collaborerà con lui alla stesura della colossale Geografia universale e sarà poi espulso nel 1881, a seguito appunto dell’attentato allo zar.
Il clima creato nell’ultimo ventennio del XIX secolo dal passaggio alla “propaganda del fatto”, che porta ad una lunga catena di attentati (nei quali trovano la morte oltre ad Alessandro II il presidente francese Sadi Carnot, quello spagnolo Canovas del Castillo, l’imperatrice Elisabetta d’Austria, Umberto I e il presidente americano William Mc Kinley, il re di Grecia Giorgio I e quello del portogallo Carlo I), induce anche la Svizzera ad un giro di vite nei confronti degli anarchici. Prima ancora di Kropotkin vengono espulsi Malatesta e Cafiero e più tardi è la volta di Pietro Gori (autore di Addio Lugano bella, composta proprio in questa circostanza, amico e avvocato difensore di Sante Caserio, l’uccisore del presidente Sadi Carnot). Ancora una volta quanto accade all’esterno, in particolare l’adozione in Francia delle “leggi scellerate” nel 1893 e in Italia delle leggi eccezionali volute da Crispi e applicate addirittura con l’uso dell’esercito, riversa folle di proscritti o di fuggiaschi sulle frontiere svizzere. La reazione delle autorità confederali è un’ulteriore stretta, con disposizioni che colpiscono chiunque metta in forse, con l’istigazione o con l’azione, la “sicurezza pubblica”. Ma gli anarchici pagano soprattutto la concorrenza vincente del socialismo e del sindacalismo rivoluzionario, trapiantati in territorio elvetico dagli ultimi arrivati, che godono di una ramificazione internazionale più organizzata e di una maggiore disciplina al loro interno.
Di quanto poi accade nel ‘900 ho già parlato. I rifugiati anarchici vi recitano ormai una parte secondaria, la loro grande stagione è al tramonto. Ma proprio in Svizzera è ospitato un singolare tentativo di sperimentazione sociale, che per certi aspetti rappresenta il canto del cigno dell’utopismo anarchico. Agli inizi del ‘900 nei pressi di Ascona, nel Canton Ticino, nasce la “cooperativa vegetariana” di Monte Verità, nella quale affluiscono utopisti, teosofi, nudisti, naturisti che amano lavorare all’aria aperta, coltivando la terra, e passeggiare. Arrivano quasi tutti dal nord Europa, ma anche dal Montenegro o dalla Transilvania, e cercano un’alternativa allo stile di vita capitalista, borghese e patriarcale.
Delle precedenti comunità anarchiche, di quelle ad esempio fondate in Argentina alla fine dell’800, Monte Verità ha molto poco. I suoi adepti sono adoratori della natura, girano abbigliati in maniera stravagante, portano i capelli lunghi, lavorano giardini e campi, costruiscono capanne in legno e si espongono a bagni di sole integrali. La loro dieta esclude la carne e si basa interamente su piante, verdura e frutta. Sembra piuttosto una sorta di comunità hippie ante-litteram, con la differenza di essere caratterizzata da un tasso culturale altissimo, ciò che consente ai singoli di mantenere all’interno della pratica comunitaria una reale indipendenza nelle scelte di vita. La popolazione di Ascona sulle prime è molto diffidente, ma finisce poi per adottarli, anche perché la fama della comunità si sparge in tutta l’Europa (e oltre), e col passare degli anni essa diventa quasi un luogo di cura, un sanatorio spirituale, frequentato da personaggi della levatura di Kropotkin, Erich Mühsam, August Bebel, Karl Kautsky, Hermann Hesse, D.H. Lawrence e Isadora Duncan. Infine, dopo il 1920, perde ogni connotazione anarchica per diventare un fenomeno bohémien.
Come esperimento quello di Monte Verità è senz’altro fallito, ed è stato addirittura portato a riprova della capacità degli svizzeri di assoggettare al proprio tornaconto qualsiasi idealità. Ma ha offerto comunque, almeno nella fase iniziale, l’esempio di un sistema cooperativo assolutamente volontaristico e di una forma di coesione sociale capace di salvaguardare l’autonomia decisionale degli individui. Si trattava chiaramente di una proposta elitaria, improponibile su scala diversa da quella del piccolissimo gruppo e adottata per segnare la distanza dalla strada violenta imboccata dall’anarchismo classico: ma resta il fatto che a questa iniziativa è stato consentito nascere, svilupparsi e crescere senza censure e interventi repressivi. Una cosa del genere non avrebbe potuto accadere un secolo fa in nessun altro paese del mondo.

Il Federalismo
Ognuno assume le proprie responsabilità e contribuisce secondo le proprie forze
alla realizzazione dei compiti dello Stato e della Società. (art. 6 della Costituzione federale)
Se sino a qui sono riuscito sin troppo pesante, è perché mi sembrava opportuno mettere assieme un po’ di materiali su cui riflettere, per rinfrescare la memoria e per provare a disegnare un’immagine nuova. Se lo sarò anche nel prosieguo sarà solo questione di scrittura mia. Quanto alle riflessioni, per dare loro un avvio mi affido ad un autore svizzero troppo poco conosciuto: Denis de Rougemont. De Rougemont è stato uno dei più brillanti saggisti del Novecento, uno svizzero in controtendenza, convinto europeista. A differenza di molti suoi connazionali, pensava che la Svizzera non solo potesse, ma avesse l’obbligo morale di entrare a far parte della Comunità Europea (come si chiamava originariamente) e di portare in dote la straordinaria esperienza federale accumulata nel corso della sua storia.
Già nei primi anni sessanta, nel suo “La Svizzera. Storia di un popolo felice”, scriveva: “Se lo Stato nazionale ha i giorni contati, la Svizzera è il solo paese d’Europa che abbia modo di felicitarsene senza la minima riserva mentale. Perché la Svizzera non è nata da una volontà di potenza, come tutti gli Stati unificati da una dinastia conquistatrice, Francia, Castiglia, Prussia o Piemonte, ma da una libera associazione di comuni autonomi, che avevano come solo obiettivo la salvaguardia della loro libertà”.
E ancora: “Lungi dall’essere minacciata dalla disgregazione degli schemi napoleonici, essa può trovare, nella composizione progressiva di un’Europa delle regioni, lo sviluppo dei suoi principi originari”. In realtà De Rougemont non ha trovato tra i suoi connazionali un uditorio particolarmente favorevole. Un po’ per l’antico retaggio isolazionista, un po’ per una diffidenza non del tutto immotivata nei confronti degli equilibri di potere che si profilavano all’interno della Comunità, gli elvetici scelsero un impegno molto più sfumato. Nel 1960 infatti la Svizzera aderì alla Associazione europea di libero scambio (AELS) promossa dal Regno Unito, col chiaro intento di creare un contrappeso proprio alla neonata Comunità Economica Europea, fornendo un’alternativa che non si proponeva altri fini che quelli prettamente commerciali. E anche recentemente, nel 1994, quando gli altri tre rimanenti membri dell’AELS hanno aderito all’accordo sullo Spazio economico europeo (1994), la Svizzera si è chiamata fuori, optando per la stipula di accordi bilaterali con la UE. Nel febbraio 2014, infine, chiamati a votare su una proposta fortemente limitativa dell’immigrazione, i tre quarti degli Svizzeri l’hanno approvata: e le relazioni tra la Svizzera e l’UE sono diventate ancor più difficili.
In patria De Rougemont è stato dunque un profeta inascoltato. Ma anche fuori non ha riscosso molto successo. Quella che auspicava era infatti una scelta davvero “rivoluzionaria”, capace di stravolgere i paradigmi su cui sono nati e proliferati gli Stati nazione: ma solo per sostituirli con qualcosa che andasse ben oltre. Oggi il superamento degli Stati nazionali sta in effetti avvenendo, a dispetto di tutti i sovranismi e populismi e nazionalismi risorgenti, ma solo perché siamo in presenza di un’Europa messa a dura prova da flussi migratori incontrollati, da una classe politica ben lontana dall’autorevolezza culturale dei padri fondatori, da popoli smarriti in cerca di identità perdute. Per questo il modello di federalismo adottato dalla Confederazione torna ad essere più che mai attuale: applicato con gli opportuni adeguamenti su scala continentale potrebbe fornire la soluzione per uscire dall’impasse che blocca da oltre mezzo secolo la crescita politica della Comunità.
Vediamo intanto di cosa si tratta. Il nuovo Stato federale è stato introdotto in Svizzera nel 1848, mantenendo il nome di “Confederazione” in omaggio alla tradizione storica, ma realizzando una entità giuridica ben diversa da quella precedente. Si è passati infatti da una semplice “dieta” federale, composta da delegati dei singoli cantoni che erano portatori di interessi particolaristici e difficilmente approdavano a decisioni unanimi, se non nei frangenti di pericolo, e quindi aveva ben poche possibilità di operare, a un organismo di governo pienamente operativo.
Il modello federalista svizzero è in sé molto semplice. Attribuzioni e competenze sono disciplinate da una Costituzione federale “aggiornata” nel 1999, a centoventicinque anni dall’ultima versione e a un secolo e mezzo da quella originale. È un documento di impianto molto prosaico, che bada alla chiarezza e alla certezza applicativa piuttosto che all’enunciazione di principi. Sembra un manuale di istruzioni per l’uso inteso a garantire il massimo di libertà possibile ai singoli attori politici, a partire dal cittadino, e quindi a responsabilizzarli il più possibile nelle scelte. All’apice del sistema giuridico-amministrativo c’è un’Assemblea federale bicamerale, con potere legislativo, eletta col sistema proporzionale, composta da un Consiglio Nazionale, a rappresentanza del popolo, e da un consiglio degli Stati, in rappresentanza dei Cantoni. Le due camere riunite eleggono un Consiglio federale di sette membri che esercita il potere esecutivo. L’Assemblea è competente a legiferare per la politica estera, la difesa, la sicurezza, la politica monetaria, le scelte energetiche, l’istruzione e la ricerca universitaria, le infrastrutture ferroviarie, la navigazione, il trasporto aereo, ecc…: insomma, su tutto ciò che va disciplinato a livello nazionale per garantirne il funzionamento.
Il territorio è suddiviso in ventisei “Cantoni”, ciascuno dei quali ha una sua Costituzione, proprie leggi, un parlamento, un governo e tribunali propri. Anche i governi cantonali sono eletti dal popolo, per lo più mediante il sistema maggioritario. Le loro competenze comprendono ambiti come la sicurezza, la scuola, la sanità pubblica, i trasporti e l’approvvigionamento idrico ed energetico. Ma godono di una quasi totale autonomia anche nell’ambito fiscale, sul sistema scolastico, sulla polizia, sulla sanità pubblica, sui trasporti, ecc…
Alla base del sistema stanno i Comuni. Le loro competenze sono svariate, riguardano soprattutto i servizi essenziali, anagrafe, protezione civile, sicurezza, scuola primaria, assistenza sociale, pianificazione territoriale, sanità, ecc… Ma ce n’è una in particolare che vorrei sottolineare: sono responsabili per il diritto di cittadinanza. In Svizzera si è prima di tutto cittadini di un comune, e la cittadinanza comunale conferisce automaticamente quella cantonale e nazionale. Il che ha certo avuto un grosso peso anche sulla vicenda dell’accoglienza. L’altra particolarità è che quattro quinti dei comuni praticano attraverso l’assemblea comunale, alla quale possono partecipare tutti gli abitanti aventi diritto al voto, una forma di democrazia diretta. In tutte le occasioni in cui è tecnicamente possibile farlo, il popolo non si fa rappresentare, ma prende direttamente parte ad ogni decisione che lo concerne nel suo ambito territoriale.
Questo sistema funziona perché le competenze dei tre livelli, Confederazione, Cantoni e Comuni, sono ripartite secondo un principio di sussidiarietà che viene applicato con correttezza da tutte le parti concorrenti. Tutto quanto può essere fatto da un livello politico non deve essere avocato da quello superiore. Solo quando un compito risulta eccessivamente complesso o oneroso, sul piano organizzativo o su quello economico, per un istituto di livello inferiore, quello superiore interviene a sostenerlo. Ancora una volta, vige la responsabilizzazione. È in fondo l’applicazione realistica e concreta del “comunalismo” di Camillo Berneri.
La domanda ora è: si potrebbe esportare su scala dell’Unione Europea il modello svizzero? Teoricamente si. Nella pratica, se guardiamo alla situazione continentale attuale, parrebbe la cosa più lontana da una possibile applicazione. E tuttavia, se dovessimo sempre pensare ed operare tenendo conto solo dell’apparente necessità delle condizioni presenti non ci muoveremmo mai di un passo. Qui entra in campo l’opposta necessità dell’utopia, intesa alla maniera in cui la definiva Leszec Kolakowski: “ L’utopia è la tensione verso mutamenti che “realisticamente” non possono essere il frutto di un’azione immediata, cambiamenti che stanno al di là di ogni prevedibile futuro e sfidano qualsiasi pianificazione.” Ma che per il fatto stesso di essere pensati cominciano a mettere piede nella coscienza sociale. D’altro canto, a questa utopia non c’è alternativa, se si vuole che l’Unione Europea continui ad esistere.
Il modello federale svizzero è probabilmente l’unico che permetta di tenere ragionevolmente unite culture e realtà diverse. È nato proprio a questo scopo, in quanto la Svizzera è caratterizzata da quattro lingue nazionali e da notevoli differenze geografiche e di costume: col tempo, alla prova dei fatti e della storia, si è ulteriormente affinato.
Certo, non è un modello facilmente esportabile, se non nelle linee di massima, perché legato ad una antica tradizione repubblicana e pluriconfessionale. Si potrebbe dire che l’Ue si trova oggi in una situazione molto simile a quella che ha portato alla nascita della nazione elvetica, ma con una differenza: quello della Svizzera era uno stato aurorale, passibile di una evoluzione positiva, anche sotto la pressione del comune nemico, mentre quello vissuto dall’Europa attuale sembra davvero un irrimediabile tramonto. Sotto la pressione economica le attitudini divisive dei singoli popoli, anziché sfumarsi, si sono incancrenite. Quel modello ha inoltre sempre comportato una convinta assunzione di responsabilità, a livello sia individuale che delle istituzioni, in particolare nella gestione della finanza pubblica (nel caso svizzero in capo ai cantoni). Esattamente il contrario di quanto sta avvenendo oggi, con gli ultimi entrati che considerano l’Unione semplicemente una mucca da mungere, e al tempo stesso non sono affatto disposti a rinunciare alle sterili autonomie nazionali; mentre altri, l’Italia in testa e fino a ieri la Grecia, non sanno far fronte alla necessità di mettere ordine nei conti e di operare drastici risanamenti in materia di finanza fiscale.
Il modello svizzero funziona molto bene (basti pensare come un paese che campa sulle banche è uscito dalla peggiore crisi bancaria e finanziaria di sempre), ma è nato appunto in Svizzera ed è cresciuto insieme alla coscienza civica di quel popolo. Prima di mutuarne lo schema istituzionale sarebbe necessario provare ad assimilare proprio questo civismo.
Si torna sempre lì. Libertà, sicurezza, benessere non sono affatto un diritto scontato, nascono dell’impegno quotidiano dei cittadini. Di quelli di ieri e di quelli che aspirano a diventare tali domani. È necessario crederci. Chi trova rifugio nella Confederazione deve rispettare le regole del Paese, ma prima di tutto deve conoscerle, e le apprende guardando al comportamento degli svizzeri. Se provo a immaginare cosa vede e impara chi si rifugi oggi in Italia mi prende lo sconforto.
Ma in qualcosa bisogna pur continuare a credere. Per questo riporto altre due citazioni da Rougemont, e le sottoscrivo. La prima è tratta da uno scritto eloquentemente intitolato La fine del pessimismo: “Propongo all’intellighenzia un nuovo compito: quello di creare la libertà cercandola, accettando di considerare i suoi rischi. […] Propongo una rinnovata idea del Progresso […] che non sarà l’accrescimento dei nostri beni, né la soluzione dei nostri mali […], ma l’accrescimento del rischio umano”.
La seconda citazione proviene da un manoscritto inedito recuperato dagli archivi del pensatore svizzero: “Noi andremo verso una fase di barbarie mondiale, se non ricreiamo le democrazie, fondate sulla Legge e la Virtù, su un’attitudine intellettuale che riconosce che l’esistenza di convenzioni in generale, e la loro osservanza scrupolosa, sono elementi vitali per ogni società, qualunque essa sia”.
Un richiamo all’importanza delle “regole del gioco” (non a caso, titolo di questo scritto), senza cui non si dà alcun gioco. “Un sistema politico privo di diritti non è una democrazia. Ma una democrazia senza doveri resta in balia di egoismi individuali e conflitti istituzionali, è priva dei valori della solidarietà e dell’unità politica, capisaldi di qualunque forma democratica di governo”.

La neutralità
L’Italia non può rimanere neutrale per tutta la durata della guerra, senza dimissionare dal suo ruolo, senza squalificarsi, senza ridursi al livello di una Svizzera, moltiplicata per dieci. (Mussolini)
La Svizzera possiede la più disgustosa e miserabile popolazione e sistema politico. Gli svizzeri sono il nemico mortale della nuova Germania. (Hitler)
Una delle affermazioni più stupide che mi è capitato di ascoltare è: “Gli svizzeri sono neutrali perché la neutralità conviene. Hanno guadagnato su tutte le guerre altrui”. Certo che ci hanno guadagnato: in vite umane e anche in termini materiali. Ma questo che significa? Significa che sono gli altri ad essere stupidi, perché se tutti fossero neutrali tutti ci guadagnerebbero. E significa che gli altri non sono convinti affatto che la neutralità paghi, altrimenti non si spiegherebbe perché continuino a fare guerre. Gli svizzeri, quantomeno, non ritengono che per guadagnare occorra aggredire o massacrare altri popoli.
Nel già citato “La Svizzera, storia di un popolo felice”, Denis de Rougemont ricorda che inizialmente la scelta della neutralità rappresentò una sorta di soluzione di ripiego. Si impose quando apparve chiaro che, una volta venute meno le pretese asburgiche, e quindi la necessità di rimanere uniti per sopravvivere, la varietà degli interessi e le propensioni religiose dei singoli cantoni avrebbero alimentato nella Confederazione spinte centrifughe e alleanze esterne contrastanti. Nacque quindi per un calcolo di politica sia interna che estera, ma produsse poi effetti benefici talmente evidenti da radicarsi nel profondo della coscienza nazionale.
Gli svizzeri erano stati tentati, nella seconda metà del ‘400, dopo due secoli nei quali si erano allenati a respingere tutti gli invasori, di intraprendere una politica di espansione: ma dopo una serie di successi ininterrotti erano stati bruscamente ridimensionati nella battaglia di Marignano, dove aveva trovato la morte oltre metà degli effettivi del loro esercito, più di diecimila uomini. Fu l’ultima guerra condotta in maniera unitaria dalla Confederazione. Da quel momento gli svizzeri rinunciarono ad ogni espansionismo e combatterono solo come mercenari in eserciti di altre nazioni, o in conflitti locali, anche se non meno sanguinosi, come la guerra della Valtellina.
La prima dichiarazione ufficiale di neutralità della Confederazione risale al 1674, all’epoca delle guerre di Luigi XIV. È stata poi ribadita a più riprese, in pratica dopo ogni grande scossone storico: nel Patto federale del 1815, nelle Costituzioni federali del 1848, del 1874 e del 1999. È diventata per gli svizzeri la norma in materia di politica estera, piegata magari con una certa flessibilità alle circostanze e agli interessi del paese.
Si è interrotta ad esempio all’epoca dell’invasione francese, nel 1798, quando Napoleone impose un’alleanza militare che obbligò di lì a poco la Confederazione a partecipare alla campagna di Russia. Appena si presentò l’occasione di combattere contro lo stesso Napoleone (all’assedio di Hüningen), gli svizzeri lo fecero spontaneamente, e ciò valse loro il riconoscimento da parte della Coalizione della neutralità permanente e la garanzia dell’inviolabilità del loro territorio.
Più tardi, durante la guerra franco-tedesca del 1870, la Svizzera fece valere la sua neutralità armata offrendo in pratica asilo a una parte dell’esercito francese sconfitto. E divenne la più assidua promotrice della stipula di convenzioni internazionali sui diritti e sugli obblighi degli Stati neutrali, ma soprattutto sul trattamento dei feriti e dei prigionieri.
Sarebbe bene infatti non dimenticare che proprio in Svizzera è nato anche il moderno umanitarismo. Furono quattro cittadini svizzeri a fondare nel 1863 la Croce Rossa, dopo aver assistito con sgomento ai massacri di San Martino e di Solferino, e fu la Confederazione a convocare a Ginevra una conferenza dalla quale uscì la prima Convenzione per il soccorso dei feriti in battaglia e il trattamento dei prigionieri. Convenzione che fu poi pressoché universalmente sottoscritta nella conferenza dell’Aja del 1907.
Pochi anni dopo, nel 1915, la Svizzera si trovò completamente circondata da Paesi in guerra, ma tutti i belligeranti sapevano che non avrebbe ammesso sconfinamenti nel suo territorio senza opporre una feroce resistenza, e ne rispettarono le frontiere. Alla fine del conflitto aderì alla Società delle Nazioni (che aveva sede proprio a Ginevra), ottenendo l’ennesimo riconoscimento della sua neutralità e accettando tuttavia di partecipare ad eventuali sanzioni economiche nei confronti di paesi che avessero violato gli accordi (tecnicamente questa si chiamava “neutralità differenziata”). Quando però le sanzioni decretate dalla Società delle Nazioni nei confronti dell’Italia si dimostrarono totalmente inefficaci abbandonò la neutralità differenziata e tornò a quella integrale.
All’inizio della Seconda Guerra Mondiale questa neutralità venne per l’ennesima volta riconosciuta tanto dagli Alleati che dalle potenze dell’Asse. La Confederazione tuttavia mobilitò precauzionalmente il proprio esercito, pronta a difendere la sua indipendenza. Non si trattava di un eccesso di prudenza: nei piani di Hitler c’era effettivamente l’unificazione entro una “Grande Germania” di tutte le popolazioni di lingua tedesca, compresa quindi anche parte di quella svizzera. Hitler disprezzava gli svizzeri, il loro sistema politico e la loro mentalità democratica (“la Svizzera è un brufolo sulla faccia dell’Europa”): ma rimanevano comunque un popolo germanico, sia pure da rieducare totalmente. Il piano per l’invasione, denominato “Operazione Tannenbaum” (albero di Natale) era già pronto a scattare nell’autunno del 1940, e prevedeva la spartizione del territorio e dei popoli della confederazione con la Francia di Vichy e con l’Italia. Venne però più volte rimandato, mano a mano che si aprivano altri fronti (Inghilterra, Russia, ecc…), fino ad essere abbandonato dopo il 1943.
La Svizzera riuscì ad evitare l’invasione nazista senz’altro, come già detto, a prezzo di una serie di compromessi, ma con ogni probabilità anche perché lo stato maggiore tedesco temeva di incontrare una resistenza molto più dura di quella opposta da altre nazioni europee. Tra il Reno e le Alpi, su un territorio insidioso e difficile per i mezzi pesanti, c’erano oltre un milione uomini tra i diciotto e i sessant’anni dotati di un armamento modernissimo e decisi a onorare una tradizione secolare di indipendenza e di fierezza militare. Non sarebbe stata affatto una passeggiata.
Negli ultimi settant’anni la tenuta della neutralità svizzera non è più stata messa alla prova. Le relazioni estere sono state ispirate ad una sua duplice declinazione: quella della “neutralità armata” (ovvero: ben vengano le garanzie, ma a difendere la nostra indipendenza e i nostri principi ci pensiamo noi) e quella di “neutralità e solidarietà”, ovvero della partecipazione attiva di personale svizzero nel ruolo di osservatore alle missioni di mantenimento della pace e accoglimento dei perseguitati politici. In compenso, la Svizzera non è mai entrata a far parte dell’ONU, e nell’ultima consultazione su questa ipotesi, avvenuta nel 1986, più di tre quarti dei votanti si sono dichiarati contrari.
Non penso si possa liquidare questa posizione come una scappatoia furbesca per mascherare il disimpegno. Credo invece che sia coerente con la scelta di assoluta autonomia d’azione compiuta tantissimo tempo fa. E comunque è purtroppo ampiamente giustificata dal fatto che il ruolo dell’ONU, dopo il lungo periodo di guerra fredda in cui quest’ultimo è rimasto ostaggio dalle due superpotenze, si sta rivelando oggi sempre più inefficace, così come a suo tempo quello della Società delle Nazioni.
Anche in questo caso, non mi sembra si possa rimproverare alla Svizzera la mancata iscrizione ad un club le cui regole non sono affatto chiare e vincolanti ed eguali per tutti, e i cui associati non rispettano nemmeno quelle.
Riassumendo (e anticipando). Negli ultimi quattrocento anni la Svizzera ha rappresentato in diverse occasioni l’unica possibile sponda per migliaia di fuggiaschi, vittime di conflitti o perseguitati per motivi religiosi, politici, razziali, ecc… Poco alla volta, in parte per via dello spirito particolare di tolleranza che già era alla base della nascita della nazione, in parte sotto la spinta delle circostanze storiche, ha cominciato a prendere corpo nella mentalità dei suoi abitanti l’idea che alla Svizzera fosse destinata una particolare missione storica, quella dell’accoglienza dei profughi. Una volta costituita l’antica confederazione in un moderno Stato federale, questa idea divenne un principio fondante della costituzione e conferì alla Svizzera una reputazione e una dignità internazionali. Gli elvetici se ne avvalsero per legittimare moralmente il disimpegno politico simboleggiato dalla neutralità e allo stesso tempo per costruire, anche attraverso la letteratura, un’identità nazionale pacifista (ma tutt’altro che arrendevole) e caritativa.
Questa identità ha superato per un secolo e mezzo le prove della storia, e si è solo leggermente incrinata quando, di fronte alle minacce del nazismo, ha dovuto piegare la sua vocazione umanitaria alla necessità di non compromettere le relazioni con gli Stati confinanti per salvaguardare l’indipendenza nazionale.
Questo sia pur giustificato cedimento ha provocato, a qualche decennio dalla fine della seconda guerra mondiale, un acceso dibatto, dapprima interno e poi allargatosi a livello internazionale. Un dibattito che ha messo in discussione tanto la politica d’asilo della Svizzera quanto il suo ruolo, considerato ambiguo ed egoista, nello scenario internazionale, finanziario e non.
Quel dibattito non si è risolto in una nuvola di polvere: ha prodotto delle conseguenze, morali e pratiche. Prima tra tutte la volontà di rifare i conti col passato, che tanto limpido più non appare, e di guardare in modo più realistico al presente. Una lezione di umiltà di cui andiamo a parlare.

Il “patriottismo critico”
I racconti leggendari relativi alla nascita della Confederazione (la saga di Guglielmo Tell, la rivolta dei primi cantoni e il loro giuramento di alleanza) sono stati tramandati oralmente fino al XV secolo, quando hanno cominciato ad essere raccolti nel libro bianco di Sarnen (1470), e sono poi stati ripresi nelle cronache di Aegidius Tschudi (De prisca ac vera Alpina Rhætia, pubblicato nel 1538) e di Johannes Stumpf (1556). Da allora fino a tutto l’Ottocento quei miti fondativi sono stati considerati assolutamente autentici, e hanno rivestito un ruolo fondamentale nel consolidamento dell’identità svizzera e nella creazione dello stato federale. Nel corso dei secoli si è affermata dunque una lettura del passato in chiave patriottica che ha contribuito a rafforzare l’idea del “caso particolare” svizzero, di un piccolo paese neutrale e al tempo stesso agguerrito, saldamente piazzato al centro dell’Europa.
Dopo il poema di Von Haller però la letteratura elvetica non ha prodotto, almeno sino alla metà del secolo scorso, opere di particolare rilievo. D’altro canto, in un paese nel quale si parlano (e si scrive in) quattro lingue diverse è difficile definire una identità letteraria. Gli scrittori svizzeri stessi tendono a pensare che una letteratura elvetica non esista (lo pensano evidentemente anche quelli di Wikipedia. La voce “letteratura elvetica” è una semplice scheda in bianco). Ma negli autori più significativi dell’Ottocento, come Gottfried Keller[25] o Jeremias Gotthelf[26] è facile ravvisare i topoi della mitologia primitiva anche nel semplice racconto della quotidianità, mentre in Conrad Ferdinand Meyer li ritroviamo nella tipizzazione dei personaggi storici[27]. Lo stesso vale nella prima metà del Novecento, per la Passeggiata di Robert Walser, che è un inno malinconico alla bellezza e all’armonia del paesaggio, ma anche all’urbanità degli incontri, ad una educazione degli uomini e della natura che non può essere che svizzera. Insomma, viene sommessamente costruita un’immagine storica e sociale del paese che ricolora a tinte pastello l’esistente, quasi a difenderlo dall’erosione della storia e dal buio che avanza.
Paradossalmente, l’opera che meglio documenta la profonda trasformazione avvenuta nel corso dell’Ottocento nella coscienza di sé degli svizzeri, e la conseguente convivenza di due anime, quella conservatrice, naturistica e montanara e quella innovatrice, industriale e cittadina, è il romanzo Heidi (1880), di Johanna Spyri. Oggi è conosciuto quasi solo per la stucchevole trasposizione in un cartone animato giapponese, ma a suo tempo il libro ebbe un enorme successo, fu tradotto in una ventina di lingue, divenne una lettura di culto non solo in Germania ma anche in Giappone (non a caso la versione animata l’hanno fatta loro): e l’autrice è tra i personaggi in assoluto più famosi in Svizzera.
La storia di Heidi, al di là delle arcinote vicende dell’orfanella e della sua amica Klara, non è affatto la pappina zuccherosa propinata ai nostri figli dalla televisione o dalle innumerevoli trasposizioni cinematografiche. Al contrario, evidenzia molto bene, e senza nascondere nulla, il contrasto di cui parlavo sopra tra la vita di campagna e quella di città alla fine dell’Ottocento, con i problemi indotti dall’industrializzazione, ma anche con lo sfruttamento del lavoro minorile, con la piaga dell’analfabetismo, con i guasti prodotti da una pedagogia rigida. L’autrice tifa chiaramente per il vecchio montanaro burbero e un po’ misantropo, ma intimamente buono e giusto, che alla domanda della nipote: “Perché strilla così l’uccellaccio, Nonno?” risponde: “Perché? Perché ride di quelli che stanno laggiù, stretti nei villaggi a litigare fra loro; e grida, così che tutti possano udirlo: se ve ne andaste ciascuno per la sua strada su una montagna come faccio io, stareste meglio!” Ma poi prende realisticamente atto che per quanto l’orfananella venga allevata con profondo amore dal nonno non può avere come unica prospettiva nella vita quella di portare le capre al pascolo sulle montagne: deve scendere a valle, in città, e imparare non solo a leggere e scrivere, ma anche a confrontarsi con altre persone. Tutto sommato, è un libro pieno di buon senso, che solleva un sacco di questioni molto serie, e non ha la presunzione di fornire risposte definitive. Le tematiche presenti in Heidi sono infatti quelle ricorrenti non solo nella letteratura ma in tutto il dibattito culturale e sociale interno al paese nei primi decenni del Novecento.
A partire da quel periodo, e segnatamente negli anni trenta, prima dell’ultima guerra mondiale, si sviluppa in Svizzera un forte sentimento di patriottismo nazionalista, alimentato dal timore per la politica aggressiva del vicino settentrionale. La cultura svizzera si rinserra, come un tempo le sue fanterie, a far quadrato contro l’accerchiamento, e oppone ad esso il mito enfatizzato di una innocente saggezza e di una specialissima sensibilità umanitaria, il modello di una Svizzera “buona”, in una rappresentazione spesso sin troppo oleografica della quotidianità o autoglorificante della storia.
La manifestazione più eclatante di questo atteggiamento è l’Esposizione Nazionale che viene organizzata ogni quarto di secolo a partire dal 1883 (la prima si tiene a Zurigo),con l’obiettivo di presentare un quadro della vita culturale, politica ed economica del Paese, ma soprattutto di promuoverne l’eccezionalità agli occhi dei suoi stessi abitanti e di recuperare o addirittura creare ex novo una forte immagine identitaria. La prima di queste esposizioni è incentrata sulla scuola e sull’istruzione, uno dei chiodi fissi dergli svizzeri, mentre le successive tre edizioni (1896 a Ginevra, 1914 a Berna e 1939 a Zurigo) saranno dedicate ad esaltare il ruolo aggregante ed educativo dell’esercito, ad esibire l’orgoglio per una indipendenza secolare e a sottolineare l’importanza di una “Difesa Spirituale” del modello esistenziale elvetico, quello fondato su una vita rurale serena e armoniosa e contrapposto alla frenesia disordinata e violenta del mondo industriale. Questo messaggio viene trasmesso ricostruendo ad esempio a grandezza naturale un “tipico” villaggio di montagna sulle rive del lago di Zurigo, e traferendo in esso per tutto il periodo dell’esposizione gli abitanti di un villaggio reale. Può sembrare ingenuo, e persino patetico, ma è in fondo la versione pre-televisiva e pre-internettiana della realtà virtuale.
Nell’immediato dopoguerra a questa immagine se ne sovrappone un’altra: quella di un paese che è in fondo il vero vincitore morale del conflitto, perché ha salvaguardato l’integrità del suo territorio, non ha subito perdite di vite umane, ha conservato intatto il suo apparato industriale ed è pronto ora ad approfittare del grande affare della ricostruzione del continente. Il tutto viene associato appunto alla neutralità: agli occhi di molti svizzeri appare come un premio per il comportamento “virtuoso” mantenuto dal paese in mezzo a tanto orrore, un comportamento che va giustamente remunerato. Ciò finisce però per collegare l’idea della neutralità a quella di una rendita di posizione fondata sulla stupidaggine e sulle disgrazie altrui. In maniera sottile si insinua nella popolazione elvetica la presunzione di costituire una sorta di popolo “auto-eletto”: il costante stato d’allerta del periodo bellico, la mobilitazione generale, hanno creato la sensazione che la guerra in qualche modo la si sia davvero combattuta, in difesa della purezza degli ideali e contro il dilagare della barbarie. È il preludio ad una concezione separatista, se non ancora razzista, nei rapporti con gli altri: la purezza va ancora difesa, la guerra in realtà non è finita, si continua a combatterla, sia pure con altri mezzi.
Questo autocompiacimento ha cominciato a vacillare, attorno ai primi anni sessanta, di fronte al “miracolo” della rinascita velocissima di quei paesi che la guerra l’avevano prima voluta e poi subita davvero sul proprio territorio, versando un tributo insensato di sangue alla follia: e soprattutto di fronte alla nascita di istituzioni sovranazionali che si ponevano, almeno negli intenti, l’obiettivo di evitarne per il futuro qualsiasi altra. La Svizzera si era tenuta fuori sia dall’Onu che dalla nascente Comunità europea, con pronunciamenti sempre largamente maggioritari della popolazione: e questo creava nervosismo tanto negli ambienti economici più avanzati, che temevano di perdere il treno di una espansione economica senza precedenti, quanto in quelli più sensibili alle problematiche sociali e all’apertura verso l’esterno. Il mondo andava avanti, e la Svizzera rimaneva a guardarlo avanzare, sia pure dal suo balcone fiorito. Non era sufficiente mantenere attivo l’impegno umanitario. Occorreva riallinearsi, aggiornare alla nuova situazione le vecchie idealità, magari senza ripudiarle, ma modernizzandone l’interpretazione.
Il ripensamento è partito sulla scia del sessantottismo, che pure aveva toccato la Svizzera in maniera marginale, e del decostruzionismo postmoderno. Il primo vero choc era venuto con la pubblicazione de “La Svizzera al di sopra di ogni sospetto”, libro-denuncia di un sociologo ginevrino, Jean Ziegler, apparso nel 1976. Ricordo ancora il clamore suscitato anche (e probabilmente, soprattutto) in Italia dall’atto d’accusa che Ziegler lanciava nei confronti della politica spregiudicata e cinica delle più grandi imprese e delle maggiori banche del suo paese, portata avanti con la collusione delle autorità governative. All’epoca quelle rivelazioni mi avevano spiacevolmente sorpreso: ma la lettura del saggio, arrivata solo qualche anno dopo, mi ha invece convinto poco. Anche a fronte di verità non contestabili, mi ha infastidito l’impostazione, davvero troppo ideologica e pregiudiziale.
Subito appresso hanno iniziato a piovere le accuse alle banche elvetiche di custodire i patrimoni di vari dittatori del terzo mondo, poi quelle ancora più gravi di aver incamerato i beni di molte vittime dell’Olocausto e, infine – queste rivolte allo stato e alla “falsa coscienza” pubblica – di avere respinto durante il conflitto migliaia di profughi. Erano attacchi che partivano in genere direttamente dall’interno, portati da giornalisti di sinistra, da terzomondisti o postmodernisti di complemento o da studiosi seri come Ziegler, ma venivano immediatamente riprese e amplificate con uno zelo visibilmente maligno all’estero.
La mia impressione ha continuato ad essere che, al di là della loro fondatezza, in qualche caso tutta da verificare, molte di quelle accuse fossero motivate da un assunto principalmente ideologico, e non tenessero in conto la situazione drammatica nella quale la Svizzera si era trovata durante la guerra. Abbiamo già visto come ha reagito il Governo della Confederazione: le cifre stanziate per risarcire gli ebrei non sono affatto simboliche, e quanto alla vicenda dei respingimenti è stata istuita una commissione che ha prodotto un rapporto tutt’altro che addomesticato.
L’effetto di queste ripetute chiamate al banco degli imputati ha tuttavia inferto una grave ferita morale alla popolazione elvetica, mettendo drammaticamente in forse l’autostima dell’intera nazione. Ed ha acuito i segnali di un malessere che circolavano già da parecchi anni.
Al patriottismo nazionalista si è dunque sostituito nel corso di una sola generazione un “patriottismo critico”, nato dalla volontà di riconsiderare quelle immagini patriottiche che senz’altro avevano avuto un senso, come sosteneva De Rougemont, contribuendo in maniera fondamentale al processo di democratizzazione, ma che ormai erano diventate un cliché folkloristico ed una zavorra, per alcuni addirittura un falso specchio dietro il quale nascondere una cultura fondata sulla violenza e sullo sfruttamento. Così, mentre Ziegler rincarava la dose del suo j’accuse con “La Svizzera lava più bianco”, Max Frisch, l’autore de “L’uomo nell’Olocene”, andava in profondità e liquidava definitivamente con “Guglielmo Tell. Per la scuola” il mito fondativo stesso su cui è nata e di cui ha vissuto la “singolarità” svizzera, e di conseguenza tutta l’iconografia che ne corredava la leggenda. L’idea poi che dietro il perbenismo, il bigottismo e il candore della vita semplice e ordinata degli svizzeri si nasconda del marcio traspare da ogni opera di Dürrenmatt, ed è esplicitamente espressa in quelle di Paul Nizon[28].
Tutto questo lavorio di de-costruzione ha indotto una nuova chiave interpretativa della storia e della realtà svizzera, quello della “ristrettezza”: come se la scelta della neutralità adombrasse in realtà una scelta di insignificanza, di auto-esclusione dalla storia. Da positiva e autoglorificatoria, o perlomeno giustificatoria, l’attitudine promossa e testimoniata dalla letteratura è diventata autodenigratoria. È scattato in fondo quel particolare meccanismo psicologico che agisce molto spesso in chi ha fatto i soldi onestamente (chi li fa disonestamente non ha di questi scrupoli), che prova comunque un senso di colpa di fronte all’invidia altrui e sente di doversi quasi scusare della propria fortuna, di essere tenuto ad una azione in qualche modo riparatrice, o redistributiva. Meccanismo che va a sommarsi a quell’altro, comune a tutte le nazioni “piccole”, che fa si che siano combattute tra la paura dell’insignificanza, qualora si tengano in disparte, e la volontà di sottolineare una differenza, e quindi una estraneità ai giochi politici delle grandi potenze, che ne giustifica l’esistenza stessa.
Si è trattato di un passaggio importante, e la transizione ad una nuova immagine, più pacificata, non è ancora affatto conclusa. Senza dubbio però il “patriottismo critico” ha fatto il suo tempo: l’atteggiamento dissacratorio è diventato quasi d’obbligo. Ma una volta raggiunto il suo scopo il “patriottismo critico” non ha saputo andare oltre. Ha creato un vuoto, che non può essere nuovamente riempito dai miti di fondazione e dall’immagine stereotipa, ormai messi a nudo e addirittura ridicolizzati, e rischia di essere colonizzato da un nuovo nazionalismo, non più umanitario e comunque accogliente, ma ostentatamente chiuso e ed egoista.

Il formidabile esercito svizzero
«Lo svizzero fu per me – venivo da Vienna in piena guerra – la lingua della pace. Ma era una lingua forte, con espressioni vigorose e contumelie assai caratteristiche, e quindi questa “pacificità” non aveva niente di tiepido o di fiacco: la lingua menava colpi, ma il paese era in pace» (Elias Canetti, La lingua salvata)
Nell’epoca rinascimentale gli svizzeri erano considerati i migliori soldati d’Europa. Quanto meno, i più efficaci e feroci. A ragion veduta. Avevano iniziato due secoli prima, respingendo i cavalieri austriaci che venivano a imporre loro il vassallaggio, e non solo li avevano respinti, ma li avevano proprio fatti a pezzi. Poi si erano ripetuti di fronte a quelli francesi e ai borgognoni. Fino, appunto, alla già citata battaglia di Marignano, che in termini di perdite non fu una sconfitta, piuttosto un pareggio, ma ebbe un grosso e differente peso sull’autostima dei contendenti. Affrettandosi a proclamarsi vincitore, Francesco I, che non brillava per modestia, disse che in precedenza solo Cesare era riuscito a sconfiggere gli svizzeri.
In realtà la rinuncia ad ogni tentativo di un espansionismo elvetico non fu causata da quella sconfitta. Di lì a pochissimi anni esplose la Riforma, e i cantoni si trovarono ad essere divisi non più solo dalla lingua, ma anche dalla religione: divenne pertanto molto difficile far combattere sotto le stesse insegne cattolici e protestanti, a meno che non fosse per la causa più alta della difesa del suolo patrio.
L’attitudine però non venne meno: gli svizzeri andarono a combattere sotto altre bandiere, reclutati e “affittati” dai singoli cantoni, e quello delle armi divenne un mestiere, anzi, il ramo più redditizio dell’economia del paese. Ascanio Manso, decisamente portato a sovrastimare le cifre ma buon conoscitore dell’indole e dei costumi svizzeri, scrive: “Si conosce chiaramente che la Lega helvetica può mettere in campagna più di 150 miglia huomini armati per soi bisogni, senza lasciar però abbandonate di governi e presidi convenevoli le sue terre, et in servitio d’altri principi può mandare comodamente 40 miglia soldati.” La regola in effetti era quella di non usare mai per operazioni diverse dalla difesa diretta della circoscrizione più della metà degli uomini disponibili.
La tradizione è rimasta anche dopo che le milizie mercenarie sono diventate illegali, e gli svizzeri l’hanno onorata fornendo, ad esempio, un grosso contributo ai ranghi della Legione Straniera, e raccomandandosi per affidabilità e lealtà. Nel settecento quasi tutti i sovrani europei, e non solo i pontefici, si circondavano di una “Guardia svizzera”. E furono proprio quei mercenari a opporre l’ultima resistenza, nel 1792 alle Tuilleries e nel 1830 durante la rivoluzione di luglio, in difesa dei Borboni, facendosi massacrare a centinaia[29].
È una tradizione viva tuttora, perché gli svizzeri non si vergognano affatto del loro passato guerriero, lo ricordano anzi con orgoglio. E quando occorre, lo ricordano anche agli altri. Ai tempi della guerra fredda, nei piani di invasione dell’Europa occidentale predisposti dal Cremlino la Svizzera — rinchiusa nella sua neutralità armata — era considerata uno degli ossi più duri. Se neppure i tedeschi avevano ritenuto di provarci qualche motivo doveva esserci: ogni monte, ogni valle, ogni strada celava (e cela) un’insidia, una casamatta, un arsenale, un aeroporto, un campo minato. Negli stessi piani la resistenza italiana, al contrario, era calcolata in ore: giusto quelle necessarie all’aviazione sovietica per raggiungere e distruggere a terra ogni postazione o mezzo di difesa.
Si vis pacem, para bellum. “Ufficialmente gli svizzeri non fanno la guerra da cinquecento anni, e sono ben decisi a saperla fare appunto per non farla” scrive John McPhee, l’autore de Il formidabile esercito svizzero. Il modello di riferimento è diventato quello israeliano, dopo che Israele alla sua nascita aveva chiaramente modellato il proprio esercito su quello svizzero. E non è solo l’efficienza, garantita da un costante ammodernamento degli armamenti e addestramento degli uomini, a giustificare il parallelismo, ma è soprattutto il concetto di fondo, la totale sovrapposizione di cittadinanza e servizio militare. La Svizzera non è un’enorme caserma, come la Prussia di Federico secondo, ma un paese dove tutti sono, e soprattutto si sentono, all’occorrenza, dei soldati.
Mentre la maggior parte degli stati opta oggi per forze armate composte da professionisti, la Svizzera non rinuncia al suo esercito di milizia, sia pure ridimensionato (negli anni ‘80 del secolo scorso contava oltre seicentomila effettivi, oggi si è snellito sino a meno della metà). I giovani dichiarati abili frequentano una scuola reclute che dura dalle 18 alle 21 settimane, a seconda della funzione attribuita al momento del reclutamento. In seguito vengono convocati a sei o sette corsi di ripetizione annuali di tre settimane ciascuno fino all’età di 30 anni. Il limite di età cresce a seconda che i militari ricoprano cariche più importanti nell’esercito, ed arriva fino al massimo di 50 anni per gli ufficiali superiori. Oltre a partecipare ai corsi di ripetizione, ciascun miliare è tenuto a svolgere un’altra attività complementare: andare a sparare in un poligono e partecipare ai giochi e alle “feste di tiro” che si svolgono in ogni cantone. In alternativa, i giovani possono optare per svolgere un servizio civile, ma oltre il novanta per cento sceglie di assolvere all’obbligo nei ranghi dell’esercito. Le donne non sono soggette all’obbligo, ma possono chiedere il reclutamento volontario. Per tutti i periodi effettivi di servizio, sia durante l’addestramento che nelle ripetizioni, i militari sono retribuiti, in buona parte dalle aziende presso le quali lavorano, e il loro stipendio non è simbolico: il che, stanti i numeri, comporta per lo stato una bella spesa. Spesa che rimane comunque sotto l’1% del Pil, mentre quella italiana è di una volta e mezza maggiore.
Perché dunque quando si parla dell’esercito italiano cascano le braccia, e il pensiero corre subito all’impavido aviere Cocciolone (e alla operazione Locusta, nel corso della quale un cacciabombardiere su sette decollati riuscì ad arrivare sulla meta, per essere poi lì abbattuto) mentre quello svizzero gode, almeno da parte di chi ne conosce l’esistenza, di un ammirato rispetto?
I motivi sono molti, di natura diversa, ma tutto sommato riconducibili ad uno solo: agli italiani non piace affatto combattere, sono più propensi a litigare. Quanto poi al modello organizzativo, un particolare può esemplificare il tutto. L’esercito svizzero non ha un generale. Questo grado può essere conferito solo in casi di particolare emergenza. Dopo la fine della seconda guerra mondiale non ne è più stato nominato uno. Nemmeno il capo dell’esercito, che è scelto a turno tra i comandanti di corpo d’armata, può fregiarsi di quel titolo. Al contrario, nell’esercito italiano, che conta attualmente – dati ufficiali del 2018 – meno di due terzi degli effettivi di quello svizzero, i generali sono 480 per 178 mila militari. Ma ci sono anche 2350 colonnelli. E, questo è davvero fantastico, per una stranissima legge ogni ufficiale superiore di qualsiasi grado dopo tredici anni di carriera percepisce lo stipendio da colonnello, e dopo venticinque quello da generale. Per cui il 70 per cento del bilancio del ministero della difesa va in stipendi (e non indifferenti, se già dieci anni fa la pensione di un generale sfiorava i trecentomila euro annui). Come non bastasse, sulle casse della Difesa pesa anche la “funzione anticipo pensioni”, un pensionamento anticipato per chi lascia le forze armate.
Quando parlavo del rispetto generale per l’esercito svizzero non consideravo il solito Tolstoj. Durante il viaggio in Svizzera del 1856, l’incontro con alcuni militari ubriachi lo indignò: “In nessun posto come in Svizzera si nota in modo così acuto l’influenza corruttrice della divisa. In verità tutto l’ambiente militare è fatto per trasformare l’uomo, essere buono e ragionevole, in una belva malvagia e stupida”.
C’è senz’altro qualcosa di vero in ciò che dice, ma non quando porta ad esempio gli svizzeri. Al termine del servizio di leva i congedati ricevono in consegna l’arma, fucile o pistola, che avevano in dotazione. Possono anche rifiutarla, ma succede assai raramente. In ogni casa svizzera c’è quindi un’arma da guerra. La Svizzera non è, tra i paesi in cui questi dati sono censibili, quello con più armi pro capite, ma è piazzata molto in alto. Eppure non compare affatto nelle classifiche mondiali dei paesi più violenti. Anzi, è al quinto posto in quella dei più pacifici, e anche variando i criteri e le priorità nella valutazione dei diversi fattori rimane saldamente in quei paraggi. Tanto per capirci, l’Italia, dove la legislazione sulla detenzione di armi è decisamente restrittiva, o almeno lo era sino a qualche mese fa, naviga attorno alla quarantesima posizione, dopo la Bulgaria e a diverse lunghezze dal Botswana.
Il che induce a pensare che non sia “l’ambiente militare” a rendere gli uomini stupidi e malvagi, ma siano gli uomini, non sempre esseri buoni e ragionevoli come Tolstoj li vorrebbe, a portare la loro stupidità in qualsiasi ambiente. Negli Stati Uniti, già nel 2007 circolavano circa 90 armi ogni 100 persone, e infatti si vede cosa accade. In Svizzera e in Finlandia la percentuale è comunque molto alta (45%), ma non accade nulla. In Italia il dato stimato (perché sono naturalmente molte di più le armi detenute illegalmente che quelle regolarmente denunciate) è attorno al 12%, ma ci assicuriamo comunque il primato europeo per gli omicidi commessi con armi da fuoco (e anche quello con armi da taglio)
E allora, perché in Svizzera, si chiede ad un certo punto John McPhee, dove quasi tutte le famiglie hanno in casa ha un’arma da guerra, non ci sono continui scontri a fuoco? E si risponde: perché è proibito. Come gettare le cicche per terra. Infatti, non ci sono cicche per terra: eppure fumano anche loro.
Ma sono educati.

Sull’educazione e sui suoi effetti collaterali
Se c’è un luogo nel quale gli effetti dell’educazione sono visibili, quel luogo è proprio la Svizzera. Sto parlando di un processo collettivo di lunga durata, plurisecolare, che ha interessato un intero popolo. E che ha finito per caratterizzare tutto un ambiente, prima ancora che i singoli individui che lo abitano. Gli svizzeri non arrivano da Marte, sono esseri umani, fatti della stessa pasta di tutti gli altri. Si comportano da tali, e quando ne hanno la possibilità fanno le stesse stupidaggini dei loro conspecifici. Gli ultimi due a volare giù da un viadotto a velocità pazzesca, nell’autostrada che attraversa l’Appennino sopra Genova, sono stati dei ragazzi svizzeri. Il fatto è che in patria probabilmente non avrebbero fatto nulla di simile: perché là è così. Sapevano che se li avessero beccati a provarci, oltre a pagare una salatissima multa o a scontare qualche mese di carcere avrebbero dovuto chiedere passaggi agli amici per il resto della loro vita. Da noi quel pericolo non c’è, e infatti non ci sono più neppure loro.
Ciò parrebbe andare in una direzione esattamente opposta a quella del peso dell’educazione. Invece ne è una conferma. Perché sono convinto che quei due sventurati in Svizzera si sarebbero comportati diversamente non per timore della punizione, o almeno, non solo per quello, ma perché là, oltre che proibiti, certi comportamenti sono “sentiti” come sbagliati, e quelli opposti come normali, dovuti. Ciò rimanda al problema di cosa si debba intendere per educazione, e prima ancora se è davvero possibile, e in che misura, impartirne una: ma non essendo questa la sede per discuterne mi limito a chiarire in poche parole cosa intendo io. Vale quanto già dicevo a proposito della libertà: è un habitus mentale che si acquisisce attraverso la consuetudine. Educare significa prendere per mano e indirizzare verso particolari comportamenti, quelli ritenuti giusti o comunque funzionali alla civile convivenza all’interno di una particolare società (e che quindi, certo, non sono gli stessi per tutte le società e per tutti i tempi: mutando i modelli istituzionali, i rapporti sociali e i modi di produzione evidentemente cambiano anche le regole di convivenza). Poi, a un certo punto, la mano va lasciata, perché ciascuno si assuma le proprie responsabilità. Se poi quei comportamenti siano davvero funzionali o meno lo dice il tempo, lo dicono i risultati in termini di armonia, di sicurezza, di percezione dell’equità sociale e della libertà individuale.
Gli svizzeri hanno avuto secoli per definire e correggere e limare delle regole capaci di garantire l’equilibrio in una situazione complicatissima. Quella situazione è stata la loro palestra e la loro fortuna. Sono riusciti a tradurre una (congenita?) testardaggine in determinazione, una necessità di sopravvivenza in disciplina, e a garantirsi l’autonomia per decidere sempre da soli tali regole: ciò ha fatto si che le abbiano sentite sempre come proprie e le abbiano assimilate sottopelle, direttamente in vena. Quanto poi la cosa funzioni a livello individuale, di libera scelta, questo dipende naturalmente dai singoli caratteri, e i ragazzi volati dal viadotto ne sono la dimostrazione. Ma almeno funziona un imprinting collettivo che si autoalimenta e si rafforza, se vogliamo si compiace anche, nel rapporto e nel confronto sociale.
Per gli svizzeri il tema dell’educazione è fondamentale. È oggetto di un dibattito continuo, serio e universalmente partecipato. Il paese ha una grande tradizione di pedagogisti, da Pestalozzi a Piaget, e non è un caso che i suoi collegi godano di un prestigio paragonabile a quello dei gesuiti in altri tempi. Non credo dipenda dalla rigidità delle regole, che sono normalissime e semplicemente vengono fatte rispettare, o dall’esclusività delle rette, di gran lunga inferiori, ad esempio, a quelle statunitensi: la loro eccellenza è dettata da una impostazione educativa che non guarda solo alla trasmissione di contenuti o alla creazione di competenze, ma ritiene che l’una e l’altra cosa debbano avere un correlativo nei comportamenti. La prima finalità dell’educazione, per gli svizzeri, è appunto la “buona educazione”: perché la buona educazione è innanzitutto rispetto, di sé, degli altri e dell’ambiente che con gli altri si condivide, nel quale si convive e ci si rapporta. Tutto il resto viene di conseguenza. Se hai rispetto di te stesso cercherai di darti gli strumenti per capire, per sviluppare e difendere la tua autonomia di pensiero e per desiderare di vivere nella maniera meno conflittuale e più sana possibile. Quindi avrai rispetto per gli altri e per le loro opinioni, e collaborerai a far si che con essi ci si possa confrontare attraverso regole chiare e valide per tutti allo stesso modo, rispettandole per primo ed esigendo che tutti le rispettino.
Nulla di speciale, è l’obiettivo dichiarato da tutte le scuole pedagogiche. Con la differenza che in Svizzera questo obiettivo non è solo dichiarato, ma condiviso e considerato inderogabile dalla stragrande maggioranza della popolazione, e quindi almeno formalmente realizzato. Per accertarsene basta visitare una scuola svizzera, di qualsiasi livello, dall’asilo all’università, e controllare quante scritte ci sono sui muri esterni, nei bagni, nelle aule. O più semplicemente percorrere le strade e rendersi conto che le cunette ai bordi sembrano pettinate, e i marciapiedi non sono discariche a cielo aperto. Parranno dettagli poco significativi, ma sono invece indizi del fatto che il “libero e armonioso sviluppo della personalità individuale” è introiettato come capacità di convivere anziché come affermazione di sé. O meglio, che l’affermazione di sé si realizza nel rispetto degli altri, e non contro o malgrado o a dispetto degli altri.
Ora, gli esempi che ho portato sopra sono proprio tra quelli più abusati a carico dell’antipatia svizzera. Prendiamo la pulizia. Era un tratto distintivo del paese già ai tempi di Mary Shelley: “Oltrepassando la frontiera francese, si può osservare una sorprendente differenza tra le nazioni che risiedono sui due versanti. I cottage svizzeri sono molto più puliti ed ordinati e lo stesso dicasi per gli abitanti. Le donne indossano una gran quantità di candido lino ed il loro abbigliamento è sempre perfettamente lindo. Questa estrema pulizia è prodotta per lo più dalla differenza di religione: coloro che viaggiano in Germania notano lo stesso contrasto tra le città protestanti e quelle cattoliche, sebbene non ci sia tra queste e quelle che una distanza pari ad una manciata di leghe appena.” (Il riferimento alle motivazioni religiose è un po’ partigiano, ma non infondato). Mary stava arrivando dalla Francia, e sperimentava l’effetto di contagio provocato negli svizzeri francofoni dalla prossimità e dallo scambio con i connazionali dell’area tedesca. Magari altri, come Tolstoj, non erano del tutto d’accordo, ma abbiamo visto che, al pari di Hegel, giravano con occhiali dalle lenti affumicate. Infatti la sensazione della Shelley era condivisa e confermata pochi anni dopo, nel 1826, da Felix Mendelssohn-Bartholdy: “Una gentile donna francese gestisce la locanda lassù e non è facile descrivere la soddisfazione procurata dalla semplice pulizia che vi trovammo, cosa inesistente in Italia”
Ebbene, questa pulizia, questo ordine, diventano quasi dei capi d’accusa. «La preoccupazione di essere osservati dal mondo intero sembra costituire la logica fondamentale che presiede all’immagine iconografica con cui la cultura elvetica del quotidiano si presenta: una immagine per la quale la Svizzera si ritiene “il paese più pulito della terra”. Le ricerche di Geneviève Heller hanno illustrato l’evoluzione dell’“ideologia del pulito” (o se vogliamo, la “produzione del pulito” o meglio ancora, l’“ossessione del pulito”) che sembra nascere con il “turismo sanitario” a cavallo del nostro secolo e soprattutto con la Belle époque». Lo scrive Pietro Bellasi, leggendo in chiave psicoanalitica la passione degli svizzeri per il “piccolo e pulito”. E aggiunge: «Il processo di “enjolivement” ha finito per investire gli stessi villaggi contadini e il resto del paesaggio svizzero, noto ai turisti di tutto il mondo per quanto appare minuziosamente curato, puntigliosamente ordinato, pettinato, rileccato, tanto da sembrare finto, un paesaggio da “bambole”: insomma un paesaggio imbellettato per una grande occasione. E la grande occasione è la rivoluzione turistica, che spinge tra l’altro a nascondere ogni minima traccia di sporcizia: i rifiuti vengono occultati in un sacchetto di plastica e il sacchetto in un cassoncino e il cassoncino, come avviene in alcune stazioni turistiche, in una chalet in miniatura, di legno, il “materiale della nostalgia”».
Non c’è dubbio che gli svizzeri un’attenzione quasi maniacale per la pulizia, e ammettiamo anche per l’immagine di pulizia, la coltivino. Ma leggerla in questo modo mi sembra paradigmatico di come si riesca a stigmatizzare malignamente ogni manifestazione della loro particolare cultura, capovolgendo il tipo di approccio di Tolstoj per giungere agli stessi risultati. Il fatto che i rifiuti vengano occultati in un sacchetto di plastica e il sacchetto in un cassoncino e il cassoncino in una chalet in miniatura, per di più di legno, diventa quasi l’indice di una depravazione, nasconde chissà quali inconfessate perversioni. Penso che non siano necessari commenti. È sufficiente consigliare a Bellasi una gita a Roma, dove la sporcizia è bellamente esibita, e i cassonetti non ci sono nemmeno, né di legno né di altri materiali meno nobili. Per me, anche offrire un’immagine di pulizia, al di là poi del fatto che convenga e che se ne possa fare un punto di forza per l’attrattiva turistica, è un segno di rispetto. È malata piuttosto l’interpretazione opposta. Se entro in una casa dove tutti circolano con le pianelle, perché magari il pavimento è a parquet, mi adeguo senza tanti problemi e non la considero una bizzarria malata. Al più, se proprio la cosa mi infastidisce, non frequento quella casa. Ma mi sento molto meno rispettato se devo scavalcare mucchi di scarpe e sacchetti dell’immondizia, e se prima di accomodarmi devo controllare attentamente lo stato della sedia o del divano. Quanto al fatto poi che si tratti di una acquisizione recente, che nasce dal contatto con l’esterno e non ha un rapporto diretto con i “miti di fondazione”, con i modelli originari, oltre che dalla Shelley è smentito prima ancora da Goethe e da viaggiatori come Montaigne, che si meravigliavano di come a dispetto della povertà gli svizzeri riuscissero a vivere nella pulizia.
Guardiamo invece al risultato. Che il meccanismo sia stato quello della competizione interna al vicinato o all’intera confederazione, o quello dell’immagine patinata da offrire ai turisti, oppure ancora sia stato indotto dalla soggezione tipicamente protestante per la riprovazione collettiva, il risultato sono città e campagne piacevoli a vedersi e a viversi. E ormai questo meccanismo agisce a livello di inconscio, è entrato nel DNA elvetico. Certo, quell’ordine intimorisce, mette a disagio: ma solo chi non c’è abituato. Credo che il rifiuto che si manifesta in questo caso sia identificabile con la forma di risentimento di cui parla René Girard: “In quanto nostro modello, ammirato e amato, l’altro è anche il nostro maggior rivale, perché sarà sempre laddove vorremmo essere e non siamo.” E il desiderio di essere al suo posto prende la maschera dell’odio, e sono i nostri stessi desideri a far nascere la violenza.
Altri esempi clamorosi della malafede costante con la quale si guarda alle cose svizzere sono offerti da come si guarda alla democrazia praticata in quel paese e al tipo welfare adottato. A scadenze quasi regolare si legge sui nostri quotidiani (ma la notizia va cercata in sesta pagina) che un referendum cantonale o federale ha bocciato una proposta di legge innovativa, di apertura o comunque di cambiamento. In Svizzera i referendum sono nell’ordine della quasi quotidianità, e possono esserlo perché non mettono in moto tutto il baraccone che caratterizza le tornate elettorali italiane, sono gestiti da personale della pubblica amministrazione in regolare servizio, quindi costano nulla, e si svolgono tranquillamente in qualsiasi giorno lavorativo. I cittadini che intendono partecipare trovano il modo e il tempo per farlo. Non solo: nella maggior parte delle assemblee comunali dei paesi o delle cittadine minori, dove la cosa è tecnicamente possibile, tutti possono partecipare alle decisioni su problemi di interesse locale, e il voto è espresso per alzata di mano: e anche questo, l’esercitare un diritto facendosene carico come responsabilità personale, è indice di una coscienza civica senza la quale la democrazia non ha alcun significato. Ora, in un momento nel quale non si parla che di crisi della democrazia e dei modelli di rappresentanza, questo esempio di una prassi democratica vissuta quotidianamente dovrebbe essere considerato con un po’ più di attenzione, per trarne magari indicazioni terapeutiche. Invece ciò che rimbalza all’esterno sono soltanto i casi che si prestano a bollare il conservatorismo, la chiusura, l’isolazionismo egoista degli svizzeri. Travisando di norma la reale sostanza del problema e della risposta data dai cittadini elvetici.
Nel giugno del 2016, ad esempio, è stata respinta in un referendum su scala nazionale, con il 78% di voti contrari, la proposta di creazione di un reddito di base incondizionato. La proposta era magari un po’ esagerata, almeno se comparata ai nostri standard: si trattava di corrispondere ad ogni cittadino un reddito minimo mensile di 2.200 euro, ridotto di un terzo per i minorenni e ad un quarto circa per gli infanti. La cifra era comunque in linea con i livelli minimi degli stipendi svizzeri, e giustificata dal costo della vita. Così come è stata presentato sui nostri quotidiani (molto in sordina, comunque) l’esito di quella votazione non era che l’ennesima dimostrazione della refrattarietà elvetica ad ogni forma di welfare, a dispetto del fatto che quella espressa fosse la volontà di quattro quinti degli elettori, o peggio ancora, proprio per quel motivo. In realtà il risultato la dice lunga sul grado di consapevolezza che rende effettiva la democrazia svizzera: intanto i cittadini hanno votato conoscendo con precisione i dati dell’eventuale esborso. Quei dati erano forniti esattamente con le stesse cifre dai promotori e dai contrari, per cui è stato possibile agli elettori fare quattro conti – non nelle proprie tasche, ma nelle casse del paese – e realizzare che la cosa sarebbe stata insostenibile. Ma non è stato solo il problema economico a bloccare la proposta. Ad essere messa in discussione era la politica di welfare nel suo complesso e nelle sue finalità. È stata la consapevolezza, chiarissima, che la redistribuzione ha senso solo se c’è qualcosa da redistribuire: e che non era il caso di mettere in forse il sistema di salvaguardie sociali già esistente, che funziona benissimo.
E ancora: l’unica volta in cui ho sentito citare in positivo un’iniziativa svizzera di politica del lavoro è stato in occasione della proposta di un salario minimo garantito di 3.000 euro fatta propria dagli elettori dal Canton Ticino. Ecco finalmente un esempio da imitare, si diceva, ridimensionando magari un po’ la cifra. Non fosse che la proposta era stata avanzata unicamente per scoraggiare l’impiego dei lavoratori frontalieri, proprio quelli provenienti dall’Italia. A parità obbligata di trattamento, tanto vale impiegare uno svizzero. Ma da noi è diventata una bandiera di segno opposto. E temo, purtroppo, in buona fede: ovvero in perfetta ignoranza.
Quanto alla democrazia reale e allo spirito necessario per viverla e farla funzionare, ho ancora un paio di brevissimi esempi, scelti tra i tanti possibili.
Io credo che uno degli indici più attendibili del livello di democrazia di un paese stia nella notorietà dei suoi governanti. Ovvero, che le due cose siano inversamente proporzionali. Tutti (intendo tutti quelli che hanno un minimo di conoscenza storica, quindi una percentuale comunque risicata) conoscono i nomi di Francisco Franco o addirittura di Salazar, ma pochissimi ricordano quelli di qualche premier scandinavo, a meno che non sia morto tragicamente, e proprio nessuno quello di un qualche presidente della Confederazione svizzera. Neppure in quest’ultimo periodo, con leader sovranisti che spuntano come funghi, è consentito a qualche cialtronesco personaggio elvetico di salire alla ribalta. Penso che questo la dica lunga sul sistema di deterrenza che la Svizzera ha elaborato nei confronti delle derive demagogiche.
E infine, sarebbe forse bastata una considerazione che ci tocca da vicino, al posto di tutto questo spiegone, per rivalutare lo spirito elvetico. Il famigerato Ratzi, prototipo dell’italiano medio e perfetto suo rappresentante nelle più alte istituzioni della repubblica, a dispetto dei quarant’anni di permanenza sul territorio e di ripetute istanze non ha mai ottenuto la cittadinanza elvetica, mentre otteneva in compenso l’elezione a deputato prima e a senatore poi nel nostro paese, finendo addirittura nelle commissioni cultura ed economia, e assurgendo poi a una enorme popolarità con la complicità dei comici che dovrebbero fare satira. L’unico attestato che gli è giunto dalla Svizzera è un procedimento per appropriazione indebita (si è fregato i fondi raccolti in Abruzzo per l’alluvione di Lucerna del 2005). Forse gli svizzeri sono gli unici a conservare, oltre al senso civico, anche quello dell’umorismo.
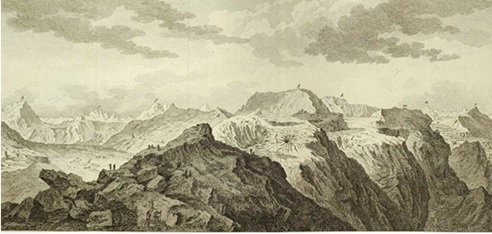
Sul risentimento antisvizzero
Qual è il posto dove le persone si sentono più felici? Nella classifica dei paesi con la più alta qualità di vita la Svizzera viene al secondo posto, subito dopo la Danimarca, mentre l’Italia è al trentaseiesimo, per capirci subito dopo la Polonia e subito prima della Bielorussia. (ne ho confrontate quattro o cinque, tra le più serie, quelle che tengono conto delle variabili più disparate, e il risultato è sempre quello).
Queste statistiche valgono per quel valgono: ma il fatto che concordino quasi perfettamente sulla percezione più o meno positiva della propria appartenenza nazionale qualcosa deve pur significare. Significa, quanto meno, che gli svizzeri ritengono di non doversi vergognare del loro paese e, volendo azzardare un po’ di più, che non provano invidia alcuna per gli abitanti degli altri. Ciò che non si può certo dire per i miei connazionali, perennemente impegnati a trovare un qualsiasi responsabile delle loro miserie e ad esibire la loro ignoranza e malafede.
Nel rovistare, oltre che nei libri (ho fatto una nuova scorpacciata di resoconti di viaggio, ed è stata davvero divertente, oltre che istruttiva), anche sulla rete, mi sono imbattuto, purtroppo solo recentemente, quando avevo in pratica già terminato di stendere queste considerazioni, in un blog che considero straordinariamente significativo. In esso erano riportati, in calce ad un articolo giornalistico che ironizzava simpaticamente sulla mania svizzera dell’ordine, i commenti dei lettori. L’avessi trovato prima mi sarei evitato un sacco di lavoro, perché credo di aver individuato due interventi che sintetizzano alla perfezione il modo in cui ci si pone e quello in cui ci si dovrebbe porre di fronte all’argomento. Li trascrivo integralmente, senza saltare una virgola, come ho già fatto in altra occasione per quelli sull’Islanda, in quanto ritengo valgano da soli, come indicatori del clima, più di tutte le sessanta pagine che li precedono.
- “La Svizzera, fino alla metà dell’Ottocento, era un Paese povero. I suoi abitanti (maschi) emigravano per arruolarsi come mercenari negli eserciti europei. Nel 1789, la famosa prigione parigina della Bastiglia, assalita dai rivoluzionari, era presidiata da mercenari svizzeri, giustiziati dagli assalitori. I montanari elvetici, quindi, fino a quel periodo (1850-70) si facevano notare soltanto per la loro attitudine alla fredda violenza a pagamento. Il Regno delle Due Sicilie, di gran lunga più ricco della Svizzera, li assoldava in gran numero, e loro accorrevano perché nel loro freddo altopiano vivevano da “morti di fame”. Essi si distinsero nella repressione dei moti a Messina, dove si divertirono ad assassinare cittadini inermi ed a saccheggiare le abitazioni. Se visitate il Museo di Zurigo (vicino la Hauptbahnhof) vedrete su un plastico schiere di soldati svizzeri che “combattono” a Messina. Quindi gli Elvetici “ricordano con orgoglio” le vergognose gesta dei loro predecessori mercenari, assassini a pagamento. Con la rivoluzione industriale, alla quale gli Svizzeri “parteciparono” in ritardo rispetto ad Inglesi e francesi, la situazione economica della Confederazione iniziò a migliorare. Gli Svizzeri si specializzarono nell’attività bancaria. Da allora sono diventati la cassaforte del Mondo. Fino agli anni 90 (del sec. scorso) la UBS era la banca più ricca del pianeta. E tutti conosciamo la provenienza di questi ingenti depositi: dittatori sanguinari, capi politici comunisti, mafia, criminali di tutto il mondo. Con questa montagna di soldi, peraltro prestati ovviamente ai cittadini elvetici con tassi minimi, La Confederazione è diventata ricchissima. Quindi un popolo come gli altri, anzi più furbo degli altri, che accoglie sollecitamente i soldi dei delinquenti del pianeta, che riserva piste esclusive (aeroporti di Zurigo e Ginevra) agli aerei privati degli sceicchi sauditi […] ma che espelle immediatamente gli stranieri poveri. Non dimentichiamo, poi, il loro cinismo nei confronti degli Ebrei, durante il periodo nazista. I loro ingenti risparmi li accettavano subito, i proprietari dei risparmi.. no! I Napoletani hanno la nomea di imbroglioni (soprattutto dopo l’arrivo degli “onesti” padani di Vittorio Emanuele II e la distruzione dell’economia meridionale operata dagli sgherri padani). Ma gli Svizzeri potrebbero essere i loro maestri, anzi potrebbero fare dei Corsi di aggiornamento a tutti i disonesti del Mondo su come imbrogliare il Prossimo. Ultimamente i leghisti svizzeri hanno iniziato una campagna diffamatoria contro i lavoratori nord italiani stagionali, definendoli “ratti”. I non abbienti, per i cretini leghisti di ogni latitudine, vanno considerati come parassiti. Quanto alla mitica pulizia elvetica … avete mai visto dei ricchi vivere in condominii fatiscenti? (Giovanni S)
- Carissimo Giovanni S. ho un’altra visione della storia svizzera ed italiana. Fatti storici indicano che gli svizzeri non si sono alleati ai tedeschi durante la Seconda guerra mondiale e non hanno neanche mandato nei campi di concentramento i loro cittadini di confessione ebraica. La svizzera per quel che si dica ha “accolto” più ebrei di quelli giunti negli USA. Non voglio neanche iniziare un discorso delle persecuzioni cristiane (con sede a Roma) verso la comunità ebraica. Voglio anche ricordare che la Svizzera non ha mai colonizzato nessun paese “straniero”: noi non possiamo malauguratamente dire altrettanto. Voglio ricordare che se i mercenari svizzeri erano a Messina, Parigi, etc è perché qualcuno li aveva chiamati e non sono certo che la persona che li ha fatti venire, sicuramente gente locale, abbia fatto la stessa fine di questi ultimi, magari non hanno neanche ricevuto un’indennità…. L’attività bancaria, per quel che si dica, conta al ~14% del PIL svizzero: dunque associare la ricchezza della CH solo all’attività bancaria a mio avviso è riduttivo. (NB. Il segreto bancario all’origine è stato introdotto per la protezione della sfera privata dei cittadini o delle persone oppresse). Non oso neanche ricordarle che durante le nostre migrazioni abbiamo esportato certe “società a scopo di lucro o meglio criminali” che non sono proprio la fierezza della nazione. La svizzera è ricca non per i soldi nelle banche ma perché spende meglio i suoi soldi per il funzionamento efficace dello stato e del finanziamento delle infrastrutture. Il sistema non è soggetto alla corruzione ed al mal costume come è il caso dell’Italia. La svizzera è ricca grazie a un tessuto industriale di prodotti di nicchia ad alto valore aggiunto, non di prodotti di massa a basso valore e facilmente de-localizzabile… La svizzera è ricca perché riesce a combinare in una piccola “piattaforma” globale: delle competenze personali (knowhow+lingue), possibilità di finanziamenti e di assicurazioni (banche+assicurazioni), delle ditte di certificazione degli scambi (certificatori) e delle ditte trasportatrici delle merci. Voglio anche ricordare che se una persona ha abbastanza soldi per pagare un diritto d’atterraggio prioritario non vedo niente di strano: questa è l’offerta e la domanda. In svizzera però il figlio dell’amico Geddafi lo hanno messo in prigione, quando in Italia (o in Francia) gli facevamo piantare la tenda nel giardino o gli baciavamo le mani per partecipare al bunga bunga nella tenda. In svizzera come nei paesi del nord la corruzione o il senso dello stato sono molto diversi dall’Italia e le posso assicurare che chi sgarra paga (vedo ancora il ministro tedesco che lascia il posto di ministro perché non ha segnalato (o copiato) certe parti della sua tesi di laurea). Da questo lato avremo molto ma molto da imparare. Finché daremo la colpa al segreto bancario svizzero dei mali dell’Italia, non risolveremo un bel cavolo. L’Italia va male perché una classe politica non ha fatto gli interessi e le scelte strategiche giuste ma ha guardato ai suoi interessi o agli interessi dei pochi amici… Troppo facile dare la colpa al vicino…. Guardiamo prima di fare i nostri bravi compitini (leggi e pene per corruzione evasione falso in bilancio, non prescrizione dei reati, etc, etc etc, e poi potremo andare a fare gli affari degli altri. Il fenomeno delle destre estreme è comune a tutti i paesi Europei, mi hanno riferito che il leghismo in svizzera è nato dall’impulso del padre lombardo; dovremo essere fieri di aver esportato qualche cosa in svizzera. Prima di criticare gli altri facciamo una bella autocritica a 360° […] (Edo)
Perfetto! Temo che Giovanni S. sia la stessa persona che sparava giudizi insensati sull’Islanda, senza naturalmente saperla identificare su una carta geografica. Se non è lui, è un parente stretto. Una perfetta imitazione del personaggio meglio riuscito a Crozza, nutrito a livore, ignoranza e pregiudizi, e in più esponente di quel neo-meridionalismo nostalgico che non cita mai Cuoco o Giustino Fortunato, e men che mai Vico, perché nemmeno sospetta siano esistiti, ma tira in ballo il buongoverno borbonico (dovrebbe andarlo a spiegare a Montesquieu o a Gladstone). Bogart direbbe: è il blog, bellezza.
Non c’è altro da aggiungere … se non un particolare che mi sento in dovere di rivelare. Ho scritto questa riflessione quasi apologetica non in preda ad un amore sviscerato per la Svizzera, a idealizzazioni o frequentazioni adolescenziali (infantili magari si: i calendari anni trenta di mia zia Lina), ma per quella che considero semplice onestà intellettuale. Non sopporto le demonizzazioni ideologiche, e proprio a una cosa di questo tipo sto assistendo nei confronti della Svizzera: un po’ quello che accade per Israele e per gli ebrei in genere.
La verità è che la Svizzera da vicino non la conosco. L’ho attraversata velocemente due o tre volte, ammaliato sempre dal panorama, ma senza mai fermarmi se non quel tanto sufficiente a farmi constatare quanto fosse vera questa cosa dell’ordine e della pulizia. Per parlarne con un minimo di cognizione almeno storica mi sono documentato e mi sono affidato ai diari e alle impressioni dei viaggiatori più famosi che l’avevano visitata nei secoli scorsi. Per l’impressione di fondo, però, sono rimasto al racconto di un caro amico che ha uno sguardo sul mondo decisamente sintonizzato col mio. Confesso anche che ho intenzionalmente scritto questa cosa, che mi girava in mente da un sacco di tempo, prima di visitare il paese come si deve. Esattamente il contrario di ciò che avevo fatto per l’Islanda. In genere nei luoghi che si visitano si portano, e quindi si ritrovano, tutti i problemi, i fastidi, i preconcetti nostri. Provate a leggere i diari di Tolstoj, di Dostoevskij, di Hegel o Mark Twain, e vi renderete conto di quanto condizionati siano i loro sguardi dalle contingenze esistenziali. Ho ritenuto fosse preferibile, per questo lavoro, un approccio neutro, “di testa”, più distaccato. Le conferme, se varrà la pena, verranno dopo.
Perché, dimenticavo, la prossima estate sarò anch’io in Svizzera, ospite tra l’altro in una vecchia magione, come Corto. Quanto alle pratiche per l’accoglienza ci devo pensare, dipenderà dall’esito delle elezioni europee.
Comunque, a me va bene anche se mi internano.

Bibliografia
Pietro Bellasi, Gulliver e noi, in Prometeo, I, 2 (maggio-luglio 1983)
Bill Bryson, Una città o l’altra.Viaggi in Europa, Guanda 2002
René de Chateaubriand, Memorie d’oltretomba, Longanesi 1973
Charles Dickens, Impressioni italiane, Robin 2005
Fëdor Dostoevskij, Diario di uno scrittore, Bompiani 2007
Alexandre Dumas, Impressioni di viaggio, Rizzoli 1963
Johann Gottfried Ebel, Anleitung, auf die nützlichste und genussvollste Art die Schweitz zu bereisen. Ulan Press 2012
Ugo Foscolo, Prose politiche e apologetiche, in Opere, 1964, vol. XIII,
René Girard, Il risentimento, Raffaello Cortina 1999
Albrecht von Haller, Le Alpi. Taratà 1999
Friedrich Hegel, Diario di viaggio sulle alpi bernesi, IBIS 2000
Ambrogio Levati, Il costume moderno e antico degli Elvezj, in: Giulio Ferrario, Il costume antico e moderno, Batelli, Firenze 1835, vol. 9 parte prima
Erich Mühsam, Ascona. Monte verità. Schegge, Chersilibri 2008
Friedrich Nietszche, Epistolario, Adelphi 1995
Hugo Pratt, Corto Maltese. Le Elvetiche, Rizzoli-Lizard 2000
John Ruskin, Praeterita, Novecento, 2002
Friedrich Schiller, Guglielmo Tell, Einaudi 2002
Étienne P. de Senancour, Oberman Rizzoli 1963
Mary Shelley, Storia di un viaggio di sei settimane, Aletheia 2000
Johanna Spyri, Heidi, Piemme 2012
Madame de Staël, De l’Allemagne, Flammarion 1980
Stendhal, Piccola guida per un viaggio in Italia, La Vita Felice 1998
Robert Louis Stevenson, Appunti di viaggio in Francia e Svizzera, Muzzio 1998
Victor Hugo Viaggi in Svizzera, Dadò 2002
Lev Tolstoj, I diari 1847-1910, Longanesi, 1980
Mark Twain, A Tramp Abroad, Penguin Books 1998
Alessandro Volta, Viaggi in Svizzera, IBIS

[1] Pratt ha qui in mente con ogni probabilità i diari di Carl Gustav Jung. Anche lui, nella Torre di Bollingen, sul lago di Zurigo, ode voci e sente strane presenze, creando un miscuglio di reale e irreale.
[2] Rodolphe Töpffer era un pittore, illustratore e insegnante, che scrisse e disegnò una serie di brevi storie illustrate peri suoi allievi. Le pubblicò poi su pressione degli amici, tra i quali Goethe, La prima, di queste storie Histoire de monsieur Jabot, apparve nel 1833, Ne seguirono altre sette, Töpffer è considerato oggi come il primo fumettista, ma su questo ci sarebbe da discutere: non lo è se il fumetto, anziché uno strumento e un supporto, viene considerato una espressione letteraria e artistica a sé stante).
[3] Joseph Addison fece tra il 1701 e il 1702 un viaggio sul Continente, fermandosi a lungo in Svizzera: soggiornò diversi mesi a Ginevra e visitò Losanna, Friburgo, Berna, Soletta, Zurigo e San Gallo, Raccolse le sue impressioni, completate da quelle di viaggi successivi, nel Remarks on several Parts of Italy, etc. In the Years 1701, 1702, 1703, 1705.
[4] Già l’anno precedente aveva pubblicato in francese un Récit du premier voyage dans les Alpes, ma Die Alpen è il primo poema interamente dedicato alla catena alpina. La sua fortuna è soprattutto legata alla traduzione francese del 1750, mentre per leggere quella italiana si dovrà attendere il 1768.
[5] Eccone un esempio: Calva montagna i precipizi suo i/ Veste d’eterno ghiaccio, che rimanda / Del sole i raggi di cristallo al pari, / E contro cui s’adopra in van l’ardente / Calor di Sirio. Un altro fertil monte / Di pascoli abbondanti si ricopre, / E l’insensibil suo dolce pendio / Pomposa mostra fa di varie biade, / Che maturando vanno; ed i suoi colli / Di cento mandre veggonsi coperti: / E questi climi infra di lor sì opposti / Son sol divisi da una stretta valle / Da freschissimo ognor rezzo abitata.
[6] Nel corso del XVIII sec. furono soprattutto gli interessi naturalistici destati dall’Illuminismo e la concezione della natura introdotta dal Romanticismo a rendere più frequenti i viaggi in montagna: Johann Jakob Scheuchzer raccontò in Itinera per Helvetiae alpinas regiones (1723) quelli da lui compiuti nelle Alpi svizzere dal 1702 al 1711. Tuttavia la più antica cronaca odeporica consacrata alle Alpi orientali è la Schesaplana Bergreis redatta da Nicolin Sererhard (1730 ca.). Nel 1779 Laurent Joseph Murith, priore del Gran San Bernardo e botanico, scalò per primo il monte Velan; anche il monaco geografo, botanico e geologo Placidus Spescha percorse le montagne e fu il primo a salire sull’Adula (1789). Nella prima metà del XIX sec. furono soprattutto gli interessi per la glaciologia a richiamare sulle grandi montagne bernesi e vallesane studiosi come Louis Agassiz, Edouard Desor e Franz Joseph Hugi; per interessi legati alla cartografia vennero scalati la Jungfrau (1811) e il Pizzo Bernina (1850). Nel 1806 Karl Ulysses von Salis pubblicò il primo annuario alpino intitolato Alpina, eine Schrift, der genaueren Kenntnis der Alpen gewidmet.
[7] I primi centri di alpinismo in Svizzera furono Grindelwald e Zermatt. Durante le escursioni gli inglesi avevano l’abitudine di farsi accompagnare da guide locali (in particolare da Christian Almer, Franz Andenmatten, Melchior Anderegg, Franz Biner, Peter Knubel, Ulrich Lauener, Peter Taugwalder, Matthäus Zum Taugwald): in questo modo, sull’esempio francese di Chamonix, sorsero le prime associazioni di guide a Grindelwald (1857) e a Zermatt (1858).
[8] Goethe tornò in Svizzera a più riprese. Nel 1775 si recò da Sciaffusa al lago dei Quattro cantoni, e in seguito al passo del Gottardo. A Zurigo soggiornò presso Johann Kaspar Lavater, cultore della fisiognomica. Nel secondo viaggio, che fece nel 1779 in compagnia del duca di Weimar, si recò nell’Oberland bernese, a Losanna e Ginevra; anche in questa occasione concluse la trasferta con un prolungato soggiorno presso Lavater. Nel 1796 diede alle stampe la raccolta di lettere scritte durante questo viaggio (Briefe auf einer Reise nach dem Gotthard). Il terzo itinerario, compiuto nel 1797, lo condusse di nuovo nelle regioni della Svizzera centrale e sul Gottardo, dove coltivò soprattutto il suo interesse per la mineralogia. Trascorse inoltre un periodo piuttosto lungo a Stäfa presso il pittore Johann Heinrich Meyer. Il racconto di questo terzo viaggio fu pubblicato postumo nel 1832 (Schweizerreise vom Jahr 1797).
[9] Nel 1777 compie il primo dei viaggi a scopi scientifici in Svizzera, Alsazia e Savoia. Porta con sé strumenti fisici per il rilievo delle altitudini, delle pressioni barometriche e della salubrità dell’aria e calamite per la ricerca di minerali di ferro Tra il 1781 e il 1782 viaggia nuovamente in Europa attraverso Savoia, Svizzera, Germania, Belgio, Olanda, Francia e Inghilterra.
[10] “Mentre gli altri, circondati da’ battaglioni di Ungheri, proferivano il giuramento, mi veniva fatto di toccare i confini degli Svizzeri”. Foscolo dimora in Svizzera dal 1814 al 1816, sempre in clandestinità.
[11] George Byron affitta una villa sul lago di Ginevra e lì compone Childe Harold, Il Prigioniero di Chillon, Il sogno, i primi due atti del Manfred. Del paese apprezza soprattutto le bellezze femminili, ma non manca di coglierne (o di creare) misteriose e inquietanti suggestioni: “Il diavolo deve avere certamente messo la mano (o lo zoccolo) tra certe rupi e certi burroni”. E di trasmetterle a chi gli sta accanto. Non a caso John Polidori, figlio dell’ex segretario di Alfieri, proprio sotto l’influenza di Byron scrive qui a vent’anni Il Vampiro, mentre Mary Shelley inizia a redigere durante il suo soggiorno svizzero assieme al marito, Percy Bysshe Shelley, il suo Frankenstein. Un’altra giovane viaggiatrice, Lavinia Spencer, forse scossa dalla traversata verso l’Italia (1819), non ne è affatto entusiasta: “Mi allieta la certezza che non passerò mai più il Sempione”, mentre Stendhal annota: “Niente di più pittoresco della valle di Iselle: la si attraversa per giungere al ponte di Crevola, dove incomincia il Bel Paese”.
Più tardi Dickens (nel 1844) riesuma la fascinazione dell’orrido: “A poco a poco il frastuono delle acque divenne più forte e la stupenda strada penetrò tra due muri massicci di rocce perpendicolari che ci tolsero completamente la luce della luna e ci lasciarono solo la vista di alcune stelle. Poi perdemmo anche queste nella profonda oscurità di una caverna. Uscendo dall’altra parte, di nuovo in un tratto rischiarato dalla luna, attraverso un ponte altissimo la strada proseguì tortuosa lungo la gola di Gondo, orrida e grandiosa oltre ogni dire”.
[12] Mary Shelley, Storia di un viaggio di sei settimane (1817)
[13] 13. Nel luglio 1832 Dumas, convalescente dal colera, parte per la Svizzera. Al ritorno pubblica sulla “Revue des deux mondes” le sue “Impressioni di viaggio”. Il libro contiene la famosa intervista di Dumas al vecchio Balmat, primo salitore del Monte Bianco, che alimentò l’ingiusta leggenda sull’eroica guida a danno del dottor Paccard.
[14] 14I ghiacciai non hanno per lui niente di particolarmente affascinante, grandioso e piacevole, se si toglie la semplice idea di esservi fisicamente tanto vicino da toccarli: “Si può solo dire che è un nuovo tipo di veduta, che però non offre assolutamente nessun’alta occupazione allo spirito se non la constatazione di trovarsi nel pieno della calura estiva a così breve distanza da masse di ghiaccio che un caldo simile non riesce a fondere […]”.
[15] Fino alla fine del medioevo i viaggiatori, ma anche gli stessi abitanti delle vallate alpine, evitavano le vette, avvolte da saghe e leggende e ritenute sedi di demoni. Ancora nel 1387 le autorità di Lucerna avevano fatto arrestare il monaco Niklaus Bruder e cinque suoi compagni che avevano cercato di scalare il mitico Pilatus. Il tabù era stato infranto da Joachim Vadiano, un umanista e riformatore sangallese che era salito nel 1518, e già nel 1541 Konrad Gessner nel De admiratione Montium scriveva: “Sono fermamente deciso a salire ogni anno su alcune montagne o almeno su una […], sia per studiare la flora montana sia per procurare al corpo un nobile esercizio e alla mente una gioia”.
[16] John Ruskin, Praeterita, Ruskin tornò in Svizzera almeno trenta volte.
[17] Victor Hugo, In viaggio – Le Alpi – 17 settembre 1839
[18] Citato in: Il costume antico e moderno di tutti popoli di Giulio Ferrario, edito in Firenze, da Vinvcenzo Batelli nel 1828, volume 9, parte prima.
[19] Anche Flaubert è molto sensibile a questo aspetto: “Colazione. Robusta montanara, fresca, rosa, carnosa, un po’ tedesca col suo piccolo cappello rotondo dal nastro pieghettato, capelli annodati dietro”.
[20] Oltre, naturalmente, alle emozioni suscitate dal paesaggio. Nel VI libro del Preludio ne dà un racconto in versi emozionati, ma non fantasiosi:
Entrammo in una stretta spaccatura,
Rivoli d’acqua e sentiero ci accompagnavano nella buia trincea,
Con loro camminammo piano piano diverse ore.
L’incalcolabile altezza degli alberi sospesi mai tagliati,
Il continuo precipitare delle cascate,
E nei passaggi esposti a ogni curva
Venti e controventi confusi e perduti.
Torrenti che eruttano contro il cielo azzurro,
Rocce che mormorano accanto alle nostre orecchie,
Pietre nere precipitano nel vuoto fischiando come se avessero voce,
La vista paurosa e la folle violenza della corrente del fiume,
Le nubi indifferenti nella regione dei cieli.
Due decenni dopo, nel 1820, il suo interesse è passato dalla natura alla storia. Dopo aver attraversato Briga annota: “Un’immensa colonna di granito giace sull’orlo della strada, come se il suo viaggio fosse stato interrotto dalla notizia della disfatta di Napoleone. Egli la destinava a un suo arco di trionfo a Milano: io desidero che rimanga così prostrata sulla montagna per i secoli venturi. Il suo più acerbo nemico non potrebbe escogitare un segno così impressionante di vanità e ambizione deluse”.
[21] Altrove la parte più negativa del giudizio è rincarata: “I nostri compagni di viaggio erano di infima estrazione sociale, fumavano smodatamente ed erano disgustosi oltre ogni dire. Ritornando alla barca dopo esserne scesi per ristorarci nel mezzo della giornata, scoprimmo che i nostri posti erano stati occupati; ne prendemmo altri, ma i precedenti occupanti si misero ad insistere affinché li lasciassimo, in modo rabbioso e quasi violento. La loro brutale maleducazione verso di noi, che neanche capivamo la loro lingua, costrinse S*** a colpire con un pugno quello più aggressivo: questi non restituì il colpo, ma continuò con le sue grida fino a che non intervennero gli addetti del battello, assegnandoci altri posti”.
[22] Inchiesta della Commissione indipendente di esperti “Svizzera – Seconda guerra mondiale (CIE)” diretta da Jean-François Bergier. Al di là delle aspre critiche e delle polemiche scatenatesi in seguito alla pubblicazione del suo rapporto finale nel 2002, la “Commissione Bergier” ha avuto il merito di far luce sui molteplici aspetti delle misure d’accoglienza e internamento nel corso dell’ultimo conflitto.
[23] Un miliardo e 250 milioni di dollari è quanto 20 anni fa le banche svizzere accettarono di pagare per chiudere la vicenda dei fondi ebraici in giacenza dalla fine della Seconda guerra mondiale.
[24] Ho fatto qualche ricerca, e non mi risulta che altri stati, tranne la Germania, abbiano risarcito chicchessia per le ruberie, gli espropri, i danni materiali e morali provocati ad altri popoli.
[25] Gottfried Keller (1819-1890) ha scritto con Enrico il verde una delle migliori autobiografie poetiche della letteratura europea. Da noi è naturalmente pressoché sconosciuto.
[26] Jeremias Gotthelf, Novelle, Utet, 1955. Il druido, Il Ragno, I tre fratelli sono dei piccoli capolavori della narrativa breve.
[27] Conrad F. Meyer, Giorgio Jenatsch: Una storia dei Grigioni (1895). È la storia romanzata di un mercenario, abile quanto privo di scrupoli, che opera per il partito protestante durante le guerre di religione e che viene ucciso alla fine da un sicario travestito da orso. Meyer ne fa un eroe, in linea con la costruzione di un passato mitico per la Svizzera.
[28] Ha descritto in Canto (1963) la vita piatta e regolata di Berna messa a confronto con quella di Roma, dove ha soggiornato prima di trasferirsi a Parigi. In Diskurs in der Enge (1970; Elucubrazioni sulla ristrettezza) Nizon, che è anche storico dell’arte, denuncia il difficile rapporto tra la Svizzera e i suoi artisti, spesso costretti a lasciare il Paese, troppo “angusto” e loro ostile.
[29] La Confederazione proibì alle potenze straniere l’arruolamento degli Svizzeri nei propri contingenti militari nel 1874. Gli abitanti dei cantoni continuarono però a partire volontari negli eserciti delle potenze europee sino a che non venne loro vietato, nel 1927.



