di Paolo Repetto e Vittorio Righini, 2 novembre 2023
Pubblichiamo un recente scambio epistolare tra due Viandanti. Non stiamo scivolando in una deriva autoreferenziale. È che spesso da questi scambi nascono delle idee, che vengono poi tradotte in pezzi da postare sul sito: ma questa volta si è preferito puntare direttamente sugli originali, perché si prestavano bene a mostrare come per venire alla luce le idee compiano talvolta strani giri. Non solo: più banalmente, ci sembra testimonino che pure attraverso la comunicazione digitale è possibile un confronto costruttivo. Con buona pace di Mc Luhan, non è sempre il mezzo a fare il messaggio. Qualche volta, se ai due capi del filo c’è gente che pensa con la propria testa, il mezzo rimane ciò che deve essere, uno strumento al servizio della conoscenza.

Niente scuse
di Vittorio, 27 ottobre
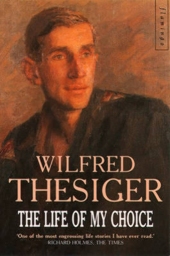 Ciao Paolo, ti scrivo anzitutto per ringraziarti di avermi procurato il bellissimo documentario su Vincent Munier e sulla sua caccia alle immagini del “Leopardo delle Nevi” (così si chiama, ma i francesi, vai a sapere perché, lo chiamano la Panthère des Neiges. Qui ci vorrebbe un consulto con un etologo di lingua francese, che sappia di cosa parliamo e che ci spieghi perché quello che noi – e Peter Matthiessen – chiamiamo leopardo, per loro è panthère). Grazie inoltre per avermi restituito l’autobiografia di Thesiger, che mi è sembrata si interessante come si dice, ma anche complessa come la vita che lui ha vissuto. Io, comunissimo mortale, ne ho letto solo una parte: le straordinarie esperienze raccontate ne La vita a modo mio mi hanno lasciato basito, ma anche intimorito dall’infi nità di luoghi e di persone a noi perfettamente sconosciuti, mai sentiti prima. Non che non sia abituato a leggere storie in paesi fuori dall’ordinario, anzi, sono la mia passione, ma Thesiger, che già mi aveva deliziato con Sabbie Arabe (Arab Sands) e con il meraviglioso Quando gli arabi vivevano sull’acqua (The Marsh Arab), in questa sua biografia mi fa smarrire in un universo troppo ignoto, soprattutto per la parte che si svolge in Eritrea, Abissinia, Dancalia, etc. E poi, diciamolo, è grande anche nei suoi difetti, primo fra tutti la caccia grossa. Certo, erano altri tempi, ma leggere di stragi di animali oggi rari o quasi estinti mi lascia sbigottito, benché io non abbia mai fatto nulla per proteggerli, se non dedicare loro un amorevole pensiero, e coltivi un’innata repulsione verso le armi. Insomma, mi si perdoni ma non riesco a leggere questa biografia mettendomi nei panni dell’autore.
Ciao Paolo, ti scrivo anzitutto per ringraziarti di avermi procurato il bellissimo documentario su Vincent Munier e sulla sua caccia alle immagini del “Leopardo delle Nevi” (così si chiama, ma i francesi, vai a sapere perché, lo chiamano la Panthère des Neiges. Qui ci vorrebbe un consulto con un etologo di lingua francese, che sappia di cosa parliamo e che ci spieghi perché quello che noi – e Peter Matthiessen – chiamiamo leopardo, per loro è panthère). Grazie inoltre per avermi restituito l’autobiografia di Thesiger, che mi è sembrata si interessante come si dice, ma anche complessa come la vita che lui ha vissuto. Io, comunissimo mortale, ne ho letto solo una parte: le straordinarie esperienze raccontate ne La vita a modo mio mi hanno lasciato basito, ma anche intimorito dall’infi nità di luoghi e di persone a noi perfettamente sconosciuti, mai sentiti prima. Non che non sia abituato a leggere storie in paesi fuori dall’ordinario, anzi, sono la mia passione, ma Thesiger, che già mi aveva deliziato con Sabbie Arabe (Arab Sands) e con il meraviglioso Quando gli arabi vivevano sull’acqua (The Marsh Arab), in questa sua biografia mi fa smarrire in un universo troppo ignoto, soprattutto per la parte che si svolge in Eritrea, Abissinia, Dancalia, etc. E poi, diciamolo, è grande anche nei suoi difetti, primo fra tutti la caccia grossa. Certo, erano altri tempi, ma leggere di stragi di animali oggi rari o quasi estinti mi lascia sbigottito, benché io non abbia mai fatto nulla per proteggerli, se non dedicare loro un amorevole pensiero, e coltivi un’innata repulsione verso le armi. Insomma, mi si perdoni ma non riesco a leggere questa biografia mettendomi nei panni dell’autore.
Vengo però al dunque, al motivo principale per cui ti scrivo. Come ricorderai, all’inizio del nostro ultimo viaggio in Grecia, già in volo tu leggevi un testo piuttosto pesante, che hai presto giustamente abbandonato (le scelte errate del paio di libri da portarsi in vacanza ci puniscono severamente). Hai poi recuperato con il libro di riserva, quel Nero. Storia di un colore, di Michel Pastoureau, che ti ha accompagnato per qualche giorno. Un gran bel libro, immagino, che non ho letto ma che riesco ad immaginare, perché ho apprezzato l’originalità e l’enorme cultura dell’autore in un’altra opera, nella quale sui colori fa una panoramica completa.
Poi hai finito di leggere anche Pastoureau, e siccome il nostro era un finto viaggio culturale, in realtà una settimana di scazzo totale per riposare la mente e il corpo, sei rimasto senza carburante. Allora io, che avevo provveduto a portarmi il succitato Thesiger e, per rilassarmi, una trilogia di romanzi gialli di un autore che non conoscevo, ho lasciato questi ultimi in sospeso e te li ho passati, attaccandomi invece a Thesiger: ciò che mi ha permesso di arrivare quasi a fine settimana nel nostro viaggio alla ricerca delle fonti della Macedonia (forse, più che delle fonti, delle essenze; oggi dove mangiamo? che cosa mangiamo? cosa beviamo? queste erano le imprescindibili domande che ci ponevamo subito dopo l’ampia colazione). Tra l’Olimpo (un panettone in lontananza) e il Monte Athos (questa invece una vera montagna, una sorta di piramide visibile da gran parte della penisola Calcidica), le montagne del Pindo e i laghi di Prespa, abbiamo avuto la fortuna di fermarci su spiagge poco frequentate (metà settembre, nord della Grecia, da stare molto, molto tranquilli).
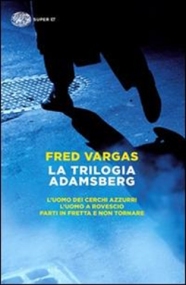 Poi, curioso di leggere questo nuovo autore di romanzi gialli, che tu avevi già divorato, mi sono approcciato alla Trilogia di Adamsberg (la prima trilogia), 8 o 900 pagine, non ricordo, tre storie, di un tale Fred Vargas. Ho letto questi tre romanzi. Mi sono piaciuti? non mi sono piaciuti? non ho una risposta sicura, e anche tu che li avevi già divorati non mi hai dato una risposta convinta. Certo però mi hanno incuriosito, e tornato in patria ho trovato (anche questo usato) la seconda Trilogia di Adamsberg. Comprata al volo, mille pagine. Il primo racconto mi ha entusiasmato, lo ammetto, uno dei più bei polizieschi o noir o come cavolo si definiscono questi racconti, quasi 400 pagine, titolo Sotto i venti di Nettuno.
Poi, curioso di leggere questo nuovo autore di romanzi gialli, che tu avevi già divorato, mi sono approcciato alla Trilogia di Adamsberg (la prima trilogia), 8 o 900 pagine, non ricordo, tre storie, di un tale Fred Vargas. Ho letto questi tre romanzi. Mi sono piaciuti? non mi sono piaciuti? non ho una risposta sicura, e anche tu che li avevi già divorati non mi hai dato una risposta convinta. Certo però mi hanno incuriosito, e tornato in patria ho trovato (anche questo usato) la seconda Trilogia di Adamsberg. Comprata al volo, mille pagine. Il primo racconto mi ha entusiasmato, lo ammetto, uno dei più bei polizieschi o noir o come cavolo si definiscono questi racconti, quasi 400 pagine, titolo Sotto i venti di Nettuno.
Bene, mi sono detto, ho aperto una nuova strada di lettura: ora vediamo chi è questo Fred Vargas. Ho scoperto anzitutto che Fred Vargas è una donna, e questo è meglio: a me piacciono tanto la Alicia Gimenez-Bartlett e i suoi polizieschi catalani, ben venga dunque una autrice che posiziona il commissario Adamsberg a Parigi. Lei si chiama in realtà Frederique Audoin-Rouzeau, e Wikipedia mi dice che è ricercatrice di archeozoologia presso il CNRS francese ed esperta in medievistica. Una mente illuminata, che usa uno pseudonimo per firmare i suoi libri (con un cognome improponibile, meglio uno pseudonimo banale). Leggo la sua biografia e mi annoto i vari romanzi polizieschi, poi, poi… leggo che è anche autrice di un pamphlet intitolato La veritè sur Cesare Battisti, 2004. In questo testo, la figura di Battisti è portata ad esempio di intellettuale intelligente, non corrotto e assolutamente estraneo ai fatti che la giustizia italiana gli imputa. Secondo la Vargas Battisti è vittima di un governo alla Pinochet e di forze di Polizia corrotte che cercano un capro espiatorio, mandando in galera migliaia di innocenti. In quel periodo al governo c’era Berlusconi, certo non il politico a me più simpatico, ma l’accostamento a Pinochet mi pare inopportuno. Allora approfondisco, e vedo che la Vargas, insieme a molti altri intellettuali della gauche, ha anche firmato una petizione nella quale si chiede giustizia per il mirabile Battisti.
Ora, nel 2019 Battisti, in carcere in Italia, dopo l’estradizione concessa dall’ex presidente del Brasile Bolsonaro, la fuga in Bolivia e il successivo arresto, ammette il suo coinvolgimento nei quattro omicidi e nei tre ferimenti commessi durante gli anni di militanza nel PAC (Proletari Armati per il Comunismo), due compiuti personalmente e due in condivisione.
A questo punto l’Ansa a Parigi va a cercare la Audoin-Rouzeau (Fred Vargas) per chiederle cosa ne pensa, e lei risponde: l’ammissione di colpevolezza di Cesare Battisti per l’omicidio di quattro persone durante gli anni di piombo “non cambia nulla alle mie conclusioni di ricercatrice, lo ritengo ancora innocente”: “Non ho da presentare nessuna scusa – aggiunge – non ritengo di aver difeso un assassino, è l’ultima cosa che avrei fatto. Purtroppo è triste, perché mi prenderanno tutti per un’imbecille. ma è così”. Alla domanda se fosse stata messa al corrente che Battisti, oltre a riconoscere i quattro omicidi durante gli Anni di Piombo, avrebbe dichiarato, dinanzi ai magistrati, di aver mentito ai suoi sostenitori, compresi quelli francesi, Vargas ha risposto: “Le sue dichiarazioni non mi feriscono, mi lasciano indifferente, è possibile che abbia i suoi motivi, forse ci sono delle ragioni, non ne so niente, lo lascio libero di dire ciò che ha scelto di dire”.
Così, sono giunto alla conclusione che si, Fred Vargas Audoin-Rouzeau è una imbecille, perché fin da bambino mi hanno detto che chi non cambia mai idea è un’imbecille.

Nulla di buono dal fronte occidentale
di Paolo, 31 ottobre
Caro Vittorio, la tua mail arriva opportuna, perché mi spinge a tornare su un tema che continua a ronzarmi in testa, ma che affronto ormai con sempre maggiore riluttanza. Per più ragioni: intanto per noia, perché sono cose che sto ripetendo da sempre: poi perché a questo punto dubito che sull’argomento ci sia ancora una effettiva possibilità di confronto; infine perché mi trovo a sostenere una causa che con uno straordinario ribaltone è stata fatta propria dal “pensiero di destra”, sia pure con tutte le ambiguità e la smaccata strumentalizzazione che lo caratterizzano. Mi riesce allora difficile mantenere chiari i distinguo, soprattutto se la controparte “di sinistra” ragiona per slogan ideologizzanti. Dubito insomma che valga la pena insistere: ma mi hai servito un assist, e allora ci provo ancora una volta. Cercherò di farlo almeno con altre parole.
Andiamo comunque con ordine, perché nella tua missiva ci sono molte altre cose che mi solleticano.
 Intanto i libri, a partire da quello di Tesson e dalla sua titolazione. In effetti quella francese è la titolazione più fedele al nome scientifico del leopardo, che è Panthera uncia. Ma sul piano pratico, dato che il genere panthera comprende tutti i più grandi felini, dal leone alla tigre, al leopardo, al giaguaro, si prestano molto meglio all’identificazione spicciola i nomi comuni affibbiati alle varie specie. Tant’è che in inglese, in tedesco, in spagnolo, sempre leopard o leopardo rimane. Ora, uno penserebbe che i francesi, che vantano un grande naturalista come Buffon, abbiano mantenuto la terminologia scientifica (sia pure parziale, perché ad esempio quella completa del leopardo delle nevi è appunto Panthera uncia, e gli è stato riconosciuto lo status di panthera solo da poco: prima era uncia e basta) per puro spirito di esattezza, ma non è così. Sai benissimo che appena possono i nostri cugini rivendicano una totale autonomia culturale, rifuggono dalla globalizzazione linguistica e chiamano ad esempio ordinateur quello che in tutto il resto del mondo si chiama computer. Nel nostro caso tecnicamente hanno ragione, ma rischiano di creare confusione sul piano comunicativo, perché panthera definisce solo il genere, e non identifica la specie. Voglio dire che di primo acchito panthère des neiges potrebbe essere tradotto anche con leone delle nevi, tigre delle nevi, ecc. Allora, queste sottigliezze linguistiche possono sembrare assolutamente irrilevanti e pedantesche, ma a mio giudizio un loro rilievo lo hanno, e non solo per pignoli rompiballe come siamo tu ed io: l’imprecisione linguistica moltiplica in maniera esponenziale la confusione mentale già esistente: si parte dalle pantere e si arriva inevitabilmente a Babele.
Intanto i libri, a partire da quello di Tesson e dalla sua titolazione. In effetti quella francese è la titolazione più fedele al nome scientifico del leopardo, che è Panthera uncia. Ma sul piano pratico, dato che il genere panthera comprende tutti i più grandi felini, dal leone alla tigre, al leopardo, al giaguaro, si prestano molto meglio all’identificazione spicciola i nomi comuni affibbiati alle varie specie. Tant’è che in inglese, in tedesco, in spagnolo, sempre leopard o leopardo rimane. Ora, uno penserebbe che i francesi, che vantano un grande naturalista come Buffon, abbiano mantenuto la terminologia scientifica (sia pure parziale, perché ad esempio quella completa del leopardo delle nevi è appunto Panthera uncia, e gli è stato riconosciuto lo status di panthera solo da poco: prima era uncia e basta) per puro spirito di esattezza, ma non è così. Sai benissimo che appena possono i nostri cugini rivendicano una totale autonomia culturale, rifuggono dalla globalizzazione linguistica e chiamano ad esempio ordinateur quello che in tutto il resto del mondo si chiama computer. Nel nostro caso tecnicamente hanno ragione, ma rischiano di creare confusione sul piano comunicativo, perché panthera definisce solo il genere, e non identifica la specie. Voglio dire che di primo acchito panthère des neiges potrebbe essere tradotto anche con leone delle nevi, tigre delle nevi, ecc. Allora, queste sottigliezze linguistiche possono sembrare assolutamente irrilevanti e pedantesche, ma a mio giudizio un loro rilievo lo hanno, e non solo per pignoli rompiballe come siamo tu ed io: l’imprecisione linguistica moltiplica in maniera esponenziale la confusione mentale già esistente: si parte dalle pantere e si arriva inevitabilmente a Babele.
 Quanto a Thesiger, in effetti anch’io sono stato frastornato dal suo continuo andirivieni da un luogo e da un popolo all’altro. E sono rimasto interdetto davanti alla freddezza con cui ad esempio scrive, a chiusura di un capitolo, “Dopo cena sono uscito e ho ucciso un leone”. Va bene l’understatement inglese, e qui senz’altro Thesiger ci gioca, ma povera bestia, almeno gratifica la sua morte di un minimo di pathos. Per converso, lo stile british, asciutto, spocchioso, determinato fino al limite della cocciutaggine (oggi si direbbe “politicamente scorretto”), in realtà mi piace. Guarda con quale supponenza tratta gli italiani, e che ammirazione tributa invece ai dancali, agli etiopi, alle tribù più feroci dell’Abissinia. Potrà dare fastidio, ma non concede nulla alle “convenienze” o alle aspettative del lettore. C’è coerenza assoluta nel suo atteggiamento: il che non significa non cambiare mai idea, e quindi scadere nell’imbecillità, perché ad esempio nei confronti di alcuni popoli, o di alcuni personaggi, Thesiger la cambia eccome: ma le esperienze, le conoscenze o le constatazioni nuove le rubrica sempre con lo stesso stile. Per questo la ritengo una buona autobiografia: se c’è dell’autocelebrazione, e c’è senza dubbio, viene fatta scorrere tra le righe. In superficie c’è una narrazione secca, da viaggiatore medioevale.
Quanto a Thesiger, in effetti anch’io sono stato frastornato dal suo continuo andirivieni da un luogo e da un popolo all’altro. E sono rimasto interdetto davanti alla freddezza con cui ad esempio scrive, a chiusura di un capitolo, “Dopo cena sono uscito e ho ucciso un leone”. Va bene l’understatement inglese, e qui senz’altro Thesiger ci gioca, ma povera bestia, almeno gratifica la sua morte di un minimo di pathos. Per converso, lo stile british, asciutto, spocchioso, determinato fino al limite della cocciutaggine (oggi si direbbe “politicamente scorretto”), in realtà mi piace. Guarda con quale supponenza tratta gli italiani, e che ammirazione tributa invece ai dancali, agli etiopi, alle tribù più feroci dell’Abissinia. Potrà dare fastidio, ma non concede nulla alle “convenienze” o alle aspettative del lettore. C’è coerenza assoluta nel suo atteggiamento: il che non significa non cambiare mai idea, e quindi scadere nell’imbecillità, perché ad esempio nei confronti di alcuni popoli, o di alcuni personaggi, Thesiger la cambia eccome: ma le esperienze, le conoscenze o le constatazioni nuove le rubrica sempre con lo stesso stile. Per questo la ritengo una buona autobiografia: se c’è dell’autocelebrazione, e c’è senza dubbio, viene fatta scorrere tra le righe. In superficie c’è una narrazione secca, da viaggiatore medioevale.
E arrivo finalmente al tema che più mi interessa, quello cui accennavo prima. Mi limito in verità ad un abstract, perché l’argomento è complesso e scivoloso, e non può essere sviscerato in una mail. Ti anticipo comunque che il discorso non riguarda solo Fred Vargas. La Vargas, o come cavolo si chiama, può essere apprezzata o meno come giallista (personalmente non mi entusiasma), ma è senz’altro il perfetto esempio di una curiosa (e molto diffusa) tipologia umana. Applicando la tassonomia linneana la classificherei nella famiglia degli “antioccidentalisti”, nel genere “d’occidente”, nella specie “di sinistra (o orfani della rivoluzione)”. La caratteristica di fondo di questa tipologia è l’odio di sé che molti occidentali (e segnatamente quelli “più a sinistra”) hanno sviluppato, un po’ come si dice degli ebrei. Questo odio, questo “auto da fé” viene poi declinato in tutte le salse: politica, religiosa, filosofica, tradizionalista, progressista, ecc. Quella degli antioccidentalisti è infatti una famiglia molto allargata, che ultimamente ha trovato una sua nicchia ideologica nella post-modernità ma che ha un albero genealogico lungo e ramificato come quello degli Asburgo. E come tutte le famiglie che si rispettano si divide sulle opinioni e sulle aspettative, alcune almeno in apparenza diametralmente opposte, ma si ricompatta poi su una comune conclusione: che la civiltà occidentale, nel suo assieme o quantomeno a partire dalla modernità e dall’ illuminismo, è da buttare.
Occorre però distinguere l’odio di sé di cui parlo dall’occidentofobia che sta dilagando in tutto il mondo, in particolare in quello musulmano. In quest’ultima si combinano rancori di origine storica, (l’anticolonialismo e l’antimperialismo), rivendicazioni di specifiche identità culturali (ad esempio la Cina) e discutibili “risvegli” religiosi (l’islam e l’ortodossia russa): nella sostanza poi quello che ci sta dietro è uno scontro per la futura egemonia mondiale, orchestrato dai nuovi imperialismi militari ed economici. Gli interessi dei diversi attori sono decisamente contrastanti, ma per il momento sono tenuti assieme dalla identificazione di un avversario comune.

Ti chiederai cosa c’entra tutto questo con la Vargas e con Battisti. C’entra eccome, anche se per stabilire la connessione occorre fare un giro largo (e non è questa la sede).
Gli anti-occidentali nostrani, infatti, non sono mossi dall’aspirazione a una rivincita, ma covano rancore per una profonda delusione. Che ha motivazioni diverse. Quelli “di destra” sono delusi perché l’ordine gerarchico che considerano naturale (la società tradizionale) è stato stravolto, quelli “di sinistra” perché quell’ordine non è stato rivoluzionato abbastanza. Nei primi c’è di fondo una concezione egoistica, conflittuale, dell’uomo: vale la legge del branco, nel quale emergono quelli fisicamente o intellettualmente più dotati e a ciascun individuo è assegnato un ruolo preciso, funzionale alla sopravvivenza e alla perpetuazione della “comunità”. A loro giudizio la responsabilità maggiore per lo sfaldarsi della società tradizionale è da attribuirsi al monoteismo (da cui l’antisemitismo e l’interesse per il paganesimo e le società politeistiche orientali).
I secondi sono invece eredi della convinzione rousseauiana che in origine la “natura umana” fosse buona, pacifica e altruista, e che il suo “lato oscuro” sia stato creato o almeno portato allo scoperto da un progressivo condizionamento ambientale (la cosa vale per l’intera umanità ma anche per ogni singolo individuo: in altre parole, nessuno nasce carogna di suo, e se lo diventa è colpa “della società”). Hanno nostalgia, insomma, del “buon selvaggio” e del paradiso terrestre che avremmo perduto per colpa del prevalere di una “ragione calcolante”, asservita alla pura crescita economica, individuale e collettiva. Le grandi imputate della deriva occidentale sono pertanto nel loro caso la scienza e la tecnica, dalle quali si generano gli strumenti politici, sociali ed economici del dominio. In sostanza, quali che siano le cause indicate, sia per gli uni che per gli altri i risultati della civiltà occidentale sono l’individualismo, la rottura con la natura, la volontà sfrenata di potenza, il capitalismo, l’imperialismo, il colonialismo, lo sfruttamento, etc., fino ad arrivare al disastro ambientale.
Le cose ovviamente non stanno così. In natura l’unica legge comune, al mondo animale come a quello vegetale, è quella della sopravvivenza, individuale o specifica. I mezzi per garantirsi quest’ultima sono la sopraffazione, nei confronti della natura o dei propri simili, o la cooperazione: la via che viene scelta dipende poi senza dubbio anche dalle condizioni ambientali o storiche. Ma l’egoismo o l’altruismo non sono iscritti in una “natura umana primordiale”, sono frutto di selezioni attitudinali verificatesi nel corso dell’evoluzione. E la selezione non agisce secondo i criteri di buono e di cattivo che noi abbiamo “culturalmente” elaborato, ma secondo quelli naturali dell’utile o del dannoso. L’idea di una natura buona corrotta poi dal progresso, dalla tecnica, dalle stratificazioni sociali, ecc …, è puramente consolatoria, serve soltanto a distrarre l’attenzione da una realtà di fatto che non vogliamo accettare: siamo animali e ci comportiamo, in linea di fondo, come tali. Ed è anche un’idea decisamente incoerente, perché predica il ritorno alla natura e nel contempo nega le leggi di natura. Per questo, se le cose non vanno come vorremmo in base a ciò che incoerentemente crediamo, dal momento che la nostra mente ha elaborato anche il concetto di causalità (ogni effetto ha una causa) dobbiamo responsabilizzare qualcuno, trovare un capro espiatorio.

E qui tornano in ballo la nostra amica Vargas e il suo amico Battisti, ma entrano in scena anche altre vicende, molto più recenti, e altri protagonisti. Il rancore dell’occidentale occidentofobo di sinistra si esprime nella ribellione contro una civiltà che considera corrotta e colpevole di ogni sopraffazione, interna o esterna. Questa ribellione può rimanere su un piano puramente intellettuale di appoggio o scendere su quello pratico della violenza, e nel secondo caso l’ambiente intellettuale fornisce il brodo di coltura, le motivazioni e le giustificazioni, mescolando in un confuso coacervo la lotta di classe, le avanguardie rivoluzionarie, la sollevazione dei popoli non occidentali, il terrorismo ecologico o quello puro e semplice, ecc… In questo bailamme Cesare Battisti, un delinquente senza scrupoli e senza un briciolo di dignità, assurge a limpida figura di “resistente”, come colui che ha combattuto le storture della civiltà occidentale scientista, industrialista, capitalista, pseudo-democratica: e Hamas, un branco di scannatori allevati nell’odio, a simbolo della legittima resistenza contro l’avamposto del male. Quando dici che le dichiarazioni della Vargas la qualificano come un’imbecille hai perfettamente ragione, ma la sua imbecillità non è solitaria: l’appello del 2004 che tu stesso mi hai segnalato, dove si inneggia a Battisti come “uomo onesto, arguto, profondo, anticonformista … un intellettuale vero …” che ha operato “una straordinaria e ineguagliata riflessione sugli anni Settanta” è stato firmato dal fior fiore degli anticonformisti nostrani e d’oltralpe: Agamben, naturalmente, e Nanni Balestrini, Pennac e Cacucci, Loredana Lipperini e Christian Raimo, Massimo Carlotto e Gianfranco Manfredi, e un sacco d’altri. L’unico che a posteriori ha ritirato la sua firma è Roberto Saviano, che aveva firmato a quanto pare a sua insaputa, come i proprietari di attici prospicienti il Colosseo: “Mi segnalano la mia firma in un appello per Cesare Battisti …”. Il livello è questo.
Vedi, tu parli nella tua missiva di personaggi, Tesson e Thesiger, che sono rimasti fedeli alle loro idee per tutta la vita. Noi stessi, tu ed io, non siamo particolarmente flessibili per quanto concerne i nostri convincimenti. Ma come i due che tu citi abbiamo imparato dalla vita stessa che un conto sono le idealità, che possono indirizzare la nostra esistenza ma responsabilizzano e mettono in gioco solo noi stessi, e che in questo modo dal confronto con la realtà non possono mai uscire sconfitte, e un conto sono le ideologie, che invece tirano in ballo tutti gli altri, e finiscono solo per deresponsabilizzarci nei loro confronti e scaricare su di loro i nostri insuccessi. Come avrebbe detto Totò, chi persegue delle idealità è un uomo, chi si trincera dietro le ideologie è un caporale.
Non mi sembra però il caso di tirare ulteriormente in lungo quello che minaccia di diventare un comizio. Mi riservo semmai di argomentare più diffusamente le mie idee in una trattazione futura (in realtà ho già tentato di farlo ne La discesa dal Monte Analogo, ma ne è venuto fuori un pippone noiosissimo). Tu nel frattempo, vincendo una più che giustificata ripugnanza, prova a seguire fino a quando lo stomaco ti regge gli attuali dibattiti televisivi sulla vicenda israelo-palestinese, o fai un giro sul web cliccando semplicemente le voci Hamas, Gaza, Palestina, ecc … Capirai il mio imbarazzo, a trovarmi a condividere almeno in parte le opinioni di figuri come Capezzone o addirittura Paragone, e a dover sopportare le ambiguità o la cretineria palese di chi in nome di una “sinistra” viscidamente pacifista chiude gli occhi davanti all’ evidenza. Oppure, meglio, rileggiti un buon saggio su questi temi, ad esempio l’Elogio dell’Occidente di Franco La Cecla (Elèuthera 2016). Potrai farti un’idea molto chiara di ciò di cui sto parlando.
Ci risentiamo presto, spero.














 Come vivere? Allora questa domanda ce la dobbiamo porre non soltanto alla fine di un millennio, di un secolo, di un anno, ma tutti i giorni, e tutti i giorni svegliandoci, si dovrebbe dire: “Oggi che cosa ci aspetta?”. Allora io considero che si dovrebbero fare le cose bene, perché non c’è maggiore soddisfazione di un lavoro ben fatto. Un lavoro ben fatto, qualsiasi lavoro, fatto dall’uomo che non si prefigge solo il guadagno, ma anche un arricchimento, un lavoro manuale, un lavoro intellettuale che sia, un lavoro ben fatto è quello che appaga l’uomo. Io coltivo l’orto, e qualche volta, quando vedo le aiuole ben tirate con il letame ben sotto, con la terra ben spianata, provo soddisfazione uguale a quella che ho quando ho finito un buon racconto. E allora dico anche questo: una catasta di legna ben fatta, ben allineata, ben in squadra, che non cade, è bella; un lavoro manuale quando non è ripetitivo è sempre un lavoro che va bene, perché è anche creativo: un bravo falegname, un bravo artigiano, un bravo scalpellino, un bravo contadino. E oggi dico sempre quando mi incontro con i ragazzi: voi magari aspirate ad avere un impiego in banca, ma ricordatevi che fare il contadino per bene è più intellettuale che non fare il cassiere di banca, perché un contadino deve sapere di genetica, di meteorologia, di chimica, di astronomia persino. Tutti questi lavori che noi consideriamo magari con un certo disprezzo, sono lavori invece intellettuali.
Come vivere? Allora questa domanda ce la dobbiamo porre non soltanto alla fine di un millennio, di un secolo, di un anno, ma tutti i giorni, e tutti i giorni svegliandoci, si dovrebbe dire: “Oggi che cosa ci aspetta?”. Allora io considero che si dovrebbero fare le cose bene, perché non c’è maggiore soddisfazione di un lavoro ben fatto. Un lavoro ben fatto, qualsiasi lavoro, fatto dall’uomo che non si prefigge solo il guadagno, ma anche un arricchimento, un lavoro manuale, un lavoro intellettuale che sia, un lavoro ben fatto è quello che appaga l’uomo. Io coltivo l’orto, e qualche volta, quando vedo le aiuole ben tirate con il letame ben sotto, con la terra ben spianata, provo soddisfazione uguale a quella che ho quando ho finito un buon racconto. E allora dico anche questo: una catasta di legna ben fatta, ben allineata, ben in squadra, che non cade, è bella; un lavoro manuale quando non è ripetitivo è sempre un lavoro che va bene, perché è anche creativo: un bravo falegname, un bravo artigiano, un bravo scalpellino, un bravo contadino. E oggi dico sempre quando mi incontro con i ragazzi: voi magari aspirate ad avere un impiego in banca, ma ricordatevi che fare il contadino per bene è più intellettuale che non fare il cassiere di banca, perché un contadino deve sapere di genetica, di meteorologia, di chimica, di astronomia persino. Tutti questi lavori che noi consideriamo magari con un certo disprezzo, sono lavori invece intellettuali.










 C’era una volta, tanti e tanti … beh, insomma, una ventina d’anni fa, un gruppo di amici, di quelli messi assieme dalle circostanze della vita e dalle passioni in comune anziché dall’anagrafe, che si ritrovavano sempre più spesso a frugare tra gli scaffali di una caotica libreria ovadese, a camminare lungo i sentieri del Parco di Marcarolo o a cenare in un capanno sperduto nella campagna. Era un’allegra brigata, a metà strada tra il cenacolo intellettuale e la compagnia del calcetto …
C’era una volta, tanti e tanti … beh, insomma, una ventina d’anni fa, un gruppo di amici, di quelli messi assieme dalle circostanze della vita e dalle passioni in comune anziché dall’anagrafe, che si ritrovavano sempre più spesso a frugare tra gli scaffali di una caotica libreria ovadese, a camminare lungo i sentieri del Parco di Marcarolo o a cenare in un capanno sperduto nella campagna. Era un’allegra brigata, a metà strada tra il cenacolo intellettuale e la compagnia del calcetto …
 La storia del logo dei Viandanti merita di essere raccontata. Dunque: siamo nel novembre del novantacinque e i Viandanti delle Nebbie hanno organizzato in Ovada una mostra su
La storia del logo dei Viandanti merita di essere raccontata. Dunque: siamo nel novembre del novantacinque e i Viandanti delle Nebbie hanno organizzato in Ovada una mostra su 
 Credo che anche la storia del Capanno, come quella del logo, meriti di essere raccontata.
Credo che anche la storia del Capanno, come quella del logo, meriti di essere raccontata.
 la prima versione della mappa
la prima versione della mappa

 Durante il periodo di apertura della mostra sono previsti tre incontri pubblici, mirati a presentare il lavoro del sodalizio dei Viandanti, a giustificarne per quanto possibile lo spirito e a suggerire ai visitatori alcune possibili modi per gustarlo e per trarne, se non briciole di sapere, almeno un po’ di piacere.
Durante il periodo di apertura della mostra sono previsti tre incontri pubblici, mirati a presentare il lavoro del sodalizio dei Viandanti, a giustificarne per quanto possibile lo spirito e a suggerire ai visitatori alcune possibili modi per gustarlo e per trarne, se non briciole di sapere, almeno un po’ di piacere.
 Provo ad andare al nocciolo della questione. Perché si scrive? Camillo Sbarbaro, presente nell’ultimo Ritratti di famiglia dei Viandanti, risponde ironicamente: “si scrive per essere notati, e si continua a scrivere perché si è noti”. Proprio lui che per cercare di fare i conti con la figura paterna ha scritto poesie che valgono vent’anni di sedute psicoterapiche. Non scherziamo. Scrivevano eroi come Levi, Fenoglio, Leopardi, Foscolo, Dante. Ma scrivevano anche borghesi tranquilli come Gozzano, Montale, Eco, Saba. Se proviamo a mettere in relazione le loro biografie e le loro bibliografie …
Provo ad andare al nocciolo della questione. Perché si scrive? Camillo Sbarbaro, presente nell’ultimo Ritratti di famiglia dei Viandanti, risponde ironicamente: “si scrive per essere notati, e si continua a scrivere perché si è noti”. Proprio lui che per cercare di fare i conti con la figura paterna ha scritto poesie che valgono vent’anni di sedute psicoterapiche. Non scherziamo. Scrivevano eroi come Levi, Fenoglio, Leopardi, Foscolo, Dante. Ma scrivevano anche borghesi tranquilli come Gozzano, Montale, Eco, Saba. Se proviamo a mettere in relazione le loro biografie e le loro bibliografie …


 I Quaderni sono nati con l’intento di raccogliere in volumetti e rendere disponi-bili per eventuali estimatori (?)i materiali pubblicati su Sottotiro review. E così è stato, almeno per i primi due o tre libretti. Poi la cosa ha ci preso la mano, e si è tra-sformata in una vera e propria impresa editoriale …
I Quaderni sono nati con l’intento di raccogliere in volumetti e rendere disponi-bili per eventuali estimatori (?)i materiali pubblicati su Sottotiro review. E così è stato, almeno per i primi due o tre libretti. Poi la cosa ha ci preso la mano, e si è tra-sformata in una vera e propria impresa editoriale …
 Un viandante non è un viaggiatore. Non si limita a superare occasionalmente delle distanze, ma percorre degli itinerari, connota degli spazi. E dal momento che nemmeno è un pendolare, questi spazi, questi itinerari sono sempre diversi. Il viaggio è la sua vita, lo spostamento è la sua meta …
Un viandante non è un viaggiatore. Non si limita a superare occasionalmente delle distanze, ma percorre degli itinerari, connota degli spazi. E dal momento che nemmeno è un pendolare, questi spazi, questi itinerari sono sempre diversi. Il viaggio è la sua vita, lo spostamento è la sua meta …
 È il proseguo di Sottotiro review in modalità digitale, per quel che possiamo fare noi restii al digitale. Ci autorizziamo a lanciare degli sguardi nella rete che hanno la presunzione di proiettare delle occhiate “ostinate e contrarie” verso ciò che il quotidiano ci offre. Sono sguardistorti verso un mondo di cui dichiariamo la nostra difficoltà a comprenderne i meccanismi autodistruttivi, ma che ci stupiamo a scrutare per indagarne le distopie …
È il proseguo di Sottotiro review in modalità digitale, per quel che possiamo fare noi restii al digitale. Ci autorizziamo a lanciare degli sguardi nella rete che hanno la presunzione di proiettare delle occhiate “ostinate e contrarie” verso ciò che il quotidiano ci offre. Sono sguardistorti verso un mondo di cui dichiariamo la nostra difficoltà a comprenderne i meccanismi autodistruttivi, ma che ci stupiamo a scrutare per indagarne le distopie …
 Sottotiro è una rivista nata nei primi anni novanta dello scorso secolo in Toscana. Dopo un paio di numeri e un lungo letargo è rinata in Piemonte, nelle colline ovadesi. L’intento era quello di costituire, nel suo piccolo, un tramite e un luogo di contatti, di scambi culturali, di amicizie e (magari!) anche di discussioni. Per un certo periodo lo è anche stata, e non solo a livello strettamente locale: non avrà inciso sull’opinione pubblica, ma ha senz’altro contribuito, tramite il comune impegno, le discussioni redazionali, gli incontri necessari per costruirla materialmente, a creare o a rinsaldare amicizie …
Sottotiro è una rivista nata nei primi anni novanta dello scorso secolo in Toscana. Dopo un paio di numeri e un lungo letargo è rinata in Piemonte, nelle colline ovadesi. L’intento era quello di costituire, nel suo piccolo, un tramite e un luogo di contatti, di scambi culturali, di amicizie e (magari!) anche di discussioni. Per un certo periodo lo è anche stata, e non solo a livello strettamente locale: non avrà inciso sull’opinione pubblica, ma ha senz’altro contribuito, tramite il comune impegno, le discussioni redazionali, gli incontri necessari per costruirla materialmente, a creare o a rinsaldare amicizie …


 Quando i Viandanti delle Nebbie si misero alla ricerca di riferimenti ideali si imbatterono quasi per caso negli Yamabushi. I riferimenti ideali sono importanti, soprattutto se sono abbastanza lontani nel tempo e nello spazio da rimanere ideali. Per noi gli Yamabushi erano perfetti: stavano dall’altra parte del globo ed erano praticamente spariti dalla circolazione da almeno un secolo e mezzo. In più, anche in piena New Age li conosceva nessuno (tanto che per un attimo l’idea di riesumarli ci ha sfiorato, e resto convinto che avremmo trovato adepti) e i loro rituali erano impegnativi solo sul piano fisico. Adoravano come noi le montagne, le salivano come noi, come noi le rispettavano, senza provare alcun bisogno di domarle e di sconfiggerle. Non c’era da cambiare una virgola nel nostro atteggiamento e nei nostri comportamenti. Gli Yamabushi sono quindi …
Quando i Viandanti delle Nebbie si misero alla ricerca di riferimenti ideali si imbatterono quasi per caso negli Yamabushi. I riferimenti ideali sono importanti, soprattutto se sono abbastanza lontani nel tempo e nello spazio da rimanere ideali. Per noi gli Yamabushi erano perfetti: stavano dall’altra parte del globo ed erano praticamente spariti dalla circolazione da almeno un secolo e mezzo. In più, anche in piena New Age li conosceva nessuno (tanto che per un attimo l’idea di riesumarli ci ha sfiorato, e resto convinto che avremmo trovato adepti) e i loro rituali erano impegnativi solo sul piano fisico. Adoravano come noi le montagne, le salivano come noi, come noi le rispettavano, senza provare alcun bisogno di domarle e di sconfiggerle. Non c’era da cambiare una virgola nel nostro atteggiamento e nei nostri comportamenti. Gli Yamabushi sono quindi … I Viandanti delle Nebbie sono da sempre consapevoli della prevalenza del cretino, tanto da auspicare emendanti spedizioni di massa alla chiesa francese che ospita il sarcofago di San Menulfo, antico miglioratore delle sinapsi di chiunque introduca il capo nel suo apposito orifizio (rimando all’articolo “
I Viandanti delle Nebbie sono da sempre consapevoli della prevalenza del cretino, tanto da auspicare emendanti spedizioni di massa alla chiesa francese che ospita il sarcofago di San Menulfo, antico miglioratore delle sinapsi di chiunque introduca il capo nel suo apposito orifizio (rimando all’articolo “ Il mondo lo si può “camminare” in vari modi, da soli o in compagnia, di fretta o in tutta calma, motivati da una scelta o spinti da una necessità; così come sono svariati i mezzi, oltre ai piedi, grazie ai quali si può viaggiare. Ma gli atteggiamenti fondamentali che inducono a incamminarsi per il mondo sono riconducibili in linea di massima a due: la semplice voglia di scoprirlo, magari in cerca di rifugio, e viverlo, oppure il desiderio di raccontarlo, studiarlo o conquistarlo. Nel primo caso sulla polvere o sul fango della strada percorsa si lasciano soltanto delle tracce, che vengono prima o poi spazzate via dal vento del tempo o dilavate dalle acque, mentre rimangono fortemente impresse nell’animo; negli altri casi si marcano invece delle impronte, a volte talmente profonde e durature che quel mondo vanno anche a modificarlo. E qualche volta accade anche che le orme involontarie diventino letteralmente impronte rivelatrici, come nei casi di Laetoli, dell’isola di Calvert o del deserto del Nefud.
Il mondo lo si può “camminare” in vari modi, da soli o in compagnia, di fretta o in tutta calma, motivati da una scelta o spinti da una necessità; così come sono svariati i mezzi, oltre ai piedi, grazie ai quali si può viaggiare. Ma gli atteggiamenti fondamentali che inducono a incamminarsi per il mondo sono riconducibili in linea di massima a due: la semplice voglia di scoprirlo, magari in cerca di rifugio, e viverlo, oppure il desiderio di raccontarlo, studiarlo o conquistarlo. Nel primo caso sulla polvere o sul fango della strada percorsa si lasciano soltanto delle tracce, che vengono prima o poi spazzate via dal vento del tempo o dilavate dalle acque, mentre rimangono fortemente impresse nell’animo; negli altri casi si marcano invece delle impronte, a volte talmente profonde e durature che quel mondo vanno anche a modificarlo. E qualche volta accade anche che le orme involontarie diventino letteralmente impronte rivelatrici, come nei casi di Laetoli, dell’isola di Calvert o del deserto del Nefud. Le vespe sono tornate a nidificare nella mia libreria. Accade da cinque o sei estati, prima non si era mai verificato. Probabilmente ne è entrata una per caso, ha apprezzato l’ambiente e lo ha comunicato alle altre. Le vespe, a differenza dei cristiani, comunicano molto e hanno una formidabile memoria della specie. Magari si tratta delle discendenti di quella prima esploratrice, immigrate di terza, quarta o quinta generazione, che ormai considerano casa mia anche la loro …
Le vespe sono tornate a nidificare nella mia libreria. Accade da cinque o sei estati, prima non si era mai verificato. Probabilmente ne è entrata una per caso, ha apprezzato l’ambiente e lo ha comunicato alle altre. Le vespe, a differenza dei cristiani, comunicano molto e hanno una formidabile memoria della specie. Magari si tratta delle discendenti di quella prima esploratrice, immigrate di terza, quarta o quinta generazione, che ormai considerano casa mia anche la loro …








 È andata così. Quando ancora erano in vita i miei genitori avevo l’abitudine di trascorrere tutte le sere, subito dopo cena, una mezzoretta con loro (abitavano al piano inferiore). Si commentava la giornata, si programmavano i lavori, a volte semplicemente seguivo assieme a loro il telegiornale. All’epoca (parlo di venticinque e passa anni fa) ero affetto da una sorta di compulsione a disegnare, cosa che mi portavo dietro sin dall’infanzia. Era probabilmente un modo per isolarmi dagli altri e per evadere nei miei mondi fantastici. Riempivo di immagini qualsiasi superfice cartacea bianca, in ogni occasione: da studente le fonti maggiori di ispirazione erano naturalmente le lezioni di chimica e fisica, o la lettura in classe dei Promessi sposi, da insegnante sono diventati i consigli di classe, i collegi dei docenti, i convegni, le conferenze e i corsi di aggiornamento. Ho consumato centinaia di block notes che oggi rimpiango di aver buttato, e riciclato fogli protocollo usati per metà che andavano poi a ruba tra gli studenti (forse cercavano immagini compromettenti). Ho anche attraversato periodi diversi, come Picasso, passando col tempo da battaglie molto stilizzate a studi di figure umane, e poi alla cartografia e alla paesaggistica montana, per approdare da ultimo (dopo vent’anni ininterrotti di lavori di edilizia per ristrutturare e ampliare il caseggiato in cui abito attualmente – e dove risiedono anche mio fratello e mio figlio, e nei mesi estivi cognata e nipoti con rispettive famiglie), alla fase del disegno architettonico. Sempre all’insegna di una sorta di “realismo magico”.
È andata così. Quando ancora erano in vita i miei genitori avevo l’abitudine di trascorrere tutte le sere, subito dopo cena, una mezzoretta con loro (abitavano al piano inferiore). Si commentava la giornata, si programmavano i lavori, a volte semplicemente seguivo assieme a loro il telegiornale. All’epoca (parlo di venticinque e passa anni fa) ero affetto da una sorta di compulsione a disegnare, cosa che mi portavo dietro sin dall’infanzia. Era probabilmente un modo per isolarmi dagli altri e per evadere nei miei mondi fantastici. Riempivo di immagini qualsiasi superfice cartacea bianca, in ogni occasione: da studente le fonti maggiori di ispirazione erano naturalmente le lezioni di chimica e fisica, o la lettura in classe dei Promessi sposi, da insegnante sono diventati i consigli di classe, i collegi dei docenti, i convegni, le conferenze e i corsi di aggiornamento. Ho consumato centinaia di block notes che oggi rimpiango di aver buttato, e riciclato fogli protocollo usati per metà che andavano poi a ruba tra gli studenti (forse cercavano immagini compromettenti). Ho anche attraversato periodi diversi, come Picasso, passando col tempo da battaglie molto stilizzate a studi di figure umane, e poi alla cartografia e alla paesaggistica montana, per approdare da ultimo (dopo vent’anni ininterrotti di lavori di edilizia per ristrutturare e ampliare il caseggiato in cui abito attualmente – e dove risiedono anche mio fratello e mio figlio, e nei mesi estivi cognata e nipoti con rispettive famiglie), alla fase del disegno architettonico. Sempre all’insegna di una sorta di “realismo magico”. Questa lunga premessa per dire che una sera di tardo autunno, mentre conversavo con mio padre, buttai giù uno schizzo di ciò che avrebbe potuto uscire dal recupero del cascinotto semidiroccato posto a guardia dei vigneti. Per me si trattava solo di un gioco, tanto che avevo preso a modello una di quelle case della prateria che si vedono nei fumetti di Tex. Quando diedi la buonanotte non me ne ricordavo nemmeno più. Lo schizzo rimase sul tavolo.
Questa lunga premessa per dire che una sera di tardo autunno, mentre conversavo con mio padre, buttai giù uno schizzo di ciò che avrebbe potuto uscire dal recupero del cascinotto semidiroccato posto a guardia dei vigneti. Per me si trattava solo di un gioco, tanto che avevo preso a modello una di quelle case della prateria che si vedono nei fumetti di Tex. Quando diedi la buonanotte non me ne ricordavo nemmeno più. Lo schizzo rimase sul tavolo. I lavori ebbero inizio nel febbraio del ’92, complice un inverno piuttosto mite. Arrivavo, come ho già detto, da vent’anni di ristrutturazioni e avevo contratto una sorta di malattia del cemento. Disponevo dell’attrezzatura essenziale, compresa una betoniera, e di un sacco di materiale di recupero (travi, assi, infissi, mattonelle, ecc …) frutto dei lavori di rifacimento del tetto e dell’ultimo piano della casa. Per il resto dovevo affidarmi solo alle mie braccia e alla mia testa. Nella costruzione non ha messo mano alcun altro, tranne l’idraulico e mio figlio in occasione della posa dei travi del tetto. Ci ho lavorato ininterrottamente (che significa tutti i pomeriggi nei giorni di scuola e sin dal mattino negli altri, feste comandate comprese) per dieci mesi, senza trascurare nel frattempo la cura dei vigneti. Nel suo piccolo è stata un’impresa titanica, e non mi imbarazza usare questo termine perché i problemi logistici da superare erano davvero enormi. Non ero collegato alla rete elettrica, i materiali da costruzione non mi arrivavano direttamente sul posto, ma dovevo andare a recuperarli col trattore sullo stradone, trecento metri prima, ecc …). Ognuno dei blocchetti di cemento usati per la parte aggiuntiva, ciascuna piastrella per il pavimento o ondulina per il tetto, tutti i coppi e le bacchette di ferro e le reti per le armature, mi sono passati per le mani almeno cinque o sei volte: alla fine ci davamo del tu.
I lavori ebbero inizio nel febbraio del ’92, complice un inverno piuttosto mite. Arrivavo, come ho già detto, da vent’anni di ristrutturazioni e avevo contratto una sorta di malattia del cemento. Disponevo dell’attrezzatura essenziale, compresa una betoniera, e di un sacco di materiale di recupero (travi, assi, infissi, mattonelle, ecc …) frutto dei lavori di rifacimento del tetto e dell’ultimo piano della casa. Per il resto dovevo affidarmi solo alle mie braccia e alla mia testa. Nella costruzione non ha messo mano alcun altro, tranne l’idraulico e mio figlio in occasione della posa dei travi del tetto. Ci ho lavorato ininterrottamente (che significa tutti i pomeriggi nei giorni di scuola e sin dal mattino negli altri, feste comandate comprese) per dieci mesi, senza trascurare nel frattempo la cura dei vigneti. Nel suo piccolo è stata un’impresa titanica, e non mi imbarazza usare questo termine perché i problemi logistici da superare erano davvero enormi. Non ero collegato alla rete elettrica, i materiali da costruzione non mi arrivavano direttamente sul posto, ma dovevo andare a recuperarli col trattore sullo stradone, trecento metri prima, ecc …). Ognuno dei blocchetti di cemento usati per la parte aggiuntiva, ciascuna piastrella per il pavimento o ondulina per il tetto, tutti i coppi e le bacchette di ferro e le reti per le armature, mi sono passati per le mani almeno cinque o sei volte: alla fine ci davamo del tu.

 Se ci trovassimo all’interno di un motore di ricerca, queste sarebbero le parole chiave per rintracciare e tentare di definire cosa siano stati e in parte siano ancora i Viandanti delle Nebbie: un gruppo di amici di età nemmeno così omogenea che, lontano da riflettori e da istituzioni, hanno dato vita a molti incontri privati e a qualche occasione pubblica.
Se ci trovassimo all’interno di un motore di ricerca, queste sarebbero le parole chiave per rintracciare e tentare di definire cosa siano stati e in parte siano ancora i Viandanti delle Nebbie: un gruppo di amici di età nemmeno così omogenea che, lontano da riflettori e da istituzioni, hanno dato vita a molti incontri privati e a qualche occasione pubblica.