di Marco Grassano, 27 giugno 2023
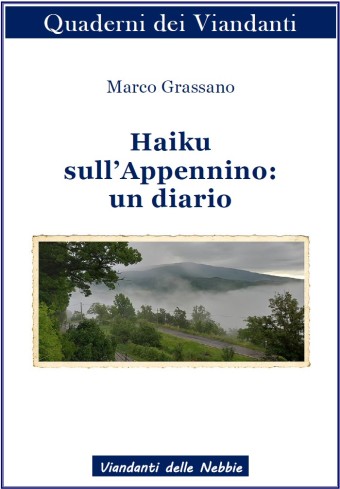 Una postfazione anticipata – di Paolo Repetto
Una postfazione anticipata – di Paolo Repetto
Giugno giapponese in Val Curone
Giugno 2013
Bozzetti di luglio e agosto 2013
Haiku 2014
Haiku 2015
Altri haiku
Una postfazione anticipata
Mi sono chiesto se avesse senso presentare un’opera che si illustra già benissimo da sola. In genere, soprattutto se si tratta di raccolte poetiche, patisco le presentazioni. Se non arrivo da solo a capire quello che l’autore voleva dirmi, a condividerne sensazioni e riflessioni ed emozioni, ricreandole poi a mia misura, delle due l’una: o non ha saputo parlarmi lui, o non sono in grado di ascoltare io. In entrambi i casi il piacere della lettura va a farsi benedire.
Ma questo libretto non è una raccolta di poesie. O meglio: lo è, anche, ma è soprattutto qualcos’altro. Il che giustifica almeno una postfazione: non un’esegesi critica, ma una postilla con la quale dare conto dei criteri che ne hanno determinato e guidato la pubblicazione.
Il libretto nasce in primo luogo da una comune amicizia, quella con Mario Mantelli. È la migliore risposta possibile ad una delle tantissime sollecitazioni che il “musagete” ha lasciato in eredità, mostrandoci come ciascuno possa percorrere del proprio passo la via dell’haiku rimanendo comunque fedele all’ortodossia formale. Come cioè la disciplina non mortifichi affatto la creatività, ma anzi la stuzzichi, e la fortifichi. Nasce quindi come un “esercizio” poetico, ma prende subito un’altra strada, trova un’espressione tutta sua, originale. Diventa esplicitamente un “diario poetico” (implicitamente, tutte le raccolte poetiche sono diari), nel quale le poesie hanno la duplice funzione di rappresentare “fotograficamente”, quasi come istantanee, la realtà naturale, traducendo la parola in immagine, e nel contempo di fermare il sentimento che l’immagine ha suscitato, riconducendolo da questa alla parola.
Mentre lo leggevo ho avuto l’impressione di trovarmi di fronte ad un album di foto dei primi anni Cinquanta, quelle di dimensioni ridotte, quadrate, in bianco e nero e con il bordo bianco dentellato. Le foto sono accompagnate da didascalie semplicissime: il tempo, il luogo, l’occasione dello scatto. Proprio per la loro essenzialità e discrezione le didascalie diventano parte integrante dell’immagine. Sono il bordo dentellato.
Per cercare di restituire questo effetto ho adottato soluzioni grafiche a dir poco rudimentali, le uniche d’altronde di cui disponevo: voglio credere però che trasmettano almeno un poco della genuinità e della immediatezza dei contenuti. Voglio crederlo perché queste piccolissime magie mi affascinano e mi commuovono, ravvivano la speranza che ci sia ancora qualcuno in grado di condividerle.
Il libretto che avete in mano è un umile frutto di quella speranza.
di Paolo Repetto, 19 giugno 2023

Giugno giapponese in Val Curone
Trasferito per l’estate, a partire da venerdì 14 giugno 2013, in Val Curone, dove gli stimoli naturali agiscono sui sensi con maggiore intensità, ho cominciato ad avvertire il bisogno di tradurre in qualche modo queste sensazioni, tentando di trasporre in italiano il metro dell’haiku giapponese (tre versi: 5, 7 e 5 sillabe), secondo quanto suggerisce il “geo poeta” Kenneth White: “Ho trovato che la forma più propria a questo genere di contesto è l’haiku, basato su un gioco delicatissimo fra il fenomeno presente e il tutto che ci circonda; ecco perché ho proposto, anni fa, quella che ho definito la passeggiata-haiku, consacrata all’ecologia delle mente, alla filosofia naturale e alla conservazione durevole del mondo”. Ma mi ha anche invogliato l’intrigante “Disciplinare dell’haiku”, dell’amico Mario Mantelli, e mi hanno confortato, a mo’ di esempio, i diari lirici di Matsuo Bashō.
Ecco cosa ne è venuto fuori…

Giugno 2013
Il mattino di domenica 16 giugno 2013 non c’erano nuvole, e il pendio che scende verso Bregni e Restegassi, per poi risalire verso il Giarolo, istoriato di boschi naturaliformi e di campi coltivati, sfavillava di tanti verdi diversi:
Splende la valle
in curve e ampi riquadri
di vario verde.
Il pomeriggio, vedendo l’effetto delle nubi in movimento e della loro ombra proiettata sulla montagna, che sembrava, così maculata, la pelle di una salamandra, però ovviamente verde, mi è venuta questa immagine:
Sembra il Giarolo
una verde salamandra
d’ombra e di sole.
Alla sera, uno stormo di corvi ha cominciato a strepitare, volando in cerchio sopra i calanchi che dominano la vicina frazione di Fontanelle, e subito dopo l’oscurità ha cominciato a farsi densa. Ecco:
Strida di corvi:
in tondo sulla rupe
chiamano il buio.
∞
La sera prima, sabato 15 giugno 2013, il cielo al tramonto era pieno di nubi spostate dal vento, che stormiva nel bosco sopra casa con un suono di risacca.
Tramonto mosso.
Il vento su nel bosco
imita il mare.
Poco dopo, il sole da casa nostra non si vedeva più, ma la sua luce spennellava di morbido viola la montagna.
Sera di giugno.
La luce sul Giarolo:
velluto viola.
∞
Mercoledì 19 giugno 2013, al pomeriggio, siamo andati in piscina a San Sebastiano. Dopo aver giocato in acqua con mia figlia, mi sono sdraiato sull’asciugamano e sono stato colto da una dolce sonnolenza, favorita, anziché disturbata, dai rumori dell’acqua e dalle voci dei bagnanti.
Stesi in piscina.
Sciacquii e continue voci
danno sopore.
(sopore: Saffo, nel frammento n° 2, “Invito al tempio”, dice “koma” – da cui anche il nostro termine medico “coma” – intendendo, appunto, un piacevole assopimento, meno profondo rispetto al sonno, “hypnos”).
Saliti alla nostra casetta, mentre aspettavo di cenare ho osservato, lungo il crinale – la “Costa” – che separa la vallata del Curone-Museglia da quella del Borbera (e affluenti), arrivando fin contro il Giarolo, un ampio campo di grano già biondo, in mezzo ai verdi variegati di tutto il resto del paesaggio.
Sopra la Costa
tra i verdi si distende
grano maturo.
Dopo cena, quando l’oscurità si stava già diffondendo, mi sono messo a rincalzare, legare e innaffiare le lavande che ho piantato a inizio maggio. I grilli cantavano, e la loro flebile vibrazione era portata da un venticello leggero (“debole sistro al vento d’una persa cicala”, scriveva Montale), mentre in cielo la luna traluceva da una nuvola che le stava passando davanti. Mi sono sentito anch’io un po’ (ma solo un po’…) monaco giapponese al lavoro nel giardino del convento. Allora ho provato ad usare il metro tanka, scoperto nella raccolta di antiche liriche “La centuria poetica” – compilazione attribuita a Teika Fujiwara (in pratica, aggiungendo a un haiku due versi di sette sillabe).
Grilli alla brezza.
L’alone della luna
dietro una nube.
Nel buio che si addensa
curo le mie lavande.
∞
Mattino di venerdì 21 giugno 2013. L’arrivo del giorno si intuisce dagli uccelli, che cominciano via via a intrecciare le loro note, e una melodia si sovrappone all’altra.
Canti di uccelli:
intrecci sovrapposti,
fanno il mattino.
Sempre mattino del 21 giugno. Il vento, abbastanza energico, fa correre alte nuvole nel cielo pulito; sui pendii, dondolano alla sua spinta le ginestre, che solo adesso (con oltre un mese di ritardo: è curioso come la Natura faccia convivere fianco a fianco piante che fioriscono sulla base del rapporto luce/buio, come i biancospini, con altre che si attivano a seconda della temperatura media, come le ginestre…) iniziano la piena fioritura. Viene in mente l’Anacreonte tradotto da Quasimodo: “Vibra il cupo fogliame / del lauro e del verde pallido ulivo”.
Il vento spinge
i cirri nell’azzurro
e fa oscillare
sulle ripe il recente
giallo delle ginestre.
Alla sera del 21, il sole tramontante esaltava il verde variegato delle pendici del Giarolo, mentre la luna, quasi piena, sorgeva da dietro la punta della montagna:
In pizzo al monte
la luna del solstizio
è quasi piena.
L’ultimo sole obliquo
fa sfavillare il verde.
∞
Sabato 22 giugno 2013 è stato tutto abbastanza ventoso. Alla sera, ondate d’aria scuotevano gli alberi, li facevano dondolare. La luna si è alzata argentea dal Giarolo, appena a destra della punta, in un tondo quasi perfetto. Poco dopo, i corvi hanno preso a girare ad ampio raggio nel cielo, ripetendo monotonamente, come una preghiera, il loro aspro verso:
Tra soffi d’aria
la luna, ostia d’argento,
si alza dal monte.
La litania dei corvi
risuona tutt’attorno.
∞
Domenica 23 giugno 2013, siamo andati a pranzare a Lunassi. Il cielo, nettato dal vento, era di un intenso blu, costellato di grandi nubi marmoree; la luce, così intensa, rincuorava.
Pranzo a Lunassi.
Il cielo, a smalto e nubi,
rischiara il cuore.
Dopo cena, il vento era freddo. Non solo sopra il Giarolo, ma anche sulla Costa e verso Dernice, ammassi di nubi sbrindellate (bluastre per lo più, molte grigie e anche qualcuna rosea) si muovevano al soffio.
Nubi a brandelli,
livide, grigie e rosa,
vanno nel vento.
∞
Lunedì 24 giugno 2013, al mattino presto. Nella notte è piovuto, con lampi e tuoni. Ne residuano nuvole sparse, tutte scure. Ma contro di esse si staglia, sopra l’orlo delle colline a est – sopra Restegassi, dal nostro angolo di visione – un grosso batuffolo candido.
Un bianco sbuffo
di nubi sul crinale;
livide le altre.
∞
Giovedì 27 giugno 2013, pomeriggio avanzato. La lavanda comincia a sventagliare i suoi cespi violetti, attirando i primi imenotteri, soprattutto bombi. Sulle lavande che fiancheggiano il muraglione, un insetto con antenne che ricordano, nella divaricazione, le corna di una lumaca, e con un rostro lungo e sottile, vola spostandosi piano, succhiando, senza posarsi, come un colibrì, da un fiore e dall’altro – e poi schizza via fulmineo (ricompare dopo cena, sulle lavande grosse del praticello). Si tratta, come ha osservato anche Darwin nel suo Viaggio di un naturalista attorno al mondo, di una farfalla sfinge (Macroglossum stellatarum).
Cuscino viola,
profuma la lavanda.
Ronzio di bombi.
Tra i fiori lungo il muro,
un colibrì d’insetto.
Verso sera, inizia a lampeggiare, a tuonare, a piovere nel vento. Il paesaggio verso il Giarolo si vela della nebbia sottile che appare, di solito, durante i piovaschi dell’estate avanzata.
Il temporale
appanna valle e clivi
come ad agosto.
Ma mi raccontano che ieri sera, col buio, hanno preso finalmente a pullulare, tra gli alberelli e i cespugli del pendio sopra casa, le lucciole.
Lucciole in volo
tra i rami della ripa:
un firmamento.
Dopo cena, verso le 21, per pochi minuti il sole si apre uno squarcio fra le nuvole a ovest, e proietta una fascia di luce rossastra a metà Giarolo.
Squarcio di nubi.
Fulgore porporino
a mezza costa.
∞
Al mattino di venerdì 28 giugno 2013, fa piuttosto freddo: 11 gradi, rispetto ai 22 della scorsa settimana, alla stessa ora. Ancora nubi, irregolari, con squarci luminosi tra una e l’altra. Il sole, passando da una di queste aperture, batte sui campi appena sopra Restegassi, e li fa brillare.
Tra nubi scure
il sole chiazza i campi
di lucentezza.
Arrivato sotto Monleale, ho visto il paese immerso in due piccole nuvole che, come una caligine autunnale leggermente scura, ne ombravano e opacizzavano le forme.
Spegne i colori
Monleale, in nuvolette
simili a nebbia.
Nel pomeriggio, sopra al Giarolo si vedono nuvole marmorizzate in bianco e grigio, come dipinte ad acquerello, e accanto, o dietro, altri vapori esili, striati, simili a un gesso cancellato male sulla lavagna.
Cielo sfumato:
marezzi di acquerello,
sbaffi di gesso.
∞
Sabato 29 giugno 2013, dopo pranzo, il cielo è velato, e il sole riesce a malapena a far trapelare il suo sfolgorio dalle nuvole. A più riprese cadono gocce, in un accenno di pioggia.
Opale ardente
nel cielo opaco, il sole.
Gocciola piano.
Vado al Guardamonte per l’inaugurazione della Casetta didattica. Dalla cima scendo agli scavi archeologici. Il bosco e il fitto sottobosco sono più bui per effetto della nuvolaglia. Salgo sulla rupe. Il paesaggio si dispiega ampio come ai tempi dei primi abitanti, e restituisce le stesse antiche emozioni.
Il bosco è scuro
sotto il cielo velato.
Ma dalla rupe
ritrovi lo stupore
dei primi insediamenti.
All’inizio della cengia che sottolinea la cima della rupe, alcuni gonfi e alti cespugli di ginestra colpiscono coi loro petali squillanti e con l’intenso aroma emanato.
Alta ginestra
a globi apre la cengia:
giallo e profumo.
∞
Domenica 30 giugno 2013, finalmente, si svegliano tutti gli insetti dell’estate. Nel pieno giorno, le cicale, sulle piante in basso e nel bosco sopra casa, friniscono forte, e non lasciano più udire i versi degli altri animali.
Frinendo in alto,
coprono le cicale
ogni altro verso.
Subito dopo cena, mentre il Giarolo si scorge nitidissimo in ogni dettaglio, col sole che lo illumina da ovest, si odono le cavallette.
Netto diorama,
di sera, il monte; ortotteri
zillano intorno.
E ancora più tardi, mentre innaffio le lavande della staccionata, e il Giarolo è ormai rosso nell’ultimo sole, si sentono anche i grilli. Subito dopo, il monte rimane livido, mentre, prima di illividirsi anch’essa, una cresta di nubi, che pare la cima del Monte Rosa, spunta velocemente, per pochi minuti, a sinistra della montagna, all’inizio del suo triangolo.
Il sole cala.
Il monte ora si arrossa.
Cantano i grilli.
Fugace marmo rosa
si affaccia verso Varzi.
∞

Bozzetti di luglio e agosto 2013
Incapace di elaborare alcunché stando ad Alessandria, ritrovo spirito di osservazione e voglia di descrivere appena ritorno in Valle. Continuo, così, coi miei esercizi pseudo-giapponesi.
Sera di venerdì 5 luglio 2013, dopo cena. Il Giarolo si erge in un crepuscolo di vago bianco sporco tinto di rosa antico. I campi di frumento, o di altre graminacee, sono ormai tutti gialli, e un po’ giallognoli iniziano a essere anche gli appezzamenti rinselvatichiti. Si sentono vibrare le ali delle cavallette, dei grilli e di qualche sparso imenottero ancora in volo. Come sottofondo sonoro, l’avifauna continua a intrecciare i suoi richiami complessi.
Contorna il monte
crepuscolo rosaceo.
Il giallo cresce
nei campi. Insetti vibrano.
Sferruzzano gli uccelli.
Solo con l’oscurità, poi, si vedono le lucciole: non solo nel bosco sopra casa, ma anche nell’erba del sentiero che sale verso l’ovile del Bruno.
Col buio pulsa,
mobile, uno stellato
tra l’erba e i rami.
∞
Il pomeriggio di sabato 6 luglio 2013, il cielo era di un azzurro più pallido, quasi velato di una sottile caligine. Su di esso, grandi blocchi di nuvole, come zatteroni, si muovevano, con colori dal bianco al grigio scuro.
Nel cielo smorto
vanno le nubi a chiatte
di bianco e grigio.
Mentre andavamo a Lunassi, verso le 19.30, passando da Magroforte inferiore, Magroforte superiore, Costa dei Ferrai e Serra, si osservava un pennacchio di nube bianca, circondato e in parte coperto da altre nubi scure. Suggestivo era l’accostamento tra i pendii illuminati dal sole, coi loro colori, e il tono bluastro delle nubi nel cielo.
Smagliante effetto
tra nube bianca, nembi
e ripe al sole.
Arrivato in paese, ho seguito Via Marchesi Malaspina, una stretta stradina asfaltata che costeggia, da sotto, le case e sovrasta il dirupo che scende al Curone. Lì, verso il torrente, accanto a un capanno avvolto di rampicanti e col tetto di fibrocemento, ho notato una palmetta come quella della piscina di San Sebastiano.
Piccola palma
dalle foglie a stiletto
sotto Lunassi.
∞
Il mattino di domenica 7 luglio 2013, le cicale attaccano a cantare assai presto, già verso le 7.30, quasi il sole desse inizio al loro verso raggiungendo coi suoi raggi i rifugi tra le foglie.
Via alle cicale,
appena il sole tocca
i loro nidi.
Le lavande, adesso, oltre che di imenotteri, sono piene di farfalle (bianche, marrone chiaro, marrone scuro, qualcuna anche nera) che svolazzano attorno. Soffia, per qualche secondo, una brezza che fa staccare e planare al suolo, in un nugolo, le foglie gialle delle robinie.
A un soffio d’aria,
foglie – farfalle gialle –
volano al suolo.
Alberi e cespugli oscillano all’unisono, in una specie di danza diretta dal vento.
Vento coreografo,
fa dondolare a ritmo
alberi e arbusti.
Appena dopo pranzo, nel cielo c’erano nuvole che poi si sono pigramente disfatte, sfilacciandosi, a ovest.
Tenui acquerelli
di nubi, in indolente
sfarsi verso ovest.
Mentre scendeva il buio e io innaffiavo le lavande, sul Giarolo indugiavano nubi pastellate, tra le quali il cielo appariva di un azzurro fosco, da pietra dura (verso Est, invece, le nuvolette erano scure contro un cielo ancora ardente).
Blu di zaffiro
tra le nubi, al crepuscolo,
borda il Giarolo.
∞
Alla mattina di lunedì 8 luglio 2013, quando mi sono alzato, appena dopo le sei, si sentiva un sonoro ronzio sulla pianta di tiglio dei vicini, che intensamente profumava. Sulle lavande, gli insetti erano ancora pochi.
Mattino presto.
Sul tiglio gli imenotteri
ronzano forte.
∞
La sera di mercoledì 10 luglio 2013, sul versante sinistro del Giarolo, un accenno di temporale che si è poi risolto in nulla.
Si affosca il monte.
Qua e là spacchi di folgore.
Rotola il tuono
∞
Mattino di domenica 14 luglio 2013, ore 9.00. Stavolta l’haiku basta da solo.
Sopra il paesaggio
un lieve appannamento.
Il cielo è smorto.
Stesso giorno, ore 11.40.
Nasconde il capo
il Giarolo fra nubi
di tenue grigio.
— o —
Per un po’ di giorni sono stato impegnato in altre scritture. Ma ho ripreso le annotazioni a fine mese. Al mattino di mercoledì 31 luglio 2013, verso le 7, scendendo a valle, il borgo di Restegassi appare ancora in ombra, perché il sole rimane basso dietro il crinale.
Le case bianche
di Restegassi attendono
il primo sole.
∞
E, i giorni di martedì 30 e mercoledì 31 2013, una mietitrebbia rossa stava lavorando nel grande campo accanto a Vigana, tra la frazione e il sentiero per Dernice, a sinistra sopra la sorgente: come per le ginestre, con un mese di ritardo rispetto alla tabella di marcia normale (il grano è generalmente pronto verso il giorno dei SS. Pietro e Paolo).
Accanto al borgo
soltanto a fine luglio
mietono il grano.
∞
Domenica 10 agosto 2013, verso le sette del mattino, ma poi anche durante buona parte della mattinata (col velo che tendeva a dilatarsi e a farsi più impalpabile), un lago di filamenti nebbiosi intrecciati ricopriva tutta la conca di Restegassi e si prolungava, sempre più lieve, passando sopra Bregni, fino a destra della frazione, quasi a rimarcare l’intera mole del Giarolo. Il cielo era purissimo.
Su Restegassi
fitta garza di nebbia
sfuma oltre Bregni;
con un cielo purissimo,
sottolinea il Giarolo.
A notte, dopo la pizzata coi vicini, ci siamo sdraiati a terra sugli asciugamani da spiaggia, di fianco alla stalla che ci schermava i lampioni, per guardare il cielo di San Lorenzo. Ho visto due piccole, rapidissime meteore scivolare fra gli astri: chissà se esaudiranno i desideri affidati loro…
Due tenui e effimere
scie uniscono le stelle
recando auspici.
∞
Domenica 17 agosto 2013, nel pomeriggio, dopo essere salito (sabato 16) sull’Ebro, ho fatto una passeggiata fino alla Rivarossa e, tornando, sul Barilaro. Nelle parti boscate del sentiero, anche lungo il tratto che aggira il monte e scende all’inizio della sterrata per Costa Merlassino, diversi tronchi di castagni, deformati e contorti dalla veneranda età, parevano enormi feticci pellerossa.
Castagni totem
ai lati del sentiero,
carichi d’anni.
∞
Martedì 19 agosto 2013, verso le 6.15, ad Est (guardando dalla stradina della Piana, sopra il tetto di casa), un livido ammasso sfilacciato di nubi bioccose, quasi a pecorelle, era tinto di rosso, nelle superfici esposte ai suoi raggi, dal sole nascente.
Sole che sorge:
su scure nubi a biocchi
spennella il rosso.
∞
La sera di domenica 24 agosto 2014, è scoppiato un violento temporale. Nubi scurissime sul tratto di cielo sopra il cimitero. Lampi vicini e tuoni fragorosi.
Fosforo crepa
il livido dei nembi
sul cimitero.
∞
Dopo i temporali serali di domenica 24 e lunedì 25 agosto 2013, martedì 26, verso le 6.15, pareva autunno. Le luci di Vigana tralucevano dalla nebbia (o dalla nube), offuscate come in pianura a novembre. E tutto, attorno, era filtrato dalla caligine. Quando sono partito, verso le 7, la compattezza della bruma si era aperta e il sole giocava con le velature sparse, sopra e sotto casa, dando a questi appannamenti colori diversi, dal giallo zolfo vagamente marroncino al livido. Svoltata la prima curva a sinistra dopo la frazione, mi sono trovato immerso in una soluzione di anice, che è durata fin dopo Fontanelle, dove il sole ha acceso tutto l’ambiente di una luce opalescente e dorata, in cui le particelle d’acqua sospese facevano da catarifrangente, da moltiplicatore.
Primo mattino:
velo di bruma. Quindi
il sole squarcia,
variopinge i vapori,
irradia opalescenza.
∞
Il mattino di venerdì 29 agosto 2013 è l’ultimo nel quale sono partito da Vigana per venire in ufficio. Quando mi sono alzato, il sole non aveva ancora varcato il crinale ad Est, verso Varzi, ma vi erano, sparse in tutto il cielo, nubi allungate e sfilacciate, assai lievi, che riflettevano la sua luce: in verità più rossa che rosea, anche se Omero ha ripetuto, sia nell’Odissea che nell’Iliade, il verso formulare “Quando, mattiniera, apparve Aurora dalle dita di rosa (rododàktylos Eos)”. Ma nell’Iliade aveva anche detto “Aurora dal peplo di croco (krokòpeplos Eos)”, facendo pensare piuttosto al colore tra giallo e rosso-bruno dello zafferano e di alcuni preparati chimici, come il cinabro (o solfuro mercurico: HgS). Saffo, nel suo raffinato dialetto isolano, si limita a definirla “lucente Aurora (faìnolis Auos)”.
Strisce leggere
di nubi in tutto il cielo,
rosse d’aurora.
∞
Per concludere il mese e il soggiorno in Valle, domenica 31 agosto 2013 ho voluto camminare sui monti attorno a Bruggi, che non avevo ancora percorso.
Dal paese sono salito, un po’ a casaccio, verso Est, tra pinete e faggete. Una capanna di tronchi e di assi grossolanamente squadrate ricordava quella di Thoreau a Walden Pond, per dimensioni e struttura (dentro, una tavola lunga con panche, una stufetta in ghisa, un ripiano – addossato alla parete – sul quale ci si può anche sdraiare).
Ho salito faticosamente ripidi pendii, anche dove non trovavo tracce umane cui affidarmi, fino al Monte Rotondo (1568 metri). Ho seguito in saliscendi (sotto gli alberi del crinale, ove il sentiero corre pianello, pozze di fango) la Via del Sale. Ho quindi abbordato il Chiappo (1700 metri), la cui cima appariva nascosta in una nube livida. Ho mangiato qualcosa ai piedi della statua di San Giuseppe, poi ho proseguito fino al Prenardo (1654 metri) e alla Bocca di Crenna, da dove sono ridisceso a Bruggi per la lunga e tortuosa carrozzabile inghiaiata alla quale si unisce la pista del Rifugio Orsi.
Duro sgambare
sui monti attorno a Bruggi,
lungo salite
di pini e faggi, fino
al Chiappo nella nube.
—
Nella pineta
un capanno di tronchi
ricorda Walden.
∞

Haiku 2014
Lunedì 6 gennaio 2014 sono andato a Vigana per fare qualche lavoretto e concedermi alcune ore di solitudine e silenzio (senza neppure il telefonino) all’aria pulita di lassù. Ho spostato una piantina di lavanda, penalizzata dall’ombra dei ciuffi più grandi, per sostituire una di quelle messe a dimora la primavera scorsa, che, dopo aver fatto i suoi fiori, è inspiegabilmente seccata. Ne è seccata anche un’altra, vicino a lei; tutte le altre hanno invece attecchito. Ho carezzato un po’ di lavande e di rosmarini. Il profumo che i cespi emanano toccandoli è benefico. E credo che il beneficio della carezza lo avverta anche la pianta. Il tatto come veicolo di positività… Mentre percorrevo il viottolo che dalla provinciale sale ripido a casa nostra, ho visto la corolla di una pratolina (Bellis perennis) biancheggiare sul verde dell’erba.
Epifania:
una margheritina
sull’erta erbosa.
∞
Domenica 9 febbraio 2014 ho approfittato del sole del pomeriggio per una gita a Vigana. In tutta la Valle l’acqua colmava i fossi e a volte traversava a rivoletti la provinciale. Salendo da San Sebastiano, poco prima della casa del pittore Bagnasco, a Fontanelle, uno smottamento di terra invadeva il lato sinistro della carreggiata. Anche a Vigana, a una decina di metri dal cartello che precede la curva a gomito, il terreno era franato verso valle, e un pezzo di asfalto aveva ceduto. Il cielo era di un azzurro nitido. Soffiavano sbuffi d’aria, abbastanza freddi. L’acqua ruscellava tra l’erba in pendio, a fianco della strada, e gorgogliava nel tombino sotto il grande cespuglio di more. Filava rapida lungo la cunetta. Il Giarolo, nelle radure delle pendici e sui prati di vetta, appariva luminoso di chiazze innevate.
Cielo pulito.
Nei chiari del Giarolo
cenci di neve.
Rivoli d’acqua e d’aria.
Smotta il terreno intriso.
∞
Domenica 23 febbraio 2014 sono andato a Vigana per sostituire la compostiera. I cespugli di lavanda si mostravano proni, così li ho legati alla staccionata per tenerli su. Ho pulito dalle erbacce le lavandine della staccionata nuova. Ho riposizionato ai lati della porta le piccole tuie in vaso. Nei punti dove il sole batteva con più insistenza, si vedevano le corolle delle viole, disposte come se qualcuno avesse spruzzato macchiette del loro colore. Tra l’erba del prato, già di un bel verde luminoso, erano fiorite le margheritine. Il Giarolo si mostrava appannato dalla foschia, ma il cielo era azzurro e il sole caldo. La neve indugiava ormai solo sui prati attorno alla vetta.
Monte appannato.
Sui prati del crinale
neve residua.
Spruzzi di viole al sole.
Pratoline nell’erba.
∞
Domenica 2 marzo 2014 sono voluto andare a Vigana con l’intenzione di mettere mano a qualche lavoretto, come falciare i prati o pulire la fila di lavande e rosmarini ai piedi del muro. Ma ho trovato una sorpresa… L’intero paesaggio, compresa la rupe dietro casa, sembrava un presepe: la neve velava, o chiazzava, o impolverava di bianco tutte le superfici non protette dagli alberi, o sulle quali gli alberi crescevano più radi. Il cielo era coperto di nuvole irregolari, bruscamente sfumate. Nelle nubi era celata anche la punta del Giarolo, le cui pendici venivano colpite, di quando in quando, da prolungati sprazzi di sole che le accendevano di una nitida tridimensionalità. Attorno, una stereofonia di acque stillanti. Mi sono seduto guardando il monte, e ho scritto:
Giarolo acefalo.
La neve segna ovunque
le aree scoperte.
Il cielo è marezzato.
Gocciola tutt’attorno.
∞
Sabato 8 marzo 2014. Finito di pranzare, e tra un lavoro di giardinaggio e l’altro, posso sedere al sole a torso nudo, leggendo pagine di Walden. Alzo gli occhi al Giarolo: la neve indugia abbacinante sui prati di vetta e in tutte le sfumate radure del versante nord. Più tardi, i raggi sghimbesci del tramonto stendono sulla cima e sulle pendici una solenne velatura violacea.
Neve nei chiari
sul lato nord del monte;
il sole avvampa
quando è alto, ma al tramonto
lo tinge di vinaccia.
∞
Venerdì 14 marzo 2014. I mandorli (uno a Fontanelle e i due sopra la nostra aia) sono le sole piante fiorite che ho visto in Valle. Il Giarolo è velato dalla foschia, di giorno e di notte. La luna, piena e alta, illumina l’intero paesaggio. Quando parto per l’agriturismo, un tasso (Meles meles) sta acquattato sulla stradina verso la Piana, col furbo musetto a strisce e gli occhietti vispi. Appena mi avvicino, si arrampica agilmente su per la ripa dei fichi d’India. Lungo la provinciale, il cartello di Vigana è ormai franato anch’esso, sprofondando verso il campo del Bruno.
Mandorli in fiore.
Giarolo nei vapori.
La luna è piena.
Un tasso sul sentiero.
Smottato anche il cartello.
∞
Sabato 15 marzo 2014. Mentre scendo a San Sebastiano per la spesa, noto che la Natura è ancora ferma, in generale, e infatti le roverelle conservano sui rami le foglie secche. Già al mattino presto, l’aria era mossa da sbuffi di brezza, anche abbastanza vivaci. Il sole è velato da nuvole discontinue, e l’intero paesaggio è appannato, con una leggera caligine che incombe su di esso.
Le roverelle
mantengono il fogliame.
Brezza animata.
Screziature di nubi.
Lieve foschia su tutto.
∞
Sabato 29 marzo 2014, la Valle è piena di germogli, sugli alberi e nei prati. I pescheti sono tutti rosa, come nella pantomima del secondo episodio del film “Sogni”, di Akira Kurosawa. I cespugli selvatici paiono esplosi in nuvolette di petali bianchi. A casa, sento il ronzio dei primi imenotteri, sulla legna del fienile e sui fiori dei rosmarini, e, tutt’attorno, gli strumenti musicali di tanti uccelli diversi.
Teneri verdi.
La danza giapponese
dei peschi in fiore.
Sbuffi bianchi i cespugli.
Ronzii. Flauti di uccelli.
∞
Domenica 30 marzo 2014. Dopo aver terminato i lavori in giardino, sistemando le lavande (che stanno poco a poco riprendendo vita), e dopo aver frugalmente pranzato, mi sdraio sotto un sole velato di nubi caliginose, con una brezza appena percettibile, di fronte a un paesaggio reso sbiadito dalla foschia. Seguendo le ondate del dormiveglia, mi giungono alla coscienza i richiami primaverili, fittamente intrecciati, degli uccelli, e il sibilo lievissimo dell’aria fra i rami.
Leggera brezza.
La lavanda si sveglia.
Paesaggio smorto.
Sonnecchio al sole opaco
e ascolto la Natura.
∞
Domenica 6 aprile 2014, arrivando a Lunassi un po’ prima dell’una, osservo il cielo interamente velato da una foschia leggera e irregolare. Qualche rara nuvoletta in giro. Sulla parte sommitale del monte che si affaccia a sudest del paesino, la neve continua a ricoprire gli spazi aperti, ed è luminosa di sole.
In tutto il cielo
caligine screziata.
Poche le nubi.
La neve ancora brilla
a sudest, sul crinale.
Alle 15 esco dal Circolo. Il cielo mi pare più pulito, ma le nuvole stanno aumentando, verso sudest (a partire dalle 17.30, a Vigana, sentirò qualche sporadico rombo di tuono provenire in direzione del Giarolo). Si odono cantare gli uccelli, e la voce liquida del Curone che sale dallo strapiombo a sud. Le piante stanno buttando il fogliame novello e sono in piena fioritura.
Nubi in arrivo.
L’azzurro è un po’ più terso.
Canti di uccelli.
Lo scroscio del torrente.
Attorno, verde e fiori.
Per andare a Vigana, valico a Serra e attraverso Costa dei Ferrai e Magroforte. Scendendo verso Montacuto, vedo la falda del Giarolo, che dichina alle poche case, disseminata di chiazze variopinte, verdi (in varie gradazioni), bianche, fulve, marroni, grigie, come schizzate dal pennello di uno scaltrito paesaggista.
Scavalco a Serra.
Spruzzi multicolori
su Montacuto.
∞
Sabato 12 aprile 2014 vado su a Vigana per piantare un Caco-mela e per fare un po’ di manutenzione al giardino. La valle è ormai in preda ai mille verdi della primavera. Terminata la fioritura rosea dei peschi, sono adesso i meli a impennacchiarsi di bianco. Il Giarolo si mostra torbido, incorniciato da un ammasso nuvoloso.
Sommerge tutto
un profluvio di verdi.
Meli fioriti.
Sul Giarolo impigliate
nubi grigie e foschia.
Quando esco dall’agriturismo, la luna proietta sulla caligine che la vela un ampio cerchio luminoso, dall’orlo quasi iridato. Il vertice del Giarolo sfuma nell’invisibilità. Arrivato a casa, avverto il soffio gradevole di un venticello leggero, che però non riesce a liberare il cielo notturno dai suoi tediosi fumi.
Luna alonata.
La punta del Giarolo
non si distingue.
Soffia dolce la brezza
senza pulire il cielo.
∞
La mattina di domenica 13 aprile 2014 il cielo è coperto. Prima che io scenda a San Sebastiano per qualche acquisto, iniziano a cadere goccioline impalpabili. La montagna rimane bluastra di foschia. Gradualmente, le nubi si fanno dense e scure, e la coprono del tutto.
Fine pioviggine
da un cielo grigio chiaro.
Giarolo fosco.
Poi il nuvolo si addensa
e copre la montagna.
Nel primo pomeriggio il tempo si schiarisce. Il Giarolo non si sgombra ugualmente.
Trapela il sole.
Si alleggerisce il cielo.
Cresce la luce.
L’azzurro si fa spazio,
ma il monte resta opaco.
Il sole riemerso ha però l’effetto di far sbocciare di colpo un intero zodiaco di stelle di Betlemme (Ornithogalum umbellatum) in vari punti della salita erbosa tra la Provinciale e il lato sud di casa nostra. Ieri ne avevo vista una sola, sul bordo del prato delle lavande.
All’improvviso
le stelle di Betlemme
sulla salita.
— o —
Nelle vacanze di Pasqua (17-21 aprile 2014) ho annotato alcune immagini, che non hanno bisogno di particolare commento.
Giovedì 17 aprile 2014, dalle 20, ora a cui sono arrivato, alle 22, quando sono andato a dormire)
Giarolo viola.
La sera oscura avanza
nel cielo puro.
Sfolgorano le stelle
e un’aria preme fresca.
∞
Venerdi 18 aprile 2014, ore 10.45, di ritorno da San Sebastiano)
Fruscio di vento.
Il canto del cuculo.
Abbaia un cane.
Liquidi cinguettii.
Ronzii sui rosmarini.
Verso le ore 17.00, durante una passeggiata nel bosco sulla rupe
Vento molesto.
I trilli degli uccelli
quasi zittiti.
Il sole filtra appena
e nega il suo tepore.
∞
Sabato 19 aprile 2014, verso le 10.00, scendendo a San Sebastiano; è poi piovuto tutto il giorno
Pioggia insistente.
La nuvola ci avvolge.
Ma a Restegassi
si scende sotto l’orlo
e la visuale è nitida.
∞
Domenica 20 aprile 2014, Pasqua, verso le 10.00, sul prato dell’aia
Riapparso è il sole.
Sui fili d’erba, iridi.
Azzurro a cirri.
Pennacchi sul Giarolo.
Vociano uccelli e insetti.
Stesso giorno: dopo aver pranzato fuori, al calore del sole, il tempo è tornato cattivo
È fredda, l’aria.
Nubi livido-grigie
e luce avara.
Sui prati della vetta
la neve è ricomparsa.
Stesso giorno, dalle 18.00 alle 21.00
Fa quasi freddo.
Giarolo incappucciato,
nubi bioccose
e cupe intorno, gocce…
ma solo a notte piove.
∞
Lunedi 21 aprile 2014, Lunedì dell’Angelo, ore 8.30 – 9.00, guardando verso Bregni e la base del Giarolo)
Cielo biancastro.
Vapore scorre a biocchi
sui boschi acclivi.
Giarolo cancellato.
È umido, ma non sgronda.
Stesso giorno, ore 15.30, passeggiando lungo la stradina asfaltata della Costa, sopra Vigoponzo, guardando attorno cime più o meno alte, tutte nascoste dai lembi inferiori della nuvolaglia
Un’aria lieve
movimenta le nubi
di grigio e bianco.
Le vette, dalla Costa,
svaniscono offuscate.
Stesso giorno, ore 16.00, proseguendo fino a Caviggino, ma anche più tardi attorno a Bregni
Dalla stradina
si odono i primi grilli
in mezzo ai prati.
∞
Giovedì 24 aprile 2014, arrivando a Vigana alle 19.45, ma anche più tardi, col buio
Anche qui a casa
scampanellano i grilli
nell’imbrunire.
∞
Venerdì 25 aprile 2014, verso le 14.00, coricandomi sul cemento verso sud, infastidito dai moscerini
Sole velato.
Pigolii multiformi.
Moschini addosso.
Stesso giorno e posizione, tra le 15.45 e le 17.15
Tuoni ad oriente;
nubi livide e gonfie
lì e sul Giarolo.
Vanno a coprire il sole
e piove: non per molto.
Stesso giorno, lasciando San Sebastiano, alle 18.45
Le chiome d’albero
sono nuvole verdi
sulla collina.
∞
Giovedì 1° maggio 2014, ore 15.30. Da Brignano in qua, il cielo è a nuvole mosse. Al sole si accompagnano, a tratti, piccoli scrosci, o una leggera pioviggine. Una volta a Vigana, sento tuonare da ammassi livido-bluastri sia a est che a ovest, mentre il soffio d’aria è quasi impercettibile, e tiepido. Mi viene in mente il proverbio dialettale che mia nonna mi ripeteva da piccolo, e che mi lasciava perplesso, spingendomi ad immaginare (all’epoca, prendevo alla lettera tutto quel che mi veniva detto) il sarto del paese inspiegabilmente innervosito dalla meteorologia: “Quanch’ el piöva cu gh’è u su, l’è e’ rabia di sartù”.
Piove e c’è il sole:
“É la rabbia dei sarti”
diceva nonna.
L’acquerugiola è lieve,
la brezza blanda e mite.
Stesso giorno, alle ore 19.00, dopo aver pulito le lavande dalle erbacce
Qualche ginestra
abbozza i primi gialli
lungo la rupe.
Stesso giorno, ore 22.30, tornando dall’agriturismo
Non c’è la luna.
Le stelle nette tremano,
ma è buio pesto.
Sulla strada, una lepre
prima di Fontanelle.
∞
Venerdì 2 maggio 2014, ore 7.50
La nebbia ammanta
di spire le pendici
e cela il monte.
Il cielo è un grigio mosso.
Crepe di chiaro a sud.
Stesso giorno, ore 9.06-10.00
La nebbia lievita,
ricoprendo i crinali.
Umido e grigio
intridono le ossa.
Solo alle dieci piove.
Nel tardo pomeriggio, ore 18.00
Per tutto il giorno
pioggia costante e fine.
Biocchi di nebbia
nascondono le chine
e la cima del monte.
∞
Sabato 3 maggio 2014, ore 10.30 – 11.00
Il sole scalda
ma il monte è inturbantato.
Cirri e altre nubi
chiaroscurano il cielo,
turchese dove appare.
Stesso giorno, ore 14.00
Un po’ di vento
spazza le nubi e asciuga
l’erba e il terreno.
Dopo cena, alle 20.30, vado a fare una passeggiata con Ester, seguendo lo stradone fino a dopo la curva a gomito verso Dernice, e poi, scendendo attraverso il sentiero, tra le case della frazione. Notiamo che un aereo lascia una scia livida, del colore delle nubi, e sentiamo tuonare verso nord-ovest, verso Tortona: dove, infatti, in quel momento fa temporale.
Sopra il Giarolo
cartine al tornasole
di nubi: rosa,
e livide d’intorno.
La luna è al primo spicchio.
∞
Domenica 4 maggio 2014, durante quasi tutta la giornata. Il cielo e l’aria erano pulitissimi, le nubi michelangiolesche. L’intero, curvo paesaggio, che saliva da Bregni al monte e ai crinali, appariva bulinato a rilievo dall’effetto tridimensionale dei chiaroscuri di sole e ombra.
Cristallo azzurro.
Gonfi marmi di nubi
sopra il Giarolo.
Il verde, in sole ed ombra,
dà volume ai versanti.
∞
Domenica 11 maggio 2014, a Vigana per qualche piccola faccenda domestica. Trovo le ginestre, sulla riva che sale a destra, dopo Fontanelle, già coi primi fiori; lo stesso avviene per quelle disseminate lungo tutto il versante sud della rupe, dietro casa nostra (ore 12.00).
Ginestre schiuse:
passata Fontanelle;
qui, per la ripa.
Stesso giorno, ore 14.30 – cade persino qualche piccola goccia
Il vento romba
e agita i rami; grigie
nubi diffuse.
Poco più tardi, ore 14.50, il vento sposta qua e là le nuvole, comprese quelle sul Giarolo: che però, pur piegandosi, rimangono ancorate alla montagna
Sul monte ondeggia
un berretto di nubi
che non si sfila.
Ma la situazione evolve rapidamente, non appena il vento muta direzione – ecco, alle ore 15.40
Girando, il vento
sta ripulendo il cielo,
anche sul monte.
Ore 15.55, guardando in su dall’angolo di casa verso il muraglione
Sopra la rupe,
il cielo è blu profondo,
tra un ramo e l’altro.
Ore 17.40, il Giarolo dà quasi l’impressione di essersi ingrandito nel sole: che, a quest’ora, lo investe dritto, senza chiaroscuri
In puro verde
ipertrofico il monte
al tardo sole.
∞
Sabato 17 maggio 2014, arrivando in Alta Valle, verso le 16.45;
Giarolo torbido
e ombrato dalle nubi.
Sul resto, il sole.
Appena finito di lavorare in giardino, verso le 19.30:
Il sole spalma
sul monte, un po’ appannato,
i tardi raggi.
Una piccola passeggiata, dopo cena, ore 21.00:
Mareggio scuro
del vento fra le piante.
Nuvole grigie
incoronano il monte.
Si odono grilli e uccelli.
∞
Domenica 18 maggio 2014 mi sveglio presto. Esco verso le 5.00 a dare un’occhiata.
Nel cielo puro
luna calante e Venere.
Albori ad est.
Col vento che persiste
il monte si è snebbiato.
Passato appena un quarto d’ora, alle 5.15:
Subito dopo
il pianeta sparisce.
Cinguettii intorno.
Faccio ancora un po’ di lavori, rifinendo l’erba e pulendo lavande e rosmarini; ore 10.40:
Fiocchi di nubi
incandescenti al sole
sopra il Giarolo.
Sempre lavorando, ore 11.00, le ginestre mi fanno venire in mente i versi di Leopardi
Il primo, dolce
profumo di ginestra
consola, al vento.
Mi siedo finalmente al sole, a leggere Lavorare stanca, di Pavese. Alzo gli occhi ripetutamente e osservo la stessa cosa: ore 11.45, ore 12.55… Poi ancora, più volte, nel pomeriggio…
Solo una scia
d’aeroplano, fugace,
graffia l’azzurro.
∞
Domenica 25 maggio 2014, dopo aver votato, salgo a Vigana. Mentre mi preparo il pranzo, verso le 13.00, odo miagolii prolungati e sonori. Nell’aia, la mamma delle nostre gatte e la loro sorella rimasta lassù, quasi uguali all’aspetto, litigano furiosamente, il pelo ritto, le code enormi.
Zuffa tra gatti,
purtroppo madre e figlia.
C’è un lieve vento.
Le nubi si coagulano,
cancellano l’azzurro.
Ore 14.30:
Appena il vento
cheta, il sole traluce
e, un poco, scalda.
Ore 16.30, mentre accudisco parte delle lavande
Tra i cespi in fila,
lavandine fiorite
di viola intenso.
Ore 18.00: dal retro della casa si ode il cucco emettere, in rapida successione, il suo limpido canto bitonale, seguito come da un ansimare di tosse
Note convulse
del cuculo, invisibile
sopra la ripa.
∞
Domenica 1 giugno 2014, verso le 12.40, arrivando a Lunassi dopo essere passato da Vigana:
Le nubi tracciano
acquerelli di grigio
sopra i crinali.
∞
Lunedì 2 giugno 2014, ore 8.30:
Boccioli gonfi
su tutte le lavande;
ginestre fulgide
di giallo; ai bordi, accese
colonie di papaveri.
Ore 11.00:
Si appanna il monte
sotto un velo di cirri.
Il sole è opaco.
Una brezza si leva,
fa vibrare le foglie.
Ore 11.15:
A poco a poco
i cirri si fan nubi
bianco-grigiastre.
Ore 11.35:
Nuvole calano
e coprono il Giarolo
di nebbia grigia.
Ore 13.00:
Svanisce il monte
in livida foschia.
L’aria è più lieve.
Il cielo è ormai coperto
ma non si odono tuoni.
Ore 14.30:
Il sole si apre
un varco e tutti i verdi
sono esaltati.
Ore 15.30:
Quando è coperto
il sole, la campagna
ha un filtro giallo.
Ore 15.50. Mentre vado, per la Piana, a portare la spazzatura, all’altezza del roveto che avvolge il susino, dove tutti gli anni colgo le more, mi imbatto nella carogna di una Mustela nivalis in avanzata decomposizione; restano intatti i denti aguzzi e la coda a lunghi peli marroni. Qualcuno deve averle sparato, perché è difficile sia morta per altre cause, su questo viottolo:
Passando a piedi,
una donnola morta
sulla stradina.
∞
Domenica 15 giugno 2014, il tempo lacrimoso non mi dissuade dal salire ugualmente, per un po’ d’aria e di pace. Poco dopo l’arrivo, alle ore 15.00:
Con questa pioggia,
il verde si è ripreso
quasi dovunque.
Il monte ha una corona
di nuvole a brandelli.
Ore 15.25. Osservando le aree a prato, vicine e (col binocolo) lontane, noto che, dove l’erba è alta, declina a un ricco color paglia.
Le graminacee
alzano spighe d’oro,
ormai mature.
Ore 15.30. Uno scampanio dondolante sale da Bruggi o da Restegassi, annunciando una funzione.
Su dal pendio
si sentono campane
ondare a festa.
Ore 15.45. Affacciato al parapetto delle lavande, ascolto sonori richiami di volatili provenire dal folto degli alberi da frutto sotto la strada, e un verso gutturale cadere dal cielo. Dietro di me, un imenottero nero e dorato svolazza sulle infiorescenze azzurro-rossastre di un cespo di erba viperina (Echium vulgare).
Tra i rami fitti
gorgheggiano gli uccelli.
Un corvo gracchia
volando alto. Sui fiori
dell’Echium ronza un bombo.
Alle 16.45, il tempo si incupisce sulla montagna, per poi alleggerirsi di nuovo mezz’ora più tardi. Una lievissima corrente d’aria, che arriva da ovest, porta con sé tracce minime di profumi.
Livide nubi
sovrastano il Giarolo.
Nell’aria, un vago
sentore di lavande,
ginestre, erba bagnata.
—- o —-
Martedì 15 luglio 2014. Riprendo cautamente a scrivere qualcosa dopo settimane di silenzio, di sconfortante, penosa sfiducia nelle parole, nella loro capacità di rompere il nostro isolamento, di comunicare il nostro dolore. Una sfiducia taoista: “Il Tao di cui si può parlare non è l’eterno Tao, i nomi che si possono nominare non sono nomi eterni. […] Per questo il saggio si pone al servizio del non agire e pratica l’insegnamento senza parole. […] Quando la fiducia è insufficiente, la fiducia viene a mancare” affermava Lao Tsu. Per la voce in parte ritrovata devo ringraziare le potenti suggestioni naturalistiche del biologo americano David George Haskell, in La foresta nascosta, Einaudi, 2014. Basta accontentarsi del poco che le parole possono fare, e non pretendere da esse cose impossibili. Ad impossibilia, nemo tenetur stabiliva, saggiamente, il Diritto romano: nel Codice giustinianeo e forse già da prima, agli esordi dell’Urbe. Anche Haskell, del resto (che a pag. 4 cita un detto del “filosofo taoista cinese” Chuang Tzu e a pag. 105, direttamente, una riflessione di Lao Tsu), pur usandole con notevole abilità, è abbastanza scettico verso le parole: “Mettiamo a tacere la nostra incapacità di capire nel solito modo: soffocandola con le parole” (pag. 101).
Ho annotato questo alle 13.30, seduto nel prato a sud:
Per tutto il giorno,
lavande piene d’api:
al peso, oscillano.
Bianche, tigrate o d’ocra
– ma lievi! – le farfalle.
Un po’ più tardi, verso le 15, camminando tra il prato sud e la staccionata che ho posizionato lo scorso anno:
Ecco, riappare
l’insetto colibrì
che liba in volo.
Sulle lavande nuove
farfalle marron scuro.
(E pazienza se viene in mente il “brutto tinello marron” di Paolo Conte…).
∞
Domenica 3 agosto 2014. Avrebbe dovuto essere la giornata della festa annuale sul Giarolo, ma una pioggia temporalesca, con lampi e tuoni, bagna l’intera zona fino alle dieci del mattino passate. Solo alle 10.30, quindi, mi metto in movimento. Vado in macchina a Borgo Adorno, e imbocco una ripida mulattiera che parte di fianco al Castello. Ore 11.30:
Da Borgo Adorno
mi inerpico alle Stalle.
Nei boschi fitti
il sentiero è di un fango
che fa pesanti i piedi.
Appena dopo le Stalle il viottolo si ricollega alla stradina che monta da Giarolo, anche questa intrisa maggiormente di pioggia nei punti ombrati dagli alberi. Ma, anziché essere appiccicoso e attaccarsi alle scarpe, il suolo è qui un limo viscidissimo. Ore 12.00:
Si sale, a tratti,
su mota scivolosa:
fatica e rischio.
Ore 12.45:
In cima al monte
un’aria fredda. Stracci
di nubi bianche
si stendono a nascondere
la valle, verso casa.
Per evitare il pericolo di rovinosi capitomboli dovuti al fango, decido di scendere passando dal rifugio dei Piani di San Lorenzo, visto che quel sentiero, secondo quanto mi dice un’escursionista appena salita, è asciutto. Composita (conifere di almeno tre varietà, frutto di piantumazioni mirate; faggi, roveri, sottobosco…) e bella la vegetazione ai lati del percorso.
Ore 14.00:
Scendendo, per i
Piani di San Lorenzo,
pini a sinistra,
a destra latifoglie.
Il sentiero è pietroso.
∞
Martedì 5 agosto 2014, prima delle 20.00, vado a Lunassi per la presentazione del libro Le erbacce nel piatto, dell’amico e collega Carlo Fortunato.
Luna a Lunassi,
crescente sul crinale
ancora al sole.
∞
Venerdì 8 agosto 2014. Accompagno Ester e la sua amica fino alle cascine abbandonate della Crosa, in un viluppo di erbe spinose che hanno invaso l’antica stradina, nel tratto finale non più utilizzata da nessuno. Gli edifici sono in rovina, ma il primo, arrivando, doveva essere una bella costruzione, perché, pur essendo in pietra, presenta una riga di mattoni decorati, a sottolineare la cimasa. Divalla, con una parte del corpo, verso l’ampio incavo del fossato (la “crosa” propriamente detta). Annoto accanto a esso, verso le 17.00:
Giù nella Crosa,
tra rovi e piante irsute,
rami di fico.
∞
Domenica 10 agosto 2014. La notte di San Lorenzo coincide con la luna piena, di dimensioni insolite, in quanto, per ragioni di rivoluzione, più vicina alla terra. Appena sorta, lungo il cateto sinistro del Giarolo, è di una tonda luminosità dorato-rossastra, poi, progressivamente, si imbianca. Difficilmente si riuscirà a vedere qualcosa. Ore 20.50:
La superluna
a sinistra del monte:
ostia di luce.
Ore 21.30:
Sfregano a ritmo
le cavallette e i grilli
i loro archetti.
Ore 22.00:
Saffo ha ragione:
quando la luna è piena
non vedi stelle.
Solo qualcuna, fioca,
affiora nell’argento
∞
Lunedì 11 agosto 2014, poco dopo essermi alzato, facendo gli esercizi mattutini. Ore 6.20:
La luna, scesa
sull’acquedotto, affonda
dietro il crinale.
∞
Domenica 31 agosto 2014, verso le 9.45, poco prima di partire per il ritorno in città, scrivo quanto avevo osservato il giorno prima, a proposito delle lavande lungo il muraglione (tutte, eccezionalmente, riammantatesi di viola, seppure con petali meno fitti) e del vecchio rosmarino: che, come le due santoregge (Satureja hortensis, chiamata anche erba pepe, per il sapore), piantate tra esso e la porta della stalla, appena fuori dall’ombra del fico, è costellato di corolle – azzurre-indaco, il contorto arbusto legnoso; bianche, i piccoli cespi scarmigliati.
In piede al muro,
il rifiorire insolito
delle lavande.
Sbocciati, accanto al fico,
rosmarino e erbe pepe.
∞
Domenica 14 settembre 2014 salgo a tagliare le lavande. Arrivo verso le 11.40, dopo aver fatto un po’ di spesa.
Verde diffuso
fino a San Sebastiano;
da Fontanelle
sulle foglie compaiono
le tinte dell’autunno.
Così il cielo mentre lavoro:
Nubi che passano;
Giarolo incoronato;
azzurro intenso.
∞
Domenica 5 ottobre 2014. Vado a Vigana per prendere un po’ d’aria – e di quiete. Il viale di San Sebastiano comincia a tingersi della stagione. Ore 11.10:
Robinie e tigli
si dorano pian piano
lungo la strada.
Salendo, appena passata la frazione Poldini e il suo torrente, grandi fiori giallo sole ai due lati, ore 11.15:
Topinambours
illuminano i fossi
dopo l’Arzuola.
Prima e dopo Fontanelle, attorno alla Provinciale (ore 11.20):
L’autunno spruzza
di gialli, rossi e viola
tutte le rive.
Quando scendo dalla macchina – ma poi anche per l’intero pomeriggio – il monte è coperto di caligine, più o meno scura e densa, secondo il momento (annotazione ore 15.00):
Giarolo fosco,
nascosto dalla nube
fino alla Costa.
Mentre pulisco le lavande dalle erbacce, noto che in cima alle spighe che non avevo tagliato è ricomparso qualche isolato fiorellino pentagonale (ore 15.15):
Sulle lavande
sporadiche corolle:
stelline viola.
∞
Domenica 9 novembre 2014, nel pomeriggio: una rapida visita per verificare che lassù tutto sia a posto. Salendo lungo la valle, si vedono gli alberi di pesco con tutte le foglie virate a un luminoso rosso-marrone. Altri alberi, come le robinie, portano ancora un certo numero di foglie, verdine in vario grado di pallore. Altri ancora hanno foglie in diverse sfumature di giallo, o, come i tigli, sono già senza foglie:
Aria appannata.
Pescheti rugginosi
come lamiere.
Il resto: verdi, gialli,
o rami denudati.
Davanti a casa:
I vellutini
allargano corolle
di giallo e rosso.
Dalle nuove lavande:
Giù verso il fico
ha l’erba viperina
steli fioriti.
In fondo alla staccionata:
La yucca innalza
cerose campanelle
riunite a spiga.
Le esplora un freddoloso
insetto nero e d’oro.
Trapela il sole
dalla coltre di nubi,
ma non riscalda.
Avvolto nel grigiore,
è invisibile il monte.
Camminando lungo la stradina della Piana, fino a casa del Renzo:
Azzurra luce
dei fiori di cicoria
vicino al forno.
∞
Venerdì 12 dicembre 2014, verso le 18.00, andiamo alla festa del centenario di Guido Delucchi, all’agriturismo Cà dell’Aglio, sul bordo di un’altura che domina Momperone e l’intera vallata. Usciamo appena dopo le 20.00 e, nel buio, vediamo lo spettacolo che di dispiega sotto di noi.
Da Cà dell’Aglio
le luci nella valle:
un firmamento.
∞

Haiku 2015
Venerdì 2 gennaio 2015 salgo a dare un’occhiata alla nostra casetta. Annoto, verso le 14.30:
Patina bianca
su suolo, e tetti in ombra.
Ma alla Casuzza
il sole ha già un tepore
che annuncia primavera.
Ore 15.00:
Il monte è a curve,
morbide d’ombra e sole.
Traluce il bianco
sulle aree più scoperte
delle falde inferiori.
Ore 15.35:
Attorno a casa
calendule arancione,
Bellis, tarassachi.
Alcuni rosmarini
osano un po’ di azzurro.
Ore 15.50:
Fruscio di vento
tra i rami della rupe:
ora fa freddo.
∞
Domenica 4 gennaio 2015, verso le 15.00, dopo un po’ che sono arrivato alla Casuzza:
Luce argentata
e cielo trasparente.
Scomparso il bianco.
Vado a fare una passeggiata lungo il sentiero sopra la rupe. Ore 16.00:
Vento nel bosco.
A ondate, l’aria fredda
cresce con l’ombra.
Più tardi, un’oretta dopo la scomparsa del sole (lungo il tratto finale della Costa, verso l’acquedotto), mentre sono davanti a casa. Ore 17.20:
Si alza la luna
dal tetto dei vicini,
nitida e tonda.
Richiami in volo annunciano
che la giornata ha fine.
Dopo cena vado a fare due passi (seguendo la provinciale e tornando poi lungo la stradina) fino a Vigana, osservando le decorazioni natalizie: in un paio di case giù a Bregni, dai Semino, da Renzo, da Silvio e lungo i contorni del Castello. Ore 20.45:
Le luminarie
nelle case abitate
e sul Castello.
∞
Lunedì 5 gennaio 2015, dopo aver fatto colazione e riordinato in casa, mi siedo fuori a leggere. Il cielo è intensamente azzurro, ma alcune nubi sfilacciate, sopra il Giarolo, velano il sole, e la temperatura è ancora bassa. Ore 9.25:
Canti di uccelli
nel freddo del mattino,
lontani e limpidi.
Dopo pranzo, mi siedo ancora davanti a casa, a leggere. Ore 13.50:
Gracida un corvo.
Punge a soffi la brezza,
ma il sole è caldo.
L’arco del sole è breve e basso, in questa stagione. Ore 16.00:
Sorto un po’ a destra
della vetta, tramonta
su Vigoponzo.
∞
Sabato 7 marzo 2015 salgo per qualche lavoretto: ripulire dalle foglie morte il prato anteriore e concimarlo; tagliare – in attesa di piantumarne una nuova – una lavanda delle prime che avevo messo a dimora (lungo la staccionata del muro), seccatasi già in autunno; spostare in basso, per l’imminente raccolta, gli ingombranti accumulati. Arrivo alla Casuzza verso le 11, dopo il viaggio in una natura soleggiata ma dormiente e la sosta a San Sebastiano per un po’ di provviste. Il Giarolo e le montagne che si intravedono ai suoi lati brillano di neve, in tutta la loro parte superiore.
Vette abbaglianti
nei chiari e sotto gli alberi
ancora nudi.
Verso le 11.30, mentre porto via lo strame con la carriola:
Bellis nel prato
e uno spruzzo di viole
scendendo al campo.
Passato mezzogiorno:
Cielo smaltato.
Il sole brilla puro,
ma l’aria è fredda.
∞
Domenica 22 marzo 2015, profittando della propizia pioggerella primaverile, salgo a piantumare le due lavande che ho comprato ieri, in sostituzione di quelle morte. Passato Monleale e poi, appena dopo il Robivecchi, a destra:
Gemmati i peschi.
Sul ciglio della strada
viole a manciate.
Arrivando alla Casuzza, verso le 10.30:
Spruzzi di viole,
mandorli nevicati
e pratoline.
A mezzogiorno:
Monte coperto,
ma cielo luminoso.
Campane a festa
e gocciolio di pioggia.
Un cane abbaia in basso.
Ore 12.23:
Raglia un uccello
in cielo, sulla stalla,
e uno squittisce.
Ore 12.25:
Si scopre il monte
con qualche chiazza bianca,
diffuminata.
Ore 12.35:
Accanto al muro
costellazioni azzurre
di rosmarini.
Sui rosmarini
un bombo già banchetta,
malgrado il tempo.
Ore 13.10:
Passata l’una,
il monte è ritagliato
da nubi a brani.
Ore 16.40:
Nel pomeriggio
si è rinascosto il monte.
Grigia pioviggine.
Di sotto, è la vallata
verde luce sommersa.
∞
Sabato 28 marzo 2015. Vado a fare un po’ di giardinaggio. Verso le 10.40, salendo:
Nel fondovalle:
primo rosa sui peschi,
meli ancor fermi.
Ore 11.00, arrivando:
Neve residua
sui pascoli di vetta.
Non una nube.
Quel che vorrei registrare alle ore 17.30 lo aveva già scritto Virgilio, alla fine della prima Ecloga:
Et iam summa procul villarum culmina fumant
maioresque cadunt altis de montibus umbrae.
Posso però cercare di tradurlo in un tanka:
“Lontano, i tetti
dei casolari fumano;
più lunghe scendono
dagli alti monti le ombre”:
così scrisse Virgilio.
Non solo nelle case lontane (a Bregni), ma anche in quelle vicine (Daniela, la Carla) comincia a uscire fumo dai camini.
∞
Domenica 29 marzo 2015. Passeggiando verso Cà Vigino, ore 14.30 (ora legale, appena adottata)
La Val Borbera
spinge un brivido d’aria
lungo la Costa.
Ore 15.00:
Per tutto il tempo
il sole è opalescente
dietro le nubi.
∞
Venerdì 3 aprile 2015 saliamo per la Pasqua. Arriviamo alla Casuzza verso le 11. Nel cielo, sole e nuvole sparse, sfilacciate.
Coi nuovi verdi
si sveglia la lavanda,
pian piano. Azzurri
varî dei rosmarini
in piena fioritura.
Nel pomeriggio, ripercorro il sentiero di Sant’Agostino, trovando, stavolta, il viottolo (ripido, erboso, sconnesso) di raccordo con la viuzza che arriva al Museglia, all’altezza della passerella che doveva essere già allora valico sul torrente, attraverso cui raggiungere il borgo di San Sebastiano – e la chiesa.
Scendendo a Sanse,
ai lati del sentiero,
primule e viole
sbocciate a ciuffi sulla
coltre di foglie secche.
∞
Sabato 4 aprile 2015 esco di casa alle 13.30 e, malgrado la pioggia caduta nella serata di ieri e ancora stamattina, vado a percorrere l’altro ramo del sentiero (che si diparte verso sinistra, a poche centinaia di metri dalla chiesetta iniziale), fino al prato che incombe, da presso, sulla compatta frazione Vallescura di Brignano.
Si aprono gemme
in punta ad ogni ramo
dei boschi spogli.
Nubi di biancospini
rischiarano i roveti.
∞
Lunedì 6 aprile 2015, con un bel cielo azzurro attraversato da rapide nubi, riesco finalmente a dirigermi alla Rivarossa. La provinciale per Montebore è franata, all’altezza del muraglione di sostegno, e il tratto venuto meno lo si percorre varcando un passaggio angusto e sconnesso scavato nel versante della collina. Anche la stradina inghiaiata che porta a Costa Merlassino è segnata dalle frane: parzialmente poco dopo l’inizio; totalmente poco prima del bivio per la Rivarossa, dove il fondo stradale è stato spinto via da un’ondata di bosco che vi si è riversata sopra, sconvolgendo ogni cosa e rendendo assai difficoltoso anche il passaggio a piedi. La ripida carraia che sale a destra, segnalata da una bella freccia blu (“Ripa rossa”), non ha invece subito danni. Ne ricavo un doppio haiku, annotato alle 15.07:
Strade e stradine
sbarrate dalle frane
a monte e a valle.
Da Costa fino
al Monte Barrilaro
percorso intatto.
Alle 16.10, poco prima dei ruderi di Rivarossa, guardo in su, a sinistra, lungo un tratto di sentiero leggermente infossato, e mi tornano alla mente i cactus dipinti da Ennio Morlotti a San Biagio della Cima, stagliati in verde, giallo e nero contro un azzurro carico:
A Rivarossa,
su un cielo morlottiano
arbusti incisi.
Torno indietro e salgo il Barrilaro. Bevo un sorso d’acqua, leggo qualche verso dagli “Ossi di seppia” di Montale, che porto nello zaino (“L’albero verdecupo / si stria di giallo tenero e s’ingromma. / Vibra nell’aria una pietà per l’avide / radici, per le tumide cortecce. / Son vostre queste piante / scarse che si rinnovano / all’alito d’Aprile, umide e liete…”). Poi mi metto a osservare l’imponente veduta che spazia ai miei piedi. Sono le 17.05:
Dal Barrilaro
si domina una trama
di creste, valli
e strade bulinate
fra boschi, rocce, campi.
∞
Domenica 12 aprile 2015. Salendo, dopo Monleale, verso le 9.30:
Distesi in schiere,
spumeggiano di petali
meli e susini.
Alla Casuzza, ore 14.30:
Nebbie bioccose
velano il cielo e il monte
di lunghe garze.
Ogni minima vita
che vedo, mi commuove.
Ore 14.40:
Eco di cani
risale la vallata
a onde rifratte.
Ore 15.00:
Cespi fioriti
di rosmarino, a picco
sul muraglione.
Ore 16.30:
Su rive e fossi,
le “Stelle di Betlemme”,
bianche fra l’erba.
Sbocciate anche le croci
dei “Dollari d’argento”.
∞
Sabato 25 aprile 2015, salgo per alcuni lavori di giardinaggio, ore 11.00:
Le viti fogliano.
Sui filari di meli
ancora i fiori.
Ore 12.00:
Verdi molteplici
spruzzano le pendici
in ciuffi tondi.
Astri di fiori gialli
avvampano nell’erba.
Ore 20.30, scendendo all’agriturismo Cà Bella:
Su Restegassi,
per metà illuminato,
il campanile.
∞
Domenica 26 aprile 2015, ore 6:30:
Tutto il paesaggio
è perso nella nube
che ci ravvolge.
Ore 7.55:
Poi, gradualmente,
la foschia si dilegua,
scopre la vista.
Ore 8.23:
Nel fondovalle
si è raccolto il vapore,
vi indugia inerte.
Ore 8.29:
Ma si riespande
fino a inghiottire il mondo,
come all’inizio.
Ore 9.00
Di nuovo, piano,
riprende a ritirarsi,
svela le cose.
Ore 15.45:
Qualche ginestra,
sul Campo dei Morroni,
ha i primi fiori.
∞
Saliamo, la sera di giovedì 30 aprile 2015, per trascorrere in Valle alcuni giorni, profittando della festività del Primo Maggio. Sono un po’ stanco e avvilito, in questo periodo, e non ho voglia di cimentarmi con inutili parole. Ma qualche momento riesce a superare la fascia grigia, a far giungere lo stesso a destinazione i suoi colori e i suoi suoni.
∞
Venerdì 1° maggio 2015, giornata piena di nubi e di vento molto forte, che costringe a rimanere in casa. Ore 19.00:
Aghi di pioggia
mi spruzza in faccia il vento
scuotendo gli alberi.
∞
Sabato 2 maggio 2015, ore 18.00. Bella giornata di sole. Appena la luminosità si attenua (ma si comportano così anche quando la diminuzione di luce è dovuta al velo di nuvole; allo stesso modo, si chiudono le corolle delle Stelle di Betlemme), i grilli attaccano il loro tremulo frinire.
Nel campo, i grilli
cominciano a scrollare
la sonagliera.
∞
Domenica 3 maggio 2015, mentre faccio i miei lavori di giardinaggio e porto nel campo la ramaglia tagliata, sono circondato dalle complesse, elaborate melodie cristalline di tantissimi uccelli:
Tutto all’intorno
lo spessore intrecciato
di mille canti.
Nel pomeriggio, subito dopo pranzo, faccio una lunga camminata (dalle 12.45 alle 16 passate). Sulla Costa, vado fino oltre Cà Vigino, visitando la chiesetta di Sant’Espedito, aperta. Poi, per una stradina fiancheggiata da roverelle, scendo a Cascina Carrano (e qui trovo aperta la cappelletta di Santa Teresa del Bambin Gesù). Poi, lungo la provinciale, risalgo a Zebedassi e a Vigoponzo, e da qui scavallo di nuovo a Vigana. Parto, per tornare in città, alle 17.15.
Sono una festa
le ginestre fiorite,
seppure poche.
Scendendo, alle 17.20, nei pressi dell’agriturismo, osservo una lama di luce obliqua puntare e trafiggere, con umido effetto iperrealista, una parte del paesaggio – un po’ come nella più famosa poesia di Quasimodo.
Sulla Cà Bella
il sole fra le nubi:
raggio nel bosco.
∞
Sabato 9 maggio 2015. Nel pomeriggio salgo a falciare l’erba attorno a casa. Ore 15.00:
La fioritura
delle robinie, immensa,
vela la Valle.
Ore 15.45:
Che giallo intenso
e che profumo fino
han le ginestre!
Notte fra il 9 e il 10 maggio:
Brillano, fredde,
miriadi di stelle,
nitide e dure.
La luna, già sbreccata,
si leva ad alta notte.
∞
Nel “fine settimana lungo” (e/o “ponte”) del 2 giugno mi occupo del giardino e, soprattutto, sgombero la cantina, in vista della successiva ristrutturazione. Lavoraccio impegnativo e faticoso, che mi lascia comunque l’agio di annotare qualche immagine. Domenica 31 maggio 2015, ore 21.30:
Le prime lucciole
indugiano al riparo
dall’aria fredda.
∞
Lunedì 1 giugno 2015, ore 21.10:
La luna è piena.
Profumo di ginestre.
Gemono i grilli.
∞
Martedì 2 giugno 2015, ore 7.45:
Al sole obliquo
del mattino, il paesaggio
ha più spessore.
∞
Sabato 6 giugno 2015, il clima in città è torrido. Solo verso sera riesco ad affrontare il viaggio. Salgo a innaffiare un po’ di vasi e a cenare (ottimamente, e con in più una bella vista sui colli circostanti, verdi e luminosi, un nostalgico sottofondo musicale dei primi anni Ottanta, e un fresco che rincuora) all’agriturismo Cascina Battignana, di San Sebastiano Curone. Stasera mi sento un po’ Montalbano che mangia da Enzo. Ore 19.40, mentre salgo:
Ha già un colore
di paglia, il grano duro,
oltre San Giorgio.
∞
Domenica 7 giugno 2015, all’alba:
La prima luce
apre liquidi suoni
in mille becchi.
Ore 10.30, dopo aver proseguito il lavoro di sgombero della cantina, mi appoggio alla staccionata che dà sul Campo dei Morroni:
Fiori en pendant
dell’erba viperina e
delle lavande.
∞
Lunedì 15 giugno 2015. Da ci ieri siamo di nuovo trasferiti per l’estate. Il tempo è variabile. Ore 13.30:
Stille di pioggia:
più fredde, per il sole
caldo ed il vento.
Ore 18.00:
More di gelso:
preludio dolce e bianco
ai frutti estivi.
∞
Sabato 20 giugno 2015, nel pomeriggio, mi siedo fuori a leggere il bel libro di Patrick Leigh Fermor (terza e conclusiva parte dell’itinerario europeo a piedi, durato tutto il 1934) La strada interrotta, appena uscito in italiano. La fruizione degli spazi aperti della natura, dei boschi e dei sentieri di montagna, che inebria l’autore di gioia fisica, coincide, così, col mio vissuto. Ore 16.20:
Vibrano a ritmo,
tutt’attorno, gli archetti
delle cicale
∞
Domenica 21 giugno 2015, tornando da una squisita “cena del solstizio” (come non pensare a Valéry? “L’anima esposta alle torce del solstizio, / ti sostengo, o mirabile giustizia / della luce, dalle armi spietate!”) presso l’agriturismo “Cascina Battignana”. Ore 22.30:
Esile luna
crescente. A lampi alterni
vagano lucciole.
Per un po’, non ho più voglia di scrivere. Dal 5 al 10 luglio 2015 torno finalmente in Provenza, ma anche lì, sul momento, nulla mi sorge. Vi scatto, però, diverse foto, e cammino molto.
∞
Sabato 25 luglio 2015, al mattino presto, piove abbastanza forte.
Con l’acquazzone,
riprende fiato, intorno,
l’erba patita.
∞
Non avevo dunque più voglia di scrivere. Però domenica 16 agosto 2015, quando percorro il sentiero della Rivarossa, mi incuriosisce il dosso verde del Gavasa, che non ho mai visitato, e decido di affrontare la deviazione. Ore 16.10:
Salendo il monte,
ovattato silenzio
sotto i castagni.
Ore 16.25:
Ma fra le querce
di vetta, qualche grillo
geme, sommesso.
Mando un messaggino coi due testi al “musagete” Mario, che ne rimane soddisfatto…
∞

Altri haiku
Domenica 19 aprile 2015, nel pomeriggio, arrivo alla Cascina Cerola, nella frazione Franchini di Altavilla Monferrato, per visitare la mostra fotografica “L’eterno messaggio della natura”, una trentina di intensi scatti artistici commentati, ognuno, da parole di scrittori. Imbocco poi un viottolo di terra, che conduce ad una vigna e da qui, attraverso un albereto, si inoltra fra i colli, in mezzo alla “natura” che le immagini esposte evocavano. Ore 15.35:
In fondo al campo, un
carretto abbandonato,
quasi disfatto.
Ore 15.50:
Mormora l’acqua
nel fosso che costeggia
redola e bosco.
Ore 16.00, raccolgo da terra, a diversi metri di distanza l’una dall’altra, tre uova di fagiano, svuotate da qualche predatore:
Sulla stradina,
i gusci grigio-beige
di uova rotte.
Ore 16.22:
Casali incombono
sui fianchi, un po’ scoscesi,
della valletta.
Ore 16.40:
Il basso colle
è una nube, screziata,
di foglie nuove.
Il filare di abeti
al piede è fuori luogo.
Ore. 17.10, tornando verso la cascina, odo latrati festosi, vociare di persone (“Diana!”), sonagli vibranti (prima, un grosso bovino, sdraiato nell’erba, aveva emesso un muggito sonoro e prolungato), e intravvedo, tra gli alberi, un cagnone dal pelo biancastro scorrazzare attorno ad una piccola mandria. Poco dopo, sono due i maremmani, identici, che vengono rapidamente verso di me, scodinzolando, e mi poggiano la testa contro le gambe, chiedendo coccole:
Stanno allenando
due cani da pastore,
con delle mucche.
Ore 17.30, lungo l’ultimo tratto di percorso, quando già si sente assai distinta la musica del trio che si esibisce nell’aia:
Due giovani asini
mi osservano in silenzio,
grigi e pezzati.
“Qué será será” suonano
fisa, chitarra e piffero.
∞
Domenica 24 maggio 2015, nel primo pomeriggio, accompagno mia figlia a Quargnento, per un saggio di ginnastica artistica in occasione della festa del paese, che ricorda i 385 anni trascorsi dalla peste superata. Esco dal concentrico e mi siedo in un prato stabile di steli già maturi, vicino alle ultime case del borgo, a leggere Desert solitaire di Edward Abbey, magnifico racconto di una stagione passata in solitudine, come ranger, a sorvegliare ed osservare la natura selvaggia dello Utah. Annoto verso le ore 15.15:
Nell’aria asciutta
schiocchi di graminacee
scagliano semi.

 Credo che nove italiani su dieci (è una stima ottimistica) non saprebbero rintracciare l’Estonia su una carta geografica. Figuriamoci poi conoscere qualcosa dell’arte estone. Quest’ultima lacuna valeva anche per me, fino a quando non ho visitato una mostra di Konrad Mägi, a Torino, quattro anni fa, l’ultimo giorno utile prima della serrata per Covid. Forse per questo la mostra mi è rimasta così impressa. Ma in realtà credo che i motivi siano altri.
Credo che nove italiani su dieci (è una stima ottimistica) non saprebbero rintracciare l’Estonia su una carta geografica. Figuriamoci poi conoscere qualcosa dell’arte estone. Quest’ultima lacuna valeva anche per me, fino a quando non ho visitato una mostra di Konrad Mägi, a Torino, quattro anni fa, l’ultimo giorno utile prima della serrata per Covid. Forse per questo la mostra mi è rimasta così impressa. Ma in realtà credo che i motivi siano altri.







 Andiamo però con ordine. Roerich coltiva precocemente i suoi interessi artisti e filosofici, e soprattutto frequenta sin da giovanissimo gli ambienti culturali all’avanguardia. Collabora come scenografo e costumista alle messe in scena di Sergej Diaghilev, il creatore del balletto russo, e firma con Stravinsky la scenografia del balletto della “Sagra della Primavera”.
Andiamo però con ordine. Roerich coltiva precocemente i suoi interessi artisti e filosofici, e soprattutto frequenta sin da giovanissimo gli ambienti culturali all’avanguardia. Collabora come scenografo e costumista alle messe in scena di Sergej Diaghilev, il creatore del balletto russo, e firma con Stravinsky la scenografia del balletto della “Sagra della Primavera”.

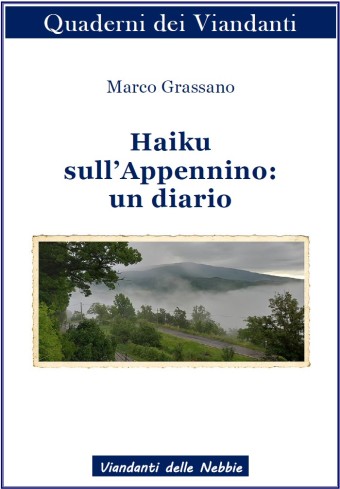







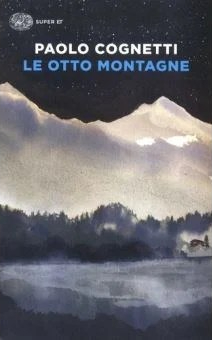 Come nascono dal nulla star della musica, così succede con gli scrittori cult, specie negli USA. In Italia è diverso? non lo so, onestamente, ma facciamo un esempio: prendete Le Otto Montagne di Cognetti. Ditemi voi, che l’avete letto, cosa c’è di nuovo, interessante, curioso, originale in questa storia. C’è poco, molto poco. La storia è trita e ritrita, non sto a ricordarla, chi l’ha letto lo sa. Un rapporto umano che abbiamo già incontrato cento volte nelle nostre letture. Cognetti, nel frattempo, passava da una televisione all’altra, da una intervista all’altra. Diventa un’icona della montagna, da del tu a grandi alpinisti, si confronta con loro come fosse una marmotta nata sul Gran Paradiso. Provate anche a leggere un paio dei suoi libri precedenti, poi ditemi se siamo di fronte a dei capolavori. Accetterò con piacere il vostro punto di vista, e se mi accorgerò di aver avuto torto, mi cospargerò il capo di cenere.
Come nascono dal nulla star della musica, così succede con gli scrittori cult, specie negli USA. In Italia è diverso? non lo so, onestamente, ma facciamo un esempio: prendete Le Otto Montagne di Cognetti. Ditemi voi, che l’avete letto, cosa c’è di nuovo, interessante, curioso, originale in questa storia. C’è poco, molto poco. La storia è trita e ritrita, non sto a ricordarla, chi l’ha letto lo sa. Un rapporto umano che abbiamo già incontrato cento volte nelle nostre letture. Cognetti, nel frattempo, passava da una televisione all’altra, da una intervista all’altra. Diventa un’icona della montagna, da del tu a grandi alpinisti, si confronta con loro come fosse una marmotta nata sul Gran Paradiso. Provate anche a leggere un paio dei suoi libri precedenti, poi ditemi se siamo di fronte a dei capolavori. Accetterò con piacere il vostro punto di vista, e se mi accorgerò di aver avuto torto, mi cospargerò il capo di cenere. All’opposto, La Montagna Vivente, di Nan Shepard; una donna (!!) scrive il suo libro verso la fine della seconda guerra mondiale; racconta le sue escursioni sulle montagne (montagne?) dell’altipiano del Cairngorm in Scozia negli anni 30’ e 40’ del secolo scorso, con la scalata di straordinarie vette alte ben mt. 1307! Eppure, è una zona freddissima, pericolosa e complessa.
All’opposto, La Montagna Vivente, di Nan Shepard; una donna (!!) scrive il suo libro verso la fine della seconda guerra mondiale; racconta le sue escursioni sulle montagne (montagne?) dell’altipiano del Cairngorm in Scozia negli anni 30’ e 40’ del secolo scorso, con la scalata di straordinarie vette alte ben mt. 1307! Eppure, è una zona freddissima, pericolosa e complessa.





 Ci risiamo. L’ho perso un’altra volta. Rallento e mi volto a cercarlo, ma già immagino cosa sta facendo: è parecchio indietro, si è fermato a scattare una foto. In una settimana ha fatto andare tre dozzine di rullini, ha fotografato ogni albero della Foresta Nera, ogni fontana, ogni casolare. Una volta a casa, se metterà in fila tutte le dia scattate potrà rifare il percorso per intero.
Ci risiamo. L’ho perso un’altra volta. Rallento e mi volto a cercarlo, ma già immagino cosa sta facendo: è parecchio indietro, si è fermato a scattare una foto. In una settimana ha fatto andare tre dozzine di rullini, ha fotografato ogni albero della Foresta Nera, ogni fontana, ogni casolare. Una volta a casa, se metterà in fila tutte le dia scattate potrà rifare il percorso per intero.

 Ogni volta che salgo il Tobbio trovo un pezzo di Pietro Jannon. Non ossa o brandelli di equipaggiamento, ché purtroppo non è morto dove gli sarebbe piaciuto, ma spezzoni di memoria, fotogrammi di sentieri percorsi assieme. È capitato anche ieri, quando a metà percorso mia figlia, senza nemmeno allungare troppo, mi ha lasciato ad ammirarne le spalle e il passo deciso e a meditare mesto sul trascorrere del tempo. Ero chiaramente orgoglioso di lei, ma non nascondo che ero anche un po’ avvilito, sia pure considerando il mezzo secolo che ci separa.
Ogni volta che salgo il Tobbio trovo un pezzo di Pietro Jannon. Non ossa o brandelli di equipaggiamento, ché purtroppo non è morto dove gli sarebbe piaciuto, ma spezzoni di memoria, fotogrammi di sentieri percorsi assieme. È capitato anche ieri, quando a metà percorso mia figlia, senza nemmeno allungare troppo, mi ha lasciato ad ammirarne le spalle e il passo deciso e a meditare mesto sul trascorrere del tempo. Ero chiaramente orgoglioso di lei, ma non nascondo che ero anche un po’ avvilito, sia pure considerando il mezzo secolo che ci separa.
 Quando penso a Pietro non posso fare a meno di ricordare l’inverno del 2000. Da parecchi fine settimana con il solito gruppo di amici del CAI di Ovada si organizzavano gite domenicali, solitamente sull’appennino ligure, comunque non lontano da Ovada, onde evitare, il mattino, il viaggio di avvicinamento. È noioso viaggiare la mattina presto nella cattiva stagione, specialmente se sei con la tua macchina, con ancora un po’ di sonno addosso, e i compagni appena saliti sono già riaddormentati, e tu, tra l’incazzatura della mancanza di compagnia e tutte le idee che circolano per la testa in queste occasioni, navighi per raggiungere la meta. Una volta arrivato doverli svegliare ad uno ad uno e sentirti dire che hai posteggiato nel posto sbagliato, in quanto c’era un posteggio più vicino, là dietro l’angolo, che ci hai messo troppo tempo, che prendevi le curve troppo veloci, che la macchina è rumorosa e il riscaldamento non era sufficiente, oppure era troppo alto, e altro ancora.
Quando penso a Pietro non posso fare a meno di ricordare l’inverno del 2000. Da parecchi fine settimana con il solito gruppo di amici del CAI di Ovada si organizzavano gite domenicali, solitamente sull’appennino ligure, comunque non lontano da Ovada, onde evitare, il mattino, il viaggio di avvicinamento. È noioso viaggiare la mattina presto nella cattiva stagione, specialmente se sei con la tua macchina, con ancora un po’ di sonno addosso, e i compagni appena saliti sono già riaddormentati, e tu, tra l’incazzatura della mancanza di compagnia e tutte le idee che circolano per la testa in queste occasioni, navighi per raggiungere la meta. Una volta arrivato doverli svegliare ad uno ad uno e sentirti dire che hai posteggiato nel posto sbagliato, in quanto c’era un posteggio più vicino, là dietro l’angolo, che ci hai messo troppo tempo, che prendevi le curve troppo veloci, che la macchina è rumorosa e il riscaldamento non era sufficiente, oppure era troppo alto, e altro ancora.
 Dice che va in Equador, ma poi depista e prende la corriera per Silvano d’Orba. Si prenota per un pellegrinaggio a Lourdes, poi segue i canterini della S.O.M.S a Riva Trigoso. A Vicenza si confonde con gli alpini al raduno nazionale, partecipa ad una gara non competitiva e raggiunge Bolzano, dove, per via della barba, lo scambiano per Messner e gli propongono un ottomila in apnea. A Francoforte, con un sorriso selvaggio, seduce una hostess della Lufthansa, che gli trova un posto sull’ala di un DC9 per un volo a Lisbona, poi Amsterdam e, finalmente, Quito. Qui, in canoa, scende le rapide del Napo, incontra gli indios che gli offrono banane e da lui imparano a dire “Ciao”. A Riobamba prende il trenino della Cordigliera Real (quello del caffè che suona la samba) e conosce tanti riobambiti. Gli offrono la testa di un nemico surgelata, col leasing; rifiuta cortesemente, insegna a dire “Ciao a tutti” e scende a Guayaquil.
Dice che va in Equador, ma poi depista e prende la corriera per Silvano d’Orba. Si prenota per un pellegrinaggio a Lourdes, poi segue i canterini della S.O.M.S a Riva Trigoso. A Vicenza si confonde con gli alpini al raduno nazionale, partecipa ad una gara non competitiva e raggiunge Bolzano, dove, per via della barba, lo scambiano per Messner e gli propongono un ottomila in apnea. A Francoforte, con un sorriso selvaggio, seduce una hostess della Lufthansa, che gli trova un posto sull’ala di un DC9 per un volo a Lisbona, poi Amsterdam e, finalmente, Quito. Qui, in canoa, scende le rapide del Napo, incontra gli indios che gli offrono banane e da lui imparano a dire “Ciao”. A Riobamba prende il trenino della Cordigliera Real (quello del caffè che suona la samba) e conosce tanti riobambiti. Gli offrono la testa di un nemico surgelata, col leasing; rifiuta cortesemente, insegna a dire “Ciao a tutti” e scende a Guayaquil.

 Pietro Jannon potrebbe essere definito, con un riferimento di carattere letterario, il pittore delle isole. Uno di quegli stravaganti personaggi dei romanzi di Conrad, che innamorato dei mari in bonaccia e delle brevi esili terre che qua e là vi galleggiano come immobili relitti di un naufragio, passano la loro vita vagabonda spostandosi di spiaggia in spiaggia, irretiti ogni volta di più, e ogni volta di più prigionieri, di un gioco di luci e di orizzonti altrove irreperibili. Erano, quelli di Conrad, personaggi alla ricerca della smemoratezza, i quali, lasciatisi alle spalle una civiltà non congeniale, solo sui mari e tra isole del Sud, a contatto con gli aspetti più elementari e violenti di una natura incontaminata dell’uomo, sembravano riacquistare il senso della propria esistenza. Che era un’esistenza vissuta epidermicamente, rinunciataria, talvolta fallimentare e consapevolmente condotta al di fuori di quegli schemi e imposizioni, e soprattuitto impegni, che le società costituite comportano. Ma al contrario di essi, dei vagabondi conradiani, Piero Jannon, pur manifestando anch’egli la vocazione a itinerari insulari e marini, non muove dalla stessa necessità di dimenticanza e di fuga: va anzi alla ricerca della nostra più antica memoria, là dove la civiltà mediterranea conobbe il punto più alto e irripertibile della propria espressione; dove ancora oggi, a distanza di millenni, le pietre e i colori ce ne conservano testimonianza, e l’aria e il paesaggio ce ne tramandano il clima. Il suo è infatti un viaggio che si ripete puntualmente sui mari greci dell’Egeo, tra Patmos e Samos, tra Rodi e Creta: e se, materialmente parlando, rispetta i ritmi lenti della vecchie navi a vapore o il respiro sonnolento delle risacche deserte, la sua cadenza vera, interiore, è sincronizzata su qualcosa di più di quanto l’occhio non consenta di abbracciare: procede all’indietro, verso le origini di ciò che fummo e che ancora oggi, grazie ad allora, siamo. Alla scoperta, cioè, della nostra stessa identità. Su queste terre battute e inaridite dal sole, sprofondate in un silenzio da tragedia consumata, già crocevia di popoli e campi di battaglia, terre finalmente restituite alla quiete della stanchezza e del destino compiuto: su queste terre, Piero Jannon, ritornato alle radici della storia, sembra potercene interpretare – attraverso le immagini di superficie – le pieghe più riposte e segrete.
Pietro Jannon potrebbe essere definito, con un riferimento di carattere letterario, il pittore delle isole. Uno di quegli stravaganti personaggi dei romanzi di Conrad, che innamorato dei mari in bonaccia e delle brevi esili terre che qua e là vi galleggiano come immobili relitti di un naufragio, passano la loro vita vagabonda spostandosi di spiaggia in spiaggia, irretiti ogni volta di più, e ogni volta di più prigionieri, di un gioco di luci e di orizzonti altrove irreperibili. Erano, quelli di Conrad, personaggi alla ricerca della smemoratezza, i quali, lasciatisi alle spalle una civiltà non congeniale, solo sui mari e tra isole del Sud, a contatto con gli aspetti più elementari e violenti di una natura incontaminata dell’uomo, sembravano riacquistare il senso della propria esistenza. Che era un’esistenza vissuta epidermicamente, rinunciataria, talvolta fallimentare e consapevolmente condotta al di fuori di quegli schemi e imposizioni, e soprattuitto impegni, che le società costituite comportano. Ma al contrario di essi, dei vagabondi conradiani, Piero Jannon, pur manifestando anch’egli la vocazione a itinerari insulari e marini, non muove dalla stessa necessità di dimenticanza e di fuga: va anzi alla ricerca della nostra più antica memoria, là dove la civiltà mediterranea conobbe il punto più alto e irripertibile della propria espressione; dove ancora oggi, a distanza di millenni, le pietre e i colori ce ne conservano testimonianza, e l’aria e il paesaggio ce ne tramandano il clima. Il suo è infatti un viaggio che si ripete puntualmente sui mari greci dell’Egeo, tra Patmos e Samos, tra Rodi e Creta: e se, materialmente parlando, rispetta i ritmi lenti della vecchie navi a vapore o il respiro sonnolento delle risacche deserte, la sua cadenza vera, interiore, è sincronizzata su qualcosa di più di quanto l’occhio non consenta di abbracciare: procede all’indietro, verso le origini di ciò che fummo e che ancora oggi, grazie ad allora, siamo. Alla scoperta, cioè, della nostra stessa identità. Su queste terre battute e inaridite dal sole, sprofondate in un silenzio da tragedia consumata, già crocevia di popoli e campi di battaglia, terre finalmente restituite alla quiete della stanchezza e del destino compiuto: su queste terre, Piero Jannon, ritornato alle radici della storia, sembra potercene interpretare – attraverso le immagini di superficie – le pieghe più riposte e segrete.
 A due anni di distanza dalla sua ultima mostra ovadese, Piero Jannon torna dunque a riconfermare la propria validità di pittore che, superando i limiti di un calligrafismo fine a se stesso, riesce a penetrare la sostanza medesima della materia. Il suo linguaggio, da allora, ha acquistato in essenzialità e, contemporaneamente, in spessore. Le sue isole desolate, i suoi mari cupi, le sue brucianti visioni, vengono a restituire anche a noi – insieme alla percezione fisica delle canicole e dei tramonti – il significato più vasto e più impalpabile del tempo: il significato, vale a dire, del nostro dramma quotidiano; la consapevolezza di ciò che è destinato a finire e di ciò che è destinato a sopravviverci. La supremazia di una natura che, in uno splendore di luci e di ombre, già racchiude in sé la compiutezza degli eventi stabiliti.
A due anni di distanza dalla sua ultima mostra ovadese, Piero Jannon torna dunque a riconfermare la propria validità di pittore che, superando i limiti di un calligrafismo fine a se stesso, riesce a penetrare la sostanza medesima della materia. Il suo linguaggio, da allora, ha acquistato in essenzialità e, contemporaneamente, in spessore. Le sue isole desolate, i suoi mari cupi, le sue brucianti visioni, vengono a restituire anche a noi – insieme alla percezione fisica delle canicole e dei tramonti – il significato più vasto e più impalpabile del tempo: il significato, vale a dire, del nostro dramma quotidiano; la consapevolezza di ciò che è destinato a finire e di ciò che è destinato a sopravviverci. La supremazia di una natura che, in uno splendore di luci e di ombre, già racchiude in sé la compiutezza degli eventi stabiliti.

 Pietro Jannon appartiene a pieno titolo a questa categoria di nomadi, imprevedibili, schivi, fieramente gelosi della propria indipendenza. Puoi incontrarlo sul Tobbio, tra le rovine dell’Acropoli o sulla via di Katmandu e non ti dirà mai “sono venuto sin qui”, ma “stavo passando di qui”, e già solleverà lo zaino, diretto da un’altra parte. Il suo viaggio è sempre in corso: non contempla punti d’arrivo, così come non suppone luoghi da cui fuggire. Non ne ha bisogno, e non perché si sostanzi dello spostamento in sé, ma perché in quest’ottica ogni luogo è altrettanto significativo nel raggiungerlo come nel lasciarlo.
Pietro Jannon appartiene a pieno titolo a questa categoria di nomadi, imprevedibili, schivi, fieramente gelosi della propria indipendenza. Puoi incontrarlo sul Tobbio, tra le rovine dell’Acropoli o sulla via di Katmandu e non ti dirà mai “sono venuto sin qui”, ma “stavo passando di qui”, e già solleverà lo zaino, diretto da un’altra parte. Il suo viaggio è sempre in corso: non contempla punti d’arrivo, così come non suppone luoghi da cui fuggire. Non ne ha bisogno, e non perché si sostanzi dello spostamento in sé, ma perché in quest’ottica ogni luogo è altrettanto significativo nel raggiungerlo come nel lasciarlo.
 Gli itinerari hanno sempre orizzonti. Brevi o ampi, sono il confine immaginario che si muove con noi. Le linee sono dunque il termine ed il prolungamento, ad un tempo, delle proiezioni fantastiche, dei desideri, delle ambizioni. Spesso, tracce appena percepibili tra cielo e terra, tra cielo e mare. Il mondo sensibile e il mondo celeste trovano l’effimera e mutevole unione nel segno tracciato.
Gli itinerari hanno sempre orizzonti. Brevi o ampi, sono il confine immaginario che si muove con noi. Le linee sono dunque il termine ed il prolungamento, ad un tempo, delle proiezioni fantastiche, dei desideri, delle ambizioni. Spesso, tracce appena percepibili tra cielo e terra, tra cielo e mare. Il mondo sensibile e il mondo celeste trovano l’effimera e mutevole unione nel segno tracciato.

 In un’opera di Pietro Jannon, una delle più recenti, appartenente al ciclo dei “divieti”, è possibile leggere la perfetta metafora della nostra attuale condizione. Probabilmente la metafora non è del tutto consapevole, ma proprio questo è il bello e il mistero dell’arte: la capacità di dire parole non pronunciate e di trasmettere idee non pensate.
In un’opera di Pietro Jannon, una delle più recenti, appartenente al ciclo dei “divieti”, è possibile leggere la perfetta metafora della nostra attuale condizione. Probabilmente la metafora non è del tutto consapevole, ma proprio questo è il bello e il mistero dell’arte: la capacità di dire parole non pronunciate e di trasmettere idee non pensate. La prima riguarda lo sforzo di edificazione di un sistema normativo universalistico di diritti e di doveri (in contrapposizione a quello particolaristico e consuetudinario), e di un corredo etico, di imperativi e finalità ( in sostituzione di quello morale e religioso), prodotto nei secoli della modernità dalla cultura laica occidentale, e mirante in ultima analisi a uniformare a livello globale i comportamenti. Questa potrebbe in apparenza sembrare addirittura una vittoria, dal momento che tale sistema è nato e si è sviluppato in funzione degli interessi dei gruppi o delle classi dominanti, e la sua sudditanza al potere non è in discussione: ma in realtà ci troviamo di fronte soltanto alla rimozione dell’impalcatura che è servita ad innalzare il palazzo della cultura e del mercato (soprattutto del mercato) globali. L’impalcatura nascondeva l’oscenità architettonica e strutturale di quel lager immenso che si estende ormai su tutto il pianeta, ma in qualche modo garantiva anche ai detenuti delle sicurezze, a volte delle vie di fuga. Garantiva il riconoscimento della individualità, se non altro esortando all’assunzione di una responsabilità individuale, o sanzionandola.
La prima riguarda lo sforzo di edificazione di un sistema normativo universalistico di diritti e di doveri (in contrapposizione a quello particolaristico e consuetudinario), e di un corredo etico, di imperativi e finalità ( in sostituzione di quello morale e religioso), prodotto nei secoli della modernità dalla cultura laica occidentale, e mirante in ultima analisi a uniformare a livello globale i comportamenti. Questa potrebbe in apparenza sembrare addirittura una vittoria, dal momento che tale sistema è nato e si è sviluppato in funzione degli interessi dei gruppi o delle classi dominanti, e la sua sudditanza al potere non è in discussione: ma in realtà ci troviamo di fronte soltanto alla rimozione dell’impalcatura che è servita ad innalzare il palazzo della cultura e del mercato (soprattutto del mercato) globali. L’impalcatura nascondeva l’oscenità architettonica e strutturale di quel lager immenso che si estende ormai su tutto il pianeta, ma in qualche modo garantiva anche ai detenuti delle sicurezze, a volte delle vie di fuga. Garantiva il riconoscimento della individualità, se non altro esortando all’assunzione di una responsabilità individuale, o sanzionandola.

 Se dovessimo formulare una definizione di Pietro Jannon, diremmo che è un pittore mediterraneo; e non nel senso che la sua produzione trae alimento, in prevalenza, da un determinato paesaggio: ma nel senso che essa sembra racchiudere quasi naturalmente, di tale paesaggio, gli elementi più intimi e segreti: quegli elementi contradditori e drammatici che soltanto una vocazione ed un’affinità riescono ad avvertire al di là dell’apparenza superficiale. Eppure Jannon è un pittore del Nord, nato precisamente a Venasca, in provincia di Cuneo (anno 1936), e vissuto tra le domestiche colline del Monferrato ovadese, che furono oggetto dei suoi primi tentativi fin dall’età di quindici anni. Nato e vissuto, cioè, in un ambiente in cui i termini dello scontro non sussistono più, sussistono più, da quando l’uomo – sia pure attraverso anni di fatica – è riuscito col lavoro a plasmare la materia a sua immagine e somiglianza. Ma forse fu proprio per questo, per questa insufficienza di contrasti, ch’egli si spinse a ricercare altrove ciò che il suo temperamento di artista richiedeva per meglio esprimersi. E lo trovò lontano dalle pianure e dalle colline dei suoi luoghi di origine, nelle isole: là dove – come lo stesso Jannon ricorda – le cose, sospese tra terra e mare, tra mare e cielo, sembrano vivere più raccolte in se stesse, incontaminate da fattori meccanici, e affidate nella loro vicenda, oggi come ieri, alla legge violenta delle stagioni.
Se dovessimo formulare una definizione di Pietro Jannon, diremmo che è un pittore mediterraneo; e non nel senso che la sua produzione trae alimento, in prevalenza, da un determinato paesaggio: ma nel senso che essa sembra racchiudere quasi naturalmente, di tale paesaggio, gli elementi più intimi e segreti: quegli elementi contradditori e drammatici che soltanto una vocazione ed un’affinità riescono ad avvertire al di là dell’apparenza superficiale. Eppure Jannon è un pittore del Nord, nato precisamente a Venasca, in provincia di Cuneo (anno 1936), e vissuto tra le domestiche colline del Monferrato ovadese, che furono oggetto dei suoi primi tentativi fin dall’età di quindici anni. Nato e vissuto, cioè, in un ambiente in cui i termini dello scontro non sussistono più, sussistono più, da quando l’uomo – sia pure attraverso anni di fatica – è riuscito col lavoro a plasmare la materia a sua immagine e somiglianza. Ma forse fu proprio per questo, per questa insufficienza di contrasti, ch’egli si spinse a ricercare altrove ciò che il suo temperamento di artista richiedeva per meglio esprimersi. E lo trovò lontano dalle pianure e dalle colline dei suoi luoghi di origine, nelle isole: là dove – come lo stesso Jannon ricorda – le cose, sospese tra terra e mare, tra mare e cielo, sembrano vivere più raccolte in se stesse, incontaminate da fattori meccanici, e affidate nella loro vicenda, oggi come ieri, alla legge violenta delle stagioni.
 Grande commozione nella sezione del CAI di Ovada per la scomparsa di Pietro Jannon, che ha avuto un ruolo determinante nella gestione della sede e dell’attività sociale negli ultimi vent’anni. Grande appassionato di ambienti naturali, pittore, fotografo, viaggiatore prima che il viaggio diventasse una moda, ti portava a scoprire l’Appennino con l’esperienza di chi ha visto il mondo: dall’Islanda alle Galapagos, dall’Alaska al Tibet.
Grande commozione nella sezione del CAI di Ovada per la scomparsa di Pietro Jannon, che ha avuto un ruolo determinante nella gestione della sede e dell’attività sociale negli ultimi vent’anni. Grande appassionato di ambienti naturali, pittore, fotografo, viaggiatore prima che il viaggio diventasse una moda, ti portava a scoprire l’Appennino con l’esperienza di chi ha visto il mondo: dall’Islanda alle Galapagos, dall’Alaska al Tibet.
 Pietro Jannon era nato nel 1936 a Venasca, in Val Varaita. ed è approdato nell’ovadese nell’immediato dopoguerra, seguendo gli spostamenti della famiglia. In Ovada ha frequentato le secondarie inferiori e un corso di disegno decorativo presso il maestro Resecco e ha successivamente lavorato come decoratore per la Cristalvetro e come designer presso la LAI.
Pietro Jannon era nato nel 1936 a Venasca, in Val Varaita. ed è approdato nell’ovadese nell’immediato dopoguerra, seguendo gli spostamenti della famiglia. In Ovada ha frequentato le secondarie inferiori e un corso di disegno decorativo presso il maestro Resecco e ha successivamente lavorato come decoratore per la Cristalvetro e come designer presso la LAI.



































































 All’interno di questo perimetro, i criteri più sensati di classificazione sono in linea di massima tre (quelli possibili sono naturalmente infiniti). Uno considera lo specifico della tipologia letteraria (saggio, diario, romanzo, ecc …), il secondo suddivide in base al teatro del viaggio, il terzo guarda alle modalità e alle motivazioni dello spostamento. La scelta dell’uno o dell’altro dipende dalla direzione d’uso o di ricerca che si intende intraprendere: qualche volta poi può accadere che siano la disposizione stessa dei libri o il modello di catalogazione usato a dettare la direzione verso cui la ricerca si indirizzerà. Voglio dire che l’ordine in cui i libri di una biblioteca privata sono disposti ha già di per sé alle spalle una storia, ma a grandi linee ne annuncia e guida anche una futura.
All’interno di questo perimetro, i criteri più sensati di classificazione sono in linea di massima tre (quelli possibili sono naturalmente infiniti). Uno considera lo specifico della tipologia letteraria (saggio, diario, romanzo, ecc …), il secondo suddivide in base al teatro del viaggio, il terzo guarda alle modalità e alle motivazioni dello spostamento. La scelta dell’uno o dell’altro dipende dalla direzione d’uso o di ricerca che si intende intraprendere: qualche volta poi può accadere che siano la disposizione stessa dei libri o il modello di catalogazione usato a dettare la direzione verso cui la ricerca si indirizzerà. Voglio dire che l’ordine in cui i libri di una biblioteca privata sono disposti ha già di per sé alle spalle una storia, ma a grandi linee ne annuncia e guida anche una futura. È il criterio che io stesso ho seguito per redigere il catalogo dei libri presenti nel settore viaggi della mia biblioteca (e del quale questo scritto è un’appendice). Lo definirei un criterio “quantitativo”, funzionale più alla gestione che alla consultazione. Si presta comunque anche ad un lavoro di ricerca storica molto ben definito e specifico, perché offre un quadro chiaro e completo degli “strumenti” disponibili. Diciamo che garantisce l’individuazione teorica del libro che ci serve. Quanto poi a trovarlo, la cosa è un po’ più complicata.
È il criterio che io stesso ho seguito per redigere il catalogo dei libri presenti nel settore viaggi della mia biblioteca (e del quale questo scritto è un’appendice). Lo definirei un criterio “quantitativo”, funzionale più alla gestione che alla consultazione. Si presta comunque anche ad un lavoro di ricerca storica molto ben definito e specifico, perché offre un quadro chiaro e completo degli “strumenti” disponibili. Diciamo che garantisce l’individuazione teorica del libro che ci serve. Quanto poi a trovarlo, la cosa è un po’ più complicata. Rimane la terza opzione, quella che prende in considerazione le motivazioni e le modalità specifiche del viaggio. In realtà non è un criterio molto funzionale, né alla collocazione né alla catalogazione, perché solitamente in ciascun testo si intrecciano e si accavallano motivazioni e modalità molteplici, ed è quasi impossibile definire raggruppamenti che risultino sufficientemente comprensivi. Questo già ci dice che delineare una mappatura della letteratura di viaggio a partire dalla fenomenologia del viaggio stesso è impresa ardua. E può sembrare anche decisamente inutile: a meno che, come nel mio caso, l’intento sia non di procedere ad uno studio o ad una trattazione dell’argomento “accademicamente” mirata, ma di regalarsi degli excursus biografici o storici, degli spaccati di storia delle idee o del costume, dettati dalla pura curiosità o dalla simpatia per i protagonisti.
Rimane la terza opzione, quella che prende in considerazione le motivazioni e le modalità specifiche del viaggio. In realtà non è un criterio molto funzionale, né alla collocazione né alla catalogazione, perché solitamente in ciascun testo si intrecciano e si accavallano motivazioni e modalità molteplici, ed è quasi impossibile definire raggruppamenti che risultino sufficientemente comprensivi. Questo già ci dice che delineare una mappatura della letteratura di viaggio a partire dalla fenomenologia del viaggio stesso è impresa ardua. E può sembrare anche decisamente inutile: a meno che, come nel mio caso, l’intento sia non di procedere ad uno studio o ad una trattazione dell’argomento “accademicamente” mirata, ma di regalarsi degli excursus biografici o storici, degli spaccati di storia delle idee o del costume, dettati dalla pura curiosità o dalla simpatia per i protagonisti. Ho iniziato a immaginare griglie mentali basate su queste possibili suddivisioni per finalità didattiche, quando ancora insegnavo letteratura: ma è poi diventata un’abitudine, perché consente di organizzare per qualsivoglia esigenza degli schemi elementari di ricerca. Tra questi schemi ce ne sono alcuni, in sostanza quelli che ho maggiormente utilizzato, che riescono immediatamente evidenti, ma che vorrei comunque dettagliare un po’ di più. Sono relativi il primo alla direzione del viaggio, il secondo alle sue motivazioni e finalità, il terzo alla sua morfologia.
Ho iniziato a immaginare griglie mentali basate su queste possibili suddivisioni per finalità didattiche, quando ancora insegnavo letteratura: ma è poi diventata un’abitudine, perché consente di organizzare per qualsivoglia esigenza degli schemi elementari di ricerca. Tra questi schemi ce ne sono alcuni, in sostanza quelli che ho maggiormente utilizzato, che riescono immediatamente evidenti, ma che vorrei comunque dettagliare un po’ di più. Sono relativi il primo alla direzione del viaggio, il secondo alle sue motivazioni e finalità, il terzo alla sua morfologia. Ma è evidente che insistendo a scovare modelli di classificazione sempre più peregrini non ci si muove dal punto di partenza; mentre se si intende davvero semplificare conviene adottare lo schema più immediato, ovvero quello direzionale, articolandolo poi con l’occasionale ricorso ad altri criteri. Ciascuna delle tipologie o sottotipologie identificate può in genere essere ricondotta ad archetipi mitologici o biblici, e trova riscontri nella fiaba e nella letteratura popolare. Il che serve tra l’altro a ribadire che non c’è mai nulla di veramente nuovo sotto il sole, e che indipendentemente dalle direzioni prese gli uomini si sono mossi lungo i millenni spinti dagli stessi aneliti o dalle stesse paure.
Ma è evidente che insistendo a scovare modelli di classificazione sempre più peregrini non ci si muove dal punto di partenza; mentre se si intende davvero semplificare conviene adottare lo schema più immediato, ovvero quello direzionale, articolandolo poi con l’occasionale ricorso ad altri criteri. Ciascuna delle tipologie o sottotipologie identificate può in genere essere ricondotta ad archetipi mitologici o biblici, e trova riscontri nella fiaba e nella letteratura popolare. Il che serve tra l’altro a ribadire che non c’è mai nulla di veramente nuovo sotto il sole, e che indipendentemente dalle direzioni prese gli uomini si sono mossi lungo i millenni spinti dagli stessi aneliti o dalle stesse paure. Un viaggio di sola andata è in genere anche quello connesso alla fuga. Qui l’archetipo potrebbe essere l’Eneide, anche se in realtà la fuga di Enea si traduce ben presto in migrazione e in conquista. Gli esempi che mi vengono in mente, e che corrispondono a ulteriori sottotipologie del viaggio di andata, sono naturalmente in primo luogo quelli di fughe dalla detenzione (da Cinque settimane in pallone a Sette anni in Tibet e Tra noi e la libertà), dalla caccia di nemici e persecutori, umani e non (Fuga senza fine, Un sacchetto di biglie, I tre giorni del Condor), dai pericoli della guerra (Palla di sego) o da quelli naturali: e poi ancora fughe adolescenziali dalla famiglia, o più mature, dal coniuge. Farei rientrare in questo gruppo anche le meno frequenti narrazioni che propongono il punto di vista del cacciatore, dell’inseguitore, (tanto meno frequenti che in questo momento mi viene in mente solo Il leopardo delle nevi).
Un viaggio di sola andata è in genere anche quello connesso alla fuga. Qui l’archetipo potrebbe essere l’Eneide, anche se in realtà la fuga di Enea si traduce ben presto in migrazione e in conquista. Gli esempi che mi vengono in mente, e che corrispondono a ulteriori sottotipologie del viaggio di andata, sono naturalmente in primo luogo quelli di fughe dalla detenzione (da Cinque settimane in pallone a Sette anni in Tibet e Tra noi e la libertà), dalla caccia di nemici e persecutori, umani e non (Fuga senza fine, Un sacchetto di biglie, I tre giorni del Condor), dai pericoli della guerra (Palla di sego) o da quelli naturali: e poi ancora fughe adolescenziali dalla famiglia, o più mature, dal coniuge. Farei rientrare in questo gruppo anche le meno frequenti narrazioni che propongono il punto di vista del cacciatore, dell’inseguitore, (tanto meno frequenti che in questo momento mi viene in mente solo Il leopardo delle nevi). Appartengono al filone dell’andata anche i viaggi di esplorazione. Quando a narrarli sono gli stessi protagonisti è evidente che si tratta in realtà di viaggi di andata e ritorno: ma la narrazione in genere privilegia il primo momento, e quindi possono essere classificati, salvo casi particolari, nella tipologia dell’andata. Gli archetipi narrativi sono naturalmente Il milione e I viaggi di Ibn Battuta, ma potrebbero esserne indicati infiniti altri, ben più antichi. Oltre ai diari di svariati esploratori troviamo in questo settore una narrativa sterminata, che va dalle incursioni verniane al centro della Terra, sulla Luna o al Polo australe ai viaggi esotici di Ridder-Haggard (Lei, Le miniere di re Salomone) o di Hudson (Terra di porpora), a quelli a ritroso di Conan Doyle ne Il mondo Perduto, alle ricostruzioni storiche romanzate di Michener, fino ad arrivare ad Alice nel paese delle meraviglie.
Appartengono al filone dell’andata anche i viaggi di esplorazione. Quando a narrarli sono gli stessi protagonisti è evidente che si tratta in realtà di viaggi di andata e ritorno: ma la narrazione in genere privilegia il primo momento, e quindi possono essere classificati, salvo casi particolari, nella tipologia dell’andata. Gli archetipi narrativi sono naturalmente Il milione e I viaggi di Ibn Battuta, ma potrebbero esserne indicati infiniti altri, ben più antichi. Oltre ai diari di svariati esploratori troviamo in questo settore una narrativa sterminata, che va dalle incursioni verniane al centro della Terra, sulla Luna o al Polo australe ai viaggi esotici di Ridder-Haggard (Lei, Le miniere di re Salomone) o di Hudson (Terra di porpora), a quelli a ritroso di Conan Doyle ne Il mondo Perduto, alle ricostruzioni storiche romanzate di Michener, fino ad arrivare ad Alice nel paese delle meraviglie. Parente prossimo del viaggio di esplorazione è quello connesso ad una particolare impresa, che in molti casi assume anche il valore di viaggio iniziatico. L’archetipo potrebbe essere quello delle Argonautiche, o più addietro ancora quello dell’epopea di Gilgamesh. Anche in questo caso gli esempi narrativi si sprecano: da Il signore degli anelli a Il giro del mondo in 80 giorni, da Ricordi di un’estate a Capitani coraggiosi, fino a Cuore di tenebra.
Parente prossimo del viaggio di esplorazione è quello connesso ad una particolare impresa, che in molti casi assume anche il valore di viaggio iniziatico. L’archetipo potrebbe essere quello delle Argonautiche, o più addietro ancora quello dell’epopea di Gilgamesh. Anche in questo caso gli esempi narrativi si sprecano: da Il signore degli anelli a Il giro del mondo in 80 giorni, da Ricordi di un’estate a Capitani coraggiosi, fino a Cuore di tenebra. Spesso però il ritorno è solo temporaneo, una rivisitazione in cerca delle radici, o dei sapori e delle atmosfere dell’infanzia (Conversazione in Sicilia): e di solito si rivela deludente, o crea una sensazione di estraneità.
Spesso però il ritorno è solo temporaneo, una rivisitazione in cerca delle radici, o dei sapori e delle atmosfere dell’infanzia (Conversazione in Sicilia): e di solito si rivela deludente, o crea una sensazione di estraneità.




