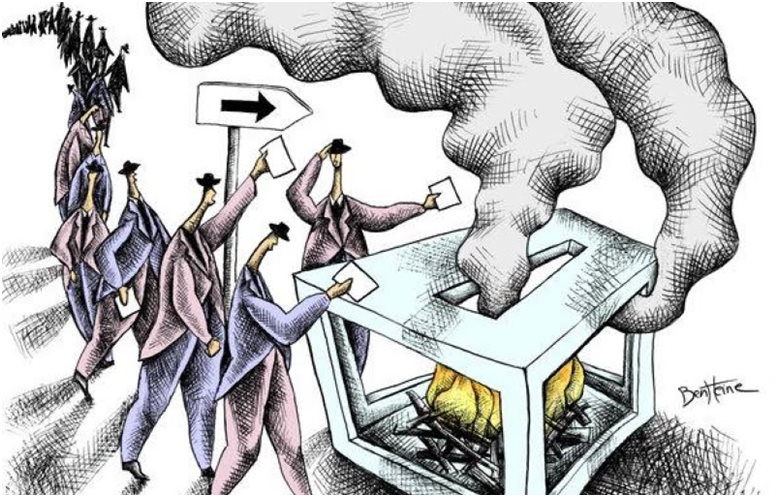Due letture recenti mi riportano ad un argomento che ho già trattato in più occasioni (cfr. soprattutto La discesa dal monte analogo). Temo però di averlo fatto piuttosto confusamente, e provo allora ad affrontarlo per l’ennesima volta cercando di essere più chiaro (e di chiarire le idee in primo luogo a me stesso).
Gli scritti che mi hanno offerto lo spunto sono molto diversi. Il primo è un “manifesto” redatto in stile futurista, comparso sulla rivista on line “L’indiscreto” il 14 settembre col titolo “Incivilizzazione”. Anche il secondo si presenta come “Manifesto del grande risveglio”, ma il titolo ufficiale è “Contro il grande reset” e ha la struttura di un vero e proprio pamphlet. Il terzo è un saggio pubblicato a inizio anno da Aldo Schiavone, intitolato “L’Occidente e la nascita di una civiltà planetaria”, che ho letto solo pochi giorni fa.
L’idea di un intervento era già nata in realtà dopo la lettura del primo, ma avevo in mente solo una ironica demolizione; l’incontro con Dugin e il libro di Schiavone mi hanno invece convinto a tentare un approfondimento più serio. Spero non riesca soltanto più pesante.
I tre testi viaggiano a livelli assolutamente diseguali, per valore e per profondità nella trattazione, e un raffronto alla pari non avrebbe alcun senso: ma tutti e tre si prestano altrettanto bene al mio scopo, perché consentono di mettere a fuoco poli diversi, addirittura opposti, dell’atteggiamento nei confronti della civilizzazione “occidentale”, della razionalità e, implicitamente, del futuro della nostra specie. Cerco quindi di trattarli come “documenti”, testimonianze significative di come una stessa atmosfera possa essere interpretata con disposizioni antitetiche.
***
Incivilization: The Dark Mountain Manifesto è uno scritto relativamente breve pubblicato nel 2009 da Paul Kingsnorth e Dougald Hine, per annunciare l’inaugurazione del The Dark Mountain Project. I due militano nella galassia tanto diffusa quanto confusa degli eco-integralisti d’oltreoceano. Nel testo fanno riferimento costante, come ispiratore e nume tutelare del progetto, al poeta Robinson Jeffers, popolare negli anni ‘20 e ‘30 nella cerchia dei bohemiens e dei letterati che affollavano le coste californiane (era un amico di George Sterling e di Edgar Lee Masters, e per un certo periodo ha frequentato anche D.H. Lawrence), ma quasi sconosciuto al di fuori di quel giro (malgrado una sua foto sia stata pubblicata sulla copertina della rivista Time, cosa piuttosto rara per un poeta, e il suo profilo compaia su un francobollo del servizio postale). Conviene partire direttamente da lui.
Jeffers era un personaggio singolare, capace di costruire con le proprie mani una casa con tanto di torre tutta in pietra (“Cercate le fondamenta di granito levigato dal mare,/ le mie dita conobbero l’arte/di sposare pietra a pietra, troverete alcuni resti”), quella che compare nella immagine di apertura, e di vivere poi in essa un’esistenza appartata e austera, ma anche attento ad alimentare il mito che attorno a questa casa e a questa esistenza si andava creando. Ha esercitato senza dubbio una grande influenza sugli scrittori ambientalisti della generazione successiva, come Edward Abbey e Gary Snyder, ma anche Bukowski, cui dell’ambiente non importava un fico, lo idolatrava. (“Mi ha influenzato moltissimo, adoravo la sua selvatica ruvidezza nel verso… Jeffers è il mio dio… non sopportava gli uomini, pensava che la vita umana fosse terribile, come potrei non adorarlo?”) Negli anni settanta-ottanta è stato poi ripescato dalla cultura new-age, continuando però ad essere un autore di nicchia: e per quello che conosco della sua opera mi pare destinato a rimanere tale. Al momento le uniche sue raccolte poetiche tradotte in italiano sono “La bipenne e altre poesie” (1969) e “Cawdor” (1977: è in realtà un vero e proprio poema “epico”), e non hanno suscitato particolari entusiasmi.
Al di là delle eccentricità e dei meriti, però, ciò che davvero qui importa di Jeffres è l’appartenenza ad una tradizione “nobile” della cultura statunitense, che vede tra gli antesignani ottocenteschi personaggi come Thoreau, Muir e soprattutto Ralph Waldo Emerson e i “trascendentalisti”, e che predica un rapporto completamente diverso con la natura, empatico anziché antagonistico. Alle spalle di questi proto-ecologisti c’era un sentire religioso profondo, lontano da quell’ipocrita dogmaticità ecclesiale alla quale gli uomini del nuovo mondo avevano voluto sottrarsi: davanti a loro c’era una natura ancora incontaminata, spazi immensi e solitari nei quali il rapporto col trascendente si imponeva immediato e che andavano salvaguardati dalla colonizzazione distruttiva delle attività umane. Sulla spinta di questa tradizione sono nati infatti i primi grandi santuari naturalistici, come Yellowstone o Yosemite.
Jeffers ne ha ereditato entrambi i presupposti di base, ma è poi andato oltre. Ha predicato una sorta di panteismo che mescola la scienza e il culto mistico della bellezza della natura, nella “convinzione che l’umanità sia troppo egocentrica e troppo indifferente alla sorprendente bellezza delle cose”: e ha coniato per il suo atteggiamento la definizione di “inumanesimo”. Lo definiva esplicitamente come “…uno spostamento dell’enfasi e del significato dall’uomo al ‘non uomo’; il rifiuto del solipsismo umano e il riconoscimento della magnificenza transumana…”.
Per dare voce a questo atteggiamento la sua poesia si compiace di immagini brutali, indulge alla descrizione della violenza (stiamo parlando di un secolo fa: oggi gli stomaci dei lettori sono abituati a digerire ben altro), insiste su un atteggiamento misantropico e su un pessimismo esasperato e addirittura auspica un suicidio liberatorio (per la natura) dell’umanità. E a questo si è voluta attribuire la sua limitata fortuna critica e di pubblico.
In realtà credo che la ragione sia un’altra. L’ambizione di Jeffers era di ridare alla poesia un respiro epico, sul modello del “Paradiso perduto” di Milton, e per farlo era necessario usare una franchezza aspra, creare emozioni ma anche accompagnare con la suggestione di immagini forti il pensiero: “La poesia racchiude ed esprime il tutto, come la prosa non potrà mai. Il suo compito è contenere un mondo intero, all’istante, fisico e sensuale, dell’intelletto e dello spirito… La scienza tende a scomporre le cose per scoprirle; seziona, analizza. La poesia invece mette le cose insieme, facendo scoperte ugualmente valide e allo stesso tempo creando.” La sua era evidentemente una cifra poetica controcorrente, in un’epoca nella quale i suoi contemporanei (da Eliot a Pound agli ermetici italiani) adottavano un linguaggio elitario e infarcito di difficoltà; e quella poetica Jeffers l’ha perseguita con coerenza e in sprezzante solitudine lungo tutta la sua carriera, infischiandosene delle mode e delle correnti, e anzi, bollando l’uso escludente della parola come puro manierismo.
Jeffers leggeva effettivamente la storia dell’umanità tutta in negativo. Era attratto dalla scienza, ma giudicava devastanti i suoi risvolti pratici, la tecnologia sfuggita al controllo. Disprezzava la politica, ma non esitava a prendere posizioni radicali e impopolari (come quella del pacifismo isolazionista all’epoca della seconda guerra mondiale). Questo modo di sentire non era comunque a suo parere né misantropico né pessimista. Piuttosto consentiva “un ragionevole distacco come regola di condotta, invece di amore, odio e invidia … offre magnificenza all’istinto religioso”.
La verità è che Jeffers non nega la violenza né la esalta: la analizza come un dato di fatto, come la caratteristica fondamentale del vivere. Lo fa da un punto di vista “materialistico”, che contrappone a quello “umanistico”. “L’umanesimo ci insegna meglio perché soffriamo, ma il materialismo ci insegna a soffrire”. Scrive: “L’universo esterno divino non è in pace con se stesso, ma pieno di tensioni e violenti conflitti. Il mondo fisico è governato da opposte tensioni. Il mondo delle cose viventi è formato da una lotta continua e da desideri irriconciliabili. Il dolore è una parte essenziale della vita”. Per “materialismo” intende quindi la coscienza darwiniana della lotta di tutti contro tutti per la sopravvivenza.
In sostanza. Per Jeffers il dolore non è stato introdotto in una preesistente serena armonia del cosmo dalla trasgressione umana: quella che è stata introdotta è invece la percezione come dolore di un conflitto che è di per sé intrinseco alla natura. Questa percezione l’uomo non l’accetta, e cerca di liberarsene modificando l’ordine delle cose, abusando quindi dell’ambiente e degradandolo. E non si limita a trasformare la terra, ma la distrugge, condannando la sua stessa specie all’estinzione. In questo senso l’uomo è il peggiore di tutti gli animali, il più dannoso e il più scriteriato. La sua è un’intelligenza malata: attraverso la presunzione razionalistica e le sue ricadute tecnologiche si stacca sempre più dalla natura, e nel contempo però non può non riconoscere la sublime bellezza di quest’ultima, nella quale intravvede l’opera di Dio; ma, ed è questo il paradosso, anziché riconciliarsi con essa è ulteriormente spinto, proprio dalla straziante coscienza di quanto sta perdendo, alla crudeltà e all’autodistruzione. Ciò vale tanto più per i popoli presso i quali il processo di “civilizzazione” è più avanzato, ovvero per la civiltà occidentale, che è avviata ad un palese declino, travolta dall’egoismo, dalle guerre, dalla mercificazione.
E così, solo una volta scomparso l’uomo l’armonia cosmica si ricomporrà, in un’altra forma, ma non ad un livello inferiore. Nel farci capire ed accettare tutto questo la poesia ha un ruolo determinante, e al poeta va tributato un religioso rispetto (che il poeta deve guadagnarsi resistendo alle tentazioni del successo e della fama: “Se Iddio ha avuto la bontà di darvi un poeta/ Ascoltatelo. Ma per l’amor di Dio lasciatelo in pace finché è vivo; niente feste o premi/ Che l’uccidono. Un poeta è colui che sa ascoltare/ La natura e il proprio cuore; e se il frastuono del mondo lo circonda, se è forte saprà sbarazzarsi dei nemici./ Ma degli amici no”.
La coerenza di Jeffers non è forse stata così totale come le sue stesse parole chiederebbero, altrimenti non saremmo qui a parlarne: il mio problema con lui non è però questo, non ho il diritto di essere così integralista. Il problema sta nel fatto che la sua poesia, pure così chiara e diretta, lascia comunque spazio sia a interpretazioni forzate (il Bukowski di cui sopra) sia ad una degustazione puramente “estetica”, per amanti dei sapori forti. Chiama insomma ad essere testimoni passivi del naufragio, o addirittura a compiacersi della violenza delle onde. E non sono del tutto sicuro che nel profondo Jeffers la pensasse davvero così: probabilmente delle onde aveva anche paura.
Una curiosità: Jeffers è quasi omonimo di un altro letterato ambientalista, appartenente però alla tradizione inglese, Richard Jefferies, grande camminatore, naturalista ed esploratore delle campagne britanniche, nonché autore di un romanzo post-apocalittico, “Dove un tempo era Londra” (1885. cfr. il mio Pensare con i piedi). Quest’ultimo immagina che dopo una improvvisa catastrofe, della quale non viene precisata la natura, il paesaggio inglese venga riconquistato dalle foreste, che si mangiano tanto la campagna quanto le strade e le città, e Londra sia ridotta ad una palude venefica. Non so se Jeffrers l’abbia mai letto, non mi risulta che lo abbia citato, ma credo che questa prospettiva gli sarebbe piaciuta.

Mi sono soffermato a lungo su Jeffers perché gli estensori del manifesto del Dark Mountain Project non si sono sforzati molto: hanno ripreso pari pari la sua visione, aggiornandola alle attuali emergenze ambientali, economiche e politiche. In effetti avevano solo l’imbarazzo della scelta. Cerco comunque di riassumere il loro testo attraverso i passi più significativi.
Il Manifesto parte appunto dalla presa d’atto delle radicali trasformazioni in corso:
“Tutt’intorno a noi avvengono cambiamenti che suggeriscono come il no stro modo di vivere stia già passando alla storia. Stiamo cadendo. Viviamo in un’epoca nella quale i limiti cui siamo abituati stanno scomparendo, e le nostre fondamenta ci vengono strappate da sotto i piedi. Dopo un quarto di secolo di noncuranza, durante il quale siamo stati spinti a credere che la bolla non sarebbe mai esplosa, i valori mai crollati, ecco la fine della storia … La Hybris ha ora la sua Nemesi. […] Una storia a noi familiare si sta concludendo. È la storia dell’impero che crolla dall’interno. È la storia di un popolo che ha creduto, per molto tempo, che le proprie azioni non avrebbero avuto conseguenze. È la storia di come quel popolo dovrà fare i conti con la fine del proprio mito. È la nostra storia.
Mentre scriviamo queste righe, nessuno può dire con certezza quando finirà lo sfaldarsi del tessuto finanziario e commerciale della nostra economia. Nel frattempo, fuori dalle metropoli, lo sfruttamento industriale incontrollato sgretola le basi materiali della vita di moltissime parti del mondo, e grava sul sistema ecologico che la sostiene.”
Vengono poi messi in discussione i plinti di fondazione della civiltà:
“La civiltà umana è una costruzione particolarmente fragile. È costruita su poco più che una semplice convinzione: la certezza che i propri valori siano quelli giusti; la fede nel suo sistema di leggi e ordine; la fede nella sua valuta; ma al di sopra di tutto, probabilmente, la fede nel suo futuro.”
Queste convinzioni sono state riassunte e rielaborate, soprattutto nel mondo occidentale, in una narrazione mitologica che ha come protagonista il progresso. La storia di questa mitologizzazione passa attraverso successive declinazioni dell’utopia razional-capitalistica:
“Sulle radici della cristianità occidentale, l’Illuminismo all’apice del suo ottimismo ha innestato una visione del paradiso terrestre, cui le gesta umane, guidate da calcolo razionale, potranno condurci. Grazie a questa guida, ogni generazione vivrà una vita migliore di quella che l’ha preceduta. La storia diventa un ascensore, e l’unica via possibile è verso l’alto. All’ultimo piano c’è la perfezione umana: è fondamentale che questa rimanga fuori portata quel tanto che basta al fine di sostenere l’illusione del moto.”
La storia recente, invece, ha dato un duro colpo a questo meccanismo.
“Il progresso ha, in molti modi, fallito nel suo tentativo di produrre benessere. Le generazioni di oggi sono evidentemente meno soddisfatte, e di conseguenza meno ottimistiche, di quelle che le hanno precedute. Lavorano di più, con meno garanzie, e hanno meno possibilità di lasciarsi alle spalle il contesto sociale nelle quali sono nate. Hanno paura del crimine, del collasso della società, dello sviluppo incontrollato e della catastrofe climatica. Non credono che il futuro sarà migliore del passato.”
E allora? Allora “è tempo di cercare nuovi percorsi e nuove storie, che ci conducano attraverso la fine del mondo per come lo conosciamo, fuori da esso. Pensiamo che mettendo in discussione le fondamenta della civilizzazione, il mito della centralità umana, il nostro immaginario isolamento, possiamo trovare i principi di questi percorsi.
Questo è il Dark Mountain Project. Inizia qui.”

Uno si aspetterebbe a questo punto lo spiegone che illustra le virtù della nuova società darkiana e indica le vie per instaurarla. Ma rimane deluso. La caduta di tono è repentina e ridimensiona drasticamente le aspettative.
“Dove finirà? Nessuno lo sa. Dove condurrà? Non ne siamo certi. La sua prima incarnazione, avviata assieme a questo manifesto, è un sito web, che indica la strada per i campi. Conterrà riflessioni, scarabocchi, schizzi, idee; lavorerà sull’Incivilizzazione, e inviterà, chiunque verrà, ad unirsi alla discussione.
Gli estensori del manifesto sembrano aver esaurito le forze e le idee nell’anamnesi: per la terapia tagliano corto e si affidano agli otto principi fondamentali dell’“incivilizzazione”.
- Viviamo in un tempo di disfacimento sociale, economico ed ecologico. Attorno a noi si affollano le avvisaglie che il nostro intero modo di vivere sta già passando alla storia. Affronteremo con franchezza questa verità e impareremo a conviverci.
- Rifiutiamo la fede nell’idea che le crisi convergenti dei nostri tempi possano essere ridotte a un insieme di ‘problemi’ bisognosi di ‘soluzioni’ tecnologiche o politiche.
- Crediamo che le radici di queste crisi si trovino nelle storie che ci siamo raccontati. Intendiamo mettere a dura prova i racconti che sorreggono la nostra civiltà: il mito del progresso, il mito della centralità umana e il mito della nostra separazione dalla ‘natura’. Tali miti sono ancor più pericolosi poiché abbiamo dimenticato che lo sono.
- Vogliamo riaffermare il ruolo della narrazione come qualcosa di più di un mero intrattenimento. È attraverso le storie che intessiamo la realtà.
- Gli umani non sono il senso e lo scopo del pianeta. La nostra arte avrà inizio con il tentativo di porsi al di fuori della bolla umana. Con prudente attenzione rientreremo in contatto col mondo non umano.
- Vogliamo celebrare la scrittura e l’arte radicate in un luogo e in un tempo. La nostra letteratura è stata troppo a lungo sotto il controllo di coloro che abitano le cittadelle cosmopolite.
- Non ci perderemo nell’elaborazione di teorie o ideologie. Le nostre parole saranno elementari. Noi scriviamo con lo sporco sotto le unghie.
- La fine del mondo per come lo conosciamo non è la fine di tutto il mondo. Insieme troveremo la speranza oltre la speranza, i percorsi che conducono al mondo sconosciuto davanti a noi.
Vediamo allora di ricapitolare. Né Jeffers né tantomeno gli autori del manifesto della Montagna Nera dicono qualcosa di realmente nuovo. Rientrano come già dicevo nella tradizione apocalittica di matrice biblica, che in America, dai Padri pellegrini in poi, ha trovato espressione in una miriade di sette millenariste. La novità sta semmai nel fatto che non contemplano una via di fuga, un eskatòn, ma predicano il ritorno e la resa incondizionata alle leggi di natura. Il legame più diretto, segnatamente per Jeffers, è con i trascendentalisti: come questi ultimi ritiene che l’unica via praticabile dall’uomo per riconciliarsi con se stesso sia quella estetica: nel confronto estetico con la Natura, dinanzi alla sua Bellezza, l’uomo ritrova la propria dimensione spirituale (“Un topo è un miracolo sufficiente a far vacillare miriadi di miscredenti” scriveva Walt Whitman): ma, a differenza che per i trascendentalisti, l’infinita varietà della natura e delle sue forme lo rende anche consapevole della propria irrilevanza e della transitorietà della specie umana. Non lo lascia estatico, ma sgomento e arrabbiato.
Su questa tradizione s’innestano via via, a partire dalla fine dell’Ottocento, da un lato il buddismo importato d’oltreoceano (Pacifico) e rivisitato all’americana (ovvero accentuandone l’individualismo e spettacolarizzandone la ritualità), dall’altro gli echi del pensiero filosofico post-nietzschiano che giungono dall’Europa (il poema Cawdor di Jeffers è pubblicato dieci anni dopo Il tramonto dell’Occidente di Spengler e arriva un anno dopo Essere e tempo di Heidegger). Il tutto dà origine a un singolare e contradditorio miscuglio di religiosità biblica e di sentire panteistico, di misticismo e di nichilismo, di umiltà professata e di presunzione di sé praticata.
Il fatto è che gli americani non hanno alle spalle una storia “profonda”, e tantomeno una mitologia originaria di fondazione. Hanno dovuto reinventarsene una, adattando alla nuova situazione la narrazione biblica, per giustificare il possesso di terre espropriate ad altri (il mito della frontiera) e trovare conferma ad una concezione assolutamente individualistica della libertà. Per questo sono i maggiori mitopoieti dell’età moderna e si esprimono con un linguaggio enfatico che trova supporto nelle nuove modalità espressive, a partire dal cinema (dove un incidente stradale non può vedere coinvolti e distrutti meno di dieci veicoli e una sparatoria non può durare meno di un quarto d’ora). Enfatizzano alla stessa maniera infantile i sentimenti, le tragedie, la malvagità, il coraggio, e ogni aspetto della quotidianità.
Per lo specifico del nostro discorso è esemplare il caso della Tor House, la dimora in pietra di Jeffers, divenuta meta di pellegrinaggio per i suoi ammiratori. In fondo Jeffers ha fatto solo ciò che milioni di pionieri avevano fatto prima di lui, senza peraltro vedere in ogni blocco angolare la mano di Dio. La vita sobria e appartata (sino ad un certo punto) che vi conduceva rimandava a sua volta all’esperienza naturistica di Thoreau, alla capanna che quest’ultimo aveva costruita con le proprie mani nei boschi di Concord e nella quale aveva dimorato per due anni, due mesi e due giorni. Quella capanna è diventata, attraverso le pagine di Walden, l’icona della scelta di una vita rude e solitaria, quando nella realtà non distava più di un miglio dal villaggio (Thoreau avrebbe potuto benissimo andarci a piedi ogni mattina per bere un caffè alla locanda). Entrambe queste esperienze sono state trasmesse dai protagonisti già circonfuse di un’aura ascetica e sapienziale, e come tali sono state poi consacrate dai lettori–spettatori.
Ci insisto perché so di cosa parlo. Anch’io ho costruito un capanno con le mie sole mani (senz’altro più ampio della dimora di Thoreau), e ho tirato su lì attorno decine di metri di muri a secco e posato rustiche pavimentazioni, ma non ho sentito in alcuna delle pietre che sistemavo la presenza di Dio (al più ho visto qualche volta la Madonna, quando mi scivolavano su un piede o al termine di giornate particolarmente faticose). Né ho ritenuto di celebrare poeticamente o filosoficamente la cosa: ho scritto una paginetta sulle origini del capanno solo perché legate ad un aneddoto che mi sembrava divertente. E soprattutto, la bellezza della natura circostante che mi fermavo ad ammirare nelle pause-sigaretta non mi ha mai indotto recriminazioni o violenza: mi ispirava anzi allora e continua oggi ad ispirarmi la determinazione a contaminarla il meno possibile. Sentivo di farne parte comunque, anche quando lavoravo sotto la pioggia o nelle giornate più roventi o afose.
Si sarà capito che ho scarsa simpatia per tutto ciò che puzza di cornici messe alle finestre per dire che sono quadri (in questo caso l’immagine si attaglia perfettamente). Per avere davvero un senso e una credibilità certe situazioni o vicende dovrebbero essere vissute come normali, non è il caso di scomodare l’epos. E lo stesso vale per le idee: non è certo l’incarto nuovo a renderle originali, ha semmai un valore riconoscerne i percorsi pregressi. Il tema dell’equivoco di fondo nel nostro rapporto con la natura era già centrale in Leopardi, sfrondato di ogni verniciatura mistica e pretesa epica; quello della necessità di reintegrarsi in essa stava alla base, oltre che del trascendentalismo americano, dei movimenti proto-ecologici fioriti anche in Europa, principalmente in Germania, agli inizi del Novecento (ma ben prima ancora era presente in Rousseau); le perplessità nei confronti della tecnica, e soprattutto dell’uso che l’uomo tende a farne, erano manifestate da quasi tutti gli scrittori di fantascienza venuti dopo Verne, da Robida a W.H. Hudson a Wells; le prospettive di degenerazione della democrazia erano state già lucidamente indicate da Tocqueville, le colpe del colonialismo e le ipocrisie della cultura occidentale denunciate da Conrad.
Insomma, tutte queste cose Jeffers non le ha spinte solo alle estreme conseguenze, ma le ha condotte in un vicolo cieco, travisando tra l’altro il succo del pensiero dei suoi ispiratori. Thoreau scriveva infatti: “Si dice che la civilizzazione è un reale progresso nella condizione dell’uomo – e io sono convinto che lo sia, anche se solo i saggi migliorano i loro vantaggi”). Jeffers non ne era evidentemente altrettanto convinto, avrebbe piuttosto condiviso con Cioran e con i professionisti del pessimismo l’idea che l’uomo è un intruso, un tragico errore dell’evoluzione, al quale la natura porrà rimedio. Vien da dire, come alla moglie del vescovo Wilberforce a proposito della nostra “discendenza” dalle scimmie: magari è proprio così, ma almeno non facciamolo sapere troppo in giro.
Gli odierni estimatori di Jeffers si fermano un po’ prima. Cercano la speranza oltre la speranza, vale a dire oltre quel poco o nulla cui oggi la scienza e la tecnologia ci consentono di guardare nella ricerca di una improbabile salvezza. E non riescono a trovare di meglio che “mettere a dura prova i racconti che sorreggono la nostra civiltà e restituire l’agire artistico a una pratica ‘incivilizzata’”. Nel fare ciò arrivano quantomeno in ritardo, da almeno un secolo la demolizione dei miti della modernità è diventata lo sport intellettuale più praticato. Se poi gli strumenti di demolizione sono la scrittura e l’arte radicate in un luogo e in un tempo (e cioè?) e praticate con lo sporco sotto le unghie da novelli costruttori di nuraghi, allora le generazioni di oggi hanno tutte le ragioni di non credere che il futuro sarà meglio del passato.

A questo punto può sembrare non valesse la pena prendere così sul serio il manifesto del progetto della Montagna Nera (e magari anche la poesia di Robinson Jeffers). Non è così. Il documento sarà pure patetico, non fosse altro per la sproporzione tra lo scenario apocalittico che dipinge e la miseria delle soluzioni che propone, ma fotografa perfettamente un atteggiamento molto diffuso nei confronti di un tema come quello della sopravvivenza della civiltà occidentale e, in seconda battuta, della specie umana (intendo quello più diffuso tra chi il problema se lo pone, perché in realtà la maggioranza dà l’impressione di non porselo affatto).
Al fondo di questa disposizione negativa sta una vocazione generalizzata al “risentimento”. Anche se nello specifico degli ambientalisti radicali alla Jeffers potrebbe sembrare il contrario, il loro è né più né meno l’atteggiamento di chi si ritiene perennemente in credito nei confronti della vita e del resto dell’umanità. Avremmo la possibilità di vivere in armonia con la natura, dicono, semplicemente accettandone tutte le leggi, anche quelle che ripugnano alla nostra ipocrita morale “civilizzata”: ma qualcuno o qualcosa ce la sta negando. Come in ogni situazione di crisi occorre identificare i responsabili (i capri espiatori di cui parla René Girard), e responsabili sono naturalmente sempre “gli altri”. Una volta poi individuato quel qualcuno o qualcosa su cui scaricare ogni colpa, ci si può sentire sdegnosamente innocenti. Si è compiuto il proprio dovere di Cassandre, Troia può ora tranquillamente bruciare. Nel nostro caso i capri espiatori sono, secondo una crescente scala di “consapevolezza” dettata dalle singole condizioni culturali ed esistenziali, le multinazionali, i “poteri forti”, il capitalismo, ma soprattutto la civilizzazione occidentale nel suo complesso; e l’imputazione è quella di aver sacrificato al proprio dominio l’armonia del cosmo e la libertà degli umani. Il perno di questa operazione di conquista essendo identificato nella razionalità, la soluzione è quella di liberarsi dai vincoli di quest’ultima. La vittima vera del “sacrificio rituale” che dovrebbe ristabilire gli equilibri, ripristinare l’armonia del cosmo violata, è dunque la ragione.
Non sono stato sconvolto dalla lettura del Manifesto, si tratta di cose trite e ritrite; ma ho avuto la conferma che questo modello di pensiero, a diversi livelli di articolazione, è ormai dominante nella maggioranza. Le tesi che gli estensori del documento banalizzano, e cioè che la civilizzazione, intesa nella sua accezione occidentale, sta portando il mondo allo sfascio, che il progresso scientifico e lo sviluppo tecnologico sono gli strumenti per imporre questo dominio e che le istituzioni democratiche sono la foglia di fico dietro la quale questo dominio si nasconde, sono le stesse sostenute con argomentazioni più complesse e raffinate da una élite culturale agguerrita, che opera al di qua e al di là dell’Atlantico e trova i suoi teorici più accreditati in pensatori come Foucault, Agamben, Negri, Severino, ecc. L’influenza di questa élite sul sentimento delle grandi masse non è naturalmente diretta, arriva attraverso la mediazione semplificatoria e spesso distorcente operata dai suoi epigoni telegenici alla Fusaro o alla Massimo Fini, da comici o da giornalisti in fregola di presenzialismo, da moderni Masanielli in cerca di una qualsiasi tribuna e da politici scafati pronti a saltare su ogni cavallo di passaggio: ma comunque arriva, si innesta su quel risentimento populista confuso e diffuso cui accennavo sopra e a giustificare il quale si parla genericamente di un “disagio” (che esiste davvero, ma è appunto soprattutto mentale, legato alla paura di fronte ad una complessità che appare incomprensibile).
In cosa si traduce questo risentimento? Lo vediamo quotidianamente, lo sentiamo tutt’attorno a noi: nella rabbia indiscriminata verso tutti, nel rifiuto di ogni responsabilizzazione, nel negazionismo pervicace, nella crescita del massimalismo che si accompagna alla volubilità nelle scelte politiche, nella rincorsa costante ai diritti e nella negligenza sui doveri, nell’irrisione delle competenze e nell’esaltazione dell’ignoranza “democratizzante”, nella sfiducia nei confronti della scienza e nella credulità superstiziosa, ecc… E poi ci sono altri sintomi che andrebbero colti, meno clamorosi ma non meno inquietanti.
Un banale esempio può valere per tutti. Negli ultimi mesi avrò visto cinquanta servizi sulle innumerevoli specie animali in estinzione, dal leopardo delle nevi alle foche monache e ai pesci del lago nel deserto, ma non uno sulle guerre che si stanno combattendo ad esempio nel sud-Sudan (oltre 80.000 morti e due milioni e mezzo di sfollati), o nello Yemen. Direi che l’antropocentrismo contro il quale tuonava Jeffers è ampiamente superato, anche se ha lasciato il posto ad una consapevolezza pelosa, che tende piuttosto a escludere l’uomo dalla natura anziché includerlo. L’animalismo ha preso pieghe grottesche (lo psicologo per cani e gatti) e ha spinto fino all’assurdo quella negazione delle differenze che nell’interpretazione corretta era stata uno dei cardini della modernità.
Ma non è tutto. Ultimamente il dibattito sulle intelligenze non umane si è allargato a considerare, oltre quelle animali, anche quelle delle piante. A presto una carta dei diritti vegetali, e i decespugliatori saranno messi fuorilegge.
In compenso l’elenco delle specie a rischio prossimo di estinzione si allunga: ci siamo dentro anche noi. E non per eventi naturali, ma per suicidio da decerebrazione. Finisce cha il presagio di Jeffers si avvera.

***

Se la lettura del manifesto Dark Mountain mi ha solo un po’ infastidito, quella di “Contro il Grande Reset. Manifesto del grande risveglio” di Alexander Dugin mi ha lasciato perplesso e preoccupato. Perplesso perché si tratta di un documento decisamente rozzo, o che almeno appare tale in una traduzione che deve essere stata affidata ad un dispositivo digitale o ad un ubriaco, senza più essere rivista nelle bozze. Voglio credere che lo standard delle opere di Dugin sia diverso, altrimenti c’è da chiedersi cosa ci hanno trovato gli “intellettuali” italiani e francesi che da anni lo frequentano (va bene, uno è il solito Fusaro, ma anche Alain de Benoit è un suo assiduo). Probabilmente l’operazione di lancio è stata montata in tutta fretta, per sfruttare l’onda della visibilità offerta a Dugin dall’attentato nel quale è rimasta uccisa la figlia, ma già il testo originale era indubbiamente sbozzato con l’accetta. In copertina è anche annunciata una introduzione di Stefano Borgonovo, che evidentemente è poi saltata, per l’urgenza di mettere on line il documento o per qualche ripensamento del vicedirettore de “La verità” (ho dei dubbi: uno che scrive su “La verità” difficilmente si fa degli scrupoli); o forse più semplicemente perché c’era poco da spiegare.
Ed è proprio questo che mi preoccupa, perché le idee di Dugin, ancorché deliranti, sono terribilmente chiare (nel senso, naturalmente, che persino Borgonovo può intenderle), e l’argomentazione segue una logica elementare di contrapposizione tra cultura occidentale e “idea russa” (o, come vedremo, “eurasiatica”), nell’ottica di un dissolvimento della prima e di un trionfo della seconda. Che tanti occidentali, con una schiera di intellettuali in testa, trovino così affascinante questa idea mi porta a pensare che davvero il deragliamento sia già in corso.
Comunque, procediamo con ordine. Dugin adotta per la sua narrazione un percorso inverso a quello degli estensori del manifesto darkiano. Parte dalla situazione attuale, fa un salto indietro per andare alle origini di quello che definisce un “progetto di globalizzazione e disumanizzazione” e seguirne il percorso nel tempo e analizza infine gli strumenti per contrastarlo (tra i quali non è affatto prevista la poesia). Dal momento che lo fa molto sinteticamente, lascio il più possibile a lui la parola.
L’esordio è da grande complotto. Prende le mosse dal “Great Reset”, un piano che intendeva sfruttare le restrizioni in tempo di Covid per digitalizzare i processi produttivi e le attività sociali, sottoscritto a Davos dal principe di Galles, l’attuale Carlo III d’Inghilterra (il libello è stato scritto prima della scomparsa di Elisabetta, durante l’ultima emergenza pandemica, e non è stato aggiornato), nel quale si delineavano le strategie per avviare un futuro sostenibile.
 Nell’interpretazione di Dugin queste strategie sono intese in realtà solo a puntellare l’ordine esistente. “L’idea principale del Great Reset è la continuazione della globalizzazione e il rafforzamento del globalismo dopo una serie di fallimenti”. Gli obiettivi di fondo del diabolico disegno possono essere riassunti in:
Nell’interpretazione di Dugin queste strategie sono intese in realtà solo a puntellare l’ordine esistente. “L’idea principale del Great Reset è la continuazione della globalizzazione e il rafforzamento del globalismo dopo una serie di fallimenti”. Gli obiettivi di fondo del diabolico disegno possono essere riassunti in:
- Controllo della coscienza pubblica su scala globale, che è al centro della “cultura dell’annullamento” — l’introduzione della censura sulle reti controllate dai globalisti (punto 1);
- Transizione a un’economia ecologica e rifiuto delle moderne strutture industriali (punti 2 e 5);
- Ingresso dell’umanità nel 4° ordine economico (a cui era dedicato il precedente incontro di Davos), ovvero la graduale sostituzione della forza lavoro con i cyborg e l’implementazione dell’intelligenza artificiale avanzata su scala globale (punto 3).
Adesso sappiamo (più o meno) cos’è il Great Reset. Ma come si è arrivati a programmarlo? E chi c’è dietro? Lapalissiano: “Leader mondiali e capi di grandi società – Big Tech, Big Data, Big Finance, ecc. – si sono riuniti e si sono mobilitati per sconfiggere i loro oppositori: Trump, Putin, Xi Jinping, Erdogan, l’Ayatollah Khamenei e altri”. Il povero Carlo è quindi solo un prestanome, anche se in verità la famiglia reale inglese è chiamata volentieri in causa dagli smascheratori di complotti mondiali. Paga ancora il fio del colonialismo ottocentesco e dell’imperialismo del secolo scorso.
La prima mossa dell’offensiva globalista scatenata “dopo una serie di fallimenti” (l’11 settembre, l’elezione di Trump, il pasticcio afgano, ecc…) è stata la vittoria di Biden, che “ha strappato la vittoria a Trump utilizzando le nuove tecnologie, attraverso la ‘cattura dell’immaginazione’, l’introduzione della censura su Internet e la manipolazione del voto per corrispondenza.” Ma come abbiamo visto il globalismo aveva già approfittato dell’occasione offerta dalla pandemia. Infatti: “L’epidemia di Covid-19 è una scusa. Con il pretesto dell’igiene sanitaria, il Great Reset prevede di alterare drasticamente le strutture di controllo delle élite globaliste sulla popolazione mondiale”.
Nello scacchiere geopolitico il piano si muove attraverso “una combinazione di ‘promozione della democrazia’ e ‘strategia aggressiva neoconservatrice di dominio su vasta scala’”. A tal fine “i progetti ambientali e le innovazioni tecnologiche (in primis l’introduzione dell’intelligenza artificiale e della robotica) si coniugano con l’affermarsi di una politica militare aggressiva”.
La parte più intrigante del “Manifesto” arriva però adesso:
“Per capire chiaramente cosa significhino su scala storica la vittoria di Biden e il ‘nuovo’ corso di Washington per il Great Reset, bisogna guardare l’intera storia dell’ideologia liberale, partendo dalle sue radici.
Le radici del sistema liberale (= capitalista) risalgono alla disputa scolastica sugli universali. Questa disputa divideva i teologi cattolici in due campi: alcuni riconoscevano l’esistenza del comune (specie, genere, universalia), mentre altri credevano solo in certe cose concrete — individuali, e interpretavano i loro nomi generalizzanti come sistemi di classificazione convenzionali puramente esterni, che rappresentano ‘suono vuoto’. Coloro che erano convinti dell’esistenza del generale, della specie, attingevano alla tradizione classica di Platone e di Aristotele. Vennero chiamati ‘realisti’, cioè coloro che riconoscevano la ‘realtà di universalia’. Il rappresentante più in vista dei ‘realisti’ era Tommaso d’Aquino e, in generale, era la tradizione dei monaci domenicani. I fautori dell’idea che solo le cose e gli esseri individuali sono reali vennero chiamati ‘nominalisti’, dal latino nomen . La pretesa — ‘le entità non dovrebbero moltiplicarsi senza necessità” ‘— risale proprio a uno dei massimi difensori del ‘nominalismo’, il filosofo inglese William Occam.”
Il progetto ha avuto dunque una quasi millenaria gestazione. Non è figlio della “modernità”, ma piuttosto della “occidentalità”. È nato già con lo “scisma d’Oriente” che nel 1054 ha lacerato la vecchia cristianità (e peraltro anche prima della nascita della Russia).
Sono interessanti le ascendenze che Dugin identifica. La modernità è per lui figlia del francescanesimo, un ordine religioso e un atteggiamento spirituale sempre prossimo alla devianza ereticale – e viene poi presa in carico e affermata dalle sette protestanti. È una lettura genealogica molto rozza, perché non distingue tra luteranesimo, puritanesimo e anabattismo, e non considera il fatto che gli anti-globalisti americani, quelli che più oltre identifica come i “resistenti trumpisti”, sono per lo più animati proprio dalla una fedeltà allo spirito originario del protestantesimo (pietisti, moravi, quaccheri, soprattutto anabattisti e mennoniti-amish, ecc) e arrivano da gruppi religiosi ultra-conservatori. Attribuisce inoltre alla chiesa ortodossa orientale, quella che fa capo al metropolita di Mosca, il merito di aver opposto la maggior resistenza al “nominalismo”. E in questo ha invece pienamente ragione.
Dugin si lancia poi in una cavalcata storica che copre quasi un millennio e chiarisce tutti i nodi fondamentali. “Il ‘nominalismo’ ha gettato le basi per il futuro liberalismo, sia ideologicamente che economicamente. Qui gli esseri umani erano visti solo come individui e nient’altro, e tutte le forme di identità collettiva (religione, classe, ecc.) dovevano essere abolite.
Il nominalismo prevalse prima di tutto in Inghilterra, si diffuse nei paesi protestanti e divenne gradualmente la principale matrice filosofica del New Age (sic: immagino intenda dell’Era moderna) — nella religione (rapporti individuali dell’uomo con Dio), nella scienza (atomismo e materialismo), nella politica (precondizioni della democrazia borghese), nell’economia (mercato e proprietà privata), nell’etica (utilitarismo, individualismo, relativismo, pragmatismo), ecc.
[…] La prima fase è stata l’introduzione del nominalismo nel regno della religione. L’identità collettiva della Chiesa, come intesa dal cattolicesimo (e ancor più dall’ortodossia), è stata sostituita dai protestanti come individui che d’ora in poi potevano interpretare la Scrittura basandosi esclusivamente sul loro ragionamento e rifiutando qualsiasi tradizione. Ciò ha creato un gran numero di sette protestanti controverse.
Parallelamente alla distruzione della Chiesa come ‘identità collettiva’ (qualcosa di ‘comune’), i possedimenti iniziarono ad essere aboliti. La gerarchia sociale dei preti, dell’aristocrazia e dei contadini fu sostituita da indefiniti ‘cittadini’, secondo il significato originario della parola ‘borghese’. La borghesia ha soppiantato tutti gli altri strati della società europea. Ma il borghese era esattamente il miglior ‘individuo’, cittadino senza clan, tribù, professione, ma con proprietà privata.
Fu abolita anche l’unità sovranazionale della Sede Pontificia e dell’Impero Romano d’Occidente, quale altra espressione di ‘identità collettiva’. Al suo posto è stato stabilito un ordine basato su stati-nazione sovrani, una specie di ‘individuo politico’.
[…] La filosofia del nuovo ordine è stata in molti modi anticipata da Thomas Hobbes e sviluppata da John Locke, David Hume e Immanuel Kant. Adam Smith ha applicato questi principi al campo economico, dando origine al liberalismo.
Il senso della storia e del progresso era ormai di ‘liberare l’individuo da ogni forma di identità collettiva’ fino al limite logico.”

Per tutto questo periodo il processo di globalizzazione ha proceduto lineare, ovviamente nei limiti consentiti dalle resistenze opposte dal vecchio mondo. La rivoluzione scientifica e quella industriale ne sono stati la mente e il braccio, e anche i grandi sconvolgimenti politici e sociali, le rivoluzioni inglese, americana e francese, rientravano nel disegno, anzi, ne hanno accelerato l’esecuzione. Le cose si sono invece complicate a partire dal secolo scorso.
[…] Socialisti, socialdemocratici e comunisti hanno contrastato i liberali con identità di classe, invitando i lavoratori di tutto il mondo a unirsi per rovesciare il potere della borghesia globale. Questa strategia si rivelò efficace e in alcuni grandi paesi (sebbene non in quei paesi industrializzati e occidentali dove aveva sperato Karl Marx, il fondatore del comunismo), furono vinte [? Nell’originale sarà ‘vinsero’] le rivoluzioni proletarie.
Parallelamente ai comunisti si verificò, questa volta nell’Europa occidentale, la presa del potere da parte di forze nazionaliste estreme. Hanno agito in nome della “nazione” o di una “razza”, sempre contrastando l’individualismo liberale con qualcosa di “comune”, qualche “essere collettivo”.
I nuovi oppositori del liberalismo non appartenevano più all’inerzia del passato, come nelle fasi precedenti, ma rappresentavano progetti modernisti sviluppati nello stesso Occidente. Ma erano anche costruiti sul rifiuto dell’individualismo e del nominalismo. Lo capirono chiaramente i teorici del liberalismo (Hayek e il suo discepolo Popper), che unirono “comunisti” e “fascisti” sotto il nome comune di ‘nemici della società aperta’, e iniziarono con loro una guerra mortale “.
Da questa guerra nel corso del Novecento sia il comunismo che i fascismi sono usciti sconfitti. Per questo: “Negli anni ‘90, i teorici liberali iniziarono a parlare della ‘fine della storia’. Questa è stata una vivida prova dell’ingresso del capitalismo nella sua fase più avanzata: la fase del globalismo. L’individualismo, il mercato, l’ideologia dei diritti umani, della democrazia e dei valori occidentali avevano vinto su scala globale.”
[…] “A ben guardare, dopo aver sconfitto il nemico esterno, i liberali hanno scoperto altre due forme di identità collettiva. Innanzitutto il genere. Dopotutto, il genere è anche qualcosa di collettivo: maschile o femminile. Quindi il passo successivo è stata la distruzione del genere come qualcosa di oggettivo, essenziale e insostituibile. Gli oppositori esterni hanno ostacolato la politica di genere: quei paesi che avevano ancora i resti della società tradizionale, i valori della famiglia, Combattere i conservatori e gli “omofobi”, cioè i difensori della visione tradizionale dell’esistenza dei sessi, è diventato il nuovo obiettivo degli aderenti al liberalismo progressista.
Con il successo dell’istituzionalizzazione delle norme di genere e il successo della migrazione di massa, che sta atomizzando le popolazioni nell’Occidente stesso divenne ovvio che ai liberali restava un ultimo passo da fare: abolire gli esseri umani.
Dopotutto, l’umano è anche un’identità collettiva, il che significa che deve essere superato, abolito, distrutto. Questo è ciò che richiede il principio del nominalismo: una ‘persona’ è solo un nome, privo di qualsiasi significato, una classificazione arbitraria e quindi sempre discutibile. C’è solo l’individuo — umano o no, maschio o femmina, religioso o ateo, dipende dalla sua scelta.
Pertanto, l’ultimo passo lasciato ai liberali, che hanno viaggiato secoli verso il loro obiettivo, è sostituire gli esseri umani, anche se in parte, con cyborg, reti di intelligenza artificiale e prodotti dell’ingegneria genetica. L’umano opzionale segue logicamente il genere opzionale.”
[…] “Questa agenda è già prefigurata dal postumanesimo, dal postmodernismo e dal realismo speculativo in filosofia, e tecnologicamente sta diventando ogni giorno più realistica. Futurologi e fautori dell’accelerazione del processo storico (accelerazionisti) stanno guardando con fiducia al prossimo futuro quando l’intelligenza artificiale diventerà paragonabile nei parametri di base agli esseri umani. Questo momento è chiamato Singolarità. Il suo arrivo è previsto entro dieci o vent’anni.”
Questa la trama. Lo schizzo storico che Dugin abbozza non è poi, per quanto sbrigativo, del tutto peregrino. Voglio dire che le cose sono andate grosso modo così, anche se poi Dugin legge l’accaduto con occhiali deformanti. E non è nemmeno particolarmente originale. Pesca un po’ dovunque nel pensiero occidentale, da Max Weber a Hegel fino a Heidegger e ai postmoderni più radicali, e cuoce il pescato nella pentola della tradizione slavofila. In sostanza, partendo dai danni reali che la civilizzazione occidentale ha prodotto, in parte come effetti collaterali indesiderati, in parte come distorsioni intrinseche alle scelte fatte – danni che stiamo scontando pesantemente, e che la cultura occidentale più consapevole ha comunque sempre denunciato – arriva a metterne in discussione tutto l’impianto. Che è più o meno quanto faceva Jeffers e quanto predicano i militanti della Montagna Nera, con la differenza però che Dugin prospetta una cura molto peggiore della malattia.
La cura è il “Grande Risveglio”. Che procede per gradi, con velocità diverse nelle diverse parti del mondo, ma già è visibile.
Riassumendo il quadro completo della situazione attuale Dugin ammette: “In effetti le norme della democrazia liberale – il mercato, le elezioni, il capitalismo, il riconoscimento dei ‘diritti umani’, le norme della ‘società civile’, l’adozione di trasformazioni tecnocratiche e il desiderio di abbracciare lo sviluppo e l’implementazione dell’alta tecnologia – in particolare la tecnologia digitale — sono stati in qualche modo affermati in tutta l’umanità”.
Ma la storia non è affatto finita. La madre di tutte le battaglie deve essere ancora combattuta.
“Il Great Reset ‘non è niente di meno che l’inizio dell’‘ultima battaglia’. I globalisti, nella loro lotta per il nominalismo, il liberalismo, la liberazione individuale e la società civile, appaiono a se stessi come ‘guerrieri della luce’, portando progresso, liberazione da migliaia di anni di pregiudizi, nuove possibilità – e forse anche l’immortalità fisica e le meraviglie della ingegneria genetica, alle masse.
Tutti coloro che vi si oppongono sono, ai loro occhi, ‘forze delle tenebre’. Così inizia a delinearsi un nuovo dualismo ideologico, questa volta all’interno dell’Occidente piuttosto che al di fuori di esso. I nemici della ‘società aperta’ ora sono comparsi all’interno della stessa civiltà occidentale.”

Sono immagini che, ribaltando un po’ (ma non troppo) i ruoli delle forze in gioco, evocano Il signore degli anelli e Guerre stellari, e ho l’impressione che soprattutto al primo siano debitrici (Tolkien è in fondo un alfiere della conservazione, anche se le ‘forze del male’ per lui venivano da Oriente). In realtà comunque i nemici della ‘società aperta’ non sono comparsi all’improvviso. Erano già presenti da un pezzo, ma si muovevano a ranghi sconnessi, senza avere un’idea ben precisa della natura vera dell’avversario, delle strategie da perseguire e degli obiettivi cui mirare. “Erano quelli che rifiutavano gli ultimi fini liberali e non accettavano la politica di genere, la migrazione di massa o l’abolizione degli statinazione e della sovranità.
Allo stesso tempo, tuttavia, questa crescente resistenza, genericamente denominata ‘populismo’ (o ‘populismo di destra’), attingeva alla stessa ideologia liberale – capitalismo e democrazia liberale – ma interpretava questi ‘valori’ e ‘punti di riferimento’ nel vecchio senso piuttosto che nel nuovo senso.”
Certo, i campioni di questa resistenza non brillavano per la ricchezza del loro bagaglio culturale o per la finezza delle loro proposte, ma avevano il pregio di coinvolgere attivamente quelle masse popolari che il globalismo stava cloroformizzando:
“Trump non è sempre stato all’altezza del suo stesso articolato compito. E non è stato in grado di realizzare nulla nemmeno vicino al ‘prosciugare la palude’ e sconfiggere il globalismo. Ma nonostante ciò, è diventato un centro di attrazione per tutti coloro che erano consapevoli o semplicemente intuivano il pericolo proveniente dalle élite globaliste e dai rappresentanti di Big Finance e Big Tech inseparabili da loro.”
In realtà: “Trump non stava affatto sfidando il capitalismo o la democrazia, ma solo le forme che avevano assunto nella loro ultima fase e la loro graduale e coerente attuazione. Ma anche questo è bastato a segnare una spaccatura fondamentale nella società americana.”
[…] La forza trainante della mobilitazione di massa dei ‘Trumpists’ è diventata l’organizzazione in rete QAnon, che ha espresso la sua critica al liberalismo, ai democratici e ai globalisti sotto forma di teorie del complotto. Hanno diffuso un torrente di accuse e denunce di globalisti coinvolti in scandali sessuali, pedofilia, corruzione e satanismo.
Sono stati i sostenitori di QAnon, in quanto avanguardia del populismo della cospirazione di massa, a guidare le proteste il 6 gennaio, quando i sostenitori di Trump hanno preso d’assalto il Campidoglio indignati dalle elezioni rubate.”
Per Dugin il fattore davvero importante e decisivo per il passaggio da una strategia di resistenza ad una di attacco è rappresentato proprio dall’emersione nel cuore nell’Occidente di un “nemico interiore”, dal quale “la storia degli ultimi secoli con il suo progresso apparentemente ininterrotto dei nominalisti e dei liberali è messa in discussione”.
Torna anche a sottolineare ripetutamente l’esistenza di un fronte esterno che si sta compattando, e che va dalla Russia di Putin alla Cina (Pechino ha usato abilmente il “mondo aperto” per perseguire i suoi interessi nazionali e persino di civiltà), al mondo islamico (nel quale tanto l’Iran sciita quanto la Turchia e il Pakistan sunniti hanno continuato la loro lotta contro l’occidentalizzazione), all’Africa (sia quella mediterranea che quella subsahariana), e che comincia a coinvolgere anche l’India e il Sudamerica: ma ciò che davvero lo conforta nella sua visione è la nascita di un nuovo dualismo ideologico, questa volta all’interno dell’Occidente piuttosto che al di fuori di esso.
Questo dualismo si fa strada anche nell’ambito intellettuale: “Sul piano filosofico, non tutti gli intellettuali hanno accettato le paradossali conclusioni della postmodernità e del realismo speculativo”.
Ma bada a non insistere troppo su questo piano: “Il Grande Risveglio non riguarda le élite e gli intellettuali, ma le persone, le masse, le persone in quanto tali. E il risveglio in questione non riguarda l’analisi ideologica. È una reazione spontanea delle masse, poco competenti in filosofia, che hanno improvvisamente capito, come bestiame davanti al macello, che il loro destino è già stato deciso dai loro governanti e che non c’è più spazio per le persone in futuro.
D’altro canto, quando deve citare qualche “autorevole” intellettuale schierato contro il Great Reset sembra in difficoltà. Si limita a dire che “Steve Bannon ha svolto un ruolo importante in questo processo, mobilitando ampi segmenti di giovani e disparati movimenti conservatori a sostegno di Trump. Lo stesso Bannon è stato ispirato da autori seri antimodernisti come Julius Evola, e la sua opposizione al globalismo e al liberalismo aveva quindi radici più profonde”. Oppure cita Pat Buchanan, Richard Weaver e Russell Kirk, degli illustri carneade, o Alex Jones, che ha il solo merito di aver coniato lo slogan del “grande Risveglio”.
In realtà il materiale non gli mancherebbe, potrebbe pescare persino in Italia, ma preferisce insistere sul carattere spontaneista, genuino e popolare (o populista, termine che usa in una accezione positiva) del movimento: “La tesi del Grande Risveglio non dovrebbe essere frettolosamente caricata di dettagli ideologici, siano essi il conservatorismo fondamentale (compreso il conservatorismo religioso), il tradizionalismo, la critica marxista del capitale o la protesta anarchica per il bene della protesta. Il Grande Risveglio è qualcosa di più organico, più spontaneo e allo stesso tempo tettonico. È così che l’umanità viene improvvisamente illuminata dalla coscienza della vicinanza della sua fine imminente”.
Arriva ad ammettere che “Il Grande Risveglio è spontaneo, in gran parte inconscio, intuitivo e cieco. Non è affatto uno sbocco per la consapevolezza, per la conclusione, per un’analisi storica approfondita. Come abbiamo visto nel filmato del Campidoglio, gli attivisti Trumpist e i partecipanti a QAnon sembrano personaggi dei fumetti o supereroi Marvel. La cospirazione è una malattia infantile dell’antiglobalizzazione. Ma, d’altra parte, è l’inizio di un processo storico fondamentale. Nasce così il polo di opposizione al corso stesso della storia nella sua accezione liberale”.
Consapevole o meno (certo è difficile parlare di consapevolezza in presenza di QAnon), il Risveglio è comunque tangibile. E anzi, è favorito proprio dal sostrato povero ma genuino di cui si nutre:
“Liberati da un serio bagaglio ideologico e filosofico, gli antiglobalisti hanno saputo cogliere l’essenza dei processi più importanti in atto nel mondo moderno. Il globalismo, il liberalismo e il Grande Reset, come espressioni della determinazione delle élite liberali di portare a termine i loro piani, con ogni mezzo – compresa la dittatura totale, la repressione su larga scala e le campagne di totale disinformazione – hanno incontrato una resistenza crescente e sempre più consapevole.”

L’ultima parte del libello è dedicata alle prospettive di tradurre questa resistenza in vittoria.
“Il Grande Risveglio è solo l’inizio. Non è nemmeno iniziato. Ma il fatto che abbia un nome, e che questo nome sia apparso proprio nell’epicentro delle trasformazioni ideologiche e storiche, negli Stati Uniti, è di grande (forse cruciale) importanza.
Se c’è chi proclama il Grande Risveglio, per quanto ingenue possano sembrare le loro formule, questo già significa che non tutto è perduto, che nelle masse sta maturando un nocciolo di resistenza, che cominciano a mobilitarsi. Da questo momento inizia la storia di una rivolta mondiale, una rivolta contro il Great Reset e i suoi seguaci. Il Grande Risveglio è un lampo di coscienza alla soglia della Singolarità. È l’ultima opportunità per prendere una decisione alternativa sul contenuto e sulla direzione del futuro.
Ma andando poi sul concreto, Dugin deve ammettere che: “Naturalmente, il Grande Risveglio è completamente impreparato. Negli stessi Stati Uniti gli oppositori del liberalismo, sia Trump che i trumpisti, sono pronti a rifiutare l’ultima fase della democrazia liberale, ma non pensano nemmeno a una vera e propria critica al capitalismo. Anche la sinistra contemporanea ha dei limiti nella sua critica al capitalismo, sia perché condivide una concezione materialistica della storia (Marx era d’accordo sulla necessità del capitalismo mondiale, che sperava sarebbe poi superato dal proletariato mondiale) sia perché i movimenti socialisti e comunisti sono state recentemente rilevate dai liberali e riorientate dal condurre una guerra di classe contro il capitalismo alla protezione dei migranti, delle minoranze sessuali e alla lotta contro i “fascisti” immaginari”. Questo si chiama vederci chiaro.
Allo stesso modo “La destra, d’altra parte, è confinata nei suoi stati-nazione e nelle sue culture, non vedendo che i popoli di altre civiltà si trovano nella stessa situazione disperata.
Quindi c’è il Grande Risveglio, ma non ha ancora una base ideologica. Se è veramente storico, e non un fenomeno effimero e puramente periferico, allora ha semplicemente bisogno di un fondamento, che vada al di là delle ideologie politiche esistenti emerse nei tempi moderni nello stesso Occidente.”
Qualcosa di totalmente inedito, insomma. E tanto per cominciare questo qualcosa ha da scavalcare le logiche di contrapposizione bi- o tri-polari:
“Per la salvezza delle persone, dei popoli e delle società, il Grande Risveglio deve iniziare con la multipolarità. Questa non è solo la salvezza dell’‘Occidente stesso, e nemmeno la salvezza di tutti gli altri dall’Occidente, ma la salvezza dell’umanità, Il Grande Risveglio richiede un’internazionalizzazione della lotta dei popoli contro l’internazionalizzazione delle élite.”
In questa prospettiva l’esito dell’inevitabile confronto finale si rivela molto meno incerto. Una rapida carrellata su quelli che potrebbero diventare i poli del Grande Risveglio ribalta i rapporti di forza.
Si parte naturalmente dagli Stati Uniti, che sono già oggi essenzialmente “in uno stato di guerra civile. Sebbene lo stesso Trump abbia perso, ciò non significa che lui stesso si sia lavato le mani, si sia rassegnato a una vittoria rubata e che i suoi sostenitori – 70.000.000 di americani – si siano sistemati e abbiano preso la dittatura liberale come un dato di fatto. Sono stati messi all’opposizione e sono sul punto di diventare illegali, ma un’opposizione di 70.000.000 di persone è seria”.
Pertanto: “Non importa come ci sentiamo nei confronti degli Stati Uniti, tutti noi dobbiamo semplicemente sostenere il polo americano del Grande Risveglio. Salvare l’America dai globalisti, e quindi contribuire a renderla di nuovo grande, è il nostro compito comune”.
Si passa quindi all’Europa. “L’odio per i liberali in Europa cresce contemporaneamente da due parti: la sinistra li vede come rappresentanti del grande capitale, sfruttatori che hanno perso ogni decenza, e la destra li vede come provocatori di migrazioni di massa artificiali, distruttori delle ultime vestigia dei valori tradizionali, distruttori della cultura europea e becchini della classe media. Allo stesso tempo, per la maggior parte, i populisti sia di destra che di sinistra hanno messo da parte le ideologie tradizionali che non soddisfano più le esigenze storiche ed esprimono le loro opinioni in forme nuove, a volte contraddittorie e frammentarie.
L’emergere di un polo europeo del Grande Risveglio deve comportare la risoluzione di questi due compiti ideologici: il definitivo superamento del confine tra Sinistra e Destra (cioè il rifiuto obbligato dell’‘antifascismo’ artificioso di alcuni e di ‘anticomunismo’ inventato da altri) e l’elevazione del populismo in quanto tale – populismo integrale – in un modello ideologico indipendente”.
Per quanto concerne la Cina, “ha sfruttato le opportunità offerte dalla globalizzazione per rafforzare l’economia della sua società. Ma non ha accettato lo spirito stesso del globalismo, il liberalismo, l’individualismo e il nominalismo dell’ideologia globalista.
La Cina è un popolo con una distinta identità collettiva. L’individualismo cinese non esiste affatto e, se esiste, è un’anomalia culturale. La civiltà cinese è il trionfo del clan, del popolo, dell’ordine e della struttura su tutta l’individualità.”
Un grande serbatoio dal quale attingere odio antiglobalista è l’Islam. “Durante il periodo coloniale e sotto il potere e l’influenza economica dell’Occidente, alcuni stati islamici si sono trovati nell’orbita del capitalismo, ma praticamente in tutti i paesi islamici c’è un rifiuto sostenuto e profondo del liberalismo e soprattutto del moderno liberalismo globalista.
Questo si manifesta sia in forme estreme – il fondamentalismo islamico – sia in forme moderate. In alcuni casi, singoli movimenti religiosi o politici diventano portatori dell’iniziativa antiliberale, mentre in altri casi lo Stato stesso assume questa missione. In ogni caso, le società islamiche sono ideologicamente preparate all’opposizione sistemica e attiva alla globalizzazione liberale.” D’altro canto: “Il contesto del Grande Risveglio potrebbe diventare una piattaforma ideologica anche per l’unificazione del mondo islamico nel suo insieme.”
Infine: “Il polo più importante del Grande Risveglio è destinato alla Russia (nessuno ne dubitava). Nonostante la Russia sia stata in parte coinvolta nella civiltà occidentale, attraverso la cultura illuminista durante il periodo zarista, sotto i bolscevichi, e soprattutto dopo il 1991, in ogni fase – nell’antichità come nel presente – la profonda identità della società russa è profondamente diffidente nei confronti dell’Occidente.
L’identità russa ha sempre dato la priorità al comune – il clan, il popolo, la chiesa, la tradizione, la nazione e il potere, e persino il comunismo rappresentava – sebbene artificiale, in termini di classe – un’identità collettiva contraria all’individualismo borghese.
Il significato della storia russa è stato diretto proprio verso il futuro e il passato ne era solo una preparazione. E in questo futuro che si avvicina, il ruolo della Russia non è solo quello di partecipare attivamente al Grande Risveglio, ma anche di esserne in prima linea, proclamando l’imperativo dell’Internazionale dei Popoli nella lotta al liberalismo, la peste del ventunesimo secolo.
La Russia si è rivelata l’erede di due imperi che crollarono all’incirca nello stesso periodo, nel XV secolo: l’impero bizantino e quello mongolo. L’impero è diventato il nostro destino. Anche nel XX secolo, con tutto il radicalismo delle riforme bolsceviche, la Russia è rimasta un impero contro ogni previsione, questa volta sotto le spoglie dell’impero sovietico. Ciò significa che la nostra rinascita è inconcepibile senza il ritorno alla missione imperiale fissata nel nostro destino storico.”
“Questa è la nostra missione: essere il katechon, ‘colui che trattiene’, impedendo l’arrivo dell’ultimo male nel mondo.
Pertanto, il risveglio imperiale della Russia è chiamato ad essere un segnale per una rivolta universale di popoli e culture contro le élite globaliste liberali. Attraverso la rinascita come impero, come impero ortodosso, la Russia costituirà un esempio per altri imperi: cinese, turco, persiano, arabo, indiano, nonché latinoamericano, africano… e europeo.”

Che dire? Il testo si commenta da solo (anche la foto sopra). Mi scuso se le continue e lunghe citazioni lo hanno reso di faticosa lettura, ma mi sembrava inutile parafrasare le argomentazioni di Dugin, dal momento che sono esposte già in maniera sintetica e tutto sommato abbastanza chiara. Mi limito pertanto ad aggiungere un’indicazione e un paio di osservazioni.
L’indicazione è per “L’idea russa”, di Bengt Jangfeldt, breviario indispensabile per chi volesse approfondire la storia profonda che sta dietro questo manifesto, a partire dal panslavismo ottocentesco. È un libro snello quasi quanto quello di Dugin, ma di ben altro “spessore”.
La prima osservazione riguarda l’uso o il non uso di determinati termini. In tutto il testo la voce Eurasia compare una sola volta. Eppure riassume l’idea di fondo di Dugin, per il quale la Russia è una realtà culturale e territoriale totalmente autonoma e sostanzialmente compatta, pur se insistente su due continenti diversi (i continenti sono una convenzione geografica). Forse non voleva forzare troppo la mano su questo concetto, che suppone un legame forte, sia culturale che storico-politico, con l’Oriente, e quindi una propensione espansionistica ed egemonica in quella direzione: cosa che non può suonare gradita né alla Cina né all’Islam, gli altri due grandi poli del Risveglio. Tra l’altro, in questo unico riferimento Dugin cita lo storico e antropologo Lev Nikolaevič Gumilëv (figlio di Anna Achmantova), che in realtà non attribuiva affatto al termine Eurasia un significato politico ma lo considerava solo un paradigma storiografico. Piuttosto, il riferimento a Gumilëv è significativo se si considera il concetto da questi coniato di ethnos, inteso come “un collettivo che si differenzia dagli altri per un proprio stereotipo comportamentale e contrappone sé stesso a tutti gli altri collettivi”. Definizione che si presta molto bene a spiegare l’idea che Dugin ha del popolo russo.
Un altro termine che nel testo non compare mai è razionalismo, pure aleggiando costantemente, sotto le specie del suo derivato applicativo razionalizzazione, dietro i progetti dei liberali globalizzanti. Credo che anche questa cosa abbia un senso: Dugin non vuole lasciare in appannaggio agli avversari il monopolio della ragione, e anzi tende a sottolineare la loro perversa devianza da quello che ne sarebbe un uso onesto e corretto: ma non può nemmeno farne la bandiera di un movimento che, per sua stessa ammissione, è nato ed è tuttora mosso da pulsioni irrazionali.
Allo stesso modo, non mette sotto accusa direttamente la scienza, se non per denunciarne l’uso criminale volto ad azzerare le coscienze e a sostituire l’uomo con un suo clone digitale. I richiami costanti all’impero e alla tradizione ortodossa non ne fanno un nostalgico reazionario, così come le strizzate d’occhio al trumpismo e a QAnon non ne fanno un complottista grossolano e ignorante: sono esche per la pesca a strascico, i primi ad uso interno, le seconde lanciate in acque internazionali: allo stesso modo in cui i riferimenti a Tommaso d’Aquino, ultimamente tornato di moda e non solo tra i teologi, lo sono negli ambienti culturali più all’avanguardia.
E ancora. Il termine “democrazia” compare nel testo sempre legato a “liberale”, in una accezione che l’aggettivo rende negativa, perché sta come “rappresentativa”. In luogo della rappresentanza democratica Dugin propone invece quella “comunitaria”: “L’identità russa ha sempre dato la priorità al comune – il clan, il popolo, la chiesa, la tradizione, la nazione e il potere, e persino il comunismo rappresentava – sebbene artificiale, in termini di classe – un’identità collettiva contraria all’individualismo borghese.”
Dugin ha in mente (altrove lo cita espressamente), il mir, l’assemblea di villaggio che nella Russia zarista gestiva tutti gli obblighi comunitari nei confronti dello stato, dalle esazioni fiscali al reclutamento per l’esercito. La rievoca a sostegno dell’immagine di un’identità russa che sino alla vigilia della prima guerra mondiale aveva resistito alle sirene della modernizzazione e dell’individualismo. L’idea che ha della democrazia non si scosta molto da quanto scritto da Massimo Fini – un intellettuale antisistema, come lui stesso si definisce – qualche settimana fa su “Il fatto quotidiano” (credo che i servizi russi di controinformazione abbiano sottoscritto l’abbonamento – e forse più di uno – al quotidiano di Travaglio):
“Non credo alla democrazia rappresentativa (cfr. Sudditi. Manifesto contro la Democrazia). Credo solo alla democrazia diretta, quella immaginata del ginevrino Rousseau. La democrazia esisteva quando non sapeva di essere democrazia. Nell’ancien régime l’assemblea del villaggio, formata da tutti i capifamiglia, in genere uomini ma anche donne se il marito era morto, decideva su tutto ciò che riguardava il villaggio.” Che è una ricostruzione di quanto avveniva nell’ancien régime piuttosto fantasiosa.
Quella di Fini è solo una delle tante voci – non certo tra le più autorevoli, ma che trova comunque un suo non trascurabile uditorio tra gli indignati a vita e una cassa di risonanza negli organi della “controinformazione” antiglobalista, pentastellata o meno – che propugnano come nuovo (o antico) modello di socialità il comunitarismo. La nebulosa comunitaria offre il migliore spaccato del mare ideologico interno all’Occidente nel quale Dugin può pescare. Di comune c’è in realtà solo la concezione di massima per la quale l’individuo esiste in virtù delle sue appartenenze culturali, etniche, religiose o sociali, ovvero della sua possibilità di creare comunità. Questa concezione può poi essere declinata in varie maniere, che vanno dall’integralismo cattolico all’anti-illuminismo della Nouvelle Droite fino alla ibridazione col marxismo, più rozza in Costanzo Preve e più articolata in Andrè Gorz: e ha forti implicazioni, oltre che sul piano del rapporto individuale con le istituzioni (il concetto di cittadinanza attiva e di partecipazione politica è molto simile a quello della pòlis greca), su quello etico (ad esempio, rifiuta l’aborto).
A questo si riferisce evidentemente Dugin quando parla di una quinta colonna antiglobalista che sgretola dall’interno la “civiltà” occidentale.
La seconda osservazione concerne ancora il tema degli “apparentamenti”. Mentre leggevo il manifesto di Dugin provavo una sensazione di déjà vu, e mi è tornato in mente qualcosa di molto simile in cui mi ero imbattuto diversi anni fa. Ho verificato poi che si tratta della prolusione ad una Conferenza Internazionale sulla Depressione (svoltasi nel 2004). L’autore era il cardinale Javier Lozano Barragán, che al termine di una carrellata ancor più sintetica di quella di Dugin sulla storia del pensiero occidentale arrivava a riassumere così la situazione attuale:
“Non vi è unità ma solo frammentazione. La società si trasforma in gruppi di simboli, associazioni, movimenti. La solidità del partito politico, ‘della comunità, della nazione, sono così sostituiti.
L’uomo radicale professa un individualismo totale, possessivo e anarchico; si manifesta in una serie di negazioni: è antifamiliare, antimilitarista, anticlericale, antipartito, antistatale. Alla sua spontaneità attribuisce un valore assoluto, con le conseguenze socio-politiche della liberazione sessuale, dell’omosessualità, del femminismo, dell’aborto, del divorzio, della lotta contro i manicomi, contro le carceri, contro i concordati, per l’abolizione dell’insegnamento religioso, ecc. È l’uomo dell’anticultura radicale.”
Le diverse valutazioni che il cardinale dava del peso da attribuirsi alle vicende storiche o alle successive correnti di pensiero non inficiano la sostanziale omogeneità dello schema di lettura adottato. Ad Occam ad esempio Barragán faceva appena cenno, ma per contrapporlo “ai grandi pensatori che culminano nella Scolastica”, in primis a proprio a Tommaso d’Aquino. Un modo elegante per liquidare il nominalismo, senza per questo tacerne l’influsso negativo. Lo stesso dicasi per gli esiti della riforma protestante. Certo, il documento non prendeva in considerazione il ruolo di ‘resistenza’ del cristianesimo ortodosso, che tanta importanza ha per Dugin, e lo attribuiva invece in toto alla Chiesa cattolica: ma insisteva comunque sull’effetto di disgregazione indotto dalla modernità, e in termini non molto diversi da quelli usati dall’ideologo russo.
Non credo che negli ultimi vent’anni la posizione del mondo cattolico militante sia cambiata molto, se non nel senso di essere diventata ancor più critica nei confronti della “globalizzazione capitalistica”. Questo spiega e “giustifica” le convergenze sul piano della politica internazionale con l’universo ex-sovietico, la comprensione per i regimi che si reggono sull’integralismo religioso, le posizioni filo-putiniane professate recentemente, a fronte dell’invasione dell’Ucraina, non solo dall’ala arroccata su postazioni preconciliari, ma anche da molti esponenti della base (condivise ad esempio dal nuovo presidente della Camera, assieme all’apprezzamento per la “coerenza” patriottica e antiliberale del metropolita di Mosca).
È ciò cui si riferisce Dugin quando afferma che nella battaglia contro il globalismo, per far decollare il Grande Risveglio, tutti i mezzi e tutti gli alleati vanno bene: non è importante partire da una piattaforma di idee comuni, ma identificare il nemico comune. A uniformare le idee e a stabilire i confini si provvederà dopo, e ciascuno degli insorgenti lo farà a casa propria e a modo suo (sempre che i confinanti glielo permettano). Come abbiamo visto sopra, quindi, si parli di “grande risveglio” (che è peraltro l’etichetta usata anche dai gruppi avventisti d’oltreatlantico), di rinascita spirituale collettiva, di Jihad o di sindrome complottista, il banco del quale Dugin aspira ad essere il pesce-pilota è ricchissimo, vi nuotano nella stessa direzione le specie ittiche più diverse, dai pescecani ai tonni. Ma soprattutto è decisamente sguarnito e scarsamente motivato quello dei suoi difensori, o almeno di quelli che pur riconoscendo la strumentale malafede dell’ideologia di Dugin non possono fare a meno di condividerne almeno in parte la lettura storica. Costoro si trovano a combattere su due fronti, stando nel bel mezzo dello scontro, senza vedere alcuna realistica via d’uscita. Non occorre essere apocalittici per capire che si annunciano tempi duri.

***
I due “manifesti” precedenti (ma a questo punto possiamo dire tre, comprendendo anche quello del cardinal Barragán) ci prospettavano diversi scenari possibili del crollo dell’occidente: il primo per implosione interna, il secondo per un attacco dall’esterno, il terzo per trasgressione delle leggi divine.
Aldo Schiavone non è così pessimista. Ne “L’Occidente e la nascita di una civiltà planetaria”, che non è un manifesto ma ha la densità e le ambizioni di un vero saggio, vede le stesse cose che vedeva Jeffers e che vedono oggi gli “incivilizzati”, parte da constatazioni che sono proprie anche di Dugin, ma lo fa da un angolo prospettico e con una disposizione d’animo completamente diversi. Non potrò seguirlo passo dopo passo come in pratica ho fatto nei due casi precedenti, ma cercherò di ordinarne le tesi in una sequenza ordinata. Andrà persa la ricchezza delle argomentazioni, ma m’importa arrivare al nocciolo.
Già dalla prima pagina si capisce che Schiavone non è un catastrofista; non dice che il mondo va a ramengo, ma che è sempre più complicato viverci.
“Viviamo in un mondo che non è mai stato così complesso e anche così caotico – di una complessità̀ che produce (tra molte altre cose) disordine – con due principali componenti che concorrono, sia pure non da sole, a determinare questi caratteri.
La prima è un prodotto delle nuove possibilità della tecnica, che mettendo in contatto realtà finora non comunicanti e anzi drasticamente separate – nello spazio e nel pensiero – ha moltiplicato reti di interazioni sempre più intricate e difficili da decifrare, creando un contesto che è estremamente arduo comprendere e padroneggiare.
La seconda è costituita dalla convivenza intorno a noi – quasi dovunque in Occidente, come esito del salto tecnologico – di due insiemi culturali e sociali del tutto disomogenei, ma intrecciati l’uno nell’altro, ciascuno dei quali condiziona e coinvolge in modo opposto: uno che sta sparendo – in maniera spesso dolorosa e a volte perfino cruenta – mentre l’altro sta appena cominciando a formarsi, e non ha ancora un volto ben definito, anche se già se ne avvertono la presenza e l’impatto.”
Il che significa che gli occidentali non sono sgomenti e passivamente rassegnati come vorrebbero tanto Dugin che Jeffers (sia la natura o siano altre culture a metterli sotto attacco), ma sono senz’altro sconcertati.
Prima di spiegarci il perché di questo sconcerto, Schiavone chiarisce cosa intende per Occidente: “Occidente si dice in molti modi, per lo più contrapposti. È una parte del mondo o la matrice di valori universali? Lo spazio in espansione della democrazia o quello del suo declino? La terra del tramonto o l’alba di un nuovo inizio?”
Per Schiavone c’è intanto un Occidente geopolitico (il global North), che è definito in linea di massima dal maggiore sviluppo industriale, e di conseguenza dalla maggiore ricchezza individuale, sia pure distribuita inegualmente. Questi parametri sono al momento attuale invalidati dalla crescita rapidissima di altre potenze economiche, fino a ieri relegate nel global south, quello che una volta si chiamava terzo mondo: l’accezione “economica” va quindi perdendo rilevanza, perché corrisponde sempre meno alla reale situazione.
Il termine assume poi un secondo significato, che designa invece una categoria universale dell’incivilimento umano, una forma di civiltà. Questo Occidente – dice Schiavone – è “un insieme di cultura, acquisizioni tecnologiche, economia, rapporti sociali, modelli e valori politici e giuridici, stili di vita, sviluppatosi originariamente in Europa, poi trapiantato in America e diffuso nel mondo fino a presentarsi ormai come tendenzialmente delocalizzato”. Ed è a questo secondo significato che l’autore farà costante riferimento.
Ad una percezione superficiale, quella che tiene conto soprattutto dei parametri economici, vince l’impressione che al rapido scombussolamento in corso degli assetti economici corrisponda una crisi ben più profonda, quasi un crollo, della intera “civiltà” occidentale. Non è cosa nuova: già nella prima metà del Novecento, quando ancora l’Occidente dominava in pratica tutto il resto del globo, si moltiplicavano le voci di un suo imminente rovinoso collasso (Spengler per tutti, ma anche Freud o i francofortesi, o economisti come Schumpeter e sociologi come Revel, o distopisti come Orwell e Bradbury). “[…] Possiamo dire sin d’ora che in tutte le predizioni di declino o addirittura di rovina dell’Occidente c’è un tratto comune, al di là degli eventuali elementi di verità che in qualche caso possono contenere.” Il tratto comune sarebbe appunto l’aumento, divenuto esponenziale, della complessità.

E tuttavia, a dispetto di eventi catastrofici (crisi economiche, conflitti mondiali, ecc.) il crollo non c’era stato, o non era stato comunque così rovinoso. Anzi, verso la fine del secolo, con la caduta del muro di Berlino e la dissoluzione dell’URSS, che per quasi l’intero secolo aveva rappresentato il principale competitor, il modello liberal-capitalistico era parso uscire definitivamente vincitore, così da far ricomparire un cauto ottimismo (espresso ad esempio da Fukuyama ne “La fine della storia”)
Le cose sono rapidamente cambiate dopo l’ingresso nel nuovo millennio: prima con l’11 settembre 2001, con la guerra in Afghanistan e la fine della “pace americana” nel mondo; poi con il dissesto finanziario ed economico esploso nel 2008; quindi con l’epidemia del Covid-19 e infine con la guerra nel cuore dell’Europa, il tema è tornato in voga. Sono cadute in pratica le certezze sul proprio ruolo-guida che l’Occidente aveva maturato nel corso degli ultimi cinquecento anni. Si sono dissolte sotto la spinta dei “risvegli” altrui, ma soprattutto per una esasperazione del sentimento autocritico che da sempre ha controbilanciato la presunzione di superiorità (persino un apologeta della civilizzazione occidentale come Arnold Toynbee ammetteva che “Nell’incontro fra il mondo e l’Occidente, in corso da ormai quattro o cinque secoli, la parte che ha vissuto un’esperienza significativa è stata finora il resto del mondo, non l’Occidente. Non è stato l’Occidente a essere colpito dal mondo; è il mondo che è rimasto colpito – e duramente colpito – dall’Occidente”).
Per Schiavone il risultato è che si sta diffondendo “una sorta di sindrome occidentale […]; uno stato d’animo che ha dato origine a una vera e propria cultura della paura e della crisi […]; tensioni che, in alcuni ambienti e circostanze soprattutto europei, hanno assunto caratteri propriamente anticapitalistici e antiamericani […]; orientamenti riconducibili a una specie di fondamentalismo antitecnologico, che fanno coincidere la tecnica con l’Occidente […]; un illanguidirsi delle appartenenze e delle identificazioni nazionali; la maggiore permeabilità sociale e personale tra i generi […]; la minor presa dei legami familiari; la trasformazione dell’etica del lavoro […]; le nuove forme di solitudine […]; l’appannarsi e il relativizzarsi del sentimento religioso, e in specie della comune identità cristiana – paragonata al fervore dell’Islam […]”.
Sono elencati in pratica tutti quei sintomi che abbiamo visto comparire nei tre precedenti manifesti, segnatamente in quello di Dugin, ma che là erano letti “positivamente” come segnali di risveglio, o quanto meno di una presa di coscienza. Schiavone li interpreta invece come frutto di “una lettura (apologetica e nostalgica) del passato, trasformata in previsione e in giudizio (fortemente negativi) sul futuro”.

Questa lettura “emotiva” è alimentata dalla deplorevole tendenza a trascurare gli studi storici a favore dei “cultural studies”, che alla ricerca di una sia pur imperfetta “oggettività” sostituiscono le interpretazioni delle vicende. La storia come la conosciamo e come veniva insegnata sino a ieri è accusata di essere una ricostruzione “occidentale”: ad essa viene opposta la “memoria storica”, che non è una disciplina, nel senso che non prevede il confronto sulla base di regole e criteri il più possibile oggettivi e condivisi. Ora, se i risultati del dibattito storico non danno la verità assoluta, ma almeno una verità sempre in fieri, le ricostruzioni operate sulla base della memoria ci rimandano ad esperienze singole o collettive che quasi mai sono state vissute e percepite allo stesso modo dagli altri protagonisti (e meno che mai dagli antagonisti). Si dice che la storia è scritta dai vincitori, ed è vero: ma è altresì vero che poi la correggono o la riscrivono gli storici, e che il compito di costoro è di arrivare, attraverso il confronto, ad una ricostruzione che regga il vaglio degli strumenti critici. In questo senso, con tutte le cautele del caso, si può affermare che la storia è una disciplina scientifica.
“È la storia che ci può aiutare a capire, – scrive Schiavone – che può rendere possibile questo radicale ma indispensabile cambio di prospettiva, aperto sul futuro. Non soltanto la storia, probabilmente: ma lei di sicuro. Ed è innanzitutto un difetto di adeguata storicizzazione a impedirci di mettere nella giusta luce quel che si vede dal nostro oggi, e a farci confondere l’alba con il tramonto, l’incompiutezza con il declino. Quasi avessimo smarrito la capacità di connettere gli eventi secondo strutture di senso che solo se colte attraverso la loro storicità possiamo sperare di rappresentare nella loro completezza, e quindi di conoscere veramente. Come se la ragione delle cose che stanno accadendo avesse sovrastato la razionalità del pensiero che dovrebbe comprenderle: una condizione che se durasse a lungo, allora sì, che potremmo dire di essere perduti.”

A dire il vero, quella che emerge dal libro è una concezione non particolarmente scientista: sembra anzi riprendere la filosofia della storia hegeliana, in quanto Schiavone cerca nel futuro le chiavi per l’interpretazione del passato, anziché viaggiare in senso opposto (e va aggiunto che anche Hegel vedeva nell’Occidente – quello che era tale alla sua epoca, quello europeo – il principale motore della storia universale, o addirittura l’unico.)
Per l’autore “la storia correttamente letta ci insegna che l’umano ha un futuro. Questo è indubbio. Come è altrettanto indubbio che l’umano, non essendo vincolato a un’essenza in forza di una legge di necessità, sta cambiando e continuerà a farlo, a oltrepassarsi, in una dimensione post-umana che lo ha accompagnato non da oggi ma da sempre, in una lotta infinita con i propri limiti”.
Dopo quanto accaduto negli ultimi decenni l’Occidente sembra però avere persa la sua capacità di guardare avanti: “L’Occidente immagina il futuro o come un prolungamento indefinito del presente o come un luogo abitato da ansia e paura. Un luogo di incertezza e di peggioramento della propria condizione sociale ed economica. Un luogo di perdita di vita complessiva della propria dignità. Arroccati nella nostalgia di un passato ormai esaurito, perdiamo la direzione complessiva del processo in corso, il suo senso d’insieme.”
Questo accade proprio nel momento in cui si annuncia una trasformazione epocale. “E così non vediamo il salto di civiltà che abbiamo di fronte. Non sappiamo sintonizzarci alla svolta che viviamo. Orientarsi in questo intrico, venire a capo delle sue sconnessioni, è tutt’altro che facile. Come se fossimo finiti in una zona morta della nostra capacità di vedere.”
La svolta di cui Schiavone parla sta nel fatto che “oggi la storia evolutiva sta smettendo di essere un presupposto immodificabile e sta per diventare un risultato delle nostre scelte. Questo perché nel giro dei prossimi decenni, non dei prossimi secoli, avremo una capacità inedita di incidere sulla nostra struttura e sulla forma biologica delle nostre vite e di modificarla.”
È questa l’idea portante che attraversa tutto il libro. Quella del passaggio della nostra specie da una storia “naturale” – controllata soltanto dai meccanismi dell’evoluzione, quindi affidata alla biologia – alla storia “culturale”. Non è certamente un’idea nuova, ma qui viene spinta sino alle estreme conseguenze. D’altro canto, era un tema già presente diversi anni fa nel saggio più famoso di Schiavone, “Storia e destino”, e sta alla base anche di tutti i suoi studi successivi sulla natura del diritto. È “[…] il superamento della separazione tra storia della vita e storia dell’intelligenza. Le basi naturali della nostra esistenza smetteranno presto di essere un presupposto immodificabile dell’agire umano, e diventeranno un risultato storicamente determinato dalla nostra cultura. Questo ricongiungimento, il passaggio dal controllo evolutivo della specie dalla natura alla mente non è lontano […]”.
La storia “culturale” nasce con la comparsa della tecnica, anzi, è la storia di come la tecnica abbia modificato i rapporti dell’uomo con tutto ciò che lo circonda, con la natura e con i suoi simili, ma soprattutto con se stesso e con il proprio destino. Perché la tecnica compare in funzione e a supporto di una progettualità, mirata ad un aumento del benessere e della sicurezza dei singoli e della specie: ovvero, compare associata all’idea di “progresso”.
“L’idea di progresso – ci spiega Schiavone – esprime qualcosa di profondo e di essenziale: una rappresentazione della storia senza la quale la nostra identità e la nostra capacità di progettare il futuro sono a rischio. Dentro un’idea positiva del futuro come progetto, come speranza, come proiezione in avanti delle nostre vite ecco che appare l’idea di progresso.”
Non va dunque liquidata come un rottame illuministico: “Oggi più che mai, noi come specie umana, abbiamo bisogno di recuperare una parola come progresso. Ne abbiamo bisogno perché quella parola ci consente di riappropriarci del futuro.”
Quel “noi”, prima ancora che all’intera specie umana, si riferisce agli occidentali. E qui sta la specificità della posizione di Schiavone. La fiducia nel progresso va recuperata innanzitutto da chi ne è stato sino ad oggi il principale interprete. Alla faccia della “cancel culture” dilagante, Schiavone rivendica all’Occidente un primato (anche se scrive: “non si tratta di rivendicare primati. E tanto meno di fissare gerarchie antropologiche, ma di riconoscere percorsi storici disuguali”). Perché “solo l’Occidente ha prodotto l’autonomia della scienza e la rivoluzione industriale”.
E aggiunge: “l’Occidente è definito dal proprio eccezionalismo perché è il continente delle idee e della libertà”.
La civiltà “eccezionale” che l’Occidente ha espresso è frutto della superiore capacità performativa della sua tecnica. Torna dunque l’annosa questione: la tecnica, proprio per lo stretto legame che immediatamente stringe con il capitale, ma anche a prescindere da questo, per l’atteggiamento performativo che induce nei confronti della natura, è di per sé “disumanizzante”? le derive sociali, ambientali, politiche e psicologiche di cui oggi è chiamata responsabile, le sono intrinseche? Schiavone non ha dubbi. Intanto, usa i termini capitale e capitalismo spogliati di ogni valenza ideologica, positiva o negativa: il capitale è il fondamento economico che permette alla tecnica di svilupparsi, traendo dalla tecnica stessa le risorse da reinvestire. Ritiene poi che le derive non siano un problema attinente la tecnica. Quest’ultima è solo un mezzo che apre all’uomo infinite possibilità di scelta e varianti di sviluppo. Produce risorse, e quindi anche strumenti di dominio o di distruzione, che dovrebbero però poi essere controllati e guidati dalla politica, dall’etica, dal diritto.
Il problema vero sta per lui nel fatto che quanto la tecnica ha più o meno direttamente indotto, dalla filosofia alla politica, al diritto, ai valori cardine della libertà e dell’uguaglianza che si esprimono nella democrazia, non tiene il passo con la tecnica stessa (e con l’economia che le è connessa). Non lo tiene perché è oggettivamente difficile marciare in pari con uno sviluppo tecnologico ed economico così prodigioso come quello odierno, ma anche perché da tempo l’eccezionalismo occidentale è messo in discussione, come abbiamo visto nei manifesti precedenti, dal suo stesso interno: il modello di crescita che ha informato questo sviluppo ha contraddetto troppo spesso i valori di cui si faceva portatore, principalmente quello dell’uguaglianza, suscitando le reazioni più disparate (estremismo, populismo, rivendicazioni identitarie, cancel culture, ecc..). Ma ciò che soprattutto pesa, secondo Schiavone, è “il declino di un intero sistema di saperi”, quello che stava invece alle spalle della tecnica e del capitale nell’Ottocento. Manca la capacità di “leggere” in un quadro d’insieme tutti gli aspetti dello sviluppo tecnologico, e quindi di governarne e orientarne le ricadute economiche e sociali.
Comunque, a dispetto delle sue contraddizioni, “l’Occidente ha costruito ciò che abbiamo chiamato modernità – e l’ha fatto non solo per se stesso, ma per tutto l’umano: ce ne stiamo appena rendendo conto. In effetti però, se guardiamo bene come solo ora ci è consentito di fare, ci accorgiamo che quella che abbiamo finora sperimentato non è stata la modernità nel suo pieno realizzarsi – come si è a lungo creduto – ma solo una specie di suo straordinario per quanto difficile prologo. Una faticosa e non lineare preparazione del salto decisivo che solo adesso stiamo iniziando a spiccare: una specie di protomodernità cominciata nelle città italiane del Rinascimento e conclusa sulle rive del Pacifico con l’avvio della rivoluzione tecnologica del tardo Novecento e con il culmine politico dell’impero americano che hanno gettato un ponte tra i due lembi di quell’oceano.”
Se la smettessimo per un attimo di autoflagellarci, scrive ancora Schiavone, dovremmo ammettere che dopo l’impatto con la civiltà occidentale “masse di donne e di uomini sono uscite per la prima volta dalla naturalità di un’esistenza spesa solo per sopravvivere, e hanno alzato lo sguardo oltre l’acqua per dissetarsi e il cibo per sfamarsi. In una manciata di anni, parti intere del pianeta – in Asia, specialmente, soprattutto nei grandi contesti urbani – hanno acquistato una visibilità mai posseduta; e chi ci vive è riuscito ad appropriarsi, per quanto poteva, del proprio destino. Enormi blocchi di umano sono per così dire usciti dalla natura ed entrati nella storia: in diversi modi, e per diverse vie. Hanno incontrato pezzi di modernità e si sono dati un tessuto identitario secondo l’unico modello disponibile: quello che l’Occidente ancora una volta vincitore – molto al di là di quanto egli stesso, anche per sfuggire alle proprie responsabilità, non riesca e non voglia riconoscere – ha saputo loro proporre”.
A questo punto secondo Schiavone si aprono per il futuro dell’umanità scenari ancora inesplorati, e il tono della trattazione diventa quasi visionario – anche se l’autore cerca di tenere i piedi sempre poggiati sulla concretezza. “Si riesce a capire il significato del presente solo così, cercando di guardare quel che ci aspetta per decifrarne il senso. Il mondo intero sta entrando nella versione globale della modernità”. La nostra epoca è testimone di un evento senza precedenti: la nascita della prima civiltà planetaria della storia. Una civiltà che vedrà fusi in un sistema unico il capitalismo e la tecnica, perché il capitalismo è esso stesso una potenzialità tecnica, è una macchina economica: e una volta che l’azione di questa macchina sarà diffusa a livello sovranazionale verrà liberata tutta la sua forza emancipativa. La crescita esponenziale della potenza prodotta dalla tecnica darà presto all’uomo, quasi totalmente affrancato dalla dipendenza dalla natura, la possibilità di decidere del proprio destino biologico.

Questa radiosa (?) prospettiva è però al momento tutt’altro che scontata. La strada è ancora molto lunga. “È al centro di una lotta in parte non anc0ra decisa che dobbiamo prendere coscienza di trovarci. Ed è questa la sfida che aspetta l’Occidente. Non solo tenere a battesimo un mondo nuovo: questo in qualche modo lo ha già fatto. Ma completarne la fisionomia secondo la razionalità che è capace di esprimere, e dargli un’anima e un destino – come solo lui si è dimostrato in grado di poter fare.
Sappiamo bene che sono in questione aspetti della nostra identità ai quali abbiamo legato parti importanti delle vite appena trascorse […] a cominciare da una certa idea di nazione, di classe, di lavoro, di famiglia, di genere – e saranno da trasformare radicalmente, se non da dismettere. […] Ma è proprio una caratteristica dell’Occidente quella di vivere rivoluzionando continuamente se stesso.”
Prima di arrivare a questo stadio tuttavia l’Occidente dovrà superare una serie di contraddizioni. “La prima è quella tra l’unificazione tecnocapitalistica del mondo e la sua frammentazione politica. Va quindi impedito il consolidarsi di una “alleanza asiana”, che veda la Russia, la Cina, il Pakistan, l’India e parte dei paesi mediorientali consolidare un blocco in funzione anti-occidentale e anti-democratica.” Per Schiavone questo rischio è concreto e presente (non so se abbia letto Dugin, ma ha scritto il saggio già avendo presente quanto accade in Ucraina); al tempo stesso però non crede possa nascere un sistema egemonico alternativo centrato sull’Asia (Cina o India) e/o sulla Russia, perché a suo parere nessuna di queste potenze è in grado di esportare su scala globale una visione del mondo e un modello culturale e sociale universalmente appetibili (sono d’accordo), e possiede capacità di innovazione tecnologica analoghe a quelle dell’Occidente (non sono d’accordo). D’altro canto “anche la Russia post-sovietica è diventata qualcosa di diverso, sulla cui carne i processi di mondializzazione stanno incidendo in modo lento ma irreversibile. Da una società neocapitalistica, per quanto ancora fragile, è assai complicato uscire, una volta che il meccanismo si è avviato”. E in Cina “il progetto perseguito dai gruppi dirigenti di modernizzare in senso occidentale la società apre a prospettive che vanno seguite con attenzione: anche lì si creeranno contrasti difficili da gestire”.
Al di là però delle arretratezze e dei problemi dei competitori, l’Occidente ha già in sé secondo Schiavone gli anticorpi per scongiurare la formazione di una alleanza asiana, o eurasica, o islamica o di qualsiasi altro tipo: e questi non sono rappresentati da un superiore armamento nucleare, ma dalla capacità di costruire “una geopolitica intesa non solo come confronto tra le potenze, ma come costruzione di canali di collaborazione e di connessione dei popoli oltre gli stati, puntando sulla valorizzazione delle reti tecnologiche e capitalistiche globali”. Ciò implica naturalmente che l’Occidente sia capace di accogliere una molteplicità di prospettive, di adattarsi per costruire sintesi unitarie più avanzate.
Ma la geopolitica nuova che l’autore auspica, e che teoricamente avrebbe anche un senso, si concilia poi con il modello di organizzazione economica proprio del capitalismo? Ebbene: “Occorre accettare realisticamente questo dato: che l’organizzazione capitalistica è solo un esito storico provvisorio, che non ha dentro di sé nulla di naturale, e come tale va accolta e discussa”. Vale a dire che nessun modello è proprio del capitalismo, ma è storicamente determinato. “La forma del mercato e delle merci non è iscritta in modo naturale in quella della nostra specie e della sua storia: ne è semplicemente un prodotto di successo” (di “meritato successo”, si affretta ad aggiungere Schiavone).
Allo stato attuale delle cose, comunque, l’organizzazione capitalistica sembra muovere in una direzione ben diversa da quella auspicata, e crea una nuova contraddizione, “quella tra carattere intrinsecamente privato e sempre più concentrato delle attuali strutture capitalistiche dal punto di vista dei poteri, delle decisioni e dell’inaudita accumulazione di profitti: e di contro il carattere sempre più ‘pubblico’ delle ricadute sociali di quei dispositivi di produzione e di mercato”. Le ragioni economiche della produzione, le ragioni del mercato, stanno insomma progressivamente “autonomizzandosi”, scindendosi da quelle sociali: nello stesso tempo pesano in misura sempre maggiore sulle scelte politiche degli stati e su quelle comportamentali degli individui. “Per questo l’Occidente ha bisogno di esercitare quella capacità di autoanalisi che ha ben imparato a mettere in campo: per la critica della sua economia, che è cosa ben diversa e più seria dell’inutile e autodistruttivo rinnegamento del proprio passato: per correggere fin dove possibile il meccanismo alla base di questo contrasto.”
L’esercizio di una corretta autoanalisi ci dice che “una volta che il lavoro ad alta intensità tecnologica ha preso il posto del vecchio lavoro di fabbrica, una volta abolito cioè il carattere sociale della produzione, e l’antagonismo strutturale che esso produceva […] la contraddizione si è trasferita dal dentro al fuori dell’ingranaggio capitalistico.”. E che anche rispetto a questa nuova contraddizione l’Occidente disporrebbe di un antidoto, che è la democrazia, se solo fosse capace di pensare quest’ultima come una costruzione (e astrazione) storica, quindi in costante evoluzione, e di conseguenza adattabile a rapporti inediti con il capitale e con il mercato. “In realtà, è l’intero rapporto fra forma capitalistica dell’economia e forma democratica della politica quale si è venuto delineando nel corso del Novecento che va ripensato a fondo, insieme al rapporto tra gestione della democrazia e uso delle più recenti tecnologie. Sapendo che nuove connessioni e compatibilità sono non solo storicamente possibili, ma appaiono funzionalmente indispensabili, e vanno a tutti i costi mantenute e sviluppate, sia pure con caratteri tutti da ricostruire.”
Quando si tratta di arrivare al dunque, però, sul modello di democrazia compatibile con l’età digitale Schiavone rimane molto vago (ed è anche comprensibile che lo faccia: è uno storico, non uno scrittore di fantascienza). Si limita a parlare di un dispositivo democratico che consenta ai cittadini un esercizio della sovranità più ravvicinato, “come oggi è tecnicamente possibile”. Liquida l’improponibile mito di una democrazia diretta esercitata per via telematica, della quale già conosciamo i disastrosi esiti sperimentali, ma è anche certo che per il futuro l’esercizio della sovranità non potrà più essere affidato al modello rappresentativo, o almeno alla sua versione attuale, che non corrisponde più al sentire comune. Parla di costruire di una cittadinanza globalmente condivisa, come accade ad esempio nei movimenti per la tutela ambientale o per quella dei diritti legati alla differenza di genere, che combini in modo nuovo iniziativa dal basso e presenza nelle istituzioni e garantisca una interazione equilibrata tra potenza tecno-economica e potere politico. Un obiettivo encomiabile, ma evidentemente ben poco realistico.

Nell’ultima parte del saggio l’azzardo sul futuro della nostra specie è spinto ancora oltre. L’autore fonda le sue anticipazioni sul presupposto che una situazione compiutamente globalizzata farà riemergere l’“invarianza del comune umano”. Ripropone cioè in termini nuovi l’annosa questione dell’esistenza o meno di una “natura umana” (tornando sul tema col quale aveva aperto il saggio, e che percorre un po’ tutti i suoi scritti). È indubbio per lui che di “natura umana” si può parlare, e che anzi da essa non si può prescindere, tenendo comunque fermo che “su una base genetica sempre eguale a se stessa in ogni esemplare si intreccia il gioco di una illimitata combinazione di caratteri morfologici e intellettivi”. Questo sostrato biologico però non è affatto immodificabile. “Osservata dalla giusta distanza, qualunque strutturazione naturale è anch’essa storia, nient’altro che storia.”
Come tutto ciò che ha a che fare con la natura, anch’esso è soggetto alle leggi dell’evoluzione. Con una novità, consistente nel fatto che “la rivoluzione attuale, dove prima c’era una enorme difformità di contesti, sta sovrapponendo all’identità della base genetica una identità globale di stimoli e di sfondi mentali e sociali”. In altre parole: la tecnica sta uniformando il volto economico del pianeta e la morfologia del suo territorio, ma sta omologando anche i comportamenti di massa dei suoi abitanti, includendoli tutti nello stesso circuito di consumi, tanto materiali quanto culturali: persino le idee sono già confezionate come merci. Questa omologazione da un lato apre alla speranza, perché per certi versi rende obsolete le guerre (l’uniformità di pensiero dovrebbe azzerare i contrasti ideologici, così come la razionalizzazione dei mercati dovrebbe attenuare quelli economici) e inutili anche i regimi autocratici; dall’altro spaventa, perché costringe il mondo nella rete di una ragione tecno-economica che in realtà non coincide con la razionalità complessiva della specie, e cancella diversità, peculiarità, ecc Ora, la sfida è quella di preservare queste differenze senza rinunciare al percorso dell’unificazione. E per differenze si intendono, oltre a quelle tra le civiltà, anche quelle con le altre forme di vita animali.
Schiavone preferisce vedere il bicchiere mezzo pieno, e legge la trasformazione all’interno di un più ampio divenire storico. Di fronte ai grandi mutamenti indotti dalla prima modernità il pensiero europeo aveva elaborato un’immagine dell’uomo come “individuo”, e questa immagine è rimasta dominante per tutta la stagione della grande industrializzazione (a dispetto anche di dottrine alternative che cercavano di opporle il modello del collettivo). La mondializzazione economica fa invece emergere il fondo comune della specie, creando attraverso un sistema universale di bisogni, quello che regge la rete globale dei mercati, una “prossimità globale”. Diventa possibile considerare l’umano, in tutte le sue complessità e differenze, come il manifestarsi di un’unica e totale soggettività impersonale. “La soggettività della specie che finalmente approda all’orizzonte della storia.” Hegel avrebbe detto che è lo Spirito che si manifesta.
La condivisione dei bisogni rende davvero possibile iniziare un discorso sull’eguaglianza, mentre l’individualismo, esaltando le differenze, le specificità, metteva in secondo piano ciò che accomuna ogni essere umano ai suoi simili. Ora invece “la tecno-economia globale esige, per venir regolata, di poter essere confrontata con una soggettività altrettanto globale, che si ponga sullo stesso piano. Per costruire un modello di soggettività e di eguaglianza che senza rinunciare ad un imprescindibile impianto formale sappia però anche guardare in tutte le profondità del diseguale che la nuova economia oggi ci propone”.
Ma alla fine, scendendo dal piano superiore della “soggettività globale” 0 “soggettività di specie” a quello terreno del “soggetto individuo”, che futuro gli riserva Schiavone? Intanto si tratterà di un individuo non più definito dalla sua attività lavorativa. “Col passaggio dalla forma industriale alla forma tecnofinanziaria del capitale, il lavoro (che era stato sin dai primordi della modernità la culla della figura dell’individuo e del paradigma di eguaglianza moderno) muta radicalmente, tanto che si può parlare di una ‘fine dell’età del lavoro’”. Con questo “non si vuol certo dire che abbia smesso di esistere il lavoro come attività propria della specie umana. Si vuole indicare soltanto che è finita una maniera storica di lavorare, che è stata costitutiva della nostra modernità e del nostro modo di pensare […]. E si vuole anche alludere, con quella formula, al fatto – di non minore importanza – che i nuovi lavori che stanno sostituendo in Occidente quello ormai al tramonto, non possono né potranno mai avere, per ragioni strutturali, indipendenti da ogni scelta politica, giuridica o etica, la stessa funzione della figura che sta scomparendo”.
Nella vita dei nostri discendenti, se le cose andranno come Schiavone pensa siano destinate ad andare, il lavoro sarà una cosa completamente diversa (lo è già adesso, con la cosiddetta “flessibilità”: ma a ben considerare è stato tale anche per un lunghissimo periodo in passato), e rivestirà un ruolo marginale. La liberazione, “l’emancipazione” degli umani non avverrà più attraverso esso, ma arriverà da una globale condivisione di strumenti conoscitivi e operativi che consentiranno alla specie il controllo non solo sull’ambiente e sulla tecnica, ma anche sulla propria natura. Avendo tra le mani il nostro destino biologico, saremo padroni delle nostre condizioni materiali di esistenza: saremo quello che vorremo essere.
Sommario: niente fine della storia o epoca del tramonto. Schiavone è anzi convinto che la vera storia cominci ora, e che a scriverla sarà ancora una volta l’Occidente, o meglio l’impronta della sua “civilizzazione” impressa su tutto il globo. Non si nasconde che la “mondializzazione” del modello occidentale ha messo in moto un percorso problematico, irto di rischi, che può anche condurre alla catastrofe, e nemmeno ignora le resistenze e i ripiegamenti che continueranno ad opporsi a questo processo. Quindi non lo considera ineluttabile, ma lo vede come l’unica vera possibilità di sopravvivenza dell’umano. Non solo, ma una sopravvivenza ricca di straordinarie potenzialità: la vicenda di un umano ormai quasi del tutto affrancato dalla dipendenza dalla natura, e sul punto di diventare completamente padrone del proprio destino.

E ora provo a tirare un po’ le fila. Intanto, non vorrei aver dato l’idea che nell’ultima parte del saggio Schiavone sia partito per la tangente. Non è così. È vero piuttosto che ho faticato molto io a costringere in poche pagine una ricchezza di argomentazioni che corre come un fiume in piena e che l’autore ha condensato in una serie di passaggi logici incalzanti. E dubito assai di esserci riuscito, anche solo parzialmente. Rimane tuttavia il fatto che dovendo passare dall’analisi del presente alla parte propositiva aperta sul futuro Schiavone cambia le tonalità del discorso: e come chiunque combatta una battaglia culturale (perché questo è, al di là della diversa profondità, un pamphlet, speculare a quello Dugin) le ha alzate di parecchio, senza peraltro mai trascurare di sottolineare come ciò che va prospettando rappresenti non una profezia ma una “possibilità.”
Che è già un ottimo distinguo. Una possibilità non è un’utopia. Non cancella il tempo o la condizione presente per rifare tutto daccapo, ma intravvede nel presente qualcosa che va interpretato nell’ottica di una futura trasformazione. In questo senso il saggio di Schiavone offre notevoli stimoli, se non a fare, perché sembra che tutto accadrà (o potrebbe accadere) dietro la spinta di forze superiori, almeno a capire, ad essere consapevoli di quali direzioni potrà prendere l’umanità dopo di noi, o magari (come sottolinea a più riprese l’autore) sta già prendendo sotto i nostri occhi. E mi offre anche l’occasione di riconfrontarmi per l’ennesima volta con le mie convinzioni.
Ora, non ho la presunzione di aver capito proprio tutto quel che Schiavone stipa in queste centottanta pagine, o di essere riuscito a seguire l’autore in certi passaggi che imponevano vere acrobazie mentali. Ma il senso generale del discorso credo di averlo afferrato, e in fondo condivido buona parte della sua impostazione e delle interpretazioni che offre del presente. Eppure non sono affatto persuaso che lo scenario futuro che ci prospetta sia coerentemente fondato. Per più di una ragione.
La prima concerne la possibilità di riconquistare il controllo sulla tecnica e di riorientare quest’ultima a finalità etiche. Ho l’impressione che sia già tardi, o meglio ancora, che sarà l’etica a riaggiornarsi sulla scia degli sviluppi tecnologici. In effetti, dobbiamo prendere atto che la tecnologia ha ormai di gran lunga sopravanzato la scienza e l’etica. Prendiamo il caso ad esempio delle scienze biologiche e della ingegneria bio-medica. Quest’ultima è in grado di produrre risultati che a livello scientifico non hanno alcun interesse o giustificazione, come le ibridazioni genetiche interspecifiche. Realizzare un uomo-scimmia non fa avanzare di un millimetro la conoscenza scientifica, mentre può avere terrificanti ricadute spettacolari o implicazioni economiche. È una cosa abietta, eppure decine di laboratori vi stanno lavorando: è tecnologia da apprendisti stregoni, fine a se stessa, intesa a mostrare sin dove può arrivare il suo potere, all’interno di una sfida continua nella quale non c’è più regola che tenga.
Un motivo ulteriore di perplessità concerne l’altra auspicata “domesticazione”, quella del capitale finanziario. Pur assumendo per scontato che il capitale sia indispensabile per reggere lo sviluppo della tecnica, e quindi che dal supporto offerto alla tecnica possa legittimamente attendersi un ritorno, mi sembra che Schiavone non dia il giusto rilievo al fatto che come la tecnica anche la finanza si è autonomizzata, ha preso una strada totalmente autoreferenziale nella quale il gioco speculativo prevale su quello produttivo. Il capitale tecno-finanziario è sempre più teso a creare ricchezza, e sempre meno a creare innovazione. O meglio, crea innovazione solo in prospettiva del ritorno, e di fatto brucia tutte le altre possibilità. Non si capisce cosa possa intervenire a disciplinarlo, a dissuaderlo dalla corsa all’accumulo. Sino ad oggi le nuove connessioni e le compatibilità etiche cui Schiavone accenna (quando scrive ad esempio che tra non molti decenni mangiare carne ci parrà un obbrobrio), e che gli paiono esemplificative della via da seguire, si sono risolte nella creazione di formidabili business che ruotano attorno alle etichette di “biologico” e di “ecosostenibile”, buone per far accettare costi maggiorati, ma che nella sostanza non mettono affatto in discussione la coazione al consumo (e anzi, in qualche modo la assolvono).
Di fronte a una situazione del genere è lodevole lo sforzo di Schiavone di richiamare in campo valori e saperi che stiamo perdendo, ma la cosa cozza contro la convinzione che lui stesso a più riprese esprime, e cioè che la trasformazione interesserà necessariamente anche l’ambito etico. Quando scrive: “Vedo che stiamo usando gli strumenti della tecnica non in eccesso, ma per difetto. Li stiamo usando al di sotto delle loro potenzialità” fa un’affermazione in parte vera, ma pericolosa. La “capacità inedita di incidere sulla nostra struttura e sulla forma biologica delle nostre vite e di modificarla”, che prevede per i prossimi decenni, non per i prossimi secoli, non appare certamente oggi finalizzata a una liberazione. Mi ripeto, ma credo che questo sia il punto più debole dell’argomentazione di Schiavone. Anche rimanendo entro i confini di ipotesi meno fantascientifiche di quella che ho prospettato sopra, gli interrogativi già oggi suscitati dallo sviluppo delle biotecnologie e dalle applicazioni (e implicazioni) dell’intelligenza artificiale sono tutt’altro che gratuiti. Toccano nel profondo il senso stesso dell’appartenenza all’umano, cambiano radicalmente i parametri di definizione della specie, fanno intravvedere non una trasformazione ma una vera e propria mutazione, che andrebbe ad interessare non solo la morfologia ma tutto il sostrato biologico, e di conseguenza gli stessi fattori di comunità nei quali Schiavone ripone la sua fiducia. Altro che “invarianza del comune umano”. L’uomo, da “antiquato” che era, rischia di diventare superfluo.
Un conto è parlare dell’uso di protesi o strumentazioni che migliorano le nostre condizioni di esistenza, di resistenza o di produttività, o suppliscono a carenze naturali o accidentali (dalla pietra scheggiata ai robot della catena di montaggio, dagli abiti alla farmacopea, dagli occhiali al bypass o agli arti artificiali), e che modificano senz’altro il nostro rapporto con l’ambiente e con il nostro prossimo, ma non vanno a toccare i ritmi e i percorsi evolutivi del nostro patrimonio genetico (o lo fanno in tempi lunghissimi, che consentono di ovviare ad eventuali effetti collaterali indesiderati): un altro conto è la presunzione di “decidere noi il nostro destino”, di programmarci totalmente in proprio l’esistenza, di accedere alla condizione post-naturale, senza in realtà nessuna idea di dove vorremmo o potremmo andare a parare. A meno di intendere che a decidere sarà la “soggettività globale della specie” (e temo che Schiavone intenda proprio questo), prospettiva che nella sua indeterminatezza fa accapponare la pelle. Pur facendo le debite tare, somiglia troppo al suo esatto contrario, a quello che Dugin, mostrando senz’altro lungimiranza, definisce “lo scambio dell’identità collettiva umana con l’identità collettiva postumana: la creazione di strumenti tecnici che diventano passo dopo passo i maestri, e smettono di essere strumenti”.

Mi spiego meglio. Questo discorso chiama automaticamente in causa il tema della libertà, che a sua volta si tira appresso quello dell’eguaglianza, e naturalmente quello della democrazia, che dovrebbe garantire sia la prima che la seconda. Senza volerla fare troppo lunga, sul concetto di libertà concordo pienamente con Isaiah Berlin, per il quale una persona è libera innanzitutto quando non è impedita di fare ciò che desidera fare da un atto o da un’omissione di un altro essere umano (la definisce “libertà negativa”). Per Berlin esiste però anche un’accezione più estesa del concetto, quella di “libertà positiva”, che implica che l’individuo non solo non subisca coercizioni da parte di altri, ma sia totalmente “autonomo” (alla lettera, “capace di governare se stesso”). Vale a dire che l’impedimento ad agire non gli deve venire neppure da ostacoli interni, come possono essere l’ignoranza, i desideri o le emozioni. Il che in teoria è molto vero, ma presuppone distinguere tra un soggetto autentico, interamente razionale e capace di dominare le passioni, e un Io empirico, condizionato dalle pulsioni naturali. Per la concezione positiva essere liberi significa accedere alla prima condizione, ovvero agire “moralmente”: ma, e qui nasce il problema, chi stabilisce cosa sia “moralmente” giusto? Perché se la normativa morale è dettata da altri, si è liberi in realtà solo di obbedirle.
Ora, Schiavone dice più o meno che quando la tecnica ricondotta alla sua originaria funzione ci avrà liberato dai condizionamenti, dagli impedimenti, dalle malformazioni che la natura ci riserva, e anche dalle inique differenze sociali ed economiche, ciascuno di noi potrà esprimere al meglio se stesso: ma la stessa tecnica gli fornirà anche la consapevolezza che in una società del genere la vera realizzazione individuale non può che coincidere con il benessere collettivo e con la sopravvivenza dell’intera specie. Quindi non saranno “altri” a dettare le norme morali, ma queste scaturiranno da una volontà collettiva concorde e razionalmente illuminata.
L’impressione che ho ricavato io dalla lettura è che qui non si parli più di un aggiornamento dell’etica, ma di una sua completa rifondazione. E se a decidere di ciò che è bene e ciò che è male fosse davvero la “soggettività della specie”, credo che nemmeno si potrebbe più parlare di etica, perché ci troveremmo in una condizione molto simile a quella degli insetti sociali. Con la differenza, certo, che quella condizione sarebbe ciascuno di noi a sceglierla, una volta messo in grado di decidere davvero del proprio destino e di capire cosa è meglio per lui, mentre gli insetti sociali rispondono ad una determinazione biologica: ma questo è comunque in contraddizione con quella difesa della diversità che l’autore rivendica costantemente, e presume anche una identificazione tra il bene individuale e l’utile collettivo che suona molto sospetta. Non sarei poi nemmeno così sicuro che tutti gli umani, anche messi di fronte ad una (discutibile) evidenza del “bene”, sceglierebbero di conseguenza.
Berlin invece la mette così: senz’altro la “libertà positiva” indica un livello di libertà superiore, ma la pretesa che esista una sola concezione universalmente valida del bene, e che quindi tutte le questioni etiche abbiano, almeno in linea di principio, una sola risposta corretta, sta purtroppo alla base delle tentazioni totalitarie. Tutti i grandi Utopisti (quelli con la maiuscola, che hanno immaginato – e qualche volta cercato di attuare – grandi disegni sociali) partono dal presupposto che una volta conosciuto il vero sistema morale potranno essere appianati tutti i conflitti e diverrà possibile creare una società perfetta, trovare un accordo universale su un unico modello di vita. Il paragrafo che riporto da “Due concetti di libertà” (1957) sembra scritto apposta per mettere in guardia contro gli entusiasmi un po’ facili di Schiavone:
“Una credenza è più di ogni altra responsabile delle stragi di esseri umani sull’altare dei grandi ideali storici: giustizia o progresso o felicità delle generazioni future o la sacra missione o l’emancipazione di una nazione, di una razza o di una classe, o persino la libertà stessa, che esige il sacrificio degli individui perché sia libera la società. Si tratta della credenza che da qualche parte, nel passato o nel futuro, nella rivelazione divina o nella mente di un singolo pensatore, nelle solenni dichiarazioni della storia o della scienza, o nel cuore semplice di un uomo integralmente buono vi sia una soluzione finale”.
Per questo al “monismo morale” Berlin oppone il “pluralismo dei valori”, concetto sul quale peraltro, in una accezione più sfumata, insiste molto anche Schiavone. Entrambi sono coscienti che far coesistere valori diversi è tutt’altro che facile, ma prendono poi strade diverse quando si tratta di trovare una conciliazione. Il primo ritiene che questi valori siano delle creazioni storiche dell’umanità e non dei dati di natura, anche se alcuni – la libertà individuale in primis – attraversano tutte le culture. E che pur essendo in linea di massima i valori morali tutti validi, non sempre le diverse idee relative al bene e al giusto sono commensurabili. Il secondo crede invece che a una conciliazione si possa pervenire, proprio attraverso la grande trasformazione della quale stiamo scorgendo gli inizi. Parte cioè dalla posizione di Berlin, ma finisce poi bene o male in quella degli utopisti. Insomma, il discrimine sta nel fatto che Berlin accetta l’idea che la ‘natura umana’ sia costitutivamente imperfetta, e che a ciò si possa sia pure solo parzialmente ovviare mediando tra libertà positiva e libertà negativa, mentre Schiavone ritiene che l’imperfezione sia solo una condizione temporanea, destinata ad essere cancellata.

Il caso più clamoroso di incommensurabilità dei beni è per Berlin quello tra libertà e uguaglianza. “Libertà e uguaglianza – scrive – sono tra gli scopi primari degli uomini, ma libertà totale per i lupi significa morte per gli agnelli”. D’altro canto – come dice ancora – “nel loro entusiasmo per creare le condizioni economiche e sociali affinché la libertà sia un valore autentico, gli uomini tendono a dimenticare la libertà stessa; e se ci si ricorda di essa è facile che si spinga da parte per far posto a quegli altri valori che hanno assorbito i rivoluzionari o i riformatori”.
Quindi, anche valori di per sé imprescindibili possono non andare pacificamente assieme: bisogna prendere atto che l’uguaglianza e la giustizia sociale entrano in conflitto con la libertà individuale, così come l’ordine e la sicurezza confliggono con la tolleranza o la giustizia con la misericordia: perseguono fini diversi, che devono essere bilanciati con prudenza e moderazione.
Per Schiavone invece la vera libertà non esiste se non in presenza dell’uguaglianza (ma lo pensava già Condorcet). Egli fonda come abbiamo visto la sua concezione sull’esistenza (e sulla riscoperta) dell’universale umano – per cui occorre ridefinire l’idea di uguaglianza sulla base del carattere impersonale del soggetto intra-individuale che caratterizzerà la società del futuro. In un saggio precedente, intitolato proprio “Eguaglianza”, scrive che bisogna “cominciare a pensare a un nuovo patto di uguaglianza, per salvare il futuro della democrazia; […]. Un patto che sappia farsi programma politico […], e parta non dalla parità degli individui, ma dall’illimitata eguale divisibilità della cose […], da condividersi equamente fra tutti i viventi. Un patto stretto, non nel nome di una classe, o di un qualunque soggetto che per indicare sé stesso debba escludere altri dalla definizione […], ma del comune umano come soggetto e come valore includente e globale”.
Nella sostanza, la formula di mediazione potrebbe essere questa: per come è fatto oggi l’uomo, se una società vuole essere giusta deve promulgare delle leggi che impongano questa giustizia, negando di fatto la libertà. Se invece vuole essere libera deve eliminare qualunque restrizione alla libertà; cosa che, sempre considerando la natura attuale dell’uomo, porta inevitabilmente a storture e ingiustizie. Non sappiamo se e come evolverà questa natura domani, e nel caso, se ai termini libertà ed eguaglianza potremo attribuire gli stessi significati e lo stesso valore che diamo loro oggi.
È chiaro che tra le due concezioni mi riconosco molto di più in quella di Berlin. Quanto a “soluzioni finali” ne abbiamo già viste sin troppe, ed erano tutt’altro che ispirate al trionfo della libertà, dell’uguaglianza, della giustizia e della democrazia. So bene che Schiavone ha in mente altro, che si limita a dire che possono crearsi “occasioni continue di comunione solidale rispetto a un patrimonio genetico, ambientale, culturale la cui unitarietà sostanziale è esaltata dal dominio di strumenti conoscitivi e operativi che lo padroneggiano e lo trasformano sempre più a fondo”. E che “si renderebbe possibile così la formazione, intorno a una serie definita di beni ritenuti indispensabili nelle condizioni storiche date, di spazi di condivisione che aggregano isole di eguaglianza nell’oceano multiforme delle diseguaglianze individuali”. Ma tutto questo rimane per forza di cose talmente vago da prestarsi a qualsiasi interpretazione: e anche lasciando perdere quelle che ne sono state date nel passato dai totalitarismi genocidi, è già sufficiente a farmi diffidare ciò che sento predicare dai vari Baricco e Maffesoli e dai postmoderni di complemento, che profetizzano l’avvento di una nuova “barbarie” a spazzare via le rovine della “modernità criminale”.
Nutro come Berlin una fiducia molto limitata nella essenza positiva della natura umana, e ritengo più importante per la nostra specie difendere gli ultimi ridotti di una civiltà sotto assedio piuttosto che attendere inerte l’arrivo dei nostri, di una tecnologia che venga a spalancare pianure di libertà. Sono convinto altresì che l’eguaglianza e la democrazia non si realizzano quando tutti vogliono le stesse cose, nemmeno se a suggerirle è la soggettività di specie, ma quando tutti per ottenere ciò che vogliono seguono le stesse regole. Naturalmente quando quelle regole le hanno dettate e accettate gli stessi che sono tenuti a rispettarle.
Penso infine anche che l’uguaglianza abbia a che fare solo con i diritti e con l’inviolabilità dell’esistenza di ogni essere umano: il “fondo umano comune” non ci rende uguali nelle caratteristiche corporee e nemmeno in quelle mentali. Come scrive Edoardo Boncinelli “come singoli siamo animali … il collettivo umano, e con esso l’individuo che gli appartiene, mostra un carattere storico ed è figlio di una continuità culturale che non ha l’eguale in nessun altro tipo di realtà. Di questa nostra ultima particolarità andiamo giustamente fieri, ma non è conveniente né proficuo ignorare i vincoli e le condizioni che ci limitano come singoli”. Che ci limitano, ma che alla fin fine ci rendono anche liberi, perché se la “soggettività globale della specie”, come la chiama Schiavone, o “l’identità collettiva postumana”, come la definisce Dugin, cancellassero la conflittualità tra i fini diversissimi che gli uomini perseguono, scomparirebbero la necessità e il tormento della scelta e con essa l’importanza centrale della libertà di scegliere. Non solo. La continuità culturale è quella che ha partorito il diritto, ma se si fonda l’uguaglianza dei diritti sul presupposto che siamo tutti uguali, non solo si proclama una falsità evidente, ma si creano le basi per rimettere in discussione l’uguaglianza dei cittadini ogni volta che si scoprisse tra loro qualche differenza biologica.
Basta. Mi accorgo che sto viaggiando verso la stesura di un quarto manifesto, e a questo punto non mi sembra proprio il caso (il che non significa che non abbia già in mente un’altra puntata). Anche perché ho perso completamente di vista il tema di partenza, quello del destino dell’Occidente. O forse ci ho solo girato attorno.
E allora taglio corto e lo riaggancio in extremis. I tre manifesti raccontano rispettivamente un funerale, un’agonia e un battesimo. La protagonista è sempre la stessa, la civiltà occidentale, ma ripresa da angolazioni ideologiche molto diverse, per cui i film che ci arrivano sono naturalmente discordanti. Io ho cercato bene o male di metterli a confronto. Chiunque può fare la stessa cosa, i testi sono disponibili, il primo solo in rete, gli altri anche nel formato cartaceo.
Aggiungo solo un’ultima considerazione. Parlando del compito che spetta all’Occidente (“Non solo tenere a battesimo un mondo nuovo […] ma completarne la fisionomia”) Schiavone è drastico: “Innanzi a un simile impegno non c’è nostalgia del passato che tenga; non c’è rimpianto per come eravamo che possa reggere […]”. Va bene, magari come sterile rimpianto per come eravamo o per come stavano le cose non terrà; ma questo significa ancora una volta pensare che nella storia agisca un’astuzia della ragione, una necessità che a posteriori giustifica – o condona – le nostre scelte, e condanna tutte le potenzialità che quelle scelte hanno escluso, riducendole a spazzatura abbandonata ai margini della strada. Ora, è chiaro che indietro non si può tornare, ma si può almeno guardare, purché si guardi nella direzione giusta, e non ad un passato immaginario come quello costruito da Jeffers e da tutti i nostalgici dell’Eden. Magari per rendersi conto a quale bivio si era intrapresa la direzione sbagliata; o, perché no, per frugare in quella spazzatura e verificare che non sia stato buttato qualcosa che ancora può risultare utile e vitale. Ed è lecito anche provare rammarico per le scelte non fatte, pur quando c’è consapevolezza che magari non avrebbero poi cambiato granché le cose.
Quanto a me, confesso di essere un nostalgico militante. Come un tempo i maschi ebrei ringraziavano ogni mattina Dio di non averli fatti nascere donne (non so se lo facciano ancora), io ringrazio quotidianamente il cielo di avermi fatto nascere qui, in questo luogo e in questo tempo. E mi spiace vedere il primo trasformarsi e il secondo trascorrere, vorrei poter fermare l’una cosa e l’altra, e nel mio piccolo faccio tutto il possibile per almeno rallentarle. Non parteciperò ai funerali dell’Occidente e diserterò il battesimo del mondo nuovo. E non mi sento ancora affatto spazzatura.
Indicazioni bibliografiche
Le citazioni che compaiono in questo testo sono tratte da:
KINGSNORTH Paul, HINE Dougald, Uncivilisation. The Dark Mountain Manifesto, Oxford 2009
JEFFERS, Robinson, La bipene e altre poesie, Guanda, 1969
JEFFERS, Robinson, Cawdor, Einaudi 1977
DUGIN, Aleksandr, Contro il Grande Reset. Manifesto del Grande Risveglio, AGA 2022
DUGIN, Aleksandr, Una civiltà planetaria, Il Mulino 2022
SCHIAVONE, Aldo, Eguaglianza. Una nuova visione sul filo della storia, Einaudi 2019
DE TOCQUEVILLE, Alexis, La democrazia in America, Rizzoli 1999
BERLIN, Isaiah, Il legno storto dell’umanità, Adelphi 1994
BERLIN, Isaiah, Quattro saggi sulla libertà, Feltrinelli 1989














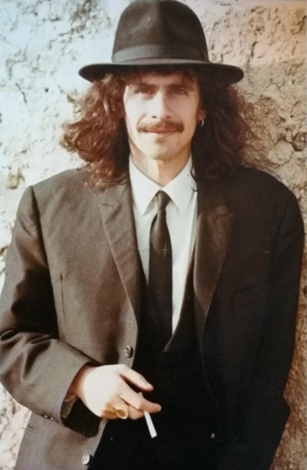
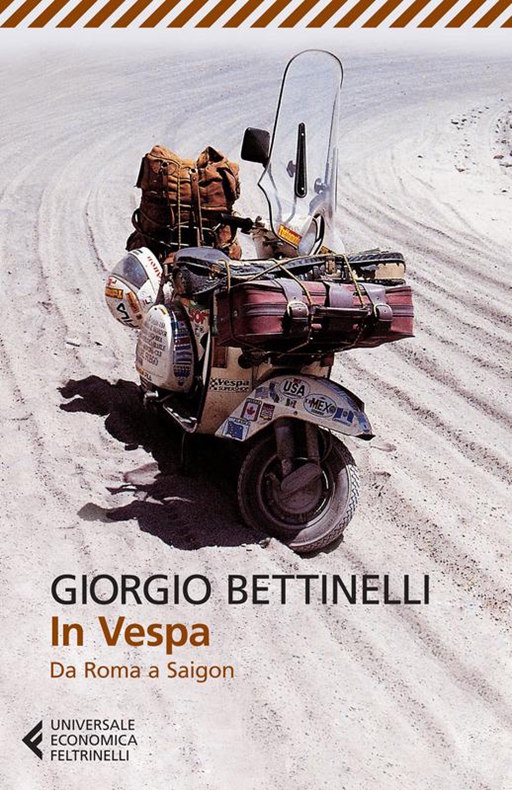








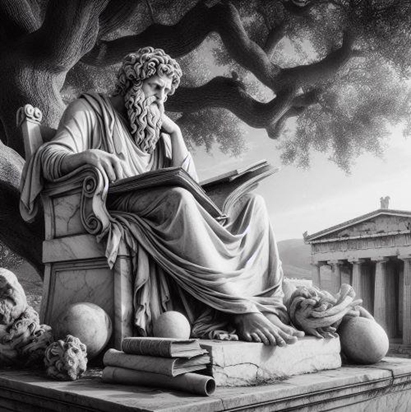



 Andiamo però con ordine. Roerich coltiva precocemente i suoi interessi artisti e filosofici, e soprattutto frequenta sin da giovanissimo gli ambienti culturali all’avanguardia. Collabora come scenografo e costumista alle messe in scena di Sergej Diaghilev, il creatore del balletto russo, e firma con Stravinsky la scenografia del balletto della “Sagra della Primavera”.
Andiamo però con ordine. Roerich coltiva precocemente i suoi interessi artisti e filosofici, e soprattutto frequenta sin da giovanissimo gli ambienti culturali all’avanguardia. Collabora come scenografo e costumista alle messe in scena di Sergej Diaghilev, il creatore del balletto russo, e firma con Stravinsky la scenografia del balletto della “Sagra della Primavera”.








 Facciamo un esempio per capirci. Bertrand Russell (1872-1970) è ritenuto generalmente un’importante figura di filosofo e attivista pacifista. È famoso per essersi impegnato per la messa al bando delle armi atomiche. Si è opposto alla partecipazione della Gran Bretagna alla Prima guerra mondiale. Per questo fu privato della cattedra e fu perfino incarcerato. Eppure Russell, dopo un notevole impegno per prevenire il conflitto, giunse ad approvare la guerra contro la Germania nazista. Come dovremmo considerare la sua posizione? Siamo in presenza di un pacifista eroico, oppure di un bellicista guerrafondaio? Oppure di un voltagabbana? Russell ha chiarito la sua posizione in un famoso articolo del 1943
Facciamo un esempio per capirci. Bertrand Russell (1872-1970) è ritenuto generalmente un’importante figura di filosofo e attivista pacifista. È famoso per essersi impegnato per la messa al bando delle armi atomiche. Si è opposto alla partecipazione della Gran Bretagna alla Prima guerra mondiale. Per questo fu privato della cattedra e fu perfino incarcerato. Eppure Russell, dopo un notevole impegno per prevenire il conflitto, giunse ad approvare la guerra contro la Germania nazista. Come dovremmo considerare la sua posizione? Siamo in presenza di un pacifista eroico, oppure di un bellicista guerrafondaio? Oppure di un voltagabbana? Russell ha chiarito la sua posizione in un famoso articolo del 1943

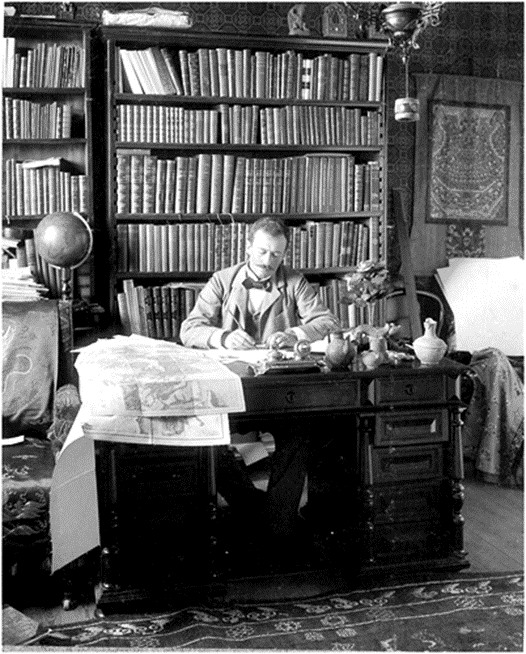

 Di ciò che era venuto prima non racconta alcunché, né in questa né nelle altre sue opere che ho letto: probabilmente riteneva la sua infanzia poco rilevante rispetto alle scelte future, e assolutamente normale, per quanto normale possa essere considerata la convivenza con cinque sorelle e due fratelli, in una famiglia governata totalmente dalla figura materna. Ad essere maligni, sarebbe invece già sufficiente a spiegare la smania perenne di lontananza e di solitudine che lo caratterizzerà. Almeno a livello inconscio, perché alla famiglia e a tutte queste donne Hedin sarà in realtà sempre molto affezionato. Solo a queste, però: nella sua vita non ce ne saranno altre, né altri affetti, e neppure vere e proprie amicizie. Non si è mai sposato e non ha avuto figli: con lui si è estinta la sua linea familiare.
Di ciò che era venuto prima non racconta alcunché, né in questa né nelle altre sue opere che ho letto: probabilmente riteneva la sua infanzia poco rilevante rispetto alle scelte future, e assolutamente normale, per quanto normale possa essere considerata la convivenza con cinque sorelle e due fratelli, in una famiglia governata totalmente dalla figura materna. Ad essere maligni, sarebbe invece già sufficiente a spiegare la smania perenne di lontananza e di solitudine che lo caratterizzerà. Almeno a livello inconscio, perché alla famiglia e a tutte queste donne Hedin sarà in realtà sempre molto affezionato. Solo a queste, però: nella sua vita non ce ne saranno altre, né altri affetti, e neppure vere e proprie amicizie. Non si è mai sposato e non ha avuto figli: con lui si è estinta la sua linea familiare. L’infanzia dunque ce la lascia immaginare, e non dobbiamo nemmeno sforzarci troppo. Piuttosto, è forse opportuno “contestualizzare” Hedin rispetto ai tempi e ai luoghi in cui è cresciuto e si è formato. Il 1865, anno della sua nascita, può essere assunto per i paesi nordici a spartiacque. Si è appena conclusa la seconda guerra tedesco-danese, con una cocente sconfitta del regno di Danimarca e la conseguente perdita dei ducati dello Schleswig-Holstein a favore della Prussia. Questo significa il tramonto dello scandinavismo, un movimento culturale e politico che propugnava l’unione dei paesi scandinavi (Danimarca, Svezia e Norvegia) in una sola nazione, e che aveva infiammato a metà del secolo soprattutto la gioventù studentesca. Produce anche, in particolare negli ambienti più legati all’istituto monarchico, una crescente ammirazione per il nuovo Reich tedesco che si va costruendo proprio in quegli anni sotto la regia di Bismarck. In più, la sconfitta è solo un prodromo alla profonda depressione economica che colpirà i paesi europei nell’ultimo quarto di secolo, e in particolare quelli scandinavi, innescando un forte fenomeno migratorio (testimoniato e raccontato, ad esempio, nei libri di Knut Hamsun).
L’infanzia dunque ce la lascia immaginare, e non dobbiamo nemmeno sforzarci troppo. Piuttosto, è forse opportuno “contestualizzare” Hedin rispetto ai tempi e ai luoghi in cui è cresciuto e si è formato. Il 1865, anno della sua nascita, può essere assunto per i paesi nordici a spartiacque. Si è appena conclusa la seconda guerra tedesco-danese, con una cocente sconfitta del regno di Danimarca e la conseguente perdita dei ducati dello Schleswig-Holstein a favore della Prussia. Questo significa il tramonto dello scandinavismo, un movimento culturale e politico che propugnava l’unione dei paesi scandinavi (Danimarca, Svezia e Norvegia) in una sola nazione, e che aveva infiammato a metà del secolo soprattutto la gioventù studentesca. Produce anche, in particolare negli ambienti più legati all’istituto monarchico, una crescente ammirazione per il nuovo Reich tedesco che si va costruendo proprio in quegli anni sotto la regia di Bismarck. In più, la sconfitta è solo un prodromo alla profonda depressione economica che colpirà i paesi europei nell’ultimo quarto di secolo, e in particolare quelli scandinavi, innescando un forte fenomeno migratorio (testimoniato e raccontato, ad esempio, nei libri di Knut Hamsun). Compie gli studi in un liceo prestigioso, conseguendo il diploma di scuola secondaria nel 1885, ma non è un allievo particolarmente brillante: si distingue solo nel disegno e nella cartografia. Mentre ancora frequenta il liceo redige a penna un atlante in sei volumi nel quale sono raccolte le conoscenze orografiche del suo tempo per tutta la terra, e disegna per la Società di Geografia di Stoccolma una carta dell’Asia Centrale che lascia tutti a bocca aperta.
Compie gli studi in un liceo prestigioso, conseguendo il diploma di scuola secondaria nel 1885, ma non è un allievo particolarmente brillante: si distingue solo nel disegno e nella cartografia. Mentre ancora frequenta il liceo redige a penna un atlante in sei volumi nel quale sono raccolte le conoscenze orografiche del suo tempo per tutta la terra, e disegna per la Società di Geografia di Stoccolma una carta dell’Asia Centrale che lascia tutti a bocca aperta.
 I due partono alla volta dell’Azerbaigian a metà agosto. Transitano per Helsinki e San Pietroburgo, e quindi si soffermano a Mosca, dal cui splendore Sven è affascinato. Poi quattro giorni in treno e in diligenza, in mezzo a una natura selvaggia che il giovane non si stanca di cercare di disegnare: foreste immense e praticamente vergini, montagne altissime innevate, valichi incassati tra le rocce, strade che corrono pericolosamente su orrendi strapiombi. Il virus dell’avventura che incubava nel suo animo trova l’ambiente ideale per manifestarsi. Sono a Baku prima della fine del mese, e qui Sven, oltre ad impartire lezioni al suo discepolo, si dedica a studiare in contemporanea una quantità di lingue: è molto portato, conosce il latino, parla quasi correntemente francese, tedesco e inglese, s’impadronisce dei rudimenti delle lingue farsi, russa e tartara. In seguito imparerà diversi dialetti persiani, oltre al turco, al kirghiso, al mongolo, al tibetano e a un po’ di cinese.
I due partono alla volta dell’Azerbaigian a metà agosto. Transitano per Helsinki e San Pietroburgo, e quindi si soffermano a Mosca, dal cui splendore Sven è affascinato. Poi quattro giorni in treno e in diligenza, in mezzo a una natura selvaggia che il giovane non si stanca di cercare di disegnare: foreste immense e praticamente vergini, montagne altissime innevate, valichi incassati tra le rocce, strade che corrono pericolosamente su orrendi strapiombi. Il virus dell’avventura che incubava nel suo animo trova l’ambiente ideale per manifestarsi. Sono a Baku prima della fine del mese, e qui Sven, oltre ad impartire lezioni al suo discepolo, si dedica a studiare in contemporanea una quantità di lingue: è molto portato, conosce il latino, parla quasi correntemente francese, tedesco e inglese, s’impadronisce dei rudimenti delle lingue farsi, russa e tartara. In seguito imparerà diversi dialetti persiani, oltre al turco, al kirghiso, al mongolo, al tibetano e a un po’ di cinese. Sei mesi dopo il suo compito di tutore è esaurito, ma Sven non ha alcuna fretta di fare ritorno a casa. Avverte semplicemente i suoi che posticiperà il rientro, e nell’aprile del 1886 lascia Baku, si imbarca su un vapore che costeggia il Mar Caspio e raggiunge la Persia. Quindi attraversa a cavallo la catena montuosa di Alborz, per toccare successivamente Teheran, Esfahan, Shiraz e arrivare al Golfo persico. Dalla città portuale di Bassora ancora in nave risale il fiume Tigri fino a Baghdad (allora nell’impero ottomano). Torna quindi a Teheran via Kermanshah, e dopo aver trovato un prestito (ha esaurito tutti i suoi fondi) intraprende finalmente la strada di casa, attraversando il Caucaso, veleggiando sul Mar Nero fino a Costantinopoli e facendo ancora tappa a Budapest. È di ritorno in Svezia il 18 settembre 1886.
Sei mesi dopo il suo compito di tutore è esaurito, ma Sven non ha alcuna fretta di fare ritorno a casa. Avverte semplicemente i suoi che posticiperà il rientro, e nell’aprile del 1886 lascia Baku, si imbarca su un vapore che costeggia il Mar Caspio e raggiunge la Persia. Quindi attraversa a cavallo la catena montuosa di Alborz, per toccare successivamente Teheran, Esfahan, Shiraz e arrivare al Golfo persico. Dalla città portuale di Bassora ancora in nave risale il fiume Tigri fino a Baghdad (allora nell’impero ottomano). Torna quindi a Teheran via Kermanshah, e dopo aver trovato un prestito (ha esaurito tutti i suoi fondi) intraprende finalmente la strada di casa, attraversando il Caucaso, veleggiando sul Mar Nero fino a Costantinopoli e facendo ancora tappa a Budapest. È di ritorno in Svezia il 18 settembre 1886. L’anno successivo pubblica un libro sulla sua prima straordinaria esperienza, Attraverso la Persia, la Mesopotamia e il Caucaso. Ricordi di viaggio. Non è un best seller, ma è pubblicato da un editore specializzato nel settore, e incuriosisce tanto gli appassionati quanto gli studiosi, colpiti soprattutto dalla giovanissima età e dalla precoce competenza dell’autore. Hedin ha però potuto rendersi conto durante il viaggio di cosa realmente serve per impegnarsi in una esplorazione. Gli anni successivi li dedica dunque a completare ad altissimo livello la sua preparazione. Studia geologia, mineralogia, zoologia tra il 1886 al 1888 a Stoccolma e a Uppsala, e nel frattempo traduce i Viaggi in Asia centrale di Nicolaï Prjevalski, individuando così la meta per la prossima avventura. In virtù della conoscenza del farsi e del turco viene anche aggregato ad una futura missione presso lo scià di Persia. Nell’attesa della partenza, tra l’ottobre 1889 e il marzo 1890, realizza un altro suo sogno e va a studiare a Berlino con il grande geografo Ferdinand von Richthofen
L’anno successivo pubblica un libro sulla sua prima straordinaria esperienza, Attraverso la Persia, la Mesopotamia e il Caucaso. Ricordi di viaggio. Non è un best seller, ma è pubblicato da un editore specializzato nel settore, e incuriosisce tanto gli appassionati quanto gli studiosi, colpiti soprattutto dalla giovanissima età e dalla precoce competenza dell’autore. Hedin ha però potuto rendersi conto durante il viaggio di cosa realmente serve per impegnarsi in una esplorazione. Gli anni successivi li dedica dunque a completare ad altissimo livello la sua preparazione. Studia geologia, mineralogia, zoologia tra il 1886 al 1888 a Stoccolma e a Uppsala, e nel frattempo traduce i Viaggi in Asia centrale di Nicolaï Prjevalski, individuando così la meta per la prossima avventura. In virtù della conoscenza del farsi e del turco viene anche aggregato ad una futura missione presso lo scià di Persia. Nell’attesa della partenza, tra l’ottobre 1889 e il marzo 1890, realizza un altro suo sogno e va a studiare a Berlino con il grande geografo Ferdinand von Richthofen
 La delegazione svedese che deve consegnare allo scià di Persia un’onorificenza (un pretesto, naturalmente, per instaurare rapporti politici ed economici) e in seno alla quale Sven svolge il ruolo di interprete parte nel maggio 1890, e via Berlino e Vienna raggiunge Costantinopoli, dove è ricevuta anche dal sultano. Una volta a Teheran, ed esauriti i suoi compiti ufficiali, il giovane ottiene di poter lasciare la delegazione per riprendere a viaggiare nell’Asia centrale. Ma prima accompagna lo Scià in un’escursione alla catena montuosa dell’Elburz, nel corso della quale assieme a due guide scala il Monte Damavand (5.600 metri). Incontra anche le prime disavventure, perché quasi ci lascia la pelle cavalcando attraverso le montagne innevate dell’Elbruz durante una feroce tempesta di neve.
La delegazione svedese che deve consegnare allo scià di Persia un’onorificenza (un pretesto, naturalmente, per instaurare rapporti politici ed economici) e in seno alla quale Sven svolge il ruolo di interprete parte nel maggio 1890, e via Berlino e Vienna raggiunge Costantinopoli, dove è ricevuta anche dal sultano. Una volta a Teheran, ed esauriti i suoi compiti ufficiali, il giovane ottiene di poter lasciare la delegazione per riprendere a viaggiare nell’Asia centrale. Ma prima accompagna lo Scià in un’escursione alla catena montuosa dell’Elburz, nel corso della quale assieme a due guide scala il Monte Damavand (5.600 metri). Incontra anche le prime disavventure, perché quasi ci lascia la pelle cavalcando attraverso le montagne innevate dell’Elbruz durante una feroce tempesta di neve.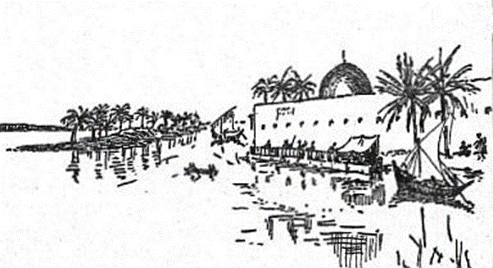 Nei dintorni comunque ha modo di incontrare gli Uiguri, di etnia turca, imparentati con altre popolazioni che abitano oltre il confine russo: ed è impressionato dalla praticità dei loro sistemi d’irrigazione, che consentono l’agricoltura in un terreno tutt’altro che adatto. A questo punto però, non avendo ottenuto il permesso di proseguire fino a Pechino, è costretto a tornare indietro per una via più settentrionale, che attraversa la catena di Thian Shan, e a fine dicembre riguadagna il territorio russo. È nuovamente nel Turkestan, dove visita la tomba dello studioso russo-asiatico Nikolai Przhevalsky a Karakol, sulla riva del lago Issyk Kul. Alla fine di marzo del 1891 è di ritorno in Svezia
Nei dintorni comunque ha modo di incontrare gli Uiguri, di etnia turca, imparentati con altre popolazioni che abitano oltre il confine russo: ed è impressionato dalla praticità dei loro sistemi d’irrigazione, che consentono l’agricoltura in un terreno tutt’altro che adatto. A questo punto però, non avendo ottenuto il permesso di proseguire fino a Pechino, è costretto a tornare indietro per una via più settentrionale, che attraversa la catena di Thian Shan, e a fine dicembre riguadagna il territorio russo. È nuovamente nel Turkestan, dove visita la tomba dello studioso russo-asiatico Nikolai Przhevalsky a Karakol, sulla riva del lago Issyk Kul. Alla fine di marzo del 1891 è di ritorno in Svezia Si è trattato solo di un viaggio preparatorio, per mettere a punto le necessità e calcolare i rischi di una spedizione vera e propria. Gli è servito anche per individuare l’area sulla quale focalizzare il suo interesse: la più impervia e sconosciuta, naturalmente. Si tratta del vasto e accidentatissimo territorio al quale afferiscono, con confini definiti in maniera molto incerta, sei differenti stati: Cina, Mongolia, Russia, Persia, Tibet e India. Al centro di questa area, nel Turkestan cinese, c’è il Takla Makan, un deserto di sabbia che gode di una fama sinistra, attorno al quale, e anticamente anche all’interno, transitava la Via della Seta individuata da Von Richthofen.
Si è trattato solo di un viaggio preparatorio, per mettere a punto le necessità e calcolare i rischi di una spedizione vera e propria. Gli è servito anche per individuare l’area sulla quale focalizzare il suo interesse: la più impervia e sconosciuta, naturalmente. Si tratta del vasto e accidentatissimo territorio al quale afferiscono, con confini definiti in maniera molto incerta, sei differenti stati: Cina, Mongolia, Russia, Persia, Tibet e India. Al centro di questa area, nel Turkestan cinese, c’è il Takla Makan, un deserto di sabbia che gode di una fama sinistra, attorno al quale, e anticamente anche all’interno, transitava la Via della Seta individuata da Von Richthofen. Per intanto ha già raccolto materiale sufficiente per dare alle stampe una Ambasciata del re Oscar allo shah di Persia e soprattutto Attraverso il Khorasan e il Turkestan, pubblicati pochi mesi dopo il suo ritorno, che consolidano la sua fama di esperto della geografia e dell’antropologia dell’Asia Centrale. Nel frattempo si è iscritto all’università di Berlino, dove ottiene in brevissimo tempo (nel 1892) una laurea dissertando sulla sua ascesa al monte Damavand.
Per intanto ha già raccolto materiale sufficiente per dare alle stampe una Ambasciata del re Oscar allo shah di Persia e soprattutto Attraverso il Khorasan e il Turkestan, pubblicati pochi mesi dopo il suo ritorno, che consolidano la sua fama di esperto della geografia e dell’antropologia dell’Asia Centrale. Nel frattempo si è iscritto all’università di Berlino, dove ottiene in brevissimo tempo (nel 1892) una laurea dissertando sulla sua ascesa al monte Damavand.
 Ormai è famoso, tanto in Svezia quanto in Germania. Si crea dunque una cordata, lanciata dal sovrano svedese Oscar II e finanziata da banchieri e imprenditori, per raccogliere la somma necessaria ad allestire una spedizione in grande stile. Partecipano anche i russi, conquistati da una conferenza che il giovane ha tenuto a Pietroburgo, davanti ai soci della società imperiale di Geografia. Esauriti i preparativi, la partenza viene però ritardata da un problema agli occhi che tiene fermo Sven per parecchi mesi. Poi, nell’ottobre del 1893, l’esploratore raggiunge Orenburg in treno e successivamente, a cavallo o su un carrettino (un tarantass), guadagna Taskent (“In diciannove giorni avevo attraversato 11 gradi di latitudine, impiegato 111 guidatori, adoperato 317 cavalli e 21 cammelli)” A marzo parte l’esplorazione vera e propria. Mi ci soffermo più a lungo perché è probabilmente l’avventura che, una volta conosciuta, sancirà la fama di Hedin come ultimo grande esploratore romantico, colui che avanza solitario verso un ignoto irto di pericoli.
Ormai è famoso, tanto in Svezia quanto in Germania. Si crea dunque una cordata, lanciata dal sovrano svedese Oscar II e finanziata da banchieri e imprenditori, per raccogliere la somma necessaria ad allestire una spedizione in grande stile. Partecipano anche i russi, conquistati da una conferenza che il giovane ha tenuto a Pietroburgo, davanti ai soci della società imperiale di Geografia. Esauriti i preparativi, la partenza viene però ritardata da un problema agli occhi che tiene fermo Sven per parecchi mesi. Poi, nell’ottobre del 1893, l’esploratore raggiunge Orenburg in treno e successivamente, a cavallo o su un carrettino (un tarantass), guadagna Taskent (“In diciannove giorni avevo attraversato 11 gradi di latitudine, impiegato 111 guidatori, adoperato 317 cavalli e 21 cammelli)” A marzo parte l’esplorazione vera e propria. Mi ci soffermo più a lungo perché è probabilmente l’avventura che, una volta conosciuta, sancirà la fama di Hedin come ultimo grande esploratore romantico, colui che avanza solitario verso un ignoto irto di pericoli. L’idea è quella di redigere una carta su grande scala del territorio che sarà percorso, riportante i livelli altimetrici e il reticolo idrografico, completata poi dalla classificazione delle rocce e della flora, dalle caratteristiche climatiche, da una descrizione antropologica delle popolazioni (caratteri fisici, lingue, costumi, …), dalla rappresentazione delle rovine delle antiche città e dei paesaggi. Un progetto decisamente ambizioso.
L’idea è quella di redigere una carta su grande scala del territorio che sarà percorso, riportante i livelli altimetrici e il reticolo idrografico, completata poi dalla classificazione delle rocce e della flora, dalle caratteristiche climatiche, da una descrizione antropologica delle popolazioni (caratteri fisici, lingue, costumi, …), dalla rappresentazione delle rovine delle antiche città e dei paesaggi. Un progetto decisamente ambizioso.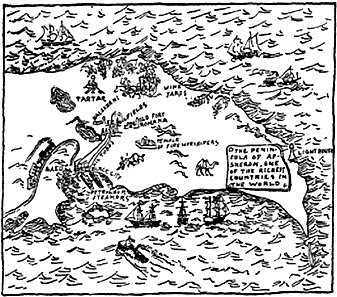 Sembra un vecchio film di John Ford, e sono convinto che molte storie cinematografiche di traversate del deserto siano state ispirate da queste pagine. Ma il meglio arriva dopo: Hedin riempie d’acqua i suoi due stivali e torna dal compagno. Questi si riprende, ma non è ancora in grado di seguirlo. Hedin torna allora allo stagno, si riposa per un giorno e prosegue poi a risalire lungo il letto del fiume. Si imbatte infine in un gruppo di pastori, che lo rifocilla, e successivamente in una carovana di mercanti che ha raccolto lungo la strada Kasim e un altro membro della spedizione miracolosamente sopravvissuto. Una volta ripresisi i tre si trascinano nuovamente fino a Kashgar. Il bilancio è catastrofico: Hedin ha perso due uomini e molti animali, nonché la gran parte dell’attrezzatura scientifica. La sua prima battaglia col deserto è perduta. O almeno, è rimandata.
Sembra un vecchio film di John Ford, e sono convinto che molte storie cinematografiche di traversate del deserto siano state ispirate da queste pagine. Ma il meglio arriva dopo: Hedin riempie d’acqua i suoi due stivali e torna dal compagno. Questi si riprende, ma non è ancora in grado di seguirlo. Hedin torna allora allo stagno, si riposa per un giorno e prosegue poi a risalire lungo il letto del fiume. Si imbatte infine in un gruppo di pastori, che lo rifocilla, e successivamente in una carovana di mercanti che ha raccolto lungo la strada Kasim e un altro membro della spedizione miracolosamente sopravvissuto. Una volta ripresisi i tre si trascinano nuovamente fino a Kashgar. Il bilancio è catastrofico: Hedin ha perso due uomini e molti animali, nonché la gran parte dell’attrezzatura scientifica. La sua prima battaglia col deserto è perduta. O almeno, è rimandata.
 L’esploratore è infatti già nuovamente in Asia nell’estate del 1899. Il 5 settembre parte dalla solita Kashgar alla testa di una carovana di 15 cammelli e 10 cavalli e raggiunge Lailik, sullo Jarcand-daria. Qui acquista e fa preparare una chiatta, con la quale intende discendere tutto il fiume fino alla sua confluenza col Tarim: “Negli anni precedenti avevo già percorso in tutti i sensi il Turkestan orientale: unica strada che m’era ancora sconosciuta, rimaneva il fiume”. L’imbarcazione è attrezzata con tutti i comfort consentiti dalla situazione: c’è persino un piccolo laboratorio per lo sviluppo delle fotografie. Su una seconda chiatta, più piccola, stipa le provviste (riso, uva, cocomeri legumi, ma anche animali vivi, montoni e galline). C’è infine un piccolo “battello pieghevole” inglese, in tela, da usare per le escursioni negli affluenti. Il 17 settembre il resto della carovana, guidata da due cosacchi, si dirige via terra al punto d’incontro stabilito sul corso del Tarim inferiore: Hedin, assieme ad uno dei compagni sopravvissuti all’avventura precedente, Islam Bai, e con cinque battellieri reclutati sul posto, inizia la sua navigazione. “Incominciò un viaggio idillico. Era una vera gioia vivere nel fiume studiandone la vita palpitante … per uno avvezzo ad avanzare sempre a cavallo o a misurare lo spazio arrampicato sul dorso di un cammello dondolantesi, è una voluttà infinita lasciarsi trasportare dalla corrente e rimanere seduto tranquillamente presso la scrivania […]”. Va da sé che la cosa non può durare. Intanto la chiatta tende ad arenarsi sui banchi di sabbia disseminati lungo il fiume: e quindi il viaggio si rivela molto più lento del previsto. Poi, quando la sua portata è arricchita da nuovi immissari, la corrente prende velocità e le imbarcazioni si salvano solo per la prontezza d’animo di uno dei battellieri. Infine, dopo due mesi, arrivano le avvisaglie dell’inverno, una sottile crosta di ghiaccio che il mattino copre le acque, e che a dicembre si trasforma in lastroni. “Alla fine la vittoria rimase al ghiaccio: la zona ghiacciata che cingeva i fianchi delle chiatte si serrò, il canale libero nel filone del fiume si restrinse, ed il 7 dicembre la crosta gelata formava un ponte che univa le due rive: eravamo imprigionati e dovemmo prendere i quartieri d’inverno.” Facendo capo a questi, Hedin intraprende la ricognizione delle zone interne sulle due sponde, malgrado temperature polari e con un equipaggiamento minimo: “Non portai con me tenda alcuna: per tutto l’inverno dormii all’aria aperta, sebbene il freddo scendesse talvolta a -33°”. È un esercizio di acclimatazione, perché ha deciso di sfidare una seconda volta il Takla Makan. E così a metà dicembre con sette cammelli, due cani, un cavallo e quattro uomini, s’inoltra nuovamente nel mare di sabbia. Nemmeno questa volta è una passeggiata. Rischiano paradossalmente ancora la sete, ma quando sono allo stremo raggiungono piccolissime oasi, o sono soccorsi dalla caduta della neve; si perdono entro tempeste di sabbia; arrivano quasi ad esaurire la provvista di legna. “Noi stavamo accosciati attorno al fuoco, raggomitolati nelle pellicce, stretti l’uno accanto all’altro […]. Al mattino io mi svegliavo completamente sepolto sotto la neve, al punto che Islam doveva spazzarla con una pala per liberarmi dalla nicchia, che lo strato di neve manteneva calda. È un’esperienza più curiosa, a dire il vero, che piacevole, quella di dormire a cielo aperto con -33° di freddo. Allorché ci trovavamo riuniti attorno al fuoco, spesso si avevano 30° di caldo dal lato della fiammata e -30 di freddo alle spalle.”
L’esploratore è infatti già nuovamente in Asia nell’estate del 1899. Il 5 settembre parte dalla solita Kashgar alla testa di una carovana di 15 cammelli e 10 cavalli e raggiunge Lailik, sullo Jarcand-daria. Qui acquista e fa preparare una chiatta, con la quale intende discendere tutto il fiume fino alla sua confluenza col Tarim: “Negli anni precedenti avevo già percorso in tutti i sensi il Turkestan orientale: unica strada che m’era ancora sconosciuta, rimaneva il fiume”. L’imbarcazione è attrezzata con tutti i comfort consentiti dalla situazione: c’è persino un piccolo laboratorio per lo sviluppo delle fotografie. Su una seconda chiatta, più piccola, stipa le provviste (riso, uva, cocomeri legumi, ma anche animali vivi, montoni e galline). C’è infine un piccolo “battello pieghevole” inglese, in tela, da usare per le escursioni negli affluenti. Il 17 settembre il resto della carovana, guidata da due cosacchi, si dirige via terra al punto d’incontro stabilito sul corso del Tarim inferiore: Hedin, assieme ad uno dei compagni sopravvissuti all’avventura precedente, Islam Bai, e con cinque battellieri reclutati sul posto, inizia la sua navigazione. “Incominciò un viaggio idillico. Era una vera gioia vivere nel fiume studiandone la vita palpitante … per uno avvezzo ad avanzare sempre a cavallo o a misurare lo spazio arrampicato sul dorso di un cammello dondolantesi, è una voluttà infinita lasciarsi trasportare dalla corrente e rimanere seduto tranquillamente presso la scrivania […]”. Va da sé che la cosa non può durare. Intanto la chiatta tende ad arenarsi sui banchi di sabbia disseminati lungo il fiume: e quindi il viaggio si rivela molto più lento del previsto. Poi, quando la sua portata è arricchita da nuovi immissari, la corrente prende velocità e le imbarcazioni si salvano solo per la prontezza d’animo di uno dei battellieri. Infine, dopo due mesi, arrivano le avvisaglie dell’inverno, una sottile crosta di ghiaccio che il mattino copre le acque, e che a dicembre si trasforma in lastroni. “Alla fine la vittoria rimase al ghiaccio: la zona ghiacciata che cingeva i fianchi delle chiatte si serrò, il canale libero nel filone del fiume si restrinse, ed il 7 dicembre la crosta gelata formava un ponte che univa le due rive: eravamo imprigionati e dovemmo prendere i quartieri d’inverno.” Facendo capo a questi, Hedin intraprende la ricognizione delle zone interne sulle due sponde, malgrado temperature polari e con un equipaggiamento minimo: “Non portai con me tenda alcuna: per tutto l’inverno dormii all’aria aperta, sebbene il freddo scendesse talvolta a -33°”. È un esercizio di acclimatazione, perché ha deciso di sfidare una seconda volta il Takla Makan. E così a metà dicembre con sette cammelli, due cani, un cavallo e quattro uomini, s’inoltra nuovamente nel mare di sabbia. Nemmeno questa volta è una passeggiata. Rischiano paradossalmente ancora la sete, ma quando sono allo stremo raggiungono piccolissime oasi, o sono soccorsi dalla caduta della neve; si perdono entro tempeste di sabbia; arrivano quasi ad esaurire la provvista di legna. “Noi stavamo accosciati attorno al fuoco, raggomitolati nelle pellicce, stretti l’uno accanto all’altro […]. Al mattino io mi svegliavo completamente sepolto sotto la neve, al punto che Islam doveva spazzarla con una pala per liberarmi dalla nicchia, che lo strato di neve manteneva calda. È un’esperienza più curiosa, a dire il vero, che piacevole, quella di dormire a cielo aperto con -33° di freddo. Allorché ci trovavamo riuniti attorno al fuoco, spesso si avevano 30° di caldo dal lato della fiammata e -30 di freddo alle spalle.” Questa volta comunque il deserto lo attraversano in lungo e in largo, e dopo quattro mesi si ricongiungono finalmente col resto del gruppo. Nel corso di un’ultima puntata esplorativa s’imbattono ancora una volta nelle rovine di antichi insediamenti, dove raccolgono tavole di legno scolpite, monete cinesi, tazze per le cerimonie, ecc… Quando sono ormai sulla via del ritorno alla base uno degli uomini scopre quasi casualmente un’antica città abbandonata, parzialmente dissepolta dall’ennesima violenta tempesta di sabbia. “Volevo assolutamente tornare indietro! Ma che follia sarebbe stata. Avevamo acqua solo per due giorni.” Per una volta il buonsenso ha la meglio. Si ripromette però di tornare l’inverno successivo, e questo cambia i piani della spedizione.
Questa volta comunque il deserto lo attraversano in lungo e in largo, e dopo quattro mesi si ricongiungono finalmente col resto del gruppo. Nel corso di un’ultima puntata esplorativa s’imbattono ancora una volta nelle rovine di antichi insediamenti, dove raccolgono tavole di legno scolpite, monete cinesi, tazze per le cerimonie, ecc… Quando sono ormai sulla via del ritorno alla base uno degli uomini scopre quasi casualmente un’antica città abbandonata, parzialmente dissepolta dall’ennesima violenta tempesta di sabbia. “Volevo assolutamente tornare indietro! Ma che follia sarebbe stata. Avevamo acqua solo per due giorni.” Per una volta il buonsenso ha la meglio. Si ripromette però di tornare l’inverno successivo, e questo cambia i piani della spedizione. Ma al di là della soluzione del problema idrografico, a Hedin interessa anche riportare alla luce quelle che erano state importanti città di sosta sulla via della seta e che erano state via via abbandonate, perché i traffici si spostavano seguendo il lago. Tornato nel luogo segnalato da uno dei suoi uomini l’anno precedente, proprio viaggiando nell’alveo del Kuruk-daria, il 18 marzo del 1900 scopre le rovine di una fortificazione (con mura di 340 x 310 metri di lunghezza), che altro non è che l’antica città reale di Loulan. Il sito era stato sede fino al 300 d.C di una guarnigione cinese, poi la popolazione l’aveva abbandonato per il repentino prosciugamento del lago sul quale si affacciava. Hedin identifica l’edificio in mattoni del comandante dell’esercito imperiale cinese, uno stupa e diciannove abitazioni costruite in legno di pioppo, ma soprattutto disseppellisce centinaia di documenti scritti su legno, carta e seta in caratteri Kharosthi. Da questi si trarranno, una volta decifrati, le informazioni sulla storia della città. “I frammenti di queste testimonianze avrebbero narrato dell’epoca in cui il Lop Nor esisteva, degli uomini che qui vivevano, delle loro condizioni, dei loro rapporti con altre parti dell’Asia interna, del nome della loro terra. Questa terra che, per così dire, venne inghiottita dai fenomeni sismici, questi uomini da tempo dimenticati, la loro storia non riportata da annali di sorta, tutto questo sarebbe tornato alla luce […]”.
Ma al di là della soluzione del problema idrografico, a Hedin interessa anche riportare alla luce quelle che erano state importanti città di sosta sulla via della seta e che erano state via via abbandonate, perché i traffici si spostavano seguendo il lago. Tornato nel luogo segnalato da uno dei suoi uomini l’anno precedente, proprio viaggiando nell’alveo del Kuruk-daria, il 18 marzo del 1900 scopre le rovine di una fortificazione (con mura di 340 x 310 metri di lunghezza), che altro non è che l’antica città reale di Loulan. Il sito era stato sede fino al 300 d.C di una guarnigione cinese, poi la popolazione l’aveva abbandonato per il repentino prosciugamento del lago sul quale si affacciava. Hedin identifica l’edificio in mattoni del comandante dell’esercito imperiale cinese, uno stupa e diciannove abitazioni costruite in legno di pioppo, ma soprattutto disseppellisce centinaia di documenti scritti su legno, carta e seta in caratteri Kharosthi. Da questi si trarranno, una volta decifrati, le informazioni sulla storia della città. “I frammenti di queste testimonianze avrebbero narrato dell’epoca in cui il Lop Nor esisteva, degli uomini che qui vivevano, delle loro condizioni, dei loro rapporti con altre parti dell’Asia interna, del nome della loro terra. Questa terra che, per così dire, venne inghiottita dai fenomeni sismici, questi uomini da tempo dimenticati, la loro storia non riportata da annali di sorta, tutto questo sarebbe tornato alla luce […]”. Una volta lasciati gli scavi, la nuova meta è il Tibet. La regione è proibita agli stranieri, e in particolare nessuno di loro può entrare in Lhasa. Questo naturalmente ha sempre stuzzicato la curiosità e la fantasia degli occidentali, che soprattutto nell’ultimo mezzo secolo hanno tentato con vari stratagemmi di eludere il divieto, e molti hanno pagato con la vita. Hedin ha concepito il piano di entrare in territorio tibetano dal Kashmir con tutta la sua carovana, che stavolta conta trenta uomini e centocinquanta animali da carico, così da far concentrare su questa l’attenzione delle guardie confinarie tibetane, e di staccarsene poi travestito da pellegrino mongolo, per filarsela a cavallo fino a Lhasa. Deve però anche superare il veto imposto all’ultimo momento dall’autorità britannica, e ci riesce solo sfruttando la reciproca ammirazione che lo lega a Younghusband, che dovrebbe fermarlo e simula invece un ritardo nella ricezione dell’ordine. I due si sono immediatamente riconosciuti e intesi: “Al momento di ripartire – scrive Younghusband – Sven Hedin mi mise una mano sulla spalla e se gli avessi dato anche il minimo incoraggiamento mi avrebbe abbracciato.”
Una volta lasciati gli scavi, la nuova meta è il Tibet. La regione è proibita agli stranieri, e in particolare nessuno di loro può entrare in Lhasa. Questo naturalmente ha sempre stuzzicato la curiosità e la fantasia degli occidentali, che soprattutto nell’ultimo mezzo secolo hanno tentato con vari stratagemmi di eludere il divieto, e molti hanno pagato con la vita. Hedin ha concepito il piano di entrare in territorio tibetano dal Kashmir con tutta la sua carovana, che stavolta conta trenta uomini e centocinquanta animali da carico, così da far concentrare su questa l’attenzione delle guardie confinarie tibetane, e di staccarsene poi travestito da pellegrino mongolo, per filarsela a cavallo fino a Lhasa. Deve però anche superare il veto imposto all’ultimo momento dall’autorità britannica, e ci riesce solo sfruttando la reciproca ammirazione che lo lega a Younghusband, che dovrebbe fermarlo e simula invece un ritardo nella ricezione dell’ordine. I due si sono immediatamente riconosciuti e intesi: “Al momento di ripartire – scrive Younghusband – Sven Hedin mi mise una mano sulla spalla e se gli avessi dato anche il minimo incoraggiamento mi avrebbe abbracciato.” Dopo una settimana, quando sono ormai a cinque giorni di cammino da Lhasa, incrociano una carovana di nomadi che guida centinaia di yak, e Hedin viene smascherato: infatti il giorno seguente (l’8 agosto) gli si para davanti una pattuglia di soldati che intima loro di tornare indietro. Prende atto che “quando al tramonto il cielo comincia ad oscurarsi ad oriente mi pare che la notte voglia stendere il suo velo sopra il paese del dalai Lama e proteggere con le sue tenebre i misteri che racchiude” e rinuncia allo scopo della missione.
Dopo una settimana, quando sono ormai a cinque giorni di cammino da Lhasa, incrociano una carovana di nomadi che guida centinaia di yak, e Hedin viene smascherato: infatti il giorno seguente (l’8 agosto) gli si para davanti una pattuglia di soldati che intima loro di tornare indietro. Prende atto che “quando al tramonto il cielo comincia ad oscurarsi ad oriente mi pare che la notte voglia stendere il suo velo sopra il paese del dalai Lama e proteggere con le sue tenebre i misteri che racchiude” e rinuncia allo scopo della missione.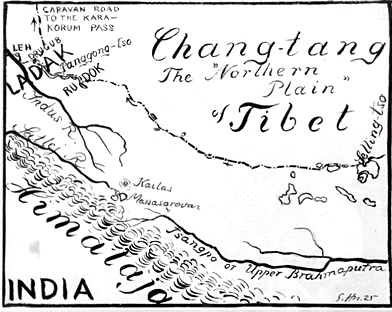 Deve prima ricongiungersi al resto della carovana, e poi con essa riattraversare le montagne tibetane. La ritirata è tutt’altro che facile, perché i soldati tibetani gli rimangono sempre alle costole. Hedin decide di puntare ad ovest, verso il Ladakh, ma il viaggio si fa sempre più pesante col sopraggiungere della stagione autunnale prima e di quella invernale poi. Muoiono tre uomini e la maggior parte degli animali, altri componenti la spedizione perdono l’uso delle gambe per congelamento. Il calvario dura quasi cinque mesi, e quando alla fine raggiungono la città di Leh, nell’India britannica, anche Hedin è prostrato.
Deve prima ricongiungersi al resto della carovana, e poi con essa riattraversare le montagne tibetane. La ritirata è tutt’altro che facile, perché i soldati tibetani gli rimangono sempre alle costole. Hedin decide di puntare ad ovest, verso il Ladakh, ma il viaggio si fa sempre più pesante col sopraggiungere della stagione autunnale prima e di quella invernale poi. Muoiono tre uomini e la maggior parte degli animali, altri componenti la spedizione perdono l’uso delle gambe per congelamento. Il calvario dura quasi cinque mesi, e quando alla fine raggiungono la città di Leh, nell’India britannica, anche Hedin è prostrato.
 L’attività di Hedin è rallentata nei due anni seguenti da alcuni avvenimenti che turbano sia la vita della Scandinavia (la separazione dei regni di Svezia e di Norvegia) che quella dell’Asia (l’invasione inglese del Tibet). Hedin stesso entra nella competizione politica, dapprima in quella nazionale, schierandosi decisamente al fianco del nuovo sovrano Gustavo V e appoggiandone la volontà di rimilitarizzare la Svezia (contro la scelta di neutralità che data dalla fine delle guerre napoleoniche), e successivamente in quella internazionale, caldeggiando l’avvicinamento della Svezia alla Germania E tuttavia non riesce a rimanere a lungo lontano dai “suoi” deserti.
L’attività di Hedin è rallentata nei due anni seguenti da alcuni avvenimenti che turbano sia la vita della Scandinavia (la separazione dei regni di Svezia e di Norvegia) che quella dell’Asia (l’invasione inglese del Tibet). Hedin stesso entra nella competizione politica, dapprima in quella nazionale, schierandosi decisamente al fianco del nuovo sovrano Gustavo V e appoggiandone la volontà di rimilitarizzare la Svezia (contro la scelta di neutralità che data dalla fine delle guerre napoleoniche), e successivamente in quella internazionale, caldeggiando l’avvicinamento della Svezia alla Germania E tuttavia non riesce a rimanere a lungo lontano dai “suoi” deserti. Tutto questo fa si che Hedin non possa più muoversi, come in precedenza, seguendo l’estro e le intuizioni del momento. Le simpatie ripetutamente manifestate per la Germania ne fanno un attore sospetto, non più coperto dallo status di cittadino di una nazione neutrale e totalmente estranea al Grande Gioco. Ora deve procedere su progetti laboriosamente concordati con i vari poteri locali (che spesso sono più di uno sugli stessi luoghi), badando a garantire la pura “scientificità” delle proprie ricerche. Vengono fuori in questo frangente le sue doti “diplomatiche”, l’importanza dei rapporti che ha stretto tramite l’attività di conferenziere e di divulgatore (ad esempio, quello col governatore dell’India, Lord Curzoon).
Tutto questo fa si che Hedin non possa più muoversi, come in precedenza, seguendo l’estro e le intuizioni del momento. Le simpatie ripetutamente manifestate per la Germania ne fanno un attore sospetto, non più coperto dallo status di cittadino di una nazione neutrale e totalmente estranea al Grande Gioco. Ora deve procedere su progetti laboriosamente concordati con i vari poteri locali (che spesso sono più di uno sugli stessi luoghi), badando a garantire la pura “scientificità” delle proprie ricerche. Vengono fuori in questo frangente le sue doti “diplomatiche”, l’importanza dei rapporti che ha stretto tramite l’attività di conferenziere e di divulgatore (ad esempio, quello col governatore dell’India, Lord Curzoon). È invece il primo europeo in assoluto a raggiungere la regione del Kailash, compresi il sacro lago Manasarovar e il monte Kailash. Secondo la mitologia buddista il Kailash è l’ombelico della terra, il centro dell’Universo, mentre per quella induista è la sacra dimora di Shiva. In questa area Hedin individua anche le sorgenti dei maggiori fiumi sacri del subcontinente indiano, l’Indo e il Brahamaputra, nonché le origini di uno dei più importanti affluenti del Gange. Col che chiude una diatriba annosa e aggiunge una perla alla sua collana di successi: “Stavo lì a meditare se Alessandro il Macedone… avesse la benché minima idea di dove si trovasse questa sorgente e mi inebriavo nella consapevolezza del fatto che, ad eccezione degli stessi tibetani, nessun essere umano tranne me era mai penetrato in questo luogo”. Infine, riconosce per primo, sia pure esplorandone solo tratti marginali, la catena del Transhimalaja, della quale il Kailash fa parte e che si stende da ovest ad est, parallela alla formazione principale, nella parte più meridionale del Tibet. Ancora oggi questa catena montuosa lunga 1600 chilometri viene talvolta indicata in suo onore come “monti di Hedin”.
È invece il primo europeo in assoluto a raggiungere la regione del Kailash, compresi il sacro lago Manasarovar e il monte Kailash. Secondo la mitologia buddista il Kailash è l’ombelico della terra, il centro dell’Universo, mentre per quella induista è la sacra dimora di Shiva. In questa area Hedin individua anche le sorgenti dei maggiori fiumi sacri del subcontinente indiano, l’Indo e il Brahamaputra, nonché le origini di uno dei più importanti affluenti del Gange. Col che chiude una diatriba annosa e aggiunge una perla alla sua collana di successi: “Stavo lì a meditare se Alessandro il Macedone… avesse la benché minima idea di dove si trovasse questa sorgente e mi inebriavo nella consapevolezza del fatto che, ad eccezione degli stessi tibetani, nessun essere umano tranne me era mai penetrato in questo luogo”. Infine, riconosce per primo, sia pure esplorandone solo tratti marginali, la catena del Transhimalaja, della quale il Kailash fa parte e che si stende da ovest ad est, parallela alla formazione principale, nella parte più meridionale del Tibet. Ancora oggi questa catena montuosa lunga 1600 chilometri viene talvolta indicata in suo onore come “monti di Hedin”. A questo punto le sue ricerche si muovono già su una linea che prefigura il futuro Ahnenerbe (Associazione per la ricerca e la diffusione dell’eredità ancestrale tedesca), di Himmler, che finanzierà anche una missione tedesca in Tibet della quale Hedin sarà inconsapevole ispiratore. Mentre in precedenza si trattava di riportare alla luce civiltà e presenze culturali dimenticate da secoli, ora l’intento è di configurare una linea di continuità proto-indoeuropea, che allaccia le culture germaniche e nordiche ai popoli parlanti lingue di derivazione dal sanscrito. Proprio gli studi linguistici, arbitrariamente letti e interpretati in chiave antropologica, inducono ad identificare una razza ariana, a partire da De Gobineau passando per Huston Chamberlain e per Vacher de Lapouge. Queste teorie, che si basano sullo stravolgimento dei dati biologici e linguistici, trovano poi una cassa di risonanza nelle elucubrazioni teosofiche di Helena Blavaskji, che conoscono una notevole diffusione alla fine dell’800. Alle une e alle altre si rifaranno, in maniera confusa e rozza, Hitler nel suo Mein Kampf, e più ancora Himmler. Nel frattempo, le imprese di Hedin e i libri che le narrano contribuiscono senz’altro a creare un modello eroico di maestro della sopravvivenza che starà alla base delle formazioni giovanili fiorenti a partire dall’inizio del secolo, i Wandervogel in Germania, ad esempio, e soprattutto i Boy Scouts nel mondo anglosassone.
A questo punto le sue ricerche si muovono già su una linea che prefigura il futuro Ahnenerbe (Associazione per la ricerca e la diffusione dell’eredità ancestrale tedesca), di Himmler, che finanzierà anche una missione tedesca in Tibet della quale Hedin sarà inconsapevole ispiratore. Mentre in precedenza si trattava di riportare alla luce civiltà e presenze culturali dimenticate da secoli, ora l’intento è di configurare una linea di continuità proto-indoeuropea, che allaccia le culture germaniche e nordiche ai popoli parlanti lingue di derivazione dal sanscrito. Proprio gli studi linguistici, arbitrariamente letti e interpretati in chiave antropologica, inducono ad identificare una razza ariana, a partire da De Gobineau passando per Huston Chamberlain e per Vacher de Lapouge. Queste teorie, che si basano sullo stravolgimento dei dati biologici e linguistici, trovano poi una cassa di risonanza nelle elucubrazioni teosofiche di Helena Blavaskji, che conoscono una notevole diffusione alla fine dell’800. Alle une e alle altre si rifaranno, in maniera confusa e rozza, Hitler nel suo Mein Kampf, e più ancora Himmler. Nel frattempo, le imprese di Hedin e i libri che le narrano contribuiscono senz’altro a creare un modello eroico di maestro della sopravvivenza che starà alla base delle formazioni giovanili fiorenti a partire dall’inizio del secolo, i Wandervogel in Germania, ad esempio, e soprattutto i Boy Scouts nel mondo anglosassone. nclude ancora una volta in India, dopo aver attraversato otto volte la catena himalajana per valichi diversi (il più alto, il Ding-La, a 5.885 metri) e percorso oltre 26.000 chilometri: una distanza, sottolinea Hedin, superiore a quella che intercorre tra i due poli (e da questa considerazione trarrà il titolo (From pole to pole) il diario divulgativo che la racconta. Dall’India Hedin torna attraverso il Giappone e la Russia. Al suo rientro a Stoccolma, nel 1909, è accolto stavolta trionfalmente da cinquemila persone, come il suo eroe Nordenskiöld trent’anni prima.
nclude ancora una volta in India, dopo aver attraversato otto volte la catena himalajana per valichi diversi (il più alto, il Ding-La, a 5.885 metri) e percorso oltre 26.000 chilometri: una distanza, sottolinea Hedin, superiore a quella che intercorre tra i due poli (e da questa considerazione trarrà il titolo (From pole to pole) il diario divulgativo che la racconta. Dall’India Hedin torna attraverso il Giappone e la Russia. Al suo rientro a Stoccolma, nel 1909, è accolto stavolta trionfalmente da cinquemila persone, come il suo eroe Nordenskiöld trent’anni prima. La prima a risentirne è la sua reputazione scientifica, e in molti casi le onorificenze, i riconoscimenti e gli appoggi economici che gli erano stati tributati in Inghilterra, vengono ritirati. Le sue attività esplorative in un’area di forte interesse strategico per l’impero britannico appaiono ora più che mai sospette, e gli stessi dati delle sue rilevazioni geografiche vengono contestati dai geografi dell’Indian Service, cui fanno ombra la sua spregiudicata attività autopromozionale e il suo successo di pubblico. In un’occasione ciò avviene molto platealmente durante una conferenza presso la Royal Geographical Society, e ciò è con ogni probabilità all’origine del suo odio per tutto ciò che è britannico. È significativo che a conferirgli dottorati honoris causa siano stati inizialmente gli atenei inglesi – sia Oxford che Cambridge nel 1909 –, e da un certo punto in avanti siano solo quelli tedeschi: Breslau (1915,), Rostock (1919), Heidelberg (1928), Uppsala (1935) Monaco (1943) e Handelshochschule Berlin (1931).
La prima a risentirne è la sua reputazione scientifica, e in molti casi le onorificenze, i riconoscimenti e gli appoggi economici che gli erano stati tributati in Inghilterra, vengono ritirati. Le sue attività esplorative in un’area di forte interesse strategico per l’impero britannico appaiono ora più che mai sospette, e gli stessi dati delle sue rilevazioni geografiche vengono contestati dai geografi dell’Indian Service, cui fanno ombra la sua spregiudicata attività autopromozionale e il suo successo di pubblico. In un’occasione ciò avviene molto platealmente durante una conferenza presso la Royal Geographical Society, e ciò è con ogni probabilità all’origine del suo odio per tutto ciò che è britannico. È significativo che a conferirgli dottorati honoris causa siano stati inizialmente gli atenei inglesi – sia Oxford che Cambridge nel 1909 –, e da un certo punto in avanti siano solo quelli tedeschi: Breslau (1915,), Rostock (1919), Heidelberg (1928), Uppsala (1935) Monaco (1943) e Handelshochschule Berlin (1931).
 L’occasione per il rientro arriva nel 1927. Hedin ha ormai più di sessant’anni, la salute non è quella di una volta, ma gli viene offerto un ruolo prestigioso. Dovrà coordinare tutte le operazioni e le attività di una grande spedizione internazionale (partecipano trentasette scienziati di sei paesi diversi) nel cuore dell’Asia, finanziata dai governi di Svezia e Germania e appoggiata da quello nazionalista cinese, che svolgerà indagini scientifiche nei campi più disparati. Il suo è un compito prevalentemente logistico, ben lontano da quello del libero esploratore indipendente: ma Hedin lo assolve magistralmente. Tra il 1927 e il 1933 la spedizione indaga sulla situazione geologica, meteorologica, topografica, botanica, archeologica e etnografica in Mongolia, nel deserto del Gobi e nello Xinjiang (il Turkestan cinese).
L’occasione per il rientro arriva nel 1927. Hedin ha ormai più di sessant’anni, la salute non è quella di una volta, ma gli viene offerto un ruolo prestigioso. Dovrà coordinare tutte le operazioni e le attività di una grande spedizione internazionale (partecipano trentasette scienziati di sei paesi diversi) nel cuore dell’Asia, finanziata dai governi di Svezia e Germania e appoggiata da quello nazionalista cinese, che svolgerà indagini scientifiche nei campi più disparati. Il suo è un compito prevalentemente logistico, ben lontano da quello del libero esploratore indipendente: ma Hedin lo assolve magistralmente. Tra il 1927 e il 1933 la spedizione indaga sulla situazione geologica, meteorologica, topografica, botanica, archeologica e etnografica in Mongolia, nel deserto del Gobi e nello Xinjiang (il Turkestan cinese). Hedin è forse l’unico uomo in grado di controllare la situazione. Mentre gli scienziati lavorano in modo quasi indipendente, lui si fa tramite con le autorità locali, assume le decisioni più importanti rispetto agli spostamenti e ai problemi organizzativi, raccoglie fondi e tiene il diario di viaggio collettivo, registrando ogni passo del percorso seguito. Deve garantire approvvigionamenti e libertà di movimento ad un gruppo che per la sua consistenza, il suo armamento, le salmerie (i soli cammelli sono trecento, e parte dell’equipaggiamento viaggia su tre camion), ma anche per le sue attività in aree che sono fortemente contese dai signori della guerra locali, somiglia a un esercito invasore.
Hedin è forse l’unico uomo in grado di controllare la situazione. Mentre gli scienziati lavorano in modo quasi indipendente, lui si fa tramite con le autorità locali, assume le decisioni più importanti rispetto agli spostamenti e ai problemi organizzativi, raccoglie fondi e tiene il diario di viaggio collettivo, registrando ogni passo del percorso seguito. Deve garantire approvvigionamenti e libertà di movimento ad un gruppo che per la sua consistenza, il suo armamento, le salmerie (i soli cammelli sono trecento, e parte dell’equipaggiamento viaggia su tre camion), ma anche per le sue attività in aree che sono fortemente contese dai signori della guerra locali, somiglia a un esercito invasore. Non mancano i momenti di tensione, perché le popolazioni locali sono sospettose e (giustificatamente) ostili, Ma alla fine il lavoro viene svolto pressoché per intero, e i risultati scientifici sono eccezionali. I resoconti relativi ad ogni settore saranno raccolti in quaranta volumi, che ancora oggi costituiscono una miniera per la conoscenza di quelle aree. La versione divulgativa del diario di viaggio o meglio, della sua ultima parte, è quella offerta sotto il titolo de Il lago errante, l’unica tradotta in italiano negli ultimi settant’anni. Viene inoltre redatta una grande carta in scala uno a un milione dell’Asia Centrale; vengono raccolti importantissimi reperti archeologici e paleontologici (resti fossili di dinosauri e altri animali estinti), che dopo essere stati valutati scientificamente per tre anni in Svezia saranno restituiti alla Cina; sono identificate e descritte specie botaniche e animali in precedenza sconosciute. Nel deserto di Lop Nor Hedin ha scoperto anche rovine di torri di segnalazione che sembrano dimostrare come la Grande Muraglia cinese un tempo si estendesse fino allo Xinjiang.
Non mancano i momenti di tensione, perché le popolazioni locali sono sospettose e (giustificatamente) ostili, Ma alla fine il lavoro viene svolto pressoché per intero, e i risultati scientifici sono eccezionali. I resoconti relativi ad ogni settore saranno raccolti in quaranta volumi, che ancora oggi costituiscono una miniera per la conoscenza di quelle aree. La versione divulgativa del diario di viaggio o meglio, della sua ultima parte, è quella offerta sotto il titolo de Il lago errante, l’unica tradotta in italiano negli ultimi settant’anni. Viene inoltre redatta una grande carta in scala uno a un milione dell’Asia Centrale; vengono raccolti importantissimi reperti archeologici e paleontologici (resti fossili di dinosauri e altri animali estinti), che dopo essere stati valutati scientificamente per tre anni in Svezia saranno restituiti alla Cina; sono identificate e descritte specie botaniche e animali in precedenza sconosciute. Nel deserto di Lop Nor Hedin ha scoperto anche rovine di torri di segnalazione che sembrano dimostrare come la Grande Muraglia cinese un tempo si estendesse fino allo Xinjiang. Nel 1933 la spedizione ha portato a termine i suoi lavori (ma soprattutto ha esaurito i fondi a disposizione) e viene sciolta ufficialmente. Ma Hedin considera tutt’altro che conclusa la sua missione. A Nanchino ha incontrato il leader nazionalista Chiang Kai-shek, che ha favorito l’iniziativa e ne è diventato uno sponsor (attraverso l’emissione di una serie di francobolli che oggi valgono una fortuna). Ora chiede a Hedin di lavorare per conto del Kuo-mintang, guidando una spedizione tutta cinese che rilevi la situazione idrografica dello Xinjiang e valuti le possibilità di creare un vastissimo sistema di irrigazione, oltre a redigere piani e mappe per la costruzione di due strade carrozzabili lungo la vecchia via della Seta, da Pechino sino all’estremo confine occidentale del Turkestan cinese. Per l’esploratore è un invito a nozze. Si mette immediatamente al lavoro e nel giro di meno di un anno fornisce sia i piani per impianti di irrigazione che trasformeranno l’economia della regione, sia i progetti per due diverse strade che da Pechino conducano a Kashgar. In questo modo rende possibile aggirare completamente il terreno acci dentato del bacino del Tarim.
Nel 1933 la spedizione ha portato a termine i suoi lavori (ma soprattutto ha esaurito i fondi a disposizione) e viene sciolta ufficialmente. Ma Hedin considera tutt’altro che conclusa la sua missione. A Nanchino ha incontrato il leader nazionalista Chiang Kai-shek, che ha favorito l’iniziativa e ne è diventato uno sponsor (attraverso l’emissione di una serie di francobolli che oggi valgono una fortuna). Ora chiede a Hedin di lavorare per conto del Kuo-mintang, guidando una spedizione tutta cinese che rilevi la situazione idrografica dello Xinjiang e valuti le possibilità di creare un vastissimo sistema di irrigazione, oltre a redigere piani e mappe per la costruzione di due strade carrozzabili lungo la vecchia via della Seta, da Pechino sino all’estremo confine occidentale del Turkestan cinese. Per l’esploratore è un invito a nozze. Si mette immediatamente al lavoro e nel giro di meno di un anno fornisce sia i piani per impianti di irrigazione che trasformeranno l’economia della regione, sia i progetti per due diverse strade che da Pechino conducano a Kashgar. In questo modo rende possibile aggirare completamente il terreno acci dentato del bacino del Tarim. Non è stato un lavoro facile. La sua carovana di autocarri è stata prima dirottata da reparti del Kuomintang in ritirata davanti ad un tentativo di invasione sovietico. Poi è stata attaccata da grappi di ribelli tungani (musulmani di lingua cinese), che hanno catturato lo stesso Hedin e lo hanno detenuto per diversi mesi a Korla, minacciando anche di passarlo per le armi assieme a tutti i membri della spedizione. Le assicurazioni e i permessi concessi dal governo centrale in quelle zone valgono poco e nulla. Al solito Hedin se la cava con la sua pratica della diplomazia e con la conoscenza dei costumi locali. Ma appena tornato libero toglie le tende.
Non è stato un lavoro facile. La sua carovana di autocarri è stata prima dirottata da reparti del Kuomintang in ritirata davanti ad un tentativo di invasione sovietico. Poi è stata attaccata da grappi di ribelli tungani (musulmani di lingua cinese), che hanno catturato lo stesso Hedin e lo hanno detenuto per diversi mesi a Korla, minacciando anche di passarlo per le armi assieme a tutti i membri della spedizione. Le assicurazioni e i permessi concessi dal governo centrale in quelle zone valgono poco e nulla. Al solito Hedin se la cava con la sua pratica della diplomazia e con la conoscenza dei costumi locali. Ma appena tornato libero toglie le tende.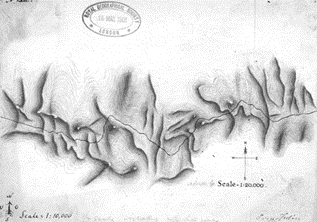 Potrebbe essere comunque soddisfatto, il successo scientifico dell’iniziativa è indubbio. Non fosse che adesso deve affrontare un altro problema, una situazione finanziaria molto difficile. Si è fatto carico infatti di una quota considerevole del finanziamento della spedizione, contraendo un pesante debito con la banca tedesco-asiatica di Pechino, in un momento peraltro nel quale il deprezzamento della moneta dovuto alla Grande Depressione ha fatto balzare i costi alle stelle. Deve allora ricominciare con un turbinoso giro di conferenze che lo porta a percorrere in pochi mesi una distanza pari a quella della circonferenza terrestre, e arriva a ipotecare tutti i suoi diritti d’autore, nonché la vastissima biblioteca che ha raccolto.
Potrebbe essere comunque soddisfatto, il successo scientifico dell’iniziativa è indubbio. Non fosse che adesso deve affrontare un altro problema, una situazione finanziaria molto difficile. Si è fatto carico infatti di una quota considerevole del finanziamento della spedizione, contraendo un pesante debito con la banca tedesco-asiatica di Pechino, in un momento peraltro nel quale il deprezzamento della moneta dovuto alla Grande Depressione ha fatto balzare i costi alle stelle. Deve allora ricominciare con un turbinoso giro di conferenze che lo porta a percorrere in pochi mesi una distanza pari a quella della circonferenza terrestre, e arriva a ipotecare tutti i suoi diritti d’autore, nonché la vastissima biblioteca che ha raccolto.
 Dopo il 1935 l’esistenza di Hedin si fa necessariamente più sedentaria. Ma a dispetto di una salute ormai cagionevole l’anziano esploratore non manca di muoversi appena possibile, per tenere conferenze, ricevere riconoscimenti, offrire consulenze. Presso le democrazie occidentali però la sua reputazione, già compromessa dalle posizioni assunte nel primo conflitto mondiale, è definitivamente rovinata dalle simpatie che manifesta per la Germania nazista e che quel regime enfatizza a scopo propagandistico (facendogli ad esempio pronunciare il discorso inaugurale alle Olimpiadi di Berlino nel 1936). Persino in patria, dove per tutti gli anni trenta e sino alla fine del secondo conflitto mondiale il governo rimane a guida socialdemocratica, malgrado il rapporto di amicizia con Gustavo V Hedin comincia ad essere considerato ingombrante.
Dopo il 1935 l’esistenza di Hedin si fa necessariamente più sedentaria. Ma a dispetto di una salute ormai cagionevole l’anziano esploratore non manca di muoversi appena possibile, per tenere conferenze, ricevere riconoscimenti, offrire consulenze. Presso le democrazie occidentali però la sua reputazione, già compromessa dalle posizioni assunte nel primo conflitto mondiale, è definitivamente rovinata dalle simpatie che manifesta per la Germania nazista e che quel regime enfatizza a scopo propagandistico (facendogli ad esempio pronunciare il discorso inaugurale alle Olimpiadi di Berlino nel 1936). Persino in patria, dove per tutti gli anni trenta e sino alla fine del secondo conflitto mondiale il governo rimane a guida socialdemocratica, malgrado il rapporto di amicizia con Gustavo V Hedin comincia ad essere considerato ingombrante. Negli anni che precedono il conflitto si dedica al riordino e alla pubblicazione dei materiali riportati dalla spedizione sino-svedese, che compaiono con il titolo di Rapporti dalla spedizione scientifica nelle province nord-occidentali della Cina sotto la guida del Dr. Sven Hedin. L’opera conosce quarantanove edizioni in svariate lingue, segno che a dispetto dell’ostracismo politico la validità e la rilevanza scientifica delle sue ricerche è ancora riconosciuta. Come già accaduto un secolo e mezzo prima per Alexander von Humboldt, però, i costi della stampa di un materiale iconograficamente così ricco e così complesso, sostenuti per la gran parte dall’autore stesso, danno fondo a quel che rimaneva del suo patrimonio, e determinano prezzi finali altissimi, sostenibili solo da un numero limitato di biblioteche e di istituti.
Negli anni che precedono il conflitto si dedica al riordino e alla pubblicazione dei materiali riportati dalla spedizione sino-svedese, che compaiono con il titolo di Rapporti dalla spedizione scientifica nelle province nord-occidentali della Cina sotto la guida del Dr. Sven Hedin. L’opera conosce quarantanove edizioni in svariate lingue, segno che a dispetto dell’ostracismo politico la validità e la rilevanza scientifica delle sue ricerche è ancora riconosciuta. Come già accaduto un secolo e mezzo prima per Alexander von Humboldt, però, i costi della stampa di un materiale iconograficamente così ricco e così complesso, sostenuti per la gran parte dall’autore stesso, danno fondo a quel che rimaneva del suo patrimonio, e determinano prezzi finali altissimi, sostenibili solo da un numero limitato di biblioteche e di istituti. Durante la fase iniziale del conflitto Hedin vive prevalentemente in Germania (e di questo soggiorno lascia una testimonianza dettagliata e rivelatrice, il Diario tedesco). Incontra personalmente Himmler e tramite lui viene a conoscenza del progetto Ahnenerbe e delle due successive spedizioni tibetane che l’istituto aveva promosse. Non è molto impressionato dal capo delle SS: “Non aveva niente nell’aspetto del despota crudele e spietato e sarebbe potuto essere benissimo un maestro elementare di qualche cittadina di provincia. Si avvertiva una mancanza di carattere e di pregnanza sul suo volto, di tratti decisi che irradiano energia e forza di volontà. Non c’era in lui traccia della classica bellezza greca o romana, né un indizio di razza o cultura […]”. Non collabora comunque alle attività dell’Ahnenerbe, anche se Ernst Schäfer, il capo delle missioni al Tibet, si ispira direttamente a lui e ambisce solo ad emularlo
Durante la fase iniziale del conflitto Hedin vive prevalentemente in Germania (e di questo soggiorno lascia una testimonianza dettagliata e rivelatrice, il Diario tedesco). Incontra personalmente Himmler e tramite lui viene a conoscenza del progetto Ahnenerbe e delle due successive spedizioni tibetane che l’istituto aveva promosse. Non è molto impressionato dal capo delle SS: “Non aveva niente nell’aspetto del despota crudele e spietato e sarebbe potuto essere benissimo un maestro elementare di qualche cittadina di provincia. Si avvertiva una mancanza di carattere e di pregnanza sul suo volto, di tratti decisi che irradiano energia e forza di volontà. Non c’era in lui traccia della classica bellezza greca o romana, né un indizio di razza o cultura […]”. Non collabora comunque alle attività dell’Ahnenerbe, anche se Ernst Schäfer, il capo delle missioni al Tibet, si ispira direttamente a lui e ambisce solo ad emularlo Gli ultimissimi anni li trascorre dunque mestamente, nel segno di un rapido oblio. Le opere che lo avevano reso famoso in tutto il mondo, soprattutto quelle divulgative in forma di diari di viaggio, libri per giovani e libri di avventura, non vengono più ristampate. Non è più tempo di eroi, di esploratori, di terre incognite, sostituiti nell’immaginario giovanile dai protagonisti degli stadi, degli schermi, del nuovo universo musicale. Le rilevazioni geografiche sono ormai affidate alla fotografia aerea, il rischio è inserito nel tutto compreso dei pacchetti vacanza. Quando Hedin muore, nel 1952, un mondo che ancora si sta leccando le ferite dell’ultimo conflitto pare nemmeno accorgersi della sua scomparsa.
Gli ultimissimi anni li trascorre dunque mestamente, nel segno di un rapido oblio. Le opere che lo avevano reso famoso in tutto il mondo, soprattutto quelle divulgative in forma di diari di viaggio, libri per giovani e libri di avventura, non vengono più ristampate. Non è più tempo di eroi, di esploratori, di terre incognite, sostituiti nell’immaginario giovanile dai protagonisti degli stadi, degli schermi, del nuovo universo musicale. Le rilevazioni geografiche sono ormai affidate alla fotografia aerea, il rischio è inserito nel tutto compreso dei pacchetti vacanza. Quando Hedin muore, nel 1952, un mondo che ancora si sta leccando le ferite dell’ultimo conflitto pare nemmeno accorgersi della sua scomparsa.
 Impostando questo pezzo avevo in mente di riassumere in tre o quattro paginette la vita e le avventure di Hedin, e di concentrarmi poi soprattutto sulle riflessioni che ne scaturivano. Non è andata così, naturalmente. So che sta diventando quasi una formula di rito, dal momento che non riesco mai a contenere la mia logorrea, ma nel caso di Hedin va detto che la sua esistenza è stata talmente ricca e movimentata che a costringerla in un centinaio di righe si rischiava di perderne le caratteristiche peculiari, l’intensità compulsiva e la determinazione quasi disumana che l’hanno governata. Qualcuno ha scritto che Hedin ha vissuto una vita così piena di avventure e fughe che il solo leggerne è estenuante. Effettivamente, se ne esce frastornati.
Impostando questo pezzo avevo in mente di riassumere in tre o quattro paginette la vita e le avventure di Hedin, e di concentrarmi poi soprattutto sulle riflessioni che ne scaturivano. Non è andata così, naturalmente. So che sta diventando quasi una formula di rito, dal momento che non riesco mai a contenere la mia logorrea, ma nel caso di Hedin va detto che la sua esistenza è stata talmente ricca e movimentata che a costringerla in un centinaio di righe si rischiava di perderne le caratteristiche peculiari, l’intensità compulsiva e la determinazione quasi disumana che l’hanno governata. Qualcuno ha scritto che Hedin ha vissuto una vita così piena di avventure e fughe che il solo leggerne è estenuante. Effettivamente, se ne esce frastornati.
 Hedin era un conservatore, un legittimista intriso sino al midollo di lealtà monarchica, un cristiano tradizionalista, e dopo la rivoluzione d’Ottobre era diventato anche un acceso anticomunista. Nel suo filonazismo non c’era alcuna componente ideologica (le idee di Hedin erano piuttosto elementari, oltre che molto radicate) ma solo l’individuazione di un comune nemico. Durante il primo conflitto aveva inneggiato agli imperi centrali come baluardo contro l’espansionismo zarista, che con le sue pretese sul Baltico minacciava la libertà e la sovranità della Svezia, e aveva caldeggiato per gli stati scandinavi una politica di riarmo: ora vedeva i bolscevichi muoversi in continuità con quel progetto di espansione, e salutava in Hitler l’unico vero loro avversario.
Hedin era un conservatore, un legittimista intriso sino al midollo di lealtà monarchica, un cristiano tradizionalista, e dopo la rivoluzione d’Ottobre era diventato anche un acceso anticomunista. Nel suo filonazismo non c’era alcuna componente ideologica (le idee di Hedin erano piuttosto elementari, oltre che molto radicate) ma solo l’individuazione di un comune nemico. Durante il primo conflitto aveva inneggiato agli imperi centrali come baluardo contro l’espansionismo zarista, che con le sue pretese sul Baltico minacciava la libertà e la sovranità della Svezia, e aveva caldeggiato per gli stati scandinavi una politica di riarmo: ora vedeva i bolscevichi muoversi in continuità con quel progetto di espansione, e salutava in Hitler l’unico vero loro avversario. La mia preoccupazione che l’educazione della gioventù tedesca, che altrimenti lodo e ammiro ovunque, sia carente in questioni di religione e dell’aldilà deriva dal mio amore e simpatia per la nazione tedesca, e come cristiano considero mio dovere dichiararlo apertamente e, certo, nella ferma convinzione che la nazione di Lutero, che è religiosa in tutto e per tutto, mi capirà.
La mia preoccupazione che l’educazione della gioventù tedesca, che altrimenti lodo e ammiro ovunque, sia carente in questioni di religione e dell’aldilà deriva dal mio amore e simpatia per la nazione tedesca, e come cristiano considero mio dovere dichiararlo apertamente e, certo, nella ferma convinzione che la nazione di Lutero, che è religiosa in tutto e per tutto, mi capirà. Ora, a mio giudizio, sortite di questo genere sono da interpretare tenendo in considerazione che Hedin ha ormai quasi ottant’anni, vissuti peraltro intensamente, che è animato da sempre da una fortissima ambizione e che certe debolezze con l’età si accentuano (pochi anni prima della morte, isolato e quasi cieco, vantava ancora di essere l’autore svedese più tradotto in altre lingue), per cui non sa sottrarsi alle lusinghe che la propaganda nazista continua a propinargli, assegnandogli premi, onorificenze, lauree honoris causa. Come giustificazione è senz’altro debole, ma all’atto pratico il suo atteggiamento non è molto lontano da quello degli innumerevoli pacifisti senza se e senza ma, sul tipo di Bertrand Russell, che sino a conflitto inoltrato sostenevano la necessità di mantenere aperto il dialogo con Hitler, o del partito comunista inglese, il cui giornale, il Daily Worker, scriveva ancora nel 1940 che la guerra era un pretesto “per schiacciare sotto il peso della macchina bellica imperialista anglo-francese milioni di sindacalisti”. O dei molti che, tanto in Inghilterra (a partire dall’ex-sovrano, Edoardo VIII) quanto in Francia (compresi i numerosi socialisti che collaborarono col governo di Vichy), simpatizzavano apertamente col regime nazista.
Ora, a mio giudizio, sortite di questo genere sono da interpretare tenendo in considerazione che Hedin ha ormai quasi ottant’anni, vissuti peraltro intensamente, che è animato da sempre da una fortissima ambizione e che certe debolezze con l’età si accentuano (pochi anni prima della morte, isolato e quasi cieco, vantava ancora di essere l’autore svedese più tradotto in altre lingue), per cui non sa sottrarsi alle lusinghe che la propaganda nazista continua a propinargli, assegnandogli premi, onorificenze, lauree honoris causa. Come giustificazione è senz’altro debole, ma all’atto pratico il suo atteggiamento non è molto lontano da quello degli innumerevoli pacifisti senza se e senza ma, sul tipo di Bertrand Russell, che sino a conflitto inoltrato sostenevano la necessità di mantenere aperto il dialogo con Hitler, o del partito comunista inglese, il cui giornale, il Daily Worker, scriveva ancora nel 1940 che la guerra era un pretesto “per schiacciare sotto il peso della macchina bellica imperialista anglo-francese milioni di sindacalisti”. O dei molti che, tanto in Inghilterra (a partire dall’ex-sovrano, Edoardo VIII) quanto in Francia (compresi i numerosi socialisti che collaborarono col governo di Vichy), simpatizzavano apertamente col regime nazista. A fronte di tutto questo, colpisce ancor più la diversità del trattamento riservato ad Hedin rispetto a quello usato nei confronti di altri personaggi, compromessi quanto e più di lui coi regimi totalitari. Un caso esemplare è, proprio per l’Italia, quello di Ardito Desio: esemplare per i molti tratti in comune dell’attività dei due protagonisti e per la differenza negli esiti e nella valutazione storica. Pochi mesi fa è passato in televisione, sul canale culturale della RAI, un documentario biografico su Desio, morto alla ragguardevole età di 104 anni, nel quale si ricordavano tutti i successi e i meriti dell’alpinista-esploratore, ma si glissava elegantemente sugli aspetti più oscuri delle sue vicende, prima e dopo la seconda guerra mondiale. Grande amico di Italo Balbo, il nostro aveva precocemente aderito al fascismo, ed era diventato la spalla del fascistissimo presidente del CAI, Angelo Manaresi, nell’opera di asservimento del sodalizio al regime; più o meno come era accaduto in Germania, con l’aggravante che là la politicizzazione era stata pressoché spontanea, coincideva con lo spirito alla Lammer che informava l’etica alpinistica tedesca del primo novecento, mentre in Italia era stata più contrastata, imposta ad una maggioranza di alpinisti tutt’altro che ansiosi di intrupparsi (e quindi aveva comportato anche delle esclusioni e delle discriminazioni).
A fronte di tutto questo, colpisce ancor più la diversità del trattamento riservato ad Hedin rispetto a quello usato nei confronti di altri personaggi, compromessi quanto e più di lui coi regimi totalitari. Un caso esemplare è, proprio per l’Italia, quello di Ardito Desio: esemplare per i molti tratti in comune dell’attività dei due protagonisti e per la differenza negli esiti e nella valutazione storica. Pochi mesi fa è passato in televisione, sul canale culturale della RAI, un documentario biografico su Desio, morto alla ragguardevole età di 104 anni, nel quale si ricordavano tutti i successi e i meriti dell’alpinista-esploratore, ma si glissava elegantemente sugli aspetti più oscuri delle sue vicende, prima e dopo la seconda guerra mondiale. Grande amico di Italo Balbo, il nostro aveva precocemente aderito al fascismo, ed era diventato la spalla del fascistissimo presidente del CAI, Angelo Manaresi, nell’opera di asservimento del sodalizio al regime; più o meno come era accaduto in Germania, con l’aggravante che là la politicizzazione era stata pressoché spontanea, coincideva con lo spirito alla Lammer che informava l’etica alpinistica tedesca del primo novecento, mentre in Italia era stata più contrastata, imposta ad una maggioranza di alpinisti tutt’altro che ansiosi di intrupparsi (e quindi aveva comportato anche delle esclusioni e delle discriminazioni).
 Che la superiorità dell’uomo bianco – diciamo pure, nell’accezione corrente ai primi del Novecento, “dell’ariano” – venga data quasi per scontata, non mi sembra un tratto attribuibile nello specifico ad Hedin. Tutti o quasi gli ambienti culturali occidentali, a partire da quello scientifico e a dispetto della lezione di Darwin, erano intrisi di questa concezione. Non erano solo Kipling o gli epigoni di De Gobineau, Chamberlain e Vacher de Lapouge a condividerla. Esploratori, antropologi, filosofi, scienziati, e persino i rappresentanti del pensiero socialista, in misura più o meno esplicita, l’avevano fatta propria (rileggetevi i romanzi di Jack London, o i saggi di Proudhon, o il dibattito sull’immigrazione al congresso mondiale della Seconda internazionale di Stoccarda, nel 1907). Le voci dissenzienti erano ben poche. Una di queste, quella di Orwell, al solito diretto e senza peli sulla lingua, denunciava a più riprese il razzismo sotterraneo del socialismo inglese.
Che la superiorità dell’uomo bianco – diciamo pure, nell’accezione corrente ai primi del Novecento, “dell’ariano” – venga data quasi per scontata, non mi sembra un tratto attribuibile nello specifico ad Hedin. Tutti o quasi gli ambienti culturali occidentali, a partire da quello scientifico e a dispetto della lezione di Darwin, erano intrisi di questa concezione. Non erano solo Kipling o gli epigoni di De Gobineau, Chamberlain e Vacher de Lapouge a condividerla. Esploratori, antropologi, filosofi, scienziati, e persino i rappresentanti del pensiero socialista, in misura più o meno esplicita, l’avevano fatta propria (rileggetevi i romanzi di Jack London, o i saggi di Proudhon, o il dibattito sull’immigrazione al congresso mondiale della Seconda internazionale di Stoccarda, nel 1907). Le voci dissenzienti erano ben poche. Una di queste, quella di Orwell, al solito diretto e senza peli sulla lingua, denunciava a più riprese il razzismo sotterraneo del socialismo inglese. Hedin in fondo sembra comportarsi allo stesso modo, ma usando criteri di valutazione molto pragmatici: durante le prime spedizioni, ad esempio, nella sua gerarchia vengono per primi gli aiutanti cosacchi, considerati i più affidabili (e con ogni probabilità erano davvero tali). Più tardi, quando lavora con i cinesi, ne apprezza la volontà e l’infaticabilità, mentre rileva lo scarso spirito d’iniziativa (ma spiegandolo con una millenaria abitudine alla sottomissione). Sono quel tipo di giudizi che ciascuno di noi può ascoltare da chi ha dimorato all’estero, foss’anche in quel Nord-Europa dal quale Hedin proveniva, senza che debbano necessariamente essere letti in una qualsivoglia chiave razzista. D’altro canto, l’idea di una “impurità” congenita all’uomo bianco è diffusissima presso le popolazioni arabe e quelle asiatiche in genere. Per questo, quando lo stigma del razzismo è applicato solo agli occidentali, si dà corpo ad una grandissima ipocrisia. Diventa una sorta di razzismo alla rovescia. Se davvero si vuole la “correttezza” politica è necessario applicare gli stessi metri a tutte le situazioni, chiaramente avendo presenti le singole condizioni storiche.
Hedin in fondo sembra comportarsi allo stesso modo, ma usando criteri di valutazione molto pragmatici: durante le prime spedizioni, ad esempio, nella sua gerarchia vengono per primi gli aiutanti cosacchi, considerati i più affidabili (e con ogni probabilità erano davvero tali). Più tardi, quando lavora con i cinesi, ne apprezza la volontà e l’infaticabilità, mentre rileva lo scarso spirito d’iniziativa (ma spiegandolo con una millenaria abitudine alla sottomissione). Sono quel tipo di giudizi che ciascuno di noi può ascoltare da chi ha dimorato all’estero, foss’anche in quel Nord-Europa dal quale Hedin proveniva, senza che debbano necessariamente essere letti in una qualsivoglia chiave razzista. D’altro canto, l’idea di una “impurità” congenita all’uomo bianco è diffusissima presso le popolazioni arabe e quelle asiatiche in genere. Per questo, quando lo stigma del razzismo è applicato solo agli occidentali, si dà corpo ad una grandissima ipocrisia. Diventa una sorta di razzismo alla rovescia. Se davvero si vuole la “correttezza” politica è necessario applicare gli stessi metri a tutte le situazioni, chiaramente avendo presenti le singole condizioni storiche.
 Ma, detto questo, non posso negare che la lettura delle sue opere sia ancora affascinante, almeno per chi come me si nutrirebbe esclusivamente di diari e resoconti di viaggi. La sua “spettacolarizzazione della natura” non è solo ruffiana, mirata a giocare sull’economia emotiva dell’elevazione per creare scenografie degne delle imprese dell’eroe: deve invece molto alla lezione di Humboldt, che aveva introdotto un secolo prima la combinazione della descrizione razionale e scientifica con le esperienze del sublime, e insistito sulla necessità di guardare dall’alto il paesaggio per cogliere da un unico punto di vista le proporzioni e le strutture della natura. Il mondo per Humboldt è un insieme integrato, mosso da forze interne; la natura è collegata in una catena indissolubile. C’è insomma l’idea che tramite la vista dall’alto lo spazio diventa comprensibile, riconducibile ad un quadro razionale e, naturalmente, dominabile. Quando si aggira per le valli o nei deserti o nelle paludi Hedin confessa spesso di sentirsi come “in un labirinto senza speranza”, disegnato da montagne e attraversato da corsi d’acqua dei quali non si capisce l’origine e non si identifica il corso: ma una volta in alto tutto diventa chiaro, può “cogliere con un solo sguardo un enorme blocco di crosta terrestre”: “l’occhio raggiunge con la massima chiarezza le distanze estreme, solo l’orizzonte erige un confine per il visibile […]. L’intera terra giace ai miei piedi”.
Ma, detto questo, non posso negare che la lettura delle sue opere sia ancora affascinante, almeno per chi come me si nutrirebbe esclusivamente di diari e resoconti di viaggi. La sua “spettacolarizzazione della natura” non è solo ruffiana, mirata a giocare sull’economia emotiva dell’elevazione per creare scenografie degne delle imprese dell’eroe: deve invece molto alla lezione di Humboldt, che aveva introdotto un secolo prima la combinazione della descrizione razionale e scientifica con le esperienze del sublime, e insistito sulla necessità di guardare dall’alto il paesaggio per cogliere da un unico punto di vista le proporzioni e le strutture della natura. Il mondo per Humboldt è un insieme integrato, mosso da forze interne; la natura è collegata in una catena indissolubile. C’è insomma l’idea che tramite la vista dall’alto lo spazio diventa comprensibile, riconducibile ad un quadro razionale e, naturalmente, dominabile. Quando si aggira per le valli o nei deserti o nelle paludi Hedin confessa spesso di sentirsi come “in un labirinto senza speranza”, disegnato da montagne e attraversato da corsi d’acqua dei quali non si capisce l’origine e non si identifica il corso: ma una volta in alto tutto diventa chiaro, può “cogliere con un solo sguardo un enorme blocco di crosta terrestre”: “l’occhio raggiunge con la massima chiarezza le distanze estreme, solo l’orizzonte erige un confine per il visibile […]. L’intera terra giace ai miei piedi”.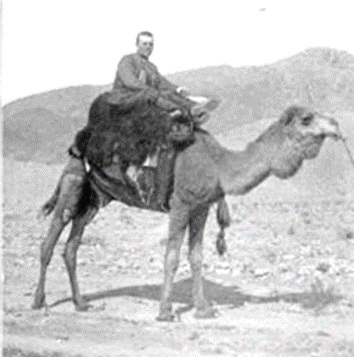
 “Il mio fidato amico, il grande e peloso Takkar, mi guarda con occhi interrogativi. Non ama le ghirlande profumate dell’estate né la zona variegata dei prati. Ricorda la vita libera nelle pianure aperte, gli mancano i combattimenti con i lupi del deserto e sogna la terra delle tempeste di neve eterne. Un giorno lo vedemmo bere a una sorgente che versava la sua acqua lungo il sentiero, e poi sdraiarsi all’ombra fresca della foresta. L’aveva fatto tante volte prima, ma non dovremmo mai vederlo ripeterlo. Si voltò e galoppò verso il solitario Tibet. Si separò con dolore nel cuore dal suo vecchio padrone, lo sapevo … Ricevo ancora di tanto in tanto, tramite il signor Marx, saluti dal vecchio Takkar, che ha difeso così fedelmente la mia tenda quando ho viaggiato sotto mentite spoglie attraverso il suo paese”.
“Il mio fidato amico, il grande e peloso Takkar, mi guarda con occhi interrogativi. Non ama le ghirlande profumate dell’estate né la zona variegata dei prati. Ricorda la vita libera nelle pianure aperte, gli mancano i combattimenti con i lupi del deserto e sogna la terra delle tempeste di neve eterne. Un giorno lo vedemmo bere a una sorgente che versava la sua acqua lungo il sentiero, e poi sdraiarsi all’ombra fresca della foresta. L’aveva fatto tante volte prima, ma non dovremmo mai vederlo ripeterlo. Si voltò e galoppò verso il solitario Tibet. Si separò con dolore nel cuore dal suo vecchio padrone, lo sapevo … Ricevo ancora di tanto in tanto, tramite il signor Marx, saluti dal vecchio Takkar, che ha difeso così fedelmente la mia tenda quando ho viaggiato sotto mentite spoglie attraverso il suo paese”.



















 Nell’interpretazione di Dugin queste strategie sono intese in realtà solo a puntellare l’ordine esistente. “L’idea principale del Great Reset è la continuazione della globalizzazione e il rafforzamento del globalismo dopo una serie di fallimenti”. Gli obiettivi di fondo del diabolico disegno possono essere riassunti in:
Nell’interpretazione di Dugin queste strategie sono intese in realtà solo a puntellare l’ordine esistente. “L’idea principale del Great Reset è la continuazione della globalizzazione e il rafforzamento del globalismo dopo una serie di fallimenti”. Gli obiettivi di fondo del diabolico disegno possono essere riassunti in: