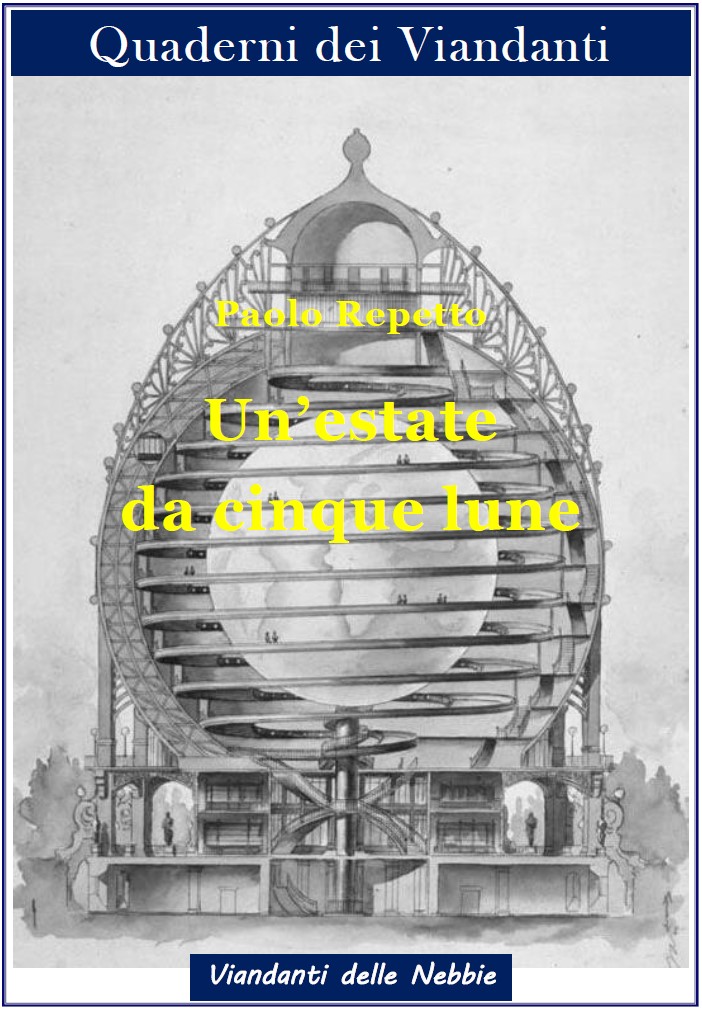di Paolo Repetto, 3 luglio 2022
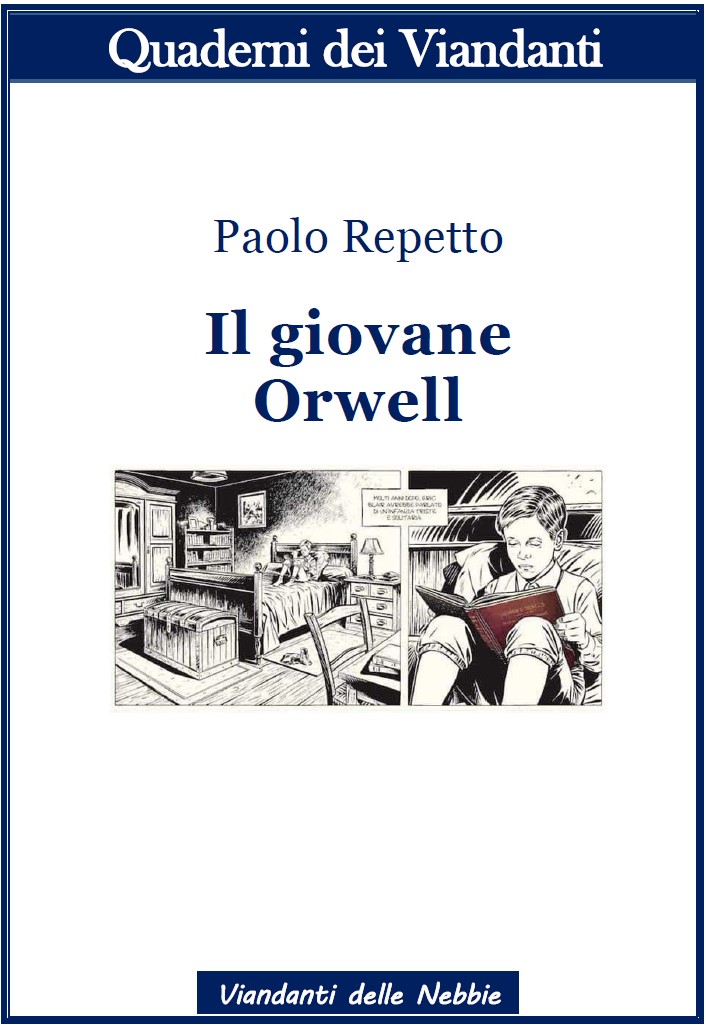 Avvertenza 2022. Avevo iniziato a scrivere questo mini-saggio circa un anno fa, prima di essere dirottato in un fastidiosissimo tunnel sanitario che si sta rivelando interminabile. All’epoca mi erano chiari gli argomenti da trattare e la modalità nella quale intendevo svilupparli, ma una volta entrato nel balletto delle terapie, delle mezze guarigioni e delle ricadute non ho più trovato la concentrazione per tornarci su e soprattutto la motivazione per portare a termine il mio proposito. È incredibile quanto il crollo della confidenza col tuo stato fisico possa mutare drasticamente l’ordine delle priorità.
Avvertenza 2022. Avevo iniziato a scrivere questo mini-saggio circa un anno fa, prima di essere dirottato in un fastidiosissimo tunnel sanitario che si sta rivelando interminabile. All’epoca mi erano chiari gli argomenti da trattare e la modalità nella quale intendevo svilupparli, ma una volta entrato nel balletto delle terapie, delle mezze guarigioni e delle ricadute non ho più trovato la concentrazione per tornarci su e soprattutto la motivazione per portare a termine il mio proposito. È incredibile quanto il crollo della confidenza col tuo stato fisico possa mutare drasticamente l’ordine delle priorità.
Riprendendo oggi in mano, grazie ad una pausa che spero definitiva, le pagine cui avevo già dato una certa sistemazione, mi sembra che in fondo una loro autonomia queste arrivino ad averla, e che il postarle, magari anche solo come bozza di un lavoro destinato ad essere ampliato ed approfondito, possa mettermi in una condizione di debito col lettore: debito al quale, per carattere, sarò poi stimolato ad ottemperare.
Non intendo farla diventare un’abitudine (è vero: ci sono già sul sito altri lavori sospesi): semplicemente, è l’unica proposta che oggi sono in grado di fare.
Quando penso all’antichità, il particolare che più mi spaventa è che quelle centinaia di milioni di schiavi sulle cui schiene poggiò la civiltà, una generazione dopo l’altra, non hanno lasciato di sé traccia alcuna. Non ne conosciamo nemmeno i nomi.
In tutta la storia greca e romana, quanti nomi di schiavi conoscete? Io non so citarne che due o al massimo tre. (George Orwell)
Premessa 2021
Sto rileggendo Nel ventre della balena, di George Orwell, e mi chiedo se la maggior parte delle idee e delle convinzioni che ho l’impressione di portarmi dietro da sempre non arrivino in realtà direttamente da queste pagine. È come le avessi apprese tantissimo tempo fa, e non solo, ma assimilate in vena, fatte mie fino a dimenticarne la provenienza e a riscriverle alla mia maniera. Al tempo stesso però continuo a dubitare di averli già letti tutti, questi saggi, perché di alcuni proprio non ho ricordo, e nemmeno ne trovo traccia quando vado a consultare le vecchie agende nelle quali fino al Duemila, per trent’anni, ho tenuto un diario delle letture.
Non è la prima volta che capita: d’altro canto, alla mia età la smemoratezza è da mettere in conto, e andrà sempre peggio. Solo che mentre in genere riesco poi a rintracciare le fonti dei “deja vu”, scoprendo pagine sottolineate in libri che da decenni avevo dimenticato persino di possedere, in questo caso ho l’impressione che la cosa sia un po’ più complessa, che la consonanza che avverto con l’autore abbia un’altra origine.
Il dubbio si è insinuato già a partire dal piccolo excursus autobiografico che apre la raccolta, intitolato Giorni Felici. Al di là delle ovvie differenze che corrono tra chi cresce in epoche e ambienti totalmente diversi, ho rivissuto attraverso Orwell l’intera gamma delle mie esperienze infantili e adolescenziali, soprattutto di quelle scolastiche, le positive e più ancora le negative. Le sintonie che ho riscontrato non potevano essere frutto solo di una precedente lettura, stavano a monte. Certe emozioni, certe rabbie, aspettative e delusioni già le conoscevo, e mi ci riconoscevo, ben prima di sentirmele raccontare.
È quindi ora che mi chiarisca un po’ le idee, anche per pagare ad Orwell il giusto tributo.
Tributare un Omaggio ad Orwell non significa azzardarne una biografia, come invece ho fatto con altri, sia pure a mio modo. Per più ragioni. Intanto Orwell aveva dettato, tra le sue ultime volontà, “desidero che dopo la mia morte non mi vengano dedicate funzioni commemorative e che di me non sia scritta alcuna biografia”. Le volontà come al solito non sono state rispettate, gli sono stati dedicati un profluvio di studi critici e biografici, oggi è persino protagonista di una grafic novel, per cui è molto noto (anche se questo non significa che sia altrettanto “conosciuto”: è noto, come vedremo, soprattutto per le ragioni sbagliate). Nemmeno intendo poi riassumere o recensire i suoi libri: li do per scontati, penso che tutti dovrebbero averli letti, e quelli che ancora non l’hanno fatto sarà bene si affrettino.
Preferisco invece fare una chiacchierata a ruota libera sul mio particolare rapporto con Orwell, mettere in luce alcuni aspetti particolari della sua vicenda umana e della sua opera (soprattutto della parte più sottovalutata) e sottolineare quei tratti della sua personalità e del suo pensiero che oggi più che mai me lo fanno sentire vicino. Senza trascurare, visto che ne ho l’occasione, di saldare qualche altro debito e di suggerire alcuni possibili apparentamenti. Spero che la cosa non mi prenda la mano, come in realtà accade troppo spesso: ma dovesse succedere, sarebbe un deragliamento annunciato.

1. La mia conoscenza di Orwell non ha seguito il tracciato canonico, che in genere procede a ritroso, dai capolavori alle opere minori (o si ferma direttamente ai primi). Ho letto Animal farm piuttosto tardi, forse ne ho addirittura visto prima la trasposizione cinematografica a cartoni animati (quella del 1954). È uno di quei libri che dopo un po’ dai per conosciuti, e finisci quindi per scoprirli con enorme ritardo. E neppure di 1984 posso vantare una lettura precoce. È andata pressappoco alla stessa maniera, ho visto prima il film (anche questo del 1954) con Edmond O’Brien nella parte di Winston Smith.
Sono convinto d’altra parte che sia proprio questo il miglior tipo di approccio. Ci sono pagine che messe prematuramente in mano ai ragazzi rischiano di non essere capite, di suscitare un amore o un rifiuto tutti di pancia (ma, soprattutto, di non essere rilette). Conoscendomi, temo che sarebbe andata proprio così. Credo che persino Animal Farm guadagni da una lettura matura e consapevole più di quanto non perda di impatto sull’ immaginario di un ragazzo o di un adolescente. Il discorso vale poi in assoluto per 1984: ho visto troppi studenti abbandonarne la lettura a metà, traditi dall’eccessivo entusiasmo di insegnanti che alle medie non consiglierebbero mai Salgari o Verne. Ora, non nego che da opere particolarmente significative possa essere colto qualche frutto ad ogni età, ma varrebbe la pena lasciare che i frutti fossero maturi.
Ciò che in realtà voglio dire è che i libri (alcuni libri) possono incidere sulla vita in due modi diversi: o perché ti indirizzano, ti indicano un possibile percorso (e questo accade in genere se li leggi nell’adolescenza; ma non solo) o perché ti danno conferme rispetto a percorsi che hai almeno in parte già compiuti (e questo accade, necessariamente, in età più matura). Nel caso del mio rapporto con Orwell la sua opera ha funzionato in entrambe le maniere, ma proprio perché l’ho accostata gradualmente, ogni volta con motivazioni diverse, e ogni volta uscendone diversamente segnato.
Ho frequentato dunque Orwell fin dall’adolescenza, ma per vie traverse. Attorno ai vent’anni conoscevo direttamente (nel senso che li avevo davvero letti) solo Giorni in Birmania, Senza un soldo a Parigi e Londra e, soprattutto, Omaggio alla Catalogna. Col senno di poi posso affermare che i tratti essenziali del carattere e delle idee di Orwell li avevo incontrati già tutti. Devo anche aggiungere che per questa occasione ho rinfrescato la conoscenza, andando a rileggere i libri di cui si parlerà nelle pagine che seguono. Un piacere enorme e una scoperta continua.
Mi ero imbattuto nel primo romanzo seguendo un percorso a zig zag che dal ciclo salgariano della jungla e dai fumetti de Il Cavaliere ideale e de Il Principe del sogno (pubblicati sul L’Intrepido) conduceva ai racconti indiani di Kipling (ma prima ancora agli straordinari film che negli anni cinquanta ne erano stati tratti, come Kim e Gunga Din) e a Lord Jim di Conrad.
L’approdo a Giorni in Birmania ha costituito un bel salto, e soprattutto mi ha impartito una salutare doccia fredda. Il fascino misterioso del paese evocato nel titolo mi aveva spinto a e cercare un supplemento di esotismo, l’anello di congiunzione tra le jungle indiane e quelle malesi: cosa che naturalmente non ho trovato, perché era del tutto estranea agli intenti dell’autore. Ho invece conosciuto l’aspetto più subdolo del colonialismo, forse meno brutale di quello raccontato nei libri sullo schiavismo, ma non meno odioso: quello del degrado morale che infetta tutti coloro che ne sono coinvolti, quale che sia il loro ruolo, passivo o attivo.
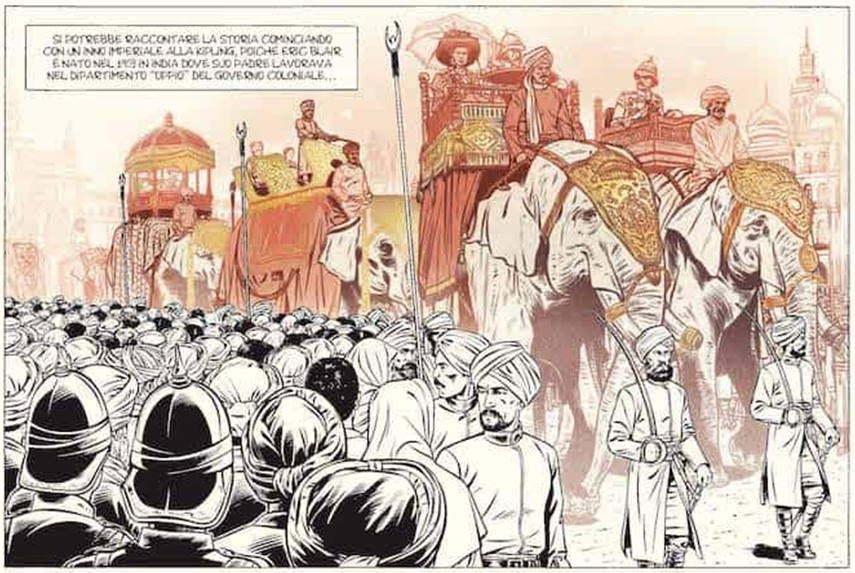
Orwell era un adolescente tutt’altro che sereno, come lui stesso racconta proprio in Giorni felici. Era incline per indole (e certamente anche per il retaggio di una educazione puritana) ai sensi di colpa, e proprio questo lo aveva spinto, dopo il mezzo fallimento negli studi rimediato al college di Eton, a mollare tutto e ad arruolarsi nella polizia coloniale. Non aveva tardato a pentirsene e a maturare un disgusto e un rimorso ancora maggiori per i cinque anni di servizio prestati in Birmania. Il libro che ci svela tutto questo non ha un carattere autobiografico in senso stretto, perché non racconta le vicende vissute dell’autore: ma raffigura impietosamente la protervia presuntuosa e l’avvilente meschinità in mezzo alle quali si è trovato e il crescente disagio da cui si è sentito pervadere. Era la cosa più antieroica che avessi letto sino ad allora: nessuno dei personaggi, coloni o colonizzati che fossero, poteva vantare non dico la statura di un eroe ma nemmeno una dignità morale accettabile. Stranamente però non ne ero rimasto deluso, perché del tutto ingenuo non ero e alcuni tratti di quel volto li avevo già intravvisti persino in Kipling: anche se poi, per capire l’ambiguità del rapporto del poliziotto Blair (ancora non aveva adottato il nom de plume) nei confronti dei colonizzati, ho dovuto attendere la lettura di racconti come Una impiccagione e Sparare all’elefante.
 Orwell è in genere presentato come il contraltare di Kipling; in tutta la sua opera, e non solo in Giorni in Birmania, c’è una indignata condanna del colonialismo e di ogni forma di imperialismo. In tal senso gli autori a lui più prossimi sono senz’altro Multatuli e Conrad (dei quali troverò modo di parlare altrove). Ma al netto delle differenti esperienze – e del fatto che Orwell abbia preso progressivamente le distanze da Kipling, fino a dichiarare senza mezzi termini di odiarlo – sono convinto che i loro atteggiamenti non fossero poi così lontani, se li leggiamo scomodando il parametro del “razzismo”: nel senso che “razzista” non era neppure il secondo, a dispetto delle sue idee sul “fardello dell’uomo bianco”. In fondo, davanti alla cultura indiana Kipling semplicemente sospendeva il giudizio: “Io ho vissuto abbastanza in questa India per sapere che è meglio non sapere nulla, e posso raccontare solo com’è andata”[1]. Cosa che puntualmente, ma in termini molto più pessimistici, pensa anche Orwell: per il quale però, a differenza di quanto pensava Kipling, il rapporto coloniale non fa che portare allo scoperto il peggio di entrambe le culture che si confrontano.
Orwell è in genere presentato come il contraltare di Kipling; in tutta la sua opera, e non solo in Giorni in Birmania, c’è una indignata condanna del colonialismo e di ogni forma di imperialismo. In tal senso gli autori a lui più prossimi sono senz’altro Multatuli e Conrad (dei quali troverò modo di parlare altrove). Ma al netto delle differenti esperienze – e del fatto che Orwell abbia preso progressivamente le distanze da Kipling, fino a dichiarare senza mezzi termini di odiarlo – sono convinto che i loro atteggiamenti non fossero poi così lontani, se li leggiamo scomodando il parametro del “razzismo”: nel senso che “razzista” non era neppure il secondo, a dispetto delle sue idee sul “fardello dell’uomo bianco”. In fondo, davanti alla cultura indiana Kipling semplicemente sospendeva il giudizio: “Io ho vissuto abbastanza in questa India per sapere che è meglio non sapere nulla, e posso raccontare solo com’è andata”[1]. Cosa che puntualmente, ma in termini molto più pessimistici, pensa anche Orwell: per il quale però, a differenza di quanto pensava Kipling, il rapporto coloniale non fa che portare allo scoperto il peggio di entrambe le culture che si confrontano.
Detto in altri termini: Kipling manifestava ammirazione e meraviglia per la cultura indiana, soprattutto per il suo retaggio sapienziale ed esoterico, ma la giudicava poi alla luce dell’evoluzionismo spenceriano. Ovvero, è tutto molto bello, ma è un mondo che non regge il passo dei tempi. Riteneva che quella antichissima civiltà non avesse mai superato lo stadio della stupefazione infantile, ed era convinto che per far uscire le popolazioni indiane dalla condizione di minorità fosse necessario il pungolo duro ma stimolante del dominio inglese. Ma pensava anche che non si può amministrare un paese se non si convive con la sua cultura, le sue tradizioni, le sue religioni, se non si è in grado di parlare con la sua gente. Un esempio limite di questo possibile rapporto lo proponeva nella simbiosi e nel reciproco rispetto tra il giovanissimo Kim e l’anziano lama, nel legame che si crea tra i due, a dispetto delle differenze e, volendo a tutti i costi scorgerla, della “superiorità” del ragazzo anglo-indiano (perché è Kim in fondo a procurare ad entrambi di che vivere e a superare con la sua scaltrezza e la sua conoscenza del territorio gli ostacoli che di volta in volta si frappongono alla loro “ricerca”).
Orwell non era altrettanto entusiasta, perché considerava di quella cultura anche gli aspetti pratici, le ricadute sui rapporti sociali, e ne coglieva quegli stessi esiti di diseguaglianza e di sfruttamento che sono comuni ad ogni forma di dominio. In più riteneva la civiltà orientale totalmente inquinata dal rapporto di sottomissione agli inglesi: i birmani che ci racconta, quale che sia il loro livello economico o di educazione, non sono molto diversi dai poliziotti inglesi che li bastonano e dai funzionari e dai commercianti che li discriminano. “È di dominio comune – scrive ne Il leone e l’unicorno – che l’indiano soffre molto più a causa dei suoi concittadini che non per colpa degli inglesi. Il piccolo capitalista indiano sfrutta gli operai nel modo più spietato. Il contadino trascorre la vita, dalla nascita alla morte, tra le grinfie dell’usuraio”. Anche se era perfettamente cosciente che “questo stato di cose è un risultato indiretto del dominio inglese che, coscientemente o no, cerca di mantenere l’India il più possibile in uno stato primitivo” (esattamente il contrario di quanto pensava Kipling).
Meno che mai confidava che il divario, il discrimine tra le due condizioni, sarebbe stato superato in un sincero rapporto d’amicizia. Il suo alter-ego romanzesco, John Flory, è anch’egli attratto dalla cultura orientale e insofferente dei codici di comportamento dei sahib bianchi, ma deve ad un certo punto prendere atto che i suoi interlocutori indigeni quei codici li hanno introiettati, li applicano anche nei loro rapporti orizzontali e non vogliono affatto mutarli o rifiutarli. In definitiva, piuttosto che del destino dell’una o dell’altra cultura gli importa di quello degli esseri umani, e punta il dito sullo stato di degrado cui questi possono essere ridotti. Ma questa situazione, come vedremo, non è precipua del mondo coloniale.
Nell’un caso e nell’altro non parlerei affatto di razzismo. Nessuno dei due romanzieri è motivato da pregiudizi di tipo biologico. Per entrambi le differenze esistono, e in effetti sarebbe un po’ difficile negarle, ma non si iscrivono in una scala valoriale delle diverse etnie. Le differenze riguardano gli individui, non le razze, e sono addirittura più accentuate all’interno delle culture alle quali quegli individui appartengono.
«Nei riguardi dei “natives” non si nutriva lo stesso sentimento che si nutriva in patria per la ‘gente bassa.’ – confessa Orwell – Il punto essenziale era che gli ‘indigeni’, i birmani, ad ogni modo, non davano l’impressione di essere fisicamente repulsivi […] Sentivo nei riguardi di un birmano quasi quello che sentirei nei riguardi di una donna. Come quasi ogni altra razza, i birmani hanno un odore caratteristico, che non so descrivere: è un odore che ti dà come un formicolio ai denti, ma che non mi ha mai disgustato. (Incidentalmente, gli orientali dicono che ‘noi’ abbiamo odore. I cinesi, credo, dicono che un bianco puzza come un cadavere. I birmani dicono lo stesso, sebbene io non abbia mai trovato un birmano così scortese da dirmelo in faccia.)»

Piuttosto, sono le convinzioni di fondo da cui i due partono, il diverso rapporto con l’idea di progresso, a segnare in direzioni opposte le loro opere. Orwell, come Conrad e al contrario di Kipling, non crede affatto che gli uomini siano fondamentalmente buoni, e nemmeno crede che con la civilizzazione possano diventarlo. Della marcia del progresso vede soprattutto la parte che rimane in ombra, le scorie e i cadaveri che lascia al bordo della strada, come testimoniano le righe che ho posto in esergo a questo scritto.
Sa anche che l’ottimismo rispetto ad una supposta “natura umana” è alla radice di ogni grande utopia sociale, e Orwell è l’autore distopico per eccellenza. Crede in compenso che tutto ciò che riesce ad assicurare agli individui un maggiore margine di libertà, intesa sia come negativa (la libertà dalle costrizioni, di non fare), sia come positiva (la libertà di pensare e di agire, nella consapevolezza naturalmente del limite, ovvero del diritto altrui alla stessa libertà), valga la pena comunque di essere perseguito. La libertà è condizione irrinunciabile per una esistenza dignitosa. E questo vale per ogni essere umano, a qualsiasi latitudine o longitudine.
Orwell pone quindi già nel suo primo libro il tema dell’illegittimità del dominio coloniale, in un’epoca in cui anche le sinistre, quella inglese principalmente, ma in sostanza tutte le altre europee, lo trovavano compatibile con gli interessi della classe operaia. Lo fa nei termini individuali ed emotivi della reazione disgustata ad uno spettacolo avvilente, ma questo lo porta a prendere le distanze dal compromesso “politico”. Se non si potrà mai realizzare una società perfetta, si dovrà pur sempre aspirare ad una meno ingiusta, partendo dall’eliminazione delle storture più vistose, rispetto alle quali l’unico strumento di riscatto è quello della crescita culturale. E se non si arriverà a migliorare il mondo, si sarà comunque in pace con la propria coscienza, per averci almeno provato. Che è ciò che ho sempre pensato anch’io.

Penso anche un’altra cosa. Paradossalmente, malgrado il ribaltamento dei rapporti (nel senso che oggi sono gli ex-colonizzati a invadere il mondo occidentale) abbia definitivamente sfatato il mito di una possibile società multiculturale, e malgrado su Kipling sia stato stampigliato il marchio scarlatto dell’imperialismo, la sua posizione sembra preludere alle mode new-age e alla filosofia post-moderna. Persino l’amicizia tra Kim e il vecchio lama, che pure è un rapporto bellissimo e genuino – con buona pace di chi vuole leggervi una strumentalizzazione imperialistica – rischia di essere letta in questa chiave. In qualità di ammiratore precocissimo e tuttora entusiasta di Kipling respingo categoricamente questa interpretazione. Credo invece che l’ulteriore ribaltamento, quello dell’immagine, nasca da una ambiguità che non è affatto di Kipling, la cui posizione (e chiamiamola pure “imperialistica”) è chiara.
L’ambiguità è piuttosto nell’atteggiamento preconcetto di chi lo legge, e si esprime essenzialmente in due modi. Da un lato c’è il lamento vittimistico (mi riferisco alla sua espressione più raffinata, quella resa popolare ad esempio da Edward Said con il suo celebratissimo saggio sull’Orientalismo), per il quale esiste un pregiudizio eurocentrico a tutt’oggi non superato nei confronti delle culture orientali (in particolare nei confronti di quelle arabo-islamiche), nato già con la riscossa medioevale dell’Europa, alimentato nell’Ottocento dalle rappresentazioni romanzesche dei popoli d’Oriente come irrazionali e moralmente corrotti, e supportato da teorie scientifiche che certificavano la loro inferiorità. Tutto vero, fatto salvo un particolare che Said e coloro che si attestano su queste posizioni tendono a trascurare. Il fatto cioè che questa lettura non solo è stata consentita, ma ha ottenuto un vasto consenso, unicamente perché chi l’ha adottata risiedeva e insegnava in Occidente. Un’operazione del genere, la critica radicale della cultura attraverso le cui istituzioni ti esprimi, non sarebbe mai stata possibile né nel vicino né nell’estremo Oriente.
Dall’altro lato c’è quello definito da Pascal Bruckner “il singhiozzo dell’uomo bianco”, che si presenta in apparenza come un doveroso ripensamento sulle storture e le ingiustizie perpetrate nei confronti del resto del mondo in nome di una presunta “missione” occidentale. Anche in questo caso, l’intento è più che positivo: ma quando dal ripensamento si passa al rifiuto in blocco degli esiti del millenario percorso della civiltà occidentale, per cercare altrove significati e valori “autentici”, si scade nella filosofia di comodo. In realtà quei valori e quei significati sono frutto di storie completamente diverse, sono impenetrabili ai nostri occhi, inconciliabili con una sensibilità diversamente educata, sono in disuso persino nei luoghi d’origine, dove continuano ad essere venduti solo sulle bancarelle per turisti, nei pacchetti “tutto compreso” degli ashran. È una filosofia deresponsabilizzante, che induce a cambiare l’arredo e la suppellettile anziché a intervenire decisamente sulle parti strutturali. (Un chiaro esempio di questa interpretazione l’ho poi ritrovato ad esempio, molto più tardi, nella Trilogia Malese di Antony Burgess: ma non mancano anche da noi gli esempi, Terzani in primis)
Quella di Orwell è invece la coscienza lucida che in un mondo governato dalle leggi del mercato non c’è cultura “alternativa” che tenga: non basta fuggirne, bisogna immergercisi per cambiarlo, nei limiti del possibile ma mirando alla sostanza. Come Kipling, che in India aveva trascorso gli anni dell’infanzia, e che da quella suggestione in fondo non era mai uscito, anche Orwell rimpiange lo sguardo del bambino, torna volentieri a rievocare un mondo precedente: ma lo fa nella piena consapevolezza di coltivare un sogno. «Non apro mai uno dei libri di Kipling – scrive – senza pensare: “Mutamento e decadenza in tutto quello che vedo intorno”» Il pensiero immediatamente successivo è però come arginare questa decadenza, senza perdersi nella nostalgia del passato: e questo sarà uno dei temi ricorrenti nella sua narrativa.
2. Da Giorni in Birmania qualcosa della vita di Orwell avevo appreso: ora ero curioso di conoscere il resto. L’occasione è arrivata qualche anno dopo con Senza un soldo a Parigi e Londra, per il quale funzionava ancora una volta la suggestione del titolo. Uscivo infatti dalla lettura di Furore e di Sulla strada, oltre che da un paio di esperienze di brevi espatri a tasche vuote, proprio nelle città cui si riferiva Orwell. Come nel caso precedente, il libro non corrispondeva affatto a ciò che cercavo, ma fotografava perfettamente quel che già avevo trovato in giro, e dava del vagabondaggio un’idea molto meno romantica di quella che Kerouac e la beat generation diffondevano in quegli anni.
Rientrato dalla Birmania, ancora nauseato per quello che aveva visto e di cui era stato anche attore, tormentato come già ho detto dai sensi di colpa, Eric Blair rifiuta di integrarsi attraverso un qualsivoglia impiego e sceglie di vedere il mondo dalla parte degli sconfitti: «Sentivo di dover sottrarmi non soltanto all’imperialismo ma ad ogni forma del dominio dell’uomo sull’uomo. Volevo sommergermi, scendere in mezzo agli oppressi, essere uno di loro e schierarmi al loro fianco contro i loro tiranni. E, soprattutto perché avevo dovuto riflettere e scoprire ogni cosa in solitudine, avevo finito per portare il mio odio dell’oppressione al di là d’ogni limite. In quel periodo, il fallimento mi sembrava essere la sola virtù. Ogni sospetto di carriera, di “successo” nella vita anche nel senso di riuscire a guadagnare qualche centinaio di sterline all’anno, mi pareva spiritualmente turpe, una specie di prepotenza».
È attratto da Parigi, che negli anni venti era la capitale della cultura europea, cosmopolita e liberale. Non ha molto chiaro quel che vuole fare, ma vuole senz’altro sottrarsi all’atmosfera ipocrita e spocchiosa dell’Inghilterra post-vittoriana. Spera che nel clima di creatività e di assoluta libertà di pensiero promesso dalla metropoli francese ci si possa seriamente dedicare alla letteratura. Le cose non sono però così facili. “Nella primavera del 1928 partii per Parigi, dove intendevo vivere con poco mentre scrivevo due romanzi (mi spiace dirlo, mai pubblicati) e magari imparare anche il francese. Nell’estate del 1929 i miei due romanzi erano terminati; ma gli editori non vollero che me ne separassi, e così mi trovai quasi senza un soldo e con un impellente bisogno di lavorare.”
Non entra nel giro che conta, non incontra i protagonisti della vita culturale, letterati e artisti, e nemmeno ha contatti con l’ambiente dei fuorusciti, russi e italiani in testa. Una volta rapidamente esaurito il piccolissimo gruzzolo sul quale faceva conto per i primi tempi, deve ingegnarsi a sbarcare il lunario. “Dici che vuoi scrivere. Scrivere è un’assurdità. C’è un solo modo per far soldi con la penna, ed è quello di sposare la figlia di un editore – gli dice un suo occasionale coinquilino – Ma tu potresti diventare un buon cameriere se ti tagliassi quei baffi.” I baffi non li taglia, e nemmeno riesce a diventare un buon cameriere, ma sopravvive.
Se si confronta la sua esperienza con quanto raccontato da Henry Miller in Parigi 1928 si ha l’impressione che il nostro sia finito in un’altra città. I suoi compagni nell’anno e mezzo di permanenza in Francia sono solo dei falliti che vivono di espedienti, una fauna internazionale sì, ma che si trascina da una occupazione miserabile all’altra, quando la trova. Niente ritrovi di intellettuali o grandi sbornie collettive con risse finali da operetta, non una serata trascorsa nei bistrot del Lungosenna a discutere di letteratura. Solo bevute solitarie per dimenticare la fatica, lavate di testa per il minimo ritardo o errore nel servizio, fregature rimediate da compagni di sventura, dagli strozzini del monte dei pegni o da professionisti dell’arte di arrangiarsi, lunghi periodi di fame nera e ambienti perennemente luridi.
La fatica, il sudiciume, le umiliazioni sono raccontati senza rancore, sono vissuti con passiva rassegnazione, ma costituiscono le uniche costanti di questa esperienza. Dopo aver letto queste pagine e dato uno sguardo a quel che accade oltre le porte delle cucine sarà difficile apprezzare un pranzo in un ristorante parigino o la sosta in un albergo. La cosa più straordinaria è però che tutto questo, in fondo, non ci indigna: come accade per i coevi film di Chaplin, siamo immersi in una vergogna sociale, ma se un riscatto ci attendiamo è solo quello individuale (forse perché sappiamo che il protagonista la sua condizione in qualche modo se l’è scelta). È significativa in proposito la descrizione delle diverse mentalità di chi lavora in questi ambienti:
 «Un albergo va avanti perché chi vi lavora è sinceramente fiero di quello che fa, per quanto possa essere stupido e orribile il suo lavoro. Se uno batte la fiacca, gli altri se ne accorgono subito e cospirano contro di lui per farlo licenziare […] Anche il cameriere è, in certo modo, fiero della propria abilità, che però consiste soprattutto nell’essere servile. Il lavoro gli conferisce l’abito mentale non già dell’operaio, ma dello snob. Vive sempre con gente ricca sotto gli occhi, ne ascolta le conversazioni, sta in piedi accanto al loro tavolo, li adula con sorrisi e piccole facezie discrete. Ha il piacere di spendere denaro per procura.
«Un albergo va avanti perché chi vi lavora è sinceramente fiero di quello che fa, per quanto possa essere stupido e orribile il suo lavoro. Se uno batte la fiacca, gli altri se ne accorgono subito e cospirano contro di lui per farlo licenziare […] Anche il cameriere è, in certo modo, fiero della propria abilità, che però consiste soprattutto nell’essere servile. Il lavoro gli conferisce l’abito mentale non già dell’operaio, ma dello snob. Vive sempre con gente ricca sotto gli occhi, ne ascolta le conversazioni, sta in piedi accanto al loro tavolo, li adula con sorrisi e piccole facezie discrete. Ha il piacere di spendere denaro per procura.
Per di più ha sempre la possibilità di diventare ricco a sua volta, perché, sebbene la maggioranza dei camerieri muoia povera, ogni tanto godono di lunghi periodi di fortuna. Il risultato è che, a furia di vedere sempre denaro e sperare di farne, il cameriere finisce con l’identificarsi, in un certo senso, col suo datore di lavoro. […] Si adopererà per servire un pranzo con stile, perché sente di partecipare egli stesso a quel pranzo […].
I “plongeurs” (è questo il solo tipo di impiego che Orwell riesce a rimediare), a loro volta, hanno una mentalità diversa. Il loro è un lavoro senza prospettive, è molto gravoso e nello stesso tempo non richiede la minima abilità, così come non presenta il minimo interesse; è il genere di lavoro che solo le donne farebbero, se avessero la forza necessaria. Tutto quello che si chiede loro è di essere sempre in attività, e sopportare un orario gravoso e un’atmosfera soffocante. Non hanno modo di cambiar vita, perché con la loro paga non possono mettere da parte un soldo, e un orario di lavoro che va dalle sessanta alle cento ore settimanali non lascia loro il tempo d’imparare a fare qualcos’altro. Tutt’al più possono sperare di trovare un lavoro un po’ più leggero come guardiano notturno o inserviente ai gabinetti.»
Per uno che era partito avendo in mente soprattutto di conservare ad ogni costo la propria libertà di pensiero e di movimento non è certo il massimo.
 Rientrato alla fine in patria, cambia scenario, ma non condizione. L’esistenza vagabonda Orwell la conduce per altri tre anni. Finisce persino in carcere, per ubriachezza (sia pure volutamente, per conoscere dall’interno anche quell’ambiente). Si concede delle rare pause quando gli capita qualche offerta per brevi periodi di insegnamento o di collaborazione a piccole riviste, poi torna a peregrinare con gli altri disgraziati seguendo la mappa delle stagioni dei raccolti, del luppolo o delle mele. È talmente impegnato a sopravvivere che non ha molto tempo per pensare. Lo farà solo dopo, al momento di tirare le somme di quell’esperienza: e sarà un bilancio tutt’altro che esaltante.
Rientrato alla fine in patria, cambia scenario, ma non condizione. L’esistenza vagabonda Orwell la conduce per altri tre anni. Finisce persino in carcere, per ubriachezza (sia pure volutamente, per conoscere dall’interno anche quell’ambiente). Si concede delle rare pause quando gli capita qualche offerta per brevi periodi di insegnamento o di collaborazione a piccole riviste, poi torna a peregrinare con gli altri disgraziati seguendo la mappa delle stagioni dei raccolti, del luppolo o delle mele. È talmente impegnato a sopravvivere che non ha molto tempo per pensare. Lo farà solo dopo, al momento di tirare le somme di quell’esperienza: e sarà un bilancio tutt’altro che esaltante.
«Nel complesso il primo contatto con la miseria è un fatto curioso. Ci avete pensato tanto, alla miseria: l’avete temuta tutta la vita, sapevate che prima o poi vi sarebbe piovuta addosso; ma in realtà tutto è totalmente, prosaicamente diverso. V’immaginavate che fosse una cosa semplicissima, e invece è quanto mai complicata. V’immaginavate che sarebbe stata terribile, ma è soltanto squallida e noiosa. Innanzitutto scoprite l’“abiezione” della miseria, gli espedienti ai quali vi costringe, le complicate meschinità, le pitoccherie.
Scoprite il tedio, che è compagno inseparabile della miseria; non avete niente da fare, e siccome siete denutrito non riuscite a interessarvi a niente. Nient’ altro che il cibo potrebbe scuotervi. Scoprite che quando un uomo va avanti una settimana a pane e margarina non è più un uomo; è solo un ventre con qualche organo accessorio.»
Potevo riconoscermi in qualche modo nella prima parte del libro, quella appunto che si svolge a Parigi, per aver lavorato come lavapiatti su una nave per qualche tempo: capivo dunque di cosa parlava quando raccontava di giornate lavorative da diciotto ore e di settimane da sette giorni senza riposo, e soprattutto conoscevo il disagio di svolgere un lavoro che non ti insegna nulla e ti costringe a prendere ordini da gente per la quale in genere nutri solo disprezzo. Allo stesso modo, in un’altra occasione avevo anche sperimentato cosa significa resistere a Londra senza una lira in tasca, sia pure per un solo mese e mezzo, e come ci si può ingegnare per sopravvivere, passando sopra anche a certi piccoli scrupoli morali.
Senza un soldo mi aveva comunque spiazzato. L’ho letto a vent’anni, col cuore che opponeva qualche resistenza, perché a quell’età per quanto scafati ci si aggrappa ancora ai miraggi di palingenesi: ma nella testa sentivo che era giusto non tacere del degrado morale che si accompagna con la fame e le privazioni a quello fisico, anche a costo di veder svanire quei miraggi. Orwell era il primo autore che riconoscevo totalmente onesto nel raccontare queste vicende e nel descrivere il mondo dei marginali e dei diseredati con i quali aveva convissuto. E, soprattutto, nel valutare lucidamente la parte giocata dal narratore all’interno del quadro: “Sfortunatamente non si risolve il problema classista diventando amici di vagabondi. Al massimo, facendolo, ci si libera di qualche pregiudizio di classe”.

3. Quanto avevo trovato in Senza un soldo mi è stato confermato qualche anno dopo da La strada di Wigan Pier. Quest’ultimo non è il resoconto di un vagabondaggio, ma un vero e proprio studio sociologico, avvalorato da cifre, dati e statistiche, sulle condizioni in cui vivevano i lavoratori nel nord-ovest industriale dell’Inghilterra, una delle zone più desolate del paese. Il quadro che risulta dalla prima parte dell’indagine è impressionante, sia quando descrive il decadimento fisico e morale degli abitanti dei quartieri poveri che quando racconta il lavoro semischiavile nei pozzi minerari.
Orwell non è affatto un osservatore freddo e distaccato. Anzi: questa sua esperienza diretta la rivendica costantemente, per dire che lo squallore lui l’ha visto da vicino, l’ha addirittura fisicamente vissuto, e proprio per questo può parlarne senza retorica, esponendo le cose così come sono. “Mi sono recato colà un po’ perché volevo vedere che cosa sia la disoccupazione di massa nella sua fase peggiore e un po’ per osservare da vicino la più tipica sezione della classe operaia inglese. Ciò era necessario per me come parte del mio aderire al socialismo. Perché prima di sentirci sicuri di essere genuinamente socialisti si deve decidere se le cose al presente siano tollerabili o non tollerabili e si deve assumere un atteggiamento definito sul problema terribilmente difficile del classismo”.
Nel suo resoconto/racconto c’è un intento fortemente polemico nei confronti della tendenza della sinistra alle costruzioni dottrinarie e puramente teoriche. In virtù di quanto ha potuto conoscere sul campo Orwell si ritiene autorizzato a lanciarsi, nella seconda parte, in un pamplet su ciò che non funziona, non tanto nel socialismo in sé, quanto nel modo in cui viene propagandato e professato. “Per difendere il socialismo occorre cominciare attaccandolo” – scrive, e precisa: “Il socialismo come lo intendo io.” La domanda da cui parte è: “come mai non siamo tutti socialisti, considerata la semplice e palese bontà dell’idea?” La risposta, o meglio, le diverse risposte che si dà mettono impietosamente a nudo le contraddizioni e le ipocrisie della sinistra, e ciò spiega perché il suo editore, un convinto militante, abbia fatto pressioni per pubblicare solo la prima parte. Il libro era stato commissionato infatti dal Left Book Club, e le riflessioni che conteneva non andavano certamente nella direzione attesa. Ma a questo punto Eric Blair era già diventato George Orwell (firma questo libro per la prima volta con lo pseudonimo che lo renderà famoso), e non aveva ceduto. All’editore non era rimasto che cercare di mitigare la deriva “ereticale” con una prefazione “allineata”, che difendeva ad esempio la politica di industrializzazione forzata portata avanti in quegli anni dall’Unione Sovietica, sulla quale invece Orwell picchiava pesante.

D’altro canto, le ragioni che Orwell adduceva per spiegare la diffidenza della maggioranza degli inglesi, lavoratori compresi, nei confronti del socialismo, rapportate alla sua epoca appaiono perfettamente plausibili (e per certi versi lo sono ancora oggi). Lo erano tanto più proprio perché nascevano dalla personale immersione nell’inferno rivelato dall’indagine. Orwell non si stanca mai di ribadire: “Questa è la realtà dei fatti, così stanno le cose”, e di sottolineare come il socialismo dottrinario quella realtà la ignori, attaccato com’è al dogmatismo dei principi e all’uso di un linguaggio stereotipato, al culto del progresso tecnologico e al pregiudizio di classe esercitato alla rovescia.
«La letteratura socialista – scrive ad esempio a proposito dei modi della comunicazione, del linguaggio della propaganda – anche quando non è apertamente scritta dall’alto in basso, è sempre totalmente estranea alla classe operaia in linguaggio e modo di pensare… È dubbio che qualcosa definibile come letteratura proletaria esista attualmente, ma un buon autore di commedie musicali si avvicina a produrre qualcosa del genere più di qualunque scrittore socialista a cui io possa pensare. Quanto al gergo tecnico dei comunisti, è tanto lontano dal linguaggio comune quanto quello di un manuale di matematica. Ricordo di aver udito il discorso di un oratore comunista a un pubblico operaio. Era un discorso zeppo delle solite cose libresche, tutto frasi lunghissime, parentesi e “ciò non ostante” e “comunque possa essere”, oltre alle consuete espressioni a base di “ideologia”, “solidarietà proletaria”, “coscienza di classe” e così via.»
Il sarcasmo orwelliano tocca però il culmine quando stigmatizza l’ostentazione di anticonvenzionalismo, un atteggiamento che irrita chi ne è spettatore e induce una rancorosa aggressività in chi lo pratica. «Come per il cristianesimo, gli adepti al socialismo sono la sua peggiore pubblicità … c’è l’orribile prevalenza – davvero preoccupante – di eccentrici e di svitati, ovunque si raccolgano dei socialisti. A volte si ha ‘impressione che le sole parole ‘socialismo’ e ‘comunismo’ attraggano a sé con forza magnetica ogni vegetariano, ogni nudista, ogni portatore di sandali, ogni maniaco sessuale, quacchero, guaritore naturista, pacifista e femminista d’Inghilterra.» Può sembrare una notazione molto forzata, ma se traduciamo i termini socialista e comunista, ormai in disuso, con i più vaghi “disobbediente” o “antagonista”, e proiettiamo l’immagine un secolo avanti, magari integrando la galassia degli ‘eccentrici’ con nuove categorie, abbiamo la fotografia della situazione attuale.

Quanto invece al progresso e alla tecnica, la posizione di Orwell è più articolata: «La specie di individuo che prontamente accetta il socialismo è anche la specie di individuo che guarda al progresso meccanico, “come tale”, con entusiasmo. E ciò è talmente vero che i socialisti sono spesso incapaci di capire che esiste l’opinione opposta. Di norma, l’argomento più persuasivo a cui possano pensare è di dirvi che la presente meccanizzazione del mondo è niente a paragone di ciò che vedremo quando il socialismo si sarà stabilito. Dove oggi c’è un solo aereo, in quei giorni ce ne saranno cinquanta! Tutto il lavoro che è fatto oggi dalla mano sarà allora fornito dalle macchine; tutto ciò che oggi è di cuoio, legno o pietra sarà fatto di gomma, vetro o acciaio; non ci sarà disordine alcuno, non ci sarà incertezza alcuna, non ci saranno distese desertiche, selvagge, non ci saranno belve feroci, male erbe, malattie, non ci sarà né povertà né dolore e così via. Il mondo socialista sarà soprattutto un mondo ‘in ordine’, un mondo efficiente. Ma è precisamente da questa visione del futuro come una specie di scintillante mondo wellsiano che rifuggono le menti sensibili.»
I tre quarti di secolo trascorsi hanno in realtà ribaltato oggi le posizioni della sinistra, almeno di quella più radicale, spingendola su posizioni che un tempo erano proprie del conservatorismo. Orwell fa però riferimento alla forma di pensiero “progressista” dominante nella sua epoca, e la sua originalità sta nel fatto che non si limita a stigmatizzare la mitizzazione della tecnica o l’uso distorto che si ne è fatto, ma ne denuncia la natura già intrinsecamente alienante. Fa parte anche lui delle “menti sensibili”, anche se poi prende atto che un’alternativa credibile al suo utilizzo non c’è. Ma su questo mi riservo di tornare tra poco.
Ciò che più mi aveva colpito in Senza un soldo (e che ho ritrovato in un’altra accezione in Wigan Pier: per questo li accomuno) è la distanza che con disarmante sincerità Orwell confessa di provare nei confronti dei ‘poveri’ ai quali si mescola. “Avevo affetto per loro e spero che essi lo avessero per me; ma mi aggiravo in mezzo a loro come un estraneo, e ne eravamo tutti consapevoli. Da qualunque parte vi volgiate, questa maledizione della differenza di classe vi si para dinanzi come una muraglia. O meglio, non tanto come una muraglia quanto come la parete di vetro di un acquario; è così facile fingere che non ci sia e così impossibile penetrarla.”
Non ha alcuna pretesa di diventare un “proletario ad honorem”: partecipa della miseria, ma non si identifica con i miserabili, Rimane sempre un testimone, ed è aiutato a mantenerne la consapevolezza dal fatto che gli altri avvertono la sua diversa estrazione, vuoi per come muove le mani, vuoi per l’accento o il modo di parlare o di camminare, per l’aspetto nel suo assieme, che a dispetto degli abiti logori mantiene una sua borghese “eleganza”.
“Prendiamo me, membro tipico del ceto medio. È facile per me dire che voglio liberarmi delle differenze di classe, ma quasi tutto ciò che penso e faccio è il risultato di differenze di classe. Tutte le mie nozioni – nozioni del bene e del male, del piacevole e dello spiacevole, del buffo e del serio, del bello e del brutto – sono essenzialmente nozioni piccoloborghesi; il mio gusto in fatto di libri, di cibi e di abiti, il mio senso dell’onore, il modo in cui so stare a tavola, il giro delle mie frasi, il mio accento, perfino i movimenti caratteristici del mio corpo, sono i prodotti di un genere particolare di educazione e di una nicchia particolare a mezza via della scala sociale. Quando capisco questo capisco anche che non serve a nulla dare una manata sulle spalle di un proletario, dicendogli che è un uomo bravo quanto me; se voglio avere un autentico rapporto con lui, devo fare uno sforzo per il quale molto probabilmente non sono preparato. Per tirarmi fuori dal brutto affare classista, devo sopprimere non solo il mio snobismo personale, ma anche quasi tutti gli altri miei gusti e pregiudizi. Devo alterare me stesso così completamente che alla fine non sarei più riconoscibile come la stessa persona”.
E allora, per evitare ipocrisie, occorre aver ben chiaro da dove arrivi la distanza, come si è generata. “Ero piccolo, molto piccolo, non avevo più di sei anni, quando mi resi conto per la prima volta delle distinzioni di classe. Prima di quell’età, i miei eroi principali erano stati generalmente operai, perché sembravano sempre intenti a fare cose interessanti come pescare, battere il ferro o costruire case. […]
Ma non passò molto tempo prima che mi si proibisse di giocare coi figli dell’idraulico; erano ‘ordinari’ e mi si disse di stare lontano da loro. Era una cosa un po’ snob, se volete, ma anche necessaria, perché gente del ceto medio non può permettere che i suoi figli imparino a parlare con accento plebeo.”
Arriva ad inserire una considerazione che, malignamente estrapolata, farà gridare allo scandalo i recensori “benpensanti” e i politicamente corretti ante-litteram, e sarà usata per screditarlo, a dispetto della chiarezza e della verità del suo significato: “Ecco che cosa ci insegnavano, che ‘la gente bassa puzza’. E qui, ovviamente, ci troviamo di fronte a una barriera insuperabile. Perché nessun sentimento di simpatia o di antipatia è così fondamentale come un sentimento fisico. L’odio di razza, l’odio di religione, differenze di educazione, di temperamento, d’intelletto, perfino differenze di codice morale, possono essere superate; ma la ripugnanza fisica non si può superare. Potete avere dell’affetto per un assassino o un sodomita, ma non per un uomo dall’alito fetido, abitualmente fetido, intendo. Per quanto bene possiate augurargli, per quanto possiate ammirare il suo carattere e la sua mente, se gli puzza il fiato, è un uomo orribile e, nel più segreto fondo del cuore, lo odiate. Può non avere grande importanza che il borghese medio sia allevato nell’idea che la classe operaia è ignorante, pigra, beona, triviale e disonesta; è quando vi si cresce nell’idea che l’operaio è anche sporco che si fa il guaio. E nella mia infanzia ci crescevano nell’idea che la gente del popolo è sporca. Molto presto nella vita acquisivi il concetto che c’è qualcosa di repulsivo in un corpo d’operaio […].”
 Tutto questo non mi indignava e non mi disturbava affatto, anzi: se una cosa non sopporto è proprio l’ipocrisia che sta dietro la mistica del proletariato, la presunzione di saperne cogliere e interpretare le aspettative e le paure, addirittura meglio dei proletari stessi, di esserne insomma la coscienza avanzata. Questa sì, mi è sempre parsa una forma insopportabile di ‘colonialismo sociale’. Persino io, che di quel proletariato facevo parte senza ombra di dubbio, avvertivo una distanza, e non perché fossi stato educato a “percepirne gli odori” (che tra l’altro, l’igienizzazione sempre più diffusa ha cancellati, reali o metaforici che fossero, così come la standardizzazione dell’abbigliamento o la scomparsa dei dialetti ha livellato gli altri indicatori sociali più eclatanti), quanto per il fatto che bene o male avevo potuto accedere a un certo livello d’istruzione e già vedevo la mia condizione da un altro punto di vista. Percepivo (e pativo) la differenza nelle aspettative “di senso”, individuali e sociali, rispetto alla maggior parte dei miei compagni del paese: ma ho patito ancor più quella rispetto ai miei compagni di studi, soprattutto all’università, e di militanza politica successivamente, che si arrogavano l’interpretazione autentica delle “istanze proletarie” e si candidavano ad avanguardie.
Tutto questo non mi indignava e non mi disturbava affatto, anzi: se una cosa non sopporto è proprio l’ipocrisia che sta dietro la mistica del proletariato, la presunzione di saperne cogliere e interpretare le aspettative e le paure, addirittura meglio dei proletari stessi, di esserne insomma la coscienza avanzata. Questa sì, mi è sempre parsa una forma insopportabile di ‘colonialismo sociale’. Persino io, che di quel proletariato facevo parte senza ombra di dubbio, avvertivo una distanza, e non perché fossi stato educato a “percepirne gli odori” (che tra l’altro, l’igienizzazione sempre più diffusa ha cancellati, reali o metaforici che fossero, così come la standardizzazione dell’abbigliamento o la scomparsa dei dialetti ha livellato gli altri indicatori sociali più eclatanti), quanto per il fatto che bene o male avevo potuto accedere a un certo livello d’istruzione e già vedevo la mia condizione da un altro punto di vista. Percepivo (e pativo) la differenza nelle aspettative “di senso”, individuali e sociali, rispetto alla maggior parte dei miei compagni del paese: ma ho patito ancor più quella rispetto ai miei compagni di studi, soprattutto all’università, e di militanza politica successivamente, che si arrogavano l’interpretazione autentica delle “istanze proletarie” e si candidavano ad avanguardie.
In Orwell la consapevolezza di quella distanza non si traduceva in rassegnazione; era il gesto di onestà necessario per cominciare sul serio a parlare di un qualche possibile cambiamento. La confessava senza tanti infingimenti e senza cercare scusanti: le cose stanno così, sembrava dire, ed è inutile e disonesto cercare di raccontarsele in altro modo. Importante è saperlo, e comportarsi di conseguenza.
Per questo, già molto prima di arrivare a quello che sarebbe stato poi giudicato un “tradimento”, non perdeva l’occasione di attaccare i “compagni” borghesi. Ne distingueva diverse tipologie: “gli schiumanti accusatori della borghesia, gli annacquati riformatori… i giovani astutissimi arrampicatori social-letterari che sono oggi i comunisti … e finalmente tutta quella deprimente tribù di donne magnanime, di uomini in sandali e di barbuti bevitori di succhi di frutta”, e di ciascuna denunciava in un aggettivo o in una lapidaria immagine la povertà di spirito, l’ambiguità, la grettezza delle motivazioni. “Un borghese abbraccia il socialismo e forse s’ iscrive addirittura al partito comunista. Ciò, che reale differenza fa? c’è qualche mutamento nei suoi gusti, nelle sue abitudini, nei suoi modi, nella sua mentalità, nella sua ‘ideologia’, per usare il termine dei comunisti? È da notarsi che egli continua a frequentare abitualmente le persone del suo ceto; si sente infinitamente più a suo agio con un membro della sua classe, il quale lo ritiene un pericoloso bolscevico, che con un membro della classe operaia, il quale si suppone condivida le sue idee; i suoi gusti in fatto di cibo, vino, abiti, libri, quadri, musica, balletto sono ancora riconoscibilmente gusti borghesi. I più dei socialisti borghesi, mentre teoricamente aspirano a una società senza classi, restano attaccati come pece ai miserabili frammenti del loro prestigio sociale”.
L’ironia di Owell è incapace di sconti nei confronti di coloro i quali, giocando a identificarsi con il proletariato, lo tradiscono. “Forse, le buone creanze a tavola non sono una cattiva dimostrazione di sincerità. Ho conosciuto molti socialisti borghesi, ho ascoltato per ore la loro tirata contro la loro classe eppure mai, neppure una volta, ne ho incontrato uno che a tavola avesse preso a comportarsi come un proletario – osserva Orwell. – Può essere solo perché in cuor suo sente che le maniere proletarie sono disgustose.”
Più tardi, in Fiorirà l’aspidispra, disegnerà la figura di Philip Ravelston, un intellettuale alto borghese che aderisce al marxismo e se ne fa ardente propugnatore, ma che a dispetto degli sforzi per scimmiottare i modi di vita dei proletari non riesce a tagliare i ponti con la classe sociale da cui proviene, e ne conserva inconsciamente gli atteggiamenti e la disposizione mentale. “Gli piaceva pensare alla gente perduta, alla gente del sottosuolo, vagabondi, mendicanti, criminali, prostitute. È un mondo buono quello in cui vivono nelle loro fetide pensioncine equivoche, nelle loro infermerie d’ospizio. Gli piaceva pensare che sotto il mondo del denaro si stendono i vasti bassifondi della sporcizia e della degradazione, dove sconfitta o riuscita non hanno più significato alcuno; una specie di regno di spettri, dove tutti sono uguali.” Ravelston lo pensa però seduto nel proprio salotto, e lo afferma durante le sedute del club di cui è socio. Eppure diventa una figura di riferimento per il protagonista del romanzo, in positivo (lo invidia) e in negativo (si compiace di coglierne le incongruenze). Questi è a sua volta un aspirante intellettuale che della propria frustrazione vuol fare virtù, imponendosi una coerenza esterna estrema nei modi di vivere: ciò che in realtà non lo porta a nulla e non lo rappacifica con se stesso.
***
4. L’idea di Orwell di studiare le classi più povere dall’interno non era così originale. Trent’anni prima Jack London, per scrivere Il popolo degli abissi, aveva vissuto per un mese e mezzo travestito da barbone nell’East End di Londra. Ne ho già parlato altrove (cfr. Tre vagabondi), e quindi non sto a ripetermi. Mi limito a cogliere la sottile differenza sia delle motivazioni che dei modi, ma soprattutto dello spirito, coi quali l’esperienza è stata vissuta dai due.
In entrambi i casi la finalità è quella del reportage giornalistico, ma la destinazione di questo reportage cambia. London intendeva, non senza una punta di sciovinismo, raccontare agli americani il ritardo dell’Inghilterra quanto a progresso sociale. Chiarisce nella nota di presentazione che la sua è una descrizione realistica dell’altra faccia della società inglese, quella che ospita gli sconfitti e gli sfruttati, e che viene sempre celata dietro l’immagine di una crescita economica straordinaria. È una sorta di rivincita nei confronti dello snobismo col quale gli inglesi avevano sempre trattato la cultura e la civiltà americana; nasce come un’indagine sociale, ma alla fine assume il significato di un j’accuse politico.
 Anche London, come Orwell, era un socialista. Sia pure in una maniera tutta sua, molto americana, che combinava Marx con Nietzsche e con Sorel. E anche lui, come Orwell, col socialismo, o meglio, coi socialisti, ebbe un rapporto conflittuale, soprattutto dopo che si rese conto che la gran parte dei suoi consistenti contributi economici alla causa era finita nelle tasche dei capi. Ciò lo aveva indotto, ad un certo punto, a prendere le distanze dal movimento e dalle organizzazioni sindacali, per coltivare un socialismo personalissimo e molto disincantato.
Anche London, come Orwell, era un socialista. Sia pure in una maniera tutta sua, molto americana, che combinava Marx con Nietzsche e con Sorel. E anche lui, come Orwell, col socialismo, o meglio, coi socialisti, ebbe un rapporto conflittuale, soprattutto dopo che si rese conto che la gran parte dei suoi consistenti contributi economici alla causa era finita nelle tasche dei capi. Ciò lo aveva indotto, ad un certo punto, a prendere le distanze dal movimento e dalle organizzazioni sindacali, per coltivare un socialismo personalissimo e molto disincantato.
È chiaro che Orwell ha preso a modello il London de Il popolo degli abissi, ed egli stesso non ha esitazioni a confessarlo: così come più tardi riconoscerà, a proposito di 1984, il debito con Il tallone di ferro, tra i primi romanzi distopici del ventesimo secolo.
La disposizione con la quale i due si calano nei bassifondi dell’umanità non è però identica. Intanto, quando aveva deciso di camuffarsi da relitto umano, assumendo le sembianze di un marinaio americano senza un soldo e alla ricerca di un imbarco, London era già uno scrittore ricco, famoso e osannato. Era uscito da una povertà che aveva conosciuto da dentro, senza bisogno di cercarla, e l’impegno di tutta la sua vita fu poi di non ricaderci. Al contrario di Orwell, quindi, arrivava da una educazione tutt’altro che borghese, che non gli aveva trasmesso pregiudizi. In quelle «bande di “cads”, ragazzacci ineducati che ti si buttavano addosso spesso in cinque o dieci contro uno”, che erano il terrore di Orwell bambino, o tra quei “figli della strada londinesi, con la loro voce squillante e la loro mancanza di scrupoli intellettuali, potevano rendere impossibile la vita a coloro che consideravano inferiore alla propria dignità rispondere loro per le rime» London sarebbe stato un capo.
Non stupisce dunque quello gli accade, la sensazione che prova: «Per strada fui ben presto colpito dalla differenza di status causata dal mio abbigliamento. Qualsiasi servilismo era scomparso dall’ atteggiamento della gente comune con cui entravo in contatto. Oplà! Un battito di ciglia, per così dire, ed ero diventato uno di loro. La mia giacca logora, dai gomiti consunti, era il segno e l’attestazione della mia classe, che era anche la loro classe. Mi rendevo simile a loro, e invece dell’attestazione servile e troppo rispettosa che avevo ricevuto fino ad allora, mi trovavo a condividere un certo cameratismo. L’uomo con i calzoni di velluto e la cravatta lercia non mi chiamava più “signore” o “principale”: ero diventato “amico”, adesso, una parola bella e sincera».
Naturalmente la solidarietà cameratesca degli uni ha il suo contraltare nel declassamento da parte degli altri: “Dal mio nuovo abbigliamento discendevano altri mutamenti di condizione. Scoprii che quando attraversavo un incrocio affollato dovevo stare più attento a evitare i veicoli, e mi apparve chiaro che il valore della mia vita era sceso in proporzione a quello dei miei vestiti. Prima, quando chiedevo la strada a un poliziotto, in genere mi domandava: – In bus o in carrozza, signore? – Adesso mi chiedeva: – A piedi? – E nelle stazioni ferroviarie mi davano un biglietto di terza classe, come fosse del tutto ovvio”.
Anche questa era una sensazione che conoscevo: la mia particolare percezione della ‘distanza’, quella di cui parlavo più sopra, l’avevo vissuta anche a parti ribaltate. Ricordo che una notte, nei tardi anni Sessanta, mentre ci aggiravamo per il quartiere di Soho dopo una giornata di digiuno quasi totale e non volontario, il mio compagno di avventura mi chiese: “Ma non dovremmo aver paura?”. Al che risposi: “Guardati attorno: sono loro ad aver paura di noi”.
London la mette giù in maniera più delicata: “E quando finalmente arrivai nell’East End, scoprii con soddisfazione che non avevo paura della folla. Ero entrato a farne parte. Il mare vasto e maleodorante si era richiuso sopra di me, o meglio mi ci ero immerso dolcemente, e non c’era nulla di terribile in questo, fatta eccezione per la maglia da fuochista”.

Di terribile c’è invece quello che nell’East End London vede, in un’epoca nella quale l’Inghilterra ha ancora un impero, è la maggiore potenza navale del mondo e accumula ricchezze che affluiscono da tutti i continenti. Vede masse enormi di diseredati: quelli che lavorano, retribuiti con salari da fame e strangolati dai debiti, costretti a spaccarsi la schiena per tirare su pochi spiccioli; i disoccupati e i vagabondi che si aggirano pressoché invisibili per le strade, sperando di trovare un qualsiasi momentaneo lavoro, a dispetto magari dell’’età avanzata o della debolezza fisica, raccolgono gli avanzi di cibo nella spazzatura e dormono di notte sulle panchine: gli uni e gli altri impegnati con tutte le loro forze solo a sopravvivere.
In quella che definisce una “voragine umana infernale” London incontra tuttavia anche alcuni personaggi che sono riusciti a dispetto della miseria a conservare la loro dignità e oppongono una resistenza eroica e solitaria alla nullificazione. Ci offre ogni tanto immagini di un socialismo un po’ deamicisiano, che devono qualcosa anche al culto superomistico di origine nietzschiana. Del resto, lui stesso rappresenta l’esempio più clamoroso di chi dalla miseria ha saputo emanciparsi con la sola forza della sua volontà e con una cultura conquistata con i denti. Sono convinto che fosse questo a fargli scorgere la possibilità di risalita dalla voragine: ma anche che figure come quelle che racconta potessero esistere veramente, prima che la burocratizzazione della lotta del proletariato ne decretasse la scomparsa.
In questo differisce da Orwell, che invece non si fa concessioni. Anche nel quadro da lui dipinto alcune figure emergono rispetto allo squallore generalizzato, ma l’impressione è che lo spazio concesso alle individualità sia davvero ridottissimo. C’entra forse il fatto che Orwell descrive la situazione creatasi immediatamente a ridosso della grande crisi del ‘29, ma la convinzione dello scrittore inglese è quella cui ho già accennato: la fame e la misera disumanizzano totalmente. La sua esperienza non dura sei settimane, ma anni, e il contatto prolungato con quella realtà finisce non per renderla normale, ma per farla cogliere al di là dell’eccezionalità e dello scandalo. Inoltre, a differenza di London, Orwell nella povertà ci si imbatte: almeno per quanto concerne le esperienze parigina e londinese non si può dire che la scelga.
Arrivano comunque alla stessa conclusione. Come scrive London: “Non ci si può sbagliare. La civiltà ha centuplicato le capacità produttive dell’uomo e, a causa della cattiva gestione, i suoi uomini vivono peggio delle bestie”. La cattiva gestione, tanto per lui quanto per Orwell, è quella operata dal modo di produzione industriale. Con la differenza che per il primo il fattore più grave è la redistribuzione ineguale delle risorse, mentre per il secondo l’industrialismo non determina soltanto una sopravvivenza fisica sempre più precaria, ma cancella nei lavoratori poveri anche ogni dignità morale, li rende quasi disumani. I personaggi disgustosi “il cui modo di parlare – dice Orwell – ti dà la sensazione che non siano persone vere, ma un tipo di fantasma che ripete in eterno lo stesso discorso senza né capo né coda […] esistono in centinaia di migliaia, e sono i prodotti caratteristici del mondo moderno, di quello che l’industrialismo ha fatto per noi”.
***
5. La denuncia della nuova miseria creata dal produttivismo arriva principalmente dagli scrittori inglesi, ed è comprensibile, dal momento che in Inghilterra le prime due fasi della rivoluzione industriale sono già compiute alla fine dell’Ottocento, e i loro risvolti negativi, a livello sia ambientale che sociale, sono ormai evidenti. La povertà narrata dai romanzieri francesi (da Hugo a Zola), da quelli russi (Gorkij) o scandinavi (Hamsun, Martinsson) o italiani (Verga) è ancora legata ad un mondo preindustriale. Orwell è stato invece preceduto anche da diversi connazionali. Dando per scontato Dickens, autore d’obbligo nella formazione culturale vittoriana, che in opere come Tempi difficili o Oliver Twist lancia una indignata protesta sociale (anche se è poi costretto da esigenze di cassetta ad annacquarla con finali dolciastri), dietro l’opera di Orwell si può ad esempio facilmente cogliere l’influsso di quella di George Gissing.
Gissing la povertà non l’aveva cercata, né ci si era imbattuto. C’era proprio cascato dentro, in seguito ad una serie di disavventure sentimentali che ne avevano troncato le aspirazioni di umanista brillante e appassionato. Aveva conosciuto persino il carcere, e si era trovato a condividere la vita degradata e umiliante degli abitanti dei più squallidi bassifondi londinesi. Non gli restava che fare di necessità virtù, denunciando nei suoi primi romanzi la miserabile realtà degli slums londinesi. “L’arte deve essere oggi il portavoce della miseria, perché la miseria è la nota dominante del nostro mondo” – faceva dire ad uno dei suoi protagonisti – “Voglio far capire alla gente le spaventose condizioni (materiali, intellettuali e morali) delle nostre classi povere, per mostrare l’orrenda ingiustizia di tutto il nostro sistema sociale, e illuminare un piano per riformarlo.”
Quella miseria Gissing la conosce meglio degli stessi London e Orwell, perché è costretto ad affrontarla non da più o meno allegro vagabondo, ma avendo sulle spalle la responsabilità di una famiglia. Per questo motivo, e soprattutto per un’attitudine caratteriale decisamente pessimista, nei confronti dell’ambiente che descrive prova soltanto antipatia ed avversione. C’è un divario enorme tra la sua capacità di rappresentare il degrado sociale e l’incapacità di entrare in sintonia con la massa che lo vive, di intenderne e di parlarne il linguaggio. Non ha nemmeno bisogno di confessare apertamente i suoi sentimenti, come farà Orwell; questo rifiuto lo si avverte subito, perché Gissing non si sforza affatto di mantenersi neutrale. Vive tra i poveri, osserva i poveri e si propone, con i suoi libri, di rendere loro un servizio, ma non riesce né ad amarli né a sopportarli, prova quasi un odio fisico, è costantemente irritato dalla loro meschina materialità. Si sente tra loro come un prigioniero, e i soli personaggi che si distinguono positivamente in tanto squallore sono i prigionieri come lui, costretti in un mondo che è loro estraneo e che tarpa l’ingegno e le speranze.
 Malgrado ciò, per molti aspetti Gissing è molto più prossimo ad Orwell di quanto potrebbe sembrare. Nel suo unico libro di viaggi, Sulle rive dello Ionio, scrive ad un certo punto: “Ogni uomo ha un suo anelito intellettuale; io ho quello di sfuggire alla vita che conosco e di tornare, per virtù del sogno, in quell’antico mondo che deliziò la mia immaginazione di fanciullo” (nel suo caso si tratta del mondo greco e romano). Le vestigia di questo mondo le trova ad esempio nel Meridione italiano, e segnatamente nella sua area più arretrata, in Calabria: ne è talmente suggestionato da tollerare la miseria delle popolazioni calabresi, che gli appare comunque solare, mentre considera torbida e insopportabile quella delle masse londinesi. (In questo è simile a molti suoi contemporanei in fuga dalla società vittoriana, ma molto diverso da Dickens, che nel suo resoconto di un viaggio in Italia parla di “Città sporche e tristi, paese decadente, umanità ambigua” e scrive, in una lettera ad un amico: “Se tu potessi vedere i lazzaroni come sono in realtà: meri animali, squallidi, abietti, miserabili, per l’ingrasso dei pidocchi; viscidi, brutti, cenciosi, avanzi di spaventapasseri!”).
Malgrado ciò, per molti aspetti Gissing è molto più prossimo ad Orwell di quanto potrebbe sembrare. Nel suo unico libro di viaggi, Sulle rive dello Ionio, scrive ad un certo punto: “Ogni uomo ha un suo anelito intellettuale; io ho quello di sfuggire alla vita che conosco e di tornare, per virtù del sogno, in quell’antico mondo che deliziò la mia immaginazione di fanciullo” (nel suo caso si tratta del mondo greco e romano). Le vestigia di questo mondo le trova ad esempio nel Meridione italiano, e segnatamente nella sua area più arretrata, in Calabria: ne è talmente suggestionato da tollerare la miseria delle popolazioni calabresi, che gli appare comunque solare, mentre considera torbida e insopportabile quella delle masse londinesi. (In questo è simile a molti suoi contemporanei in fuga dalla società vittoriana, ma molto diverso da Dickens, che nel suo resoconto di un viaggio in Italia parla di “Città sporche e tristi, paese decadente, umanità ambigua” e scrive, in una lettera ad un amico: “Se tu potessi vedere i lazzaroni come sono in realtà: meri animali, squallidi, abietti, miserabili, per l’ingrasso dei pidocchi; viscidi, brutti, cenciosi, avanzi di spaventapasseri!”).
Ora, anche Orwell, come ho già accennato, rimpiange il passato. In effetti moltissime sue pagine appaiono intrise di nostalgia (e questa la fa addirittura da protagonista in Una boccata d’aria). Ma è necessario distinguere tra le possibili disposizioni d’animo con le quali la nostalgia viene vissuta. Nel caso di Orwell la rievocazione nostalgica riguarda un tempo, un mondo, una condizione che ha direttamente conosciuto; per altri, come appunto Gissing, è rivolta invece a mondi solo idealizzati, anche se amati al punto da diventare comunque condizionanti per l’esistenza. In quest’ ultimo caso non è soltanto questione di tornare indietro, ma di andare proprio altrove. In fondo si tratta di utopie personalissime, di nicchie individuali che ci si ritaglia e che paradossalmente possono essere rese concrete, per brevi periodi e in condizioni particolari come quelle che si realizzano per Gissing lungo le rive dello Jonio.
Orwell rimane invece sempre perfettamente consapevole che quel tempo, quel mondo e quella condizione ai quali va con la memoria non possono tornare, e sa benissimo che il ricordo ne ha selezionato solo i lati positivi. “Rassegniamoci al fatto che il ritorno a un modo di vivere più semplice, più libero, meno meccanizzato, per desiderabile che possa essere, non si verificherà. Questo non è fatalismo, è semplice accettazione dei fatti.”
Questo perché: “Nessun essere umano vuol fare checchessia in modo più scomodo di quel che sia necessario. Da qui l’assurdità di quel quadro dei cittadini di Utopia che si salvano l’anima con lavoretti decorativi. In un mondo dove tutto possa essere fatto dalle macchine, tutto sarà fatto dalle macchine. Tornare deliberatamente a metodi primitivi, usare strumenti arcaici, porre piccoli ostacoli idioti sulla propria strada, sarebbe dar prova di dilettantismo, darsi arie da falso artista, rendersi ridicoli. Sarebbe come sedersi solennemente a tavola per far colazione con posate di pietra”.
Usa dunque la memoria solo per trarne una qualche consolazione di fronte ad un presente e a un futuro che non lasciano presagire nulla di buono. Se non altro, essa testimonia il fatto che modi di vita differenti sono stati possibili, e se pure irripetibili, possono fungere da parametro per orientare le nostre scelte future, per non lasciare cadere ogni speranza.
“Le città industriali erano lontane, una macchia di fumo e di sofferenza nascosta dalla curvatura della terra. Qui si era ancora nell’Inghilterra che ho conosciuto nella mia infanzia: le scarpate lungo la ferrovia ricoperte di fiori selvatici, i prati dall’erba alta dove grandi cavalli lustri brucano e meditano, i lenti ruscelli in mezzo ai salici, le verdi distese di olmi, la speronella nei giardini delle casette di campagna; e poi il grande deserto tranquillo della periferia londinese, le chiatte sul fiume fangoso, le strade familiari, i manifesti che annunciano gli incontri di cricket e i matrimoni della famiglia reale, i signori in bombetta, i piccioni di Trafalgar Square, gli autobus rossi, i poliziotti in blu – tutti addormentati nel profondo, profondissimo sonno dell’Inghilterra, da cui a volte temo non ci sveglieremo mai finché non ne saremo strappati di colpo dal boato delle bombe.”
Quanto a Gissing, Orwell lo stima moltissimo: “Era un uomo intelligente e caritatevole, una persona erudita e raffinata che, dopo aver sperimentato il contatto diretto con i poveri di Londra, arrivò alla seguente conclusione: quella gente è selvaggia, mai e poi mai deve avere accesso al potere politico […] Da questo scrittore, che amava la tragedia greca, odiava la politica e cominciò a scrivere molto prima che Hitler nascesse, si può imparare qualcosa sulle origini del fascismo”.
Sono pienamente d’accordo.
***
 6. In una delle primissime recensioni italiane ad Orwell, Giuseppe Bonura scrive che aveva la tempra del martire laico. Questa definizione richiama immediatamente il confronto con un’altra esperienza simile e pressoché coeva, quella vissuta da Simone Weil, e raccontata poi dalla filosofa francese ne “La condizione operaia”.
6. In una delle primissime recensioni italiane ad Orwell, Giuseppe Bonura scrive che aveva la tempra del martire laico. Questa definizione richiama immediatamente il confronto con un’altra esperienza simile e pressoché coeva, quella vissuta da Simone Weil, e raccontata poi dalla filosofa francese ne “La condizione operaia”.
Nel dicembre del 1934 la Weil, che vuole conoscere “dall’interno” le condizioni di lavoro della classe operaia, entra come manovale nelle officine metallurgiche della Renault. È cresciuta in una famiglia alto borghese, ha ricevuto un’istruzione laica e raffinata, è cagionevole di salute ma incredibilmente determinata, sorretta da uno spirito missionario che sconfina nella patologia.
Regge per otto mesi, sufficienti a farle sperimentare lo stato di semi-schiavitù nel quale il lavoro si svolge, i ritmi infernali della catena di montaggio, la prostrazione da fatica, l’annullamento della personalità in una rassegnata obbedienza. Sono le stesse cose raccontate da Orwell, ma sono vissute in maniera diversa. “Per me, personalmente, ecco cosa ha voluto dire lavorare in fabbrica: ha voluto dire che tutte le ragioni esterne (una volta avevo creduto trattarsi di ragioni interiori) sulle quali si fondavano, per me, la coscienza della mia dignità e il rispetto di me stessa sono state radicalmente spezzate in due o tre settimane sotto i colpi di una costruzione brutale e quotidiana […] Mettendosi dinanzi alla macchina, bisogna uccidere la propria anima per otto ore al giorno, i propri pensieri, i sentimenti, tutto […] Questa situazione fa sì che il pensiero si accartocci, si ritragga, come la carne si contrae davanti a un bisturi. Non si può essere coscienti”.
Quello che la Weil racconta è tutto vero. C’è però un piccolo particolare, tutt’altro che irrilevante. La condizione interiore di cui parla la si vive quando si ha coscienza che ne esistono altre possibili: e diventa tanto più insopportabile quando si sa che è a tempo determinato, che se ne potrà uscire quando lo si vorrà. “Ho creduto di essere minacciata, a causa della prostrazione e dell’aggravarsi del dolore, da una degradazione così spaventosa di tutta l’anima che, per molte settimane, mi sono domandata con angoscia se morire non fosse per me il dovere più imperioso, benché mi sembrasse mostruoso che la mia vita dovesse concludersi nell’orrore.”
Ciò che maggiormente preoccupa la Weil è la “degradazione dell’anima”, cosa della quale i suoi compagni di lavoro non hanno affatto modo di rendersi conto, occupati come sono a sopravvivere a quella del corpo. Di fatto, quando non regge più la Weil torna all’insegnamento e alle sue frequentazioni elitarie: è vero che si impone digiuni e ogni tipo di ristrettezza per vivere il più possibile come i poveri, per entrare in “comunione spirituale” con essi: ma è altrettanto vero che può scegliere di farlo o meno.
Intendiamoci: di fronte ad una persona che potrebbe vivere tranquillamente, fregandosene degli orrori e delle ingiustizie che la circondano, e che sceglie invece l’impegno nella sua forma più radicale, ed è coerente con la sua scelta fino ad essere uccisa dai sacrifici che si è autoimposta, non posso che inchinarmi. Ma nemmeno posso impedirmi di pensare che questa scelta sia intrisa di ambiguità, di una esasperazione mistica e religiosa che pare mirata più alla salvezza della propria anima che al miglioramento della condizione altrui. L’altruismo esasperato, quando si traduce in ascesi, mi fa sempre sospettare una forte venatura di egoismo.
Tutto questo in Orwell non c’è. Vive in mezzo ai barboni e ai vagabondi, condivide dormitori pubblici e luride stamberghe, frequenta le povere case e gli infernali luoghi di lavoro dei minatori, ma poi lo racconta rimanendo sempre consapevole della distanza della sua posizione rispetto alla loro. Orwell è un ribelle nell’animo e un riformatore nella testa, la Weill è un’asceta visionaria che anela al martirio, e lo trova.
Ad accomunarli è piuttosto la messa in discussione del progresso, inteso come transizione al modo di produzione industriale. In Simone Weil naturalmente questa opposizione si esprime nella forma più esasperata: “Niente può avere come destinazione qualcosa di diverso dalla sua origine. L’idea opposta, l’idea del progresso, è veleno”.

In Orwell è più ragionata, anche se non meno radicale. «Noi tutti dipendiamo dalla macchina, e se le macchine cessassero di lavorare la maggioranza di noi morrebbe. Si può detestare la civiltà meccanica, probabilmente avete ragione di detestarla, ma per il momento non si tratta di accettarla o respingerla. La civiltà meccanica è “qui”, onnipresente, e si può soltanto criticarla dall’interno, perché tutti noi ci troviamo nel suo interno. Sono semplicemente degli idioti romantici coloro che si lusingano di essere fuggiti, come il letterato snob nella sua villa in stile Tudor con bagno e acqua calda e fredda, e come il “vero uomo” che se ne va a fare il primitivo nella giungla con un fucile Mannlicher e quattro furgoni carichi di cibarie in scatola. E quasi certamente la civiltà meccanica continuerà a trionfare […]». Però «la tendenza del progresso meccanico, dunque, è di frustrare il bisogno umano di sforzo e di creazione. Esso rende inutili e perfino impossibili le attività dell’occhio e della mano. L’apostolo del “progresso” dirà che ciò non ha importanza, ma potrete metterlo con le spalle al muro facendogli notare a quali estremi orribili può essere portato il processo. Perché, per esempio, usare le mani addirittura, perché usarle anche per soffiarsi il naso o far la punta a una matita?»
Per il resto, ciò che l’una scrive potrebbe essere sottoscritto anche dall’ altro, tranne forse l’ultima considerazione. “Il lavoro di per sé non è opprimente; – scrive la Weil – può certo produrre noia, costrizione, ma non avvilisce. È quanto ad esso si aggiunge nella produzione industriale che opprime: l’idea che il tempo passato lavorando sia perduto per la vita, l’impressione che in nessun momento si produca qualcosa di reale, la cadenza monotona dei gesti, la sottomissione passiva ai capireparto, la schiavitù cui bisogna costringersi da soli, il senso di solitudine pur in mezzo agli altri, l’esperienza dello sradicamento perché si vive in un luogo che non appartiene al lavoratore, la schiavitù che differisce da quella classica perché non consente una libertà interiore come è invece possibile per la figura dello schiavo stoico: meschina consolazione, senza dubbio, ma proibita all’operaio.”
E allora? Da dove può venire la liberazione? Non certo dalle forme di lotta tradizionali: “Gli operai fanno lo sciopero – scrive la Weil – ma lasciano ai militanti il compito di studiare il particolare delle rivendicazioni. L’abitudine della passività contratta quotidianamente nel corso di anni ed anni, non si perde in pochi giorni, anche se così belli”. Neppure da quelle più estreme, come la rivoluzione: “In questa rivolta contro l’ingiustizia sociale l’idea rivoluzionaria è buona e sana. In quanto rivolta contro l’infelicità essenziale inerente alla condizione propria dei lavoratori, è una menzogna. Perché nessuna rivoluzione potrà abolire quell’ infelicità, risolvere i veri problemi dell’uomo che invece trovano radice nel profondo del suo animo […] Infine la rivoluzione è una compensazione dello stesso tipo; è l’ambizione ad un’altra condizione sociale per se stessi o per i propri figli, l’ambizione trasferita nel collettivo, la folle ambizione dell’ascensione di tutti i lavoratori al di sopra della condizione di lavoratori”.
Orwell è decisamente più pratico e concreto: «Compito dell’individuo ragionevole, quindi, non è di respingere il socialismo ma di decidersi a umanizzarlo. Una volta che il socialismo stia in un certo senso per essere, quelli che hanno capito completamente l’inganno del “progresso” si accorgeranno probabilmente di opporgli resistenza. Infatti la loro particolare funzione è di resistergli. Nel mondo delle macchine essi devono rappresentare una specie di opposizione permanente, cosa ben diversa dal fare dell’ostruzionismo o dal tradire. Ma io sto parlando del futuro. Per il momento la sola via possibile aperta a un galantuomo, per quanto anarchico o conservatore possa essere di temperamento, deve lavorare per l’edificazione del socialismo. Nessun’altra cosa può salvarci dalla miseria del presente o dall’incubo del futuro.»
Entrambe le posizioni, comunque, ci dicono che tra le altre esperienze i due condividono anche il rapporto conflittuale con la sinistra “ortodossa”. Simone Weil non entra mai nei quadri di partito, ma si impegna fortemente nel lavoro sindacale, nella stampa, nell’organizzazione di manifestazioni antifasciste. Arriva ad ospitare in casa propria Trotszkij, col quale litiga immediatamente, e denuncia la politica staliniana già nei primi anni Trenta. Potrebbe riconoscersi perfettamente in questa considerazione di Orwell: “Il potere non è un mezzo, è un fine. Non si stabilisce una dittatura nell’intento di salvaguardare una rivoluzione; ma si fa una rivoluzione nell’intento di stabilire una dittatura. Il fine della persecuzione è la persecuzione. Il fine della tortura è la tortura. Il fine del potere è il potere.”
Naturalmente anche la posizione ereticale che parrebbe unirli viene vissuta in maniera differente. Quella della Weil si libra alla fine in una mistica della libertà: “La libertà è una condizione politica ma deve essere inquadrata all’interno di una visione etica: non basta essere liberi, bisogna diventare liberi, cioè bisogna sapere come spendere la propria libertà”, dove l’altro corno della concezione socialista, la giustizia, sembra avere un rilievo molto minore. Quella di Orwell si mantiene invece terra terra, a difesa di un valore etico per lui altrettanto importante e niente affatto disgiunto dalla “libertà”: quella che lui chiamava la “decenza”: «Sarebbe un grandissimo vantaggio se quel continuo, insignificante e meccanico punzecchiare i borghesi, che fa parte di quasi tutta la propaganda socialista, fosse abbandonato per il momento. In tutto il pensiero e gli scritti di sinistra – dagli articoli di fondo del “Daily Worker” alle colonne umoristiche del “New Chronicle” – si perpetua una tradizione anti-cortesia, uno schernire persistente e spesso molto stupido le buone maniere e gli ideali dei ceti evoluti (o, per, usare il gergo comunista, i “valori borghesi”). È in gran parte una impostura, venendo come viene da punzecchiatori della borghesia che sono essi medesimi borghesi, ma fa gran danno, perché lascia che un problema minore ne ostacoli uno maggiore. Storna l’attenzione dal fatto centrale che la povertà è povertà, tanto se il tuo strumento di lavoro è un piccone quanto se è una penna stilografica. Tutto quello che occorre è martellare e ribadire bene nella coscienza pubblica due fatti. Uno, che gli interessi di tutti gli sfruttati sono gli stessi; l’altro che il socialismo e il comune decoro possono andare perfettamente d’accordo».
***
7. Con Simone Weil (e con molti altri) Orwell ha infine in comune la partecipazione attiva alla guerra civile spagnola, un’esperienza che per una larghissima parte degli intellettuali formatisi tra le due guerre ha rappresentato un momento di svolta, più ancora del secondo conflitto mondiale.
Il resoconto del suo contributo alla lotta al fascismo si trova in Omaggio alla Catalogna, che ho letto quando già frequentavo l’università. Al liceo naturalmente nessuno mi aveva mai parlato della guerra di Spagna: alla fine del ciclo si approdava si e no alla prima guerra mondiale, e anche i libri di testo vi accennavano appena. Nemmeno era mai stato oggetto di conversazione in famiglia, perché credo che i miei ne sapessero ben poco, o avevo avuto occasione di imbattermi in qualche opera storica sull’ argomento, visto che in Ovada non c’era una biblioteca pubblica. In definitiva tutto ciò che conoscevo di questa vicenda veniva da notizie scarse e contraddittorie raccolte su qualche rivista.
Ad accendere l’interesse era stata però la letteratura, quella frequentata fuori dalle mura scolastiche: l’Hemingway di Per chi suona la campana e il Malraux de La speranza. Di lì a I grandi cimiteri sotto la luna di Bernanos, e finalmente ad Omaggio alla Catalogna, il passaggio era obbligato.
Prima di arrivare a quest’ultimo già sapevo che Orwell aveva militato nelle file del POUM (ma non avevo idea di cosa precisamente fosse il Partido Obrero de Unificaciòn Marxista: d’altro canto, al momento della sua adesione neppure Orwell lo sapeva), che aveva combattuto sul fronte aragonese e che era stato gravemente ferito. Mi intrigava però soprattutto ciò di cui avevo avuto solo sentore, e che sembrava totalmente rimosso dalla memoria ufficiale: le epurazioni degli anarchici e dei trotskisti per mano degli emissari di Mosca (leggi: Togliatti), la sconfortata presa di coscienza degli intellettuali e dei militanti accorsi ad arruolarsi nella Brigata internazionale, l’ambiguità degli atteggiamenti delle potenze “democratiche”. Ho letto quindi la prima volta Omaggio alla Catalogna pieno di aspettative, e queste non sono andate deluse. Ciò che Orwell raccontava costituiva davvero una rivelazione, e ha contribuito in maniera determinante, in un momento di grande confusione (collettiva), a indirizzare le mie scelte di “posizionamento”.

In Perché scrivo, che fa parte della raccolta che ho tra le mani, Orwell spiega cosa ha ispirato la sua attività di saggista: “La Guerra civile spagnola e altri avvenimenti del 1936-37 hanno contribuito a farmi prendere una decisione, e da allora ho capito da che parte stavo. Ogni riga del lavoro serio che ho prodotto dal 1936 l’ho scritta, direttamente o indirettamente, contro il totalitarismo e per il socialismo democratico così come lo intendo io”.
Omaggio alla Catalogna racconta appunto il prima e il dopo di questa decisione. Alla fine del 1936 Orwell arriva in Spagna, nel pieno della guerra civile, nutrito ancora di sogni di rivoluzione e di immagini romantiche della Spagna e degli spagnoli, e accompagnato dalla moglie. Vuole raccontare quello che accade, essere un testimone. Ma si rende conto subito di non poter rimanere neutrale, e diventa protagonista. Si arruola nelle milizie del POUM, non per una scelta meditata ma perché è la prima caserma che trova, e perché ritiene che combattere con l’una o con l’altra formazione non faccia differenza, davanti ad un nemico comune. «Credevo fosse un’idiozia che gente che combatteva per salvarsi la vita dovesse appartenere a partiti diversi; il mio atteggiamento era sempre del tipo: “Perché non la smettiamo con queste sciocchezze politiche e ci concentriamo sulla guerra?”. Naturalmente questo era il corretto atteggiamento “antifascista” che era stato accuratamente diffuso dai giornali inglesi, in gran parte al fine di impedire che la gente comprendesse la vera natura del conflitto. Ma in Spagna, specialmente in Catalogna, era un atteggiamento che non si poteva mantenere a tempo indeterminato e infatti nessuno lo mantenne. Pur se a malincuore, tutti prima o poi si schieravano da una parte o dall’altra».

Va al fronte, è ferito, dopo un paio di settimane torna a combattere, e quando a maggio del 1937 rientra a Barcellona per un normale avvicendamento si rende conto che è in atto una guerra interna allo stesso schieramento repubblicano in cui milita, anzi, una vera e propria epurazione nei confronti degli anarchici e dei trotskisti, nella quale è direttamente coinvolto. Anche lui è nella lista degli accusati di “tradimento”. A differenza di molti altri (Camillo Berneri, ad esempio, è “giustiziato” per strada in quegli stessi giorni) riesce a scappare per il rotto della cuffia. Appena in tempo per rientrare in Inghilterra e raccontare ciò che ha visto.
Il reportage che scrive a caldo (uscirà nell’ottobre dello stesso anno) si suddivide anch’esso, come Wigan Pier, in due parti. La prima è il resoconto puro e semplice dei fatti bellici, nel quale non nasconde nulla, e va dall’entusiasmo immediato che respira appena giunto a Barcellona («Camerieri e commessi ti guardavano negli occhi e ti trattavano da pari a pari. Le formule d’indirizzo servili o addirittura cerimoniose erano per il momento scomparse. Nessuno più diceva “Señor” o “Don” e neanche “Usted”; tutti si chiamavano “Compagni” e si davano del tu, si salutavano con “Salud!” invece che con “Buenos días” […] si vedevano pochissime persone visibilmente povere e nessun mendicante, tranne gli zingari. Soprattutto c’era fede nella rivoluzione e nel futuro, la sensazione di trovarsi improvvisamente in un’epoca di eguaglianza e di libertà. Gli esseri umani stavano cercando di comportarsi come tali e non come ingranaggi nella macchina capitalista […]») all’insofferenza per l’impreparazione e la disorganizzazione totale che regna nelle fila repubblicane; non parla di atti di eroismo, ma della noia e dei disagi della guerra di posizione (freddo, soprattutto, e poi sporcizia, piattole, indisciplina, ecc…). Nella seconda, che viene sviluppata come una lunga appendice, fa invece un’analisi delle vicende politiche, delle menzogne, degli intrighi internazionali che hanno portato alla disfatta. Orwell vuole raccontare con voce onesta, in base a ciò che visto, i risvolti meno nobili della tragedia spagnola. Partendo dal denunciare che: “Uno degli effetti più terribili di questa guerra è stato apprendere che la stampa di sinistra è falsa e disonesta quanto quella di destra”.

La motivazione che Orwell dà del suo impegno è chiara, perfettamente in linea con i suoi libri precedenti: «Quando i combattimenti iniziarono il 18 luglio è probabile che ogni antifascista in Europa abbia provato un brivido di speranza. Perché, almeno in apparenza, ecco finalmente una democrazia che resisteva al fascismo. Per anni, in passato, le cosiddette nazioni democratiche avevano ceduto al fascismo a ogni piè sospinto […] e si limitavano a elevare pie proteste “fuori scena”. Ma quando Franco aveva tentato di rovesciare un governo moderatamente di sinistra, il popolo spagnolo, contro le aspettative di tutti, gli si era rivoltato contro».
Lo è anche la disposizione positiva che lo sorreggerà nel primo periodo: l’impressione di combattere a fianco di uomini finalmente all’altezza degli ideali che professano. “Nella caserma Lenin di Barcellona, il giorno prima di arruolarmi nella milizia, ho visto un volontario italiano in piedi davanti al tavolo degli ufficiali. Era un giovanottone dall’aspetto rude di venticinque-ventisei anni, dai capelli biondo-rossicci e un gran paio di spalle. Portava il berretto di cuoio con la visiera minacciosamente inclinato su un occhio. Era di profilo rispetto a me, con il mento sul petto, e scrutava con aria perplessa una cartina che uno degli ufficiali aveva aperto sul tavolo. C’era qualcosa nella sua espressione che mi commosse profondamente. Era l’espressione di un uomo che per un amico avrebbe ammazzato qualcuno e sacrificato la propria vita – l’espressione che ci si sarebbe aspettati di vedere sul volto di un anarchico, anche se con ogni probabilità lui era comunista. C’era un misto di candore e di ferocia in essa, ma anche la patetica riverenza che gli analfabeti mostrano per quelli che ritengono essere i loro superiori. Era chiaro che della cartina non capiva un accidente; che riteneva la capacità di leggere una carta topografica un’impresa intellettuale stupefacente. Non so bene perché, ma mi è capitato raramente di vedere una persona – voglio dire un uomo – che mi abbia ispirato una simpatia così immediata”.
Questa impressione non è destinata a ripetersi. Le differenti motivazioni non tardano a venire a galla, e a creare lo strappo. Tutta la vicenda, alla fine, potrebbe essere riassunta nelle poche righe che descrivono il suo sconcerto al rientro a Barcellona: «C’era lo sconvolgente mutamento nell’ atmosfera sociale – un fenomeno inconcepibile se non lo si è provato di persona. Appena arrivato a Barcellona l’avevo considerata una città in cui quasi non esistevano distinzioni di classe e grandi dislivelli di ricchezza. E senza dubbio l’apparenza era quella. I vestiti “eleganti” erano un’anomalia, nessuno era servile o accettava mance, camerieri, fioraie e lustrascarpe non abbassavano lo sguardo e davano del “compagno” a tutti. Quello che non avevo capito era che tutto questo era un misto di speranza e di mimetizzazione. La classe operaia credeva veramente in una rivoluzione che era iniziata, ma non si era ancora consolidata, mentre i borghesi si erano spaventati e si erano per il momento travestiti da lavoratori. Nei primi mesi della rivoluzione dovevano esserci state molte migliaia di persone che avevano indossato le tute e gridato slogan rivoluzionari solo per salvarsi la pelle. Ora le cose stavano tornando alla normalità».
Lo spettacolo della rivoluzione spontanea è finito. Il finale lo detta una regia remota. Gli attori, quelli stabili e quelli che si sono improvvisati o sentiti per un breve atto protagonisti, le comparse e il coro, dismettono l’abito di scena e tornano ciascuno al ruolo quotidiano. Almeno, quelli sopravvissuti.
«Era strano notare quanto le cose fossero cambiate. Solo sei mesi prima, quando gli anarchici dominavano ancora, si era rispettabili se si aveva l’aspetto di un proletario. Mentre scendevo da Perpignan a Cerbères un commesso viaggiatore francese nel mio scompartimento mi aveva detto tutto serio: “Non deve andare in Spagna con quell’aspetto. Si tolga il colletto e la cravatta. Altrimenti a Barcellona glieli strapperanno di dosso”. Esagerava, ma il suo atteggiamento dimostrava in che considerazione era tenuta la Catalogna. E alla frontiera le guardie anarchiche avevano respinto un francese elegante e sua moglie soltanto perché – secondo me – avevano un aspetto troppo borghese. Adesso era tutto il contrario; assumere un aspetto borghese era l’unica salvezza.»
***
8. Dopo quella di Orwell ho letto innumerevoli altre testimonianze dirette sulla guerra di Spagna, e ho notato un effetto particolare: a differenza dei testimoni della Resistenza, che al di là dei ruoli, delle opinioni, delle singole vicissitudini, raccontano tutti una vicenda che nei grandi tratti è comune, i reduci dalla guerra civile spagnola narrano la stessa storia con sguardi talmente diversi da renderla quasi irriconoscibile. Ciò vale soprattutto per i testimoni stranieri, naturalmente per gli intellettuali, e segnatamente per coloro che hanno combattuto nello schieramento repubblicano[2]. E si spiega col fatto che ognuno di loro portava con sé in Spagna una sua individualissima e particolare motivazione.
In linea di massima la guerra civile spagnola offriva a tutti la possibilità, o se vogliamo, l’illusione, di sottrarsi all’inerzia: di tornare protagonisti attivi in una storia che sembrava invece scorrere sempre più per conto proprio, indifferente alle individualità, agli ideali, ai sogni dei singoli, e che non forniva più stimoli all’azione. Finalmente c’era un nemico ben identificabile contro il quale combattere, in uno scontro almeno sulla carta non totalmente impari, e comunque giustificato, al di là degli esiti possibili, dalla volontà di resistenza finalmente dimostrata da un popolo. “Non fu tanto l’adesione incondizionata ad una causa, quanto piuttosto un atto estremo d’individualismo, una ricerca di conferme, nell’azione, alle proprie concezioni sociali e artistiche.”
Con questi presupposti, la varietà delle percezioni individuali di quella esperienza è più che giustificata. Simone Weil, ad esempio. Ancora lei, e non c’era da dubitarne. È già a Madrid nell’agosto del 1936, a pochi giorni dallo scoppio dell’insurrezione falangista, tra i primi ad accorrere. A dispetto del suo pacifismo è convinta che quando non si può più fare nulla per evitare la guerra l’unica alternativa sia impegnarsi nella lotta. Entra anch’essa col visto da giornalista, ma si arruola immediatamente nelle formazioni anarchiche. Non può accettare di vivere la lotta nelle retrovie. Le mettono in mano un fucile, si rendono conto che potrebbe farsi solo del male e la destinano al servizio in cucina e alle mense. Riesce a farsi del male lo stesso, cacciando un piede in una pentola d’olio bollente. L’ustione è abbastanza seria, e si accompagna ai dubbi velocemente maturati sulla partecipazione alla guerra. Ai primi di settembre Simone viene riaccompagnata a Parigi dai genitori, che conoscendola bene l’avevano seguita in Spagna.
La parentesi spagnola si è rivelata per lei particolarmente deludente, tanto che non ne lascia alcun resoconto: ciò che sappiamo lo si può ricostruire solo attraverso la sua corrispondenza. Intuisce le stesse cose che Orwell vedrà pochi mesi dopo, ma che le inducono un giudizio e una reazione molto diversi. La spiegazione ufficiale che darà del suo disimpegno è che la guerra non era una rivolta dei contadini affamati contro il clero e i latifondisti, ma una questione politica internazionale dietro la quale agivano l’URSS, l’Italia e la Germania nazista. A farle considerare tutti sullo stesso piano sono anche le violenze commesse dai repubblicani, in particolare dagli anarchici, che le sembrano mossi solo da una volontà distruttiva di rivincita, e non da ideali rivoluzionari. Il risultato è che la sua temporanea infatuazione per il marxismo, già messa alla prova dal rapporto con Trotskij, è definitivamente accantonata.

Altrettanto precoce di quella della Weil è l’adesione al fronte repubblicano da parte di Nicola Chiaromonte. Esule a Parigi, in rotta con Carlo Rosselli e con Giustizia e Libertà, cui aveva inizialmente collaborato, Chiaromonte è in cerca di un ideale chiaro per il quale combattere una buona volta, uscendo dalla palude delle rivalità, dei sospetti e dei distinguo tattici e ideologici che allignano tra i fuorusciti antifascisti. L’occasione gliela offre André Malraux, col quale nel frattempo ha stretto amicizia. Malraux ha messo assieme una squadriglia aerea, raccattando gli scarti dell’aviazione militare francese, e porta con sé in Spagna un gruppo di altri esuli italiani. Come per tutti coloro che vivono questa avventura, anche per Chiaramonte il primo momento è di grande entusiasmo. Lo vive come l’occasione per dare finalmente vita, di fronte all’esigenza dell’azione, ad un fronte unico internazionale contro il fascismo. Immediatamente dopo subentra però la delusione, e anche l’irritazione, sia per la confusione che inevitabilmente si accompagna allo spontaneismo, sia perché vengono subito alla luce le manovre politiche delle diverse forze che si muovono nel campo repubblicano. Non tarda ad essere nauseato dalla strumentalizzazione operata soprattutto dai comunisti staliniani, e a novembre è già di ritorno in Francia, rompendo anche con Malraux.
Malraux invece rimane, e ci mostra anche un’altra faccia di questo variegato schieramento. Lo fa attraverso un romanzo che avrà un grande successo, La speranza, nel quale sono riconoscibilissime le varie figure storiche, dall’autore stesso, sotto le spoglie di Magnin, a Chiaromonte, ma dal quale si ricava anche lo spirito col quale ha affrontato tutta la faccenda. Malraux è un avventuriero di stampo dannunziano, determinato ad essere sempre al centro della scena, si tratti dell’Estremo Oriente, della Spagna, della Resistenza e successivamente anche del governo della Francia. Sta attraversando in quel periodo una fase di avvicinamento al comunismo, proprio mentre molti altri intellettuali se ne stanno allontanando (e alcuni di essi, come Andrè Gide, lo fanno denunciando apertamente la realtà criminale dello stalinismo, guadagnandosi il disprezzo e gli anatemi dei compagni): non è affatto un ingenuo, ma pur non potendo evitare di rendersi conto di quanto sta accadendo si forza a pensare che per fare argine contro i fascismi sia necessario anche ricorrere ai metodi staliniani. Emozionalmente sta magari dalla parte degli anarchici, ma il buon senso pratico, del quale non manca, gli dice che è necessario fare ordine nelle file dei repubblicani e ricondurre i vari gruppi militanti sotto un unico comando. Peccato che si tratti di quello stalinista, e che l’eliminazione dei dissensi interni finisca per prevalere alla fine anche sulla necessità di resistere ai fascisti. Il risultato è che il fronte libertario si sfascia, così come la squadriglia aerea, e l’azione d’ordine si rivela inutile e addirittura controproducente.

Di una pasta per molti versi simile a quella di Malraux potrebbe sembrare Arthur Koestler, ungherese di origine ma apolide praticamente da sempre. La sua vita è altrettanto avventurosa, ma non per una scelta estetizzante, quanto piuttosto per la condizione di nascita (tra le altre cose, era ebreo) e per un carattere già naturalmente molto forte e consolidato ulteriormente dalle traversie: così che completamente diversa risulta alla fine la sua esperienza. Dopo una giovinezza decisamente movimentata, nei primi anni Trenta Koestler è entrato nel partito comunista tedesco e si è spostato a Parigi in seguito all’avvento del nazismo. Di lì passa nel 1936 come giornalista in Spagna, ufficialmente per seguire gli sviluppi dell’insurrezione falangista come inviato di un’agenzia di stampa, in realtà come agente del Comintern. Finisce per tre volte oltre le linee dei falangisti, la seconda viene riconosciuto da un ex-collega tedesco e denunciato come comunista, ma la sfanga, la terza è catturato dagli uomini di Franco e viene condannato a morte. Per tre mesi attenderà notte dopo notte nel carcere di Siviglia il momento dell’esecuzione, e nel frattempo vedrà sparire ad uno ad uno i suoi compagni di detenzione. La scamperà solo per l’intervento della diplomazia britannica, che organizza uno scambio di prigionieri.
La drammatica esperienza ha comunque lasciato il segno. Esce dal braccio della morte con una consapevolezza politica estremamente lucida. Come scrive Tony Judt, “ciò probabilmente accadde perché era lontano da Parigi, dalla comunità feconda di intellettuali progressisti, isolato da un contesto in cui esistevano molte buone ragioni non tanto per fingere, ma per tacere riguardo ai propri dubbi”. Una volta tornato in Francia, dopo l’ennesimo tradimento rappresentato dal patto Molotov-Von Ribbentrop non solo abbandona il partito, ma ne denuncia i crimini, in un libro che diverrà un classico dell’antistalinismo, Buio a mezzogiorno.
Le sue vicende spagnole sono invece narrate in un’altra opera, Testamento spagnolo, che racconta nella prima parte la resistenza ormai agli sgoccioli delle città assediate, lo scoordinamento evidente nelle fila dei miliziani, le divisioni ideologiche che contrappongono le fazioni diverse, e nella seconda il tran tran di una detenzione che per essere effettuata nel carcere più moderno di Spagna, costruito pochi anni prima secondo un modello liberale, consente un trattamento quotidiano relativamente umano, contraddetto poi drammaticamente dalle angosce della notte.
Orwell scriverà che a quel tempo Koestler era ancora un membro del partito comunista, e la complessa politica della guerra civile rendeva impossibile per ogni comunista scrivere con sincerità della lotta interna al fronte governativo. Lui stesso rivela che “dopo il ritorno dalla Spagna un certo numero di persone mi ha detto con vari gradi di franchezza che non si deve dire la verità su ciò che sta accadendo in Spagna e sul ruolo svolto dal Partito Comunista, perché farlo sarebbe pregiudicare l’opinione pubblica contro il governo spagnolo e così aiutare Franco”. Non ha accettato il ricatto. Ciò è vero solo in parte, ma è comunque significativo della differenza di approccio al tema dell’antitotalitarismo che i due manterranno anche in seguito. Non è un caso, ad esempio, che una bozza di manifesto dei diritti universali dell’uomo redatta nel 1946 da Orwell sia stata rielaborata da Koestler e da Bertrand Russell in senso molto più libertario e molto meno egualitario, e alla fine sia stata sconfessata da Orwell stesso.
Una vicenda non meno avventurosa e controversa di quelle di Malraux e di Koestler vede protagonista Claude Simon. “La prima parte della mia vita è stata piuttosto movimentata: – scrive quest’ultimo nel discorso di ringraziamento per l’ attribuzione del Nobel per la letteratura – sono stato testimone di una rivoluzione, ho combattuto in condizioni particolarmente truculente, sono stato fatto prigioniero, ho conosciuto la fame, la fatica fisica fino allo sfinimento, sono evaso, mi sono gravemente ammalato e sono stato più di una volta vicino alla morte, violenta o naturale, mi sono trovato al fianco di persone di vario genere, preti e incendiari di chiese, tranquilli borghesi e anarchici, filosofi e analfabeti, ho condiviso il pane con mendicanti, infine ho viaggiato un po’ ovunque nel mondo… e tuttavia non ho ancora mai, a settantadue anni, trovato alcun senso in tutto ciò, se non che ‘se il mondo significa qualcosa, è che non significa niente’, tranne che esiste”.
La desolante conclusione di questo abstract autobiografico ci presenta un ulteriore aspetto di questa partecipazione, e lo fa dall’alto di una esperienza durata oltre due anni. La racconta attraverso un romanzo, Le palace (del 1962), scritto in forma sperimentale, secondo i dettami dell’Ecole du regard. L’autore vi appare nei panni dello “studente”, testimone silenzioso delle discussioni tra altri personaggi, tra i quali spiccano “l’americano” (Orwell) e “l’italiano” (un sicario). È un ritorno sul luogo degli avvenimenti vissuti venticinque anni prima, un margine di tempo sufficiente a incrinare le verità del mito e a mettere sotto indagine la Storia ufficiale (che cosa è accaduto veramente?, è la domanda che ricorre) fino a sancire il fallimento di tutte le utopie. Non è un punto di vista, ma la messa in discussione di ogni punto di vista. E non finisce qui.
Un altro quarto di secolo dopo Simon torna sull’argomento con un romanzo-saggio, Les georgiques, nel quale mette nel mirino proprio l’opera di Orwell. A quest’ultimo rinfaccia una doppia contraddizione: da un lato, di non essersi accontentato di riferire le proprie emozioni, e di aver tentato una spiegazione politica e razionale di avvenimenti che non erano in realtà razionalmente inquadrabili (almeno, a caldo); dall’altro di aver dato di questi avvenimenti una versione lacunosa e distorta. Non lo scrive in difesa dell’operato degli stalinisti – lui stesso era finito nelle liste di proscrizione – ma in nome di una particolare (e piuttosto confusa) idea del ruolo della letteratura. Nella sostanza non intacca affatto la credibilità di Orwell. Mette in luce al più la complessità e i pericoli di operazioni letterarie che ambiscano ad andare in direzione della conoscenza e della spiegazione del mondo. Come a dire: o si fa della letteratura o si fa del giornalismo, e gli ibridi rischiano di falsare il vero e di sporcare il bello.
Orwell dal canto suo aveva già preventivamente risposto a questa critica: «Il mio libro sulla guerra civile spagnola è senza dubbio un libro schiettamente politico, ma è per gran parte scritto con un certo distacco e un certo riguardo per la forma. In esso ho cercato con ogni mezzo di dire tutta la verità senza sopraffare i miei istinti letterari. Ma tra le altre cose esso contiene un lungo capitolo, pieno di citazioni giornalistiche e cose simili, teso a difendere i trotzkisti che furono accusati di ordire un complotto con Franco. Chiaramente un capitolo del genere, che dopo un anno o due perderebbe d’interesse per ogni comune lettore, era destinato a rovinare il libro. Un critico che stimo mi fece su questo una ramanzina. “Perché ci hai messo dentro tutta quella roba? Hai trasformato in giornalismo quello che avrebbe potuto essere un buon libro.” Quello che diceva era vero, ma non avrei potuto fare altrimenti. Mi accadde di venire a conoscenza … che degli innocenti erano stati ingiustamente accusati, per cui se non fossi stato indignato non avrei scritto il libro.»

9. Penso che alla luce della sua particolare concezione della letteratura Simon abbia invece apprezzato la testimonianza letteraria fornita da un altro militante inglese, Laurie Lee. Nel 1935, a ventun anni, Lee aveva attraversato a piedi in otto mesi tutta la Spagna, per fermarsi poi a svernare in un paesino nei pressi di Malaga. Lì lo aveva raggiunto nell’estate successiva la guerra, ed era stato rimpatriato. Ma ormai la Spagna gli era entrata nel cuore, e l’inverno successivo, alla fine del ‘37, quando quasi tutti coloro di cui ho parlato sinora erano rientrati in patria, aveva rivalicato clandestinamente i Pirenei per andare ad arruolarsi tra i repubblicani.
“Cosa ci aveva portati lì, insomma? Le mie ragioni sembravano abbastanza semplici, nonostante una certa confusione: ma erano così quelle della maggioranza degli altri: fallimenti, miseria, debiti, la legge, tradimenti di mogli o amanti, la maggior parte delle motivazioni che spingevano uno a partecipare a guerre straniere. Ma nel nostro caso, credo, condividevamo qualcos’altro, che ritenevamo unico allora: la possibilità di compiere un gesto grandioso e semplice di sacrificio e di fede personali che poteva non presentarsi mai più. Certamente era l’ultima volta nel secolo che una generazione aveva una simile opportunità, prima che si addensasse la nebbia del nazionalismo e degli stermini di massa. […] Per il momento non c’erano mezze verità o esitazioni, avevamo trovato una nuova libertà, quasi una nuova morale, e scoperto un nuovo Satana: il fascismo.”
La vicenda spagnola aveva toccato nel profondo gli animi della gioventù progressista inglese. Come testimonia Eric Hobsbawm, “Chiunque entrasse nelle stanze degli studenti socialisti e comunisti di Cambridge in quei giorni era quasi certo di trovare in esse la fotografia di John Cornford, intellettuale, poeta, leader del Partito Comunista studentesco, caduto in battaglia in Spagna nel giorno del suo ventunesimo compleanno nel dicembre 1936.”
Il racconto che della propria esperienza Lee fa in Un bel mattino d’estate e in Un momento di guerra sarebbe piaciuto a Simon, perché l’autore non tenta di darsi alcuna spiegazione di quanto gli accade, e gliene accadono davvero di ogni colore. Dopo il rientro in Spagna la metà del suo tempo la trascorre in carcere, sospettato a più riprese di essere una spia, un infiltrato, un anticomunista, e rischia costantemente di essere messo al muro. Per il resto, è sballottato lungo il fronte senza mai sapere quale sia la sua destinazione e il suo ruolo, sino a trovarsi in mezzo alla battaglia di Teruel, che vive solo come una serie di scaramucce per salvare la pelle e sganciarsi dal nemico. Credo anch’io che questo racconto sia, tra tutti quelli che ho letto, il più capace di darci una immagine della realtà di cui fu fatta quella guerra: freddo, fame e pidocchi, ma soprattutto un senso di sospetto continuo, di rivalità interne e di assoluta disorganizzazione.
Altri due connazionali di Orwell e di Lee, i poeti Wynstam Auden e Stephen Spender, interpretano ancora diversamente il loro impegno. Sono già famosi, legati a quel circolo sofisticato che i critici più severi, tra cui Orwell stesso, chiamano “la cricca di Bloomsbury”. Arrivano in Spagna poco più tardi di Orwell, ai primi del 1937, mossi da un entusiasmo piuttosto snobistico, dettato da una confusa e superficiale simpatia per il comunismo. A Auden in realtà è stato chiesto di recarsi in Spagna perché il suo nome e la sua partecipazione possono esercitare un certo richiamo propagandistico, e non ha molto chiaro che ruolo può svolgere. Ad un amico scrive: “Probabilmente sarò un maledetto cattivo soldato. Ma come posso parlare per loro senza diventarlo?” I due si arruolano per prestare servizio nella sanità, ma vengono immediatamente spostati alla propaganda. Come scriverà Spender: “Il compito di Auden era di guidare autoambulanze. Mi domando ancora come facesse, perché non sapeva guidare”. Il che la dice lunga sullo spirito col quale l’avventura era stata affrontata.
E infatti, la militanza di Auden dura sette settimane. Dopo aver visto il fronte aragonese, lo stesso sul quale combatte Orwell, scrive di aver scoperto che “una parte di me chiede di vivere disperatamente”, ma è l’altra, quella che scopre le atrocità commesse da ambo le parti e la lotta per la spartizione del potere interna allo schieramento antifascista, ad avere la meglio. Fiaccato anche da condizioni quotidiane di vita cui non è assolutamente abituato, se la fila. Di quella esperienza è rimasto nella sua opera solo un piccolo poema, Spagna, 1937, ispirato proprio dalla visita al fronte, scritto immediatamente dopo il rientro e divenuto subito famoso. Ma Auden lo toglierà pochi anni dopo dalla raccolta poetica nella quale era stato pubblicato, e non tornerà mai più sull’argomento.
Orwell giudicava Spagna 1937 una delle poche cose buone uscite dal conflitto. Ma ad Auden non faceva altre concessioni. Non aveva mai nascosto il suo disprezzo per i “poeti effeminati” (“Volete piantarla di mandarmi queste stronzate? Io non sono uno dei vostri finocchietti alla moda come Auden e Spender… Io so cosa sta succedendo, cioè che il fascismo viene imposto ai lavoratori spagnoli con il pretesto della resistenza al fascismo”, scriveva alla “Left Review”, in risposta a un questionario per intellettuali) ed era rimasto molto urtato da un verso del poema stesso, quello in cui si parla de “[…] La consapevole assunzione di colpa nell’omicidio inevitabile”, nel quale leggeva una legittimazione delle epurazioni “necessarie” operate dagli stalinisti. “Qualcuno nell’Europa dell’Est liquida un trotskista, qualcuno a Bloonsbury ne scrive la giustificazione”. Evidentemente leggeva giusto, se Auden si era poi affrettato a cambiare il verso.
 Le motivazioni che avevano portato Auden e Spender in Spagna sono espresse invece molto chiaramente dal secondo nella sua autobiografia, Un mondo nel mondo: andare a combattere dalla parte comunista in Spagna sembrava il solo modo possibile di essere antifascisti. «Il comunismo “occidentale” – scrive – in quegli anni era una cosa molto diversa. Uscivamo dal disastro del 1929, il capitalismo sembrava un sistema finito, incapace di trovare soluzioni, pareva invece che in Urss avessero la risposta, e la risposta stava in un modello economico e sociale ideale applicabile anche qui […] Eravamo consapevoli dell’abisso ma non vedevamo nuovi valori che potessero sostituire quelli che ci avevano sorretto nel passato. Nel giro di poche settimane, la Spagna divenne un simbolo di speranza per tutti gli antifascisti. Offriva un 1848 al ventesimo secolo».
Le motivazioni che avevano portato Auden e Spender in Spagna sono espresse invece molto chiaramente dal secondo nella sua autobiografia, Un mondo nel mondo: andare a combattere dalla parte comunista in Spagna sembrava il solo modo possibile di essere antifascisti. «Il comunismo “occidentale” – scrive – in quegli anni era una cosa molto diversa. Uscivamo dal disastro del 1929, il capitalismo sembrava un sistema finito, incapace di trovare soluzioni, pareva invece che in Urss avessero la risposta, e la risposta stava in un modello economico e sociale ideale applicabile anche qui […] Eravamo consapevoli dell’abisso ma non vedevamo nuovi valori che potessero sostituire quelli che ci avevano sorretto nel passato. Nel giro di poche settimane, la Spagna divenne un simbolo di speranza per tutti gli antifascisti. Offriva un 1848 al ventesimo secolo».
Spender racconta di essere stato comunista solo per poche settimane. Il suo comunismo, come quello di molti altri suoi amici che con lui andarono a combattere dalla parte comunista in Spagna – tra cui Julian Bell, il nipote di Virginia Woolf, che ci morì – esprimeva in definitiva, a suo parere, il solo modo possibile di essere antifascisti. E giustifica così quel futile entusiasmo: “Bisogna aver vissuto quegli anni per capire cosa significasse. Le cose che si dicevano su Mosca, sui processi staliniani, avrebbero potuto essere, dopo tutto, un grande macchinazione della propaganda di destra”.
Mi sembra peraltro interessante una lettera scritta da Orwell a Spender l’anno successivo il loro rientro in Inghilterra. Interessante perché testimonia della estrema schiettezza del primo, ma al tempo stesso della sua capacità di correggere i propri giudizi quando dal piano politico scende su quello umano, senza tuttavia rinnegare nessuna delle proprie convinzioni. «“Mi chiedi come mai ti abbia attaccato nonostante non ti avessi mai incontrato, e d’altro canto abbia cambiato idea dopo averti incontrato. Non so se si può dire che ti abbia attaccato, ma ho certamente fatto osservazioni offensive sui “chiacchieroni Bolscevichi come Auden e Spender” o qualcosa di simile. Ti ho usato come simbolo del parlatorio Bolshie perché a) il tuo verso, ciò che ho letto di esso, non vuol dire molto per me, b) ti ho preso per una specie di uomo alla moda, di successo, un Comunista o un simpatizzante Comunista, e sono stato piuttosto ostile al Partito Comunista dal 1935, e c) perché non avendoti incontrato ti consideravo un tipo e dunque un’astrazione. Anche se quando ti ho incontrato non è capitato che ti piacessi, avrei dovuto comunque cambiare atteggiamento, perché quando incontri una creatura di carne ti rendi immediatamente conto che è un essere umano e non una specie di caricatura che incarna alcune idee. Anche per questa ragione non frequento i circoli letterati, perché so per esperienza che una volta incontrato e parlato con qualcuno non sarò più in grado di mostrare alcuna brutalità intellettuale nei suoi confronti, anche quando mi sentirei in dovere di farlo, come quelli del Labour Party, che più vengono pigliati a bastonate dai duchi e più si perdono.»
Non tutti i letterati inglesi hanno però militato nelle file dei repubblicani. Occorre ricordarlo, e non solo per par condicio. Quando scoppia la guerra civile il poeta Roy Campbell si trova già da diversi anni in Spagna. È un personaggio complesso, originario del Sudafrica, dove ha imparato a parlare la lingua zulu e dove sarà sempre poco tollerato per le sue posizioni anti apartheid e per la denuncia delle nefandezze del colonialismo: si era trasferito molto presto in Inghilterra, suscitando entusiasmo per le sue doti poetiche ma attirandosi anche molte antipatie per le critiche sarcastiche rivolte ai circoli “progressisti”, soprattutto al gruppo di Bloomsbury, che non sopporta (definisce Auden e Spender “fanciulli effeminati che suonano il piffero e si scuotono, annoiati” e “intellettuali ma senza intelletto / gente senza un sesso i cui sessi si trovano a metà”; con Spender fa anche a cazzotti). Aveva poi lasciato l’isola per trasferirsi sul continente, come moltissimi altri inglesi, per ragioni economiche. Condivide comunque con Orwell molte idiosincrasie nei confronti dell’establishment culturale.
 In un primo momento Campbell non prende posizione, ma si è da poco convertito al cattolicesimo e le sue simpatie non vanno certo agli anarchici e ai comunisti. Tanto più dopo che assiste all’incendio delle chiese di Toledo, ai roghi di libri e di immagini sacre e alle fucilazioni di frati e suore. A questo punto si arruola nelle truppe carliste (ufficialmente come corrispondente di guerra), e in queste continuo militare sino alla fine del conflitto. Come Auden, non racconta direttamente la sua esperienza, ma la traduce in una serie di poesie, alcune delle quali molto efficaci “I nostri fucili erano troppo caldi per tenerli / La notte era fatta di acciaio lacerante, / E lungo la strada le raffiche rotolarono / Dove come in preghiera i cecchini si inginocchiano.” Nel ‘39, al termine del conflitto, scrive il poema Fucile Fiorente, e questo gli vale la patente definitiva di filo-fascista. In effetti è un’ode a Franco, ma Campbell protesterà sempre di credere non solo nella famiglia e nella religione, ma soprattutto nella tolleranza.
In un primo momento Campbell non prende posizione, ma si è da poco convertito al cattolicesimo e le sue simpatie non vanno certo agli anarchici e ai comunisti. Tanto più dopo che assiste all’incendio delle chiese di Toledo, ai roghi di libri e di immagini sacre e alle fucilazioni di frati e suore. A questo punto si arruola nelle truppe carliste (ufficialmente come corrispondente di guerra), e in queste continuo militare sino alla fine del conflitto. Come Auden, non racconta direttamente la sua esperienza, ma la traduce in una serie di poesie, alcune delle quali molto efficaci “I nostri fucili erano troppo caldi per tenerli / La notte era fatta di acciaio lacerante, / E lungo la strada le raffiche rotolarono / Dove come in preghiera i cecchini si inginocchiano.” Nel ‘39, al termine del conflitto, scrive il poema Fucile Fiorente, e questo gli vale la patente definitiva di filo-fascista. In effetti è un’ode a Franco, ma Campbell protesterà sempre di credere non solo nella famiglia e nella religione, ma soprattutto nella tolleranza.
La guerra diventa nella sua poesia lo scenario di una battaglia superiore, apocalittica, tra le forze del bene e quelle del male, tra lo spirito e la materia, tra dio e il nulla, e il poeta si fa testimone delle persecuzioni contro il cristianesimo, i suoi luoghi di culto, i suoi fedeli. “Più persone sono state imprigionate per la Libertà, umiliate e torturate per l’Uguaglianza e massacrate per la Fraternità in questo secolo, che per motivi meno ipocriti, durante il Medioevo.”
A differenza di Auden, che allo scoppio del secondo conflitto mondiale si rifugia in America e si trincera dietro un opportuno e apolitico pacifismo, Campbell si arruola, viene accolto tra i fucilieri reali a dispetto dell’età e di condizioni fisiche precarie e viene inviato nell’Africa orientale britannica, dove si rivela prezioso per le sue conoscenze linguistiche. Non fa tutto questo per riscattarsi, non rinnega nulla della sua esperienza precedente, anche se rispetto al regime di Franco ha cambiato idea (e infatti, ha lasciato la Spagna per trasferirsi in Portogallo, considerato meno fascista).
Mi sembra strano non aver trovato nei saggi e negli articoli di Orwell alcuna menzione di questo personaggio, che pure godeva nell’ambiente letterario di una certa notorietà. Immagino però che non avesse molto da dire in proposito: in fondo Campbell si era schierato e aveva coerentemente combattuto sino alla fine per la parte scelta. Politicamente era stato un avversario, ma non lo aveva combattuto standogli alle spalle, ed eticamente meritava rispetto. O almeno, il silenzio.
Insomma, mi rendo conto che Orwell a questo punto sembra essere diventato solo un pretesto per parlare d’altri. Ma non è così. Credo che il confronto tra le sue esperienze e quelle di chi ne ha vissute di analoghe, o meglio, tra i resoconti che di quelle esperienze sono state date, possa riuscire illuminante per comprendere gli aspetti più particolari della sua mentalità e della sua personalità. Ciò spiega anche perché dalla carrellata sui partecipanti alla guerra di Spagna abbia escluso gli italiani, con l’eccezione di Chiaromonte. Non perché le esperienze di questi ultimi risultino meno significative, ma perché in quel periodo gli italiani, proprio per la loro condizione di esuli che il fascismo lo conoscevano bene, e da anni, avevano una consapevolezza politica diversa. Erano in sostanza molto più “politicizzati” degli altri, e arrivavano da un dibattito ormai più che decennale. Per nessuno di loro la partecipazione fu un’avventura: era in gioco qualcosa di molto più ampio della semplice realizzazione individuale. Non è un caso che una presenza così massiccia non abbia poi prodotto opere particolarmente significative sul piano della memorialista personale, ma solo resoconti di interpretazione o di giustificazione politica.
Lo spirito di quella partecipazione, almeno quello di chi accorse a combattere nelle file repubblicane, era comunque perfettamente espresso nelle famose parole di Aldo Rosselli: “È con questa speranza segreta che siamo accorsi in Ispagna. Oggi qui, domani in Italia. Ogni sforzo sembra vano contro la massiccia armata dittatoriale. Ma noi non perdiamo la fede. Sappiamo che le dittature passano e che i popoli restano. L’esperienza in corso in Ispagna è di straordinario interesse per tutti. Qui, non dittatura, non economia da caserma, non rinnegamento dei valori culturali dell’Occidente, ma conciliazione delle più ardite riforme sociali con la libertà. Non un solo partito che, pretendendosi infallibile, sequestra la rivoluzione su un programma concreto e realista: anarchici, comunisti, socialisti, repubblicani collaborano alla direzione della cosa pubblica, al fronte, nella vita sociale. Quale insegnamento per noi italiani!”
Lo spirito non era poi in fondo così diverso da quello che animava Orwell. Molto diverso fu invece l’insegnamento che da quella vicenda gli arrivò.
Una bibliografia provvisoria
George Orwell, Un’autobiografia involontaria, Rizzoli, 2021
George Orwell, Nel ventre della balena, Rizzoli, 2013
George Orwell, Giorni in Birmania, Rizzoli, 2013
George Orwell, Senza un soldo a Parigi e a Londra, Mondadori, 1966
George Orwell, La strada di Wigan Pier, Mondadori, 1960
George Orwell, La fattoria degli animali, Rizzoli, 2013
George Orwell, Omaggio alla Catalogna, Mondadori, 1948
George Orwell, 1984, Rizzoli, 2013
George Orwell, Romanzi e saggi, Mondadori, Meridiani, 2000
George Orwell, Una boccata d’aria, Mondadori, 1966
George Orwell, Fiorirà l’aspidistra, Mondadori, 1960, 2006
George Orwell, Diari di guerra, Mondadori, 2007
AA VV, Orwell e i maiali della libertà, Bevivino editore, 2004
Bernard Crick, George Orwell, Il Mulino, 1991
Christopher Hitchens, La vittoria di Orwell, Scheiwiller, 2008
Filippo La Porta, Maestri irregolari, Bollati Boringhieri, 2007
Ruyard Kipling, Kim, Adelphi, 2000
Ruyard Kipling, Racconti del mistero e dell’orrore, Bompiani, 1990
Ruyard Kipling, Tutte le opere, Mursia, 1964 (4 voll.)
Ruyard Kipling, Qualcosa di me, Einaudi, 1987
Jack London, Il popolo dell’abisso, Mondadori, 2018
George Gissing, Sulla riva dello Ionio. Cappelli, 1957
George Gissing, Il giornale intimo di Henry Ryecroft, Paoline, 1962
Simone Weil, La condizione operaia, Edizioni di Comunità, 1952
Simone Weil, La prima radice. Edizioni di Comunità, 1954
Simone Weil, Sulla guerra. Scritti 1933-1943, Pratiche, 1998
André Malraux, La speranza, Bompiani 1986
Nicola Chiaromonte, Il tempo della malafede e altri scritti, Edizioni dell’Asino, 2013
Nicola Chiaromonte, Scritti politici e civili, Bompiani, 1976
Arthur Koestler, Dialogo con la morte, Il Mulino, 1993
Claude Simon, Le Georgiche, Lavieri edizioni, 2012
Claude Simon, Le Palace, Éditions de Minuit, 1962
Laurie Lee, Un momento di guerra, L’Ippocampo, 2007
Laurie Lee, Un bel mattino d’estate, L’Ippocampo, 2008
Wystan Auden, Un altro tempo, Adelphi, 1997
Stephen Spender, Un mondo nel mondo, Barbès, 2009
Roy Campbell, Flowering Rifle, A poem from the battlefield of Spain, Longmans & Company, 1939
Utili e interessanti:
Aldo Garosci, Gli intellettuali e la guerra di Spagna, Einaudi,1959
Sara Polverini, Letteratura e memoria bellica nella Spagna del xx secolo, Firenze University Press, 2013
(Fine della prima parte)
[1] “A viva voce”, in Racconti del mistero e dell’orrore, Bompiani 1990
[2] La cifra più attendibile per la forza del corpo di volontari stranieri che combatterono per la Repubblica è di circa 35.000. Hugh Thomas, il principale storico della guerra, parla di 40.000.




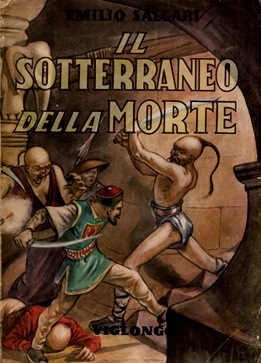

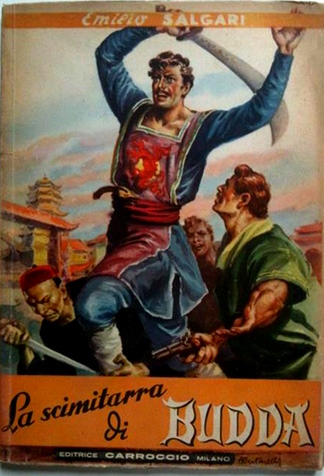





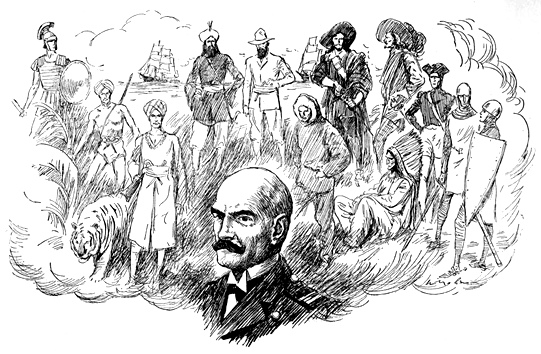



 Gli inglesi invece scrivono Kim e Alice nel paese delle meraviglie, che puoi leggere con eguale soddisfazione a dieci o a sessant’anni, o le storie dei cavalieri della Tavola Rotonda, o le avventure di Robinson Crusoe e di Oliver Twist. Sono libri che non ti senti in dovere di nascondere, appena accedi alla letteratura adulta, come accade invece con Salgari, perché non sono bollati come appartenenti a generi “minori” o marginali. Fanno parte integrante della letteratura di quel paese, ti accompagnano nella tua maturazione lungo un percorso ininterrotto sui sentieri della fantasia. Nelle scuole inglesi degli anni Cinquanta e sessanta i miei coetanei leggevano Kipling, Conan Doyle, Stevenson: a me, se mi trovavano sotto il banco un romanzo di Scerbanenco, mi cacciavano dalla scuola.
Gli inglesi invece scrivono Kim e Alice nel paese delle meraviglie, che puoi leggere con eguale soddisfazione a dieci o a sessant’anni, o le storie dei cavalieri della Tavola Rotonda, o le avventure di Robinson Crusoe e di Oliver Twist. Sono libri che non ti senti in dovere di nascondere, appena accedi alla letteratura adulta, come accade invece con Salgari, perché non sono bollati come appartenenti a generi “minori” o marginali. Fanno parte integrante della letteratura di quel paese, ti accompagnano nella tua maturazione lungo un percorso ininterrotto sui sentieri della fantasia. Nelle scuole inglesi degli anni Cinquanta e sessanta i miei coetanei leggevano Kipling, Conan Doyle, Stevenson: a me, se mi trovavano sotto il banco un romanzo di Scerbanenco, mi cacciavano dalla scuola.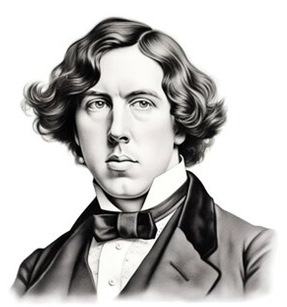 Nei confronti della letteratura inglese non c’è stata quindi una vera e propria “scoperta”, ma un passaggio graduale e conseguente. Forse potrei far coincidere l’ingresso nella fase totalmente “adulta” del rapporto con la lettura de Il ritratto di Dorian Grey, che mi ha preso a dispetto dell’inconsistenza della storia, per puro innamoramento dello stile e dell’arte del paradosso. Non so quanto abbia retto il romanzo a questi ultimi quarant’anni: ogni tanto c’è qualche studente che me lo chiede, forse perché intrigato dalla fama di libro un po’ “scandaloso”, ma quando lo riportano non vedo brillare nei loro occhi nessuna scintilla di entusiasmo. Io ormai non lo ricordo nemmeno più, ma ricordo che lo snobismo di Wilde, il suo culto dello stile, una qualche impressione deve avermela fatta, se mi ha spinto a leggere poi con gusto anche tutto il suo teatro, nonché i saggi (tra i quali è godibilissimo, e quanto mai attuale, La decadenza della menzogna).
Nei confronti della letteratura inglese non c’è stata quindi una vera e propria “scoperta”, ma un passaggio graduale e conseguente. Forse potrei far coincidere l’ingresso nella fase totalmente “adulta” del rapporto con la lettura de Il ritratto di Dorian Grey, che mi ha preso a dispetto dell’inconsistenza della storia, per puro innamoramento dello stile e dell’arte del paradosso. Non so quanto abbia retto il romanzo a questi ultimi quarant’anni: ogni tanto c’è qualche studente che me lo chiede, forse perché intrigato dalla fama di libro un po’ “scandaloso”, ma quando lo riportano non vedo brillare nei loro occhi nessuna scintilla di entusiasmo. Io ormai non lo ricordo nemmeno più, ma ricordo che lo snobismo di Wilde, il suo culto dello stile, una qualche impressione deve avermela fatta, se mi ha spinto a leggere poi con gusto anche tutto il suo teatro, nonché i saggi (tra i quali è godibilissimo, e quanto mai attuale, La decadenza della menzogna). Naturalmente, le donne. Ci stavo arrivando. Nella letteratura inglese non si può prescindere dalla scrittura al femminile, nemmeno io ho il coraggio di farlo. Sono passato per la Mary Shelley, per le Bronte, per Jane Austen, per la Barrett, su su fino ad arrivare alla Mansfield e a Virginia Woolf (e poi basta, però. Le voci femminili importanti sembrano fermarsi agli anni Venti. Deve essere accaduto qualcosa alle donne inglesi). Beh, queste devi leggertele tutte, non si scappa. Magari scegliendo, Senso e sensibilità ad esempio, o Jane Eire, se vuoi farti un’idea. E per entrare in argomento puoi iniziare con Flush, della Woolf, e proseguire subito dopo con Una stanza tutta per me, che della scrittura al femminile è un po’ il manifesto.
Naturalmente, le donne. Ci stavo arrivando. Nella letteratura inglese non si può prescindere dalla scrittura al femminile, nemmeno io ho il coraggio di farlo. Sono passato per la Mary Shelley, per le Bronte, per Jane Austen, per la Barrett, su su fino ad arrivare alla Mansfield e a Virginia Woolf (e poi basta, però. Le voci femminili importanti sembrano fermarsi agli anni Venti. Deve essere accaduto qualcosa alle donne inglesi). Beh, queste devi leggertele tutte, non si scappa. Magari scegliendo, Senso e sensibilità ad esempio, o Jane Eire, se vuoi farti un’idea. E per entrare in argomento puoi iniziare con Flush, della Woolf, e proseguire subito dopo con Una stanza tutta per me, che della scrittura al femminile è un po’ il manifesto. Auden ha combattuto in Spagna, al tempo della guerra civile, nelle Brigate Internazionali. C’era anche Orwell in quelle brigate, come militante anarchico, mentre Auden era comunista. Orwell è famoso per La fattoria degli animali, che puoi leggere anche subito, e per 1984, che ti consiglio di affrontare più in là. Ma qui ci sono anche i suoi saggi, Sul leggere, Sullo scrivere, Sul chiedere e sul non chiedere, Sul vivere e sul morire, raccolti sotto il titolo Nel ventre della balena. In realtà non sono veri e propri saggi, sono raccontini autobiografici di fattura squisita e di eccezionale sostanza etica, come l’autore, del resto.
Auden ha combattuto in Spagna, al tempo della guerra civile, nelle Brigate Internazionali. C’era anche Orwell in quelle brigate, come militante anarchico, mentre Auden era comunista. Orwell è famoso per La fattoria degli animali, che puoi leggere anche subito, e per 1984, che ti consiglio di affrontare più in là. Ma qui ci sono anche i suoi saggi, Sul leggere, Sullo scrivere, Sul chiedere e sul non chiedere, Sul vivere e sul morire, raccolti sotto il titolo Nel ventre della balena. In realtà non sono veri e propri saggi, sono raccontini autobiografici di fattura squisita e di eccezionale sostanza etica, come l’autore, del resto. Un’eccezione però riesco a farla. Per Chatwin. Come uomo Chatwin doveva essere di un’antipatia unica, l’ultima persona che vorresti avere come compagno di viaggio. Ho dovuto interrompere la lettura di una sua biografia (tra l’altro, scritta da un certo Nicholas Shakespeare) per eccesso di avvilimento. Ma come scrittore, di viaggio e non, è superbo. Utz e Sulle colline nere sono due gioiellini, il secondo non sfigura accanto ai libri di Thomas Hardy. È possibile che io non sia granché obiettivo nel giudizio, ma in senso favorevole all’autore, perché c’è di mezzo anche un mio diritto di prelazione: credo di essere stato uno tra i primissimi a leggere in Italia il libro che lo ha reso famoso, In Patagonia, subito dopo l’editore e i correttori di bozze, e per qualche mese ne ho tenuto l’esclusiva. E sai quanto godo di queste cose!
Un’eccezione però riesco a farla. Per Chatwin. Come uomo Chatwin doveva essere di un’antipatia unica, l’ultima persona che vorresti avere come compagno di viaggio. Ho dovuto interrompere la lettura di una sua biografia (tra l’altro, scritta da un certo Nicholas Shakespeare) per eccesso di avvilimento. Ma come scrittore, di viaggio e non, è superbo. Utz e Sulle colline nere sono due gioiellini, il secondo non sfigura accanto ai libri di Thomas Hardy. È possibile che io non sia granché obiettivo nel giudizio, ma in senso favorevole all’autore, perché c’è di mezzo anche un mio diritto di prelazione: credo di essere stato uno tra i primissimi a leggere in Italia il libro che lo ha reso famoso, In Patagonia, subito dopo l’editore e i correttori di bozze, e per qualche mese ne ho tenuto l’esclusiva. E sai quanto godo di queste cose! Tra l’altro, sempre a proposito di coerenza, nello scaffale opposto, dove arriveremo più tardi, c’è un librone di Humprey Carpenter, Gli Inklings. È una sorta di biografia collettiva di un gruppo di amici, tra i quali lo stesso Tolkien, C. S. Lewis, Charles Williams, tutti docenti ad Oxford negli anni Venti e Trenta, raccolti in circolo informale sotto il nome appunto di Inklings, che invece di cacciarsi le dita negli occhi a vicenda come in genere avviene nell’ambiente universitario si trovavano tutti i giovedì sera per discutere, leggere ciò che avevano scritto in settimana, farsi qualche bicchiere di Porto o di scotch. Quando uno di loro doveva tenere qualche conferenza nelle città vicine era una festa collettiva: partivano a piedi nel weekend, arrivavano a farsi anche cento chilometri, con frequentissime soste nelle osterie sul cammino, tornavano alla stessa maniera e riprendevano il loro lavoro accademico. Dove sta la coerenza? Nell’amicizia Elisa, nella capacità di non sacrificare l’amicizia alla loro professione o alla loro vocazione di scrittori. Non sapevo nulla di tutto questo quando ho letto Il signore degli anelli, ma non potevo fare a meno di accorgermi che chi scriveva conosceva davvero il valore dell’amicizia.
Tra l’altro, sempre a proposito di coerenza, nello scaffale opposto, dove arriveremo più tardi, c’è un librone di Humprey Carpenter, Gli Inklings. È una sorta di biografia collettiva di un gruppo di amici, tra i quali lo stesso Tolkien, C. S. Lewis, Charles Williams, tutti docenti ad Oxford negli anni Venti e Trenta, raccolti in circolo informale sotto il nome appunto di Inklings, che invece di cacciarsi le dita negli occhi a vicenda come in genere avviene nell’ambiente universitario si trovavano tutti i giovedì sera per discutere, leggere ciò che avevano scritto in settimana, farsi qualche bicchiere di Porto o di scotch. Quando uno di loro doveva tenere qualche conferenza nelle città vicine era una festa collettiva: partivano a piedi nel weekend, arrivavano a farsi anche cento chilometri, con frequentissime soste nelle osterie sul cammino, tornavano alla stessa maniera e riprendevano il loro lavoro accademico. Dove sta la coerenza? Nell’amicizia Elisa, nella capacità di non sacrificare l’amicizia alla loro professione o alla loro vocazione di scrittori. Non sapevo nulla di tutto questo quando ho letto Il signore degli anelli, ma non potevo fare a meno di accorgermi che chi scriveva conosceva davvero il valore dell’amicizia.
 Ho sentito la voglia di raccontarlo [ndr: Patrick Leigh Fermor] quindi per quattro ragioni, e direi che ce n’è d’avanzo: perché era un uomo coraggioso, perché era un intellettuale raffinato, perché era un grande camminatore e perché era uno snob quale solo gli inglesi sanno esserlo. Fermor appartiene alla dinastia dei Byron, George ma soprattutto Robert, quello de La via per l’Oxiana, e risalendo più in su ancora, del bucaniere Dampier, e allungando indietro lo sguardo, dei cavalieri della Tavola Rotonda. E anche di Orwell o di Auden, pronti a combattere per quella che ritengono la causa giusta, e a fermarsi appena hanno l’impressione che tanto giusta non sia, o che comunque non sia più la loro causa. Individualisti, per nulla disposti a sacrificare la loro autonomia di pensiero agli interessi di un’idea che, nel momento in cui non garantisce la massima libertà individuale, non riesce più accettabile.
Ho sentito la voglia di raccontarlo [ndr: Patrick Leigh Fermor] quindi per quattro ragioni, e direi che ce n’è d’avanzo: perché era un uomo coraggioso, perché era un intellettuale raffinato, perché era un grande camminatore e perché era uno snob quale solo gli inglesi sanno esserlo. Fermor appartiene alla dinastia dei Byron, George ma soprattutto Robert, quello de La via per l’Oxiana, e risalendo più in su ancora, del bucaniere Dampier, e allungando indietro lo sguardo, dei cavalieri della Tavola Rotonda. E anche di Orwell o di Auden, pronti a combattere per quella che ritengono la causa giusta, e a fermarsi appena hanno l’impressione che tanto giusta non sia, o che comunque non sia più la loro causa. Individualisti, per nulla disposti a sacrificare la loro autonomia di pensiero agli interessi di un’idea che, nel momento in cui non garantisce la massima libertà individuale, non riesce più accettabile.


 Ho sempre nutrito una grande ammirazione per lo spirito inglese, a dispetto di quanto ne dice mia figlia, che vive sull’isola, ne è cittadina, ma non ha dei suoi connazionali una grande opinione. La mia ammirazione ha una matrice letteraria, senz’altro, perché la letteratura inglese è quella cui ho maggiormente attinto sin da ragazzo e che ha alimentato alla grande la mia fame giovanile di viaggi e di avventura. Il riferimento obbligato in questo caso è naturalmente Stevenson. “Per un ragazzo di dodici anni traversare la Manica è come cambiare cielo; per un uomo di ventiquattro traversare l’Atlantico significa appena un lieve cambiamento di alimentazione. Ma io ero ormai uscito fuori dall’ombra dell’Impero Romano, che ci ha dominato dalla culla con le rovine dei suoi monumenti, le cui leggi e la cui letteratura ci assediano da ogni parte, piene di divieti e di costrizioni.” Schmitt avrebbe visto in queste parole una conferma della sua analisi.
Ho sempre nutrito una grande ammirazione per lo spirito inglese, a dispetto di quanto ne dice mia figlia, che vive sull’isola, ne è cittadina, ma non ha dei suoi connazionali una grande opinione. La mia ammirazione ha una matrice letteraria, senz’altro, perché la letteratura inglese è quella cui ho maggiormente attinto sin da ragazzo e che ha alimentato alla grande la mia fame giovanile di viaggi e di avventura. Il riferimento obbligato in questo caso è naturalmente Stevenson. “Per un ragazzo di dodici anni traversare la Manica è come cambiare cielo; per un uomo di ventiquattro traversare l’Atlantico significa appena un lieve cambiamento di alimentazione. Ma io ero ormai uscito fuori dall’ombra dell’Impero Romano, che ci ha dominato dalla culla con le rovine dei suoi monumenti, le cui leggi e la cui letteratura ci assediano da ogni parte, piene di divieti e di costrizioni.” Schmitt avrebbe visto in queste parole una conferma della sua analisi. Naturalmente parlo dell’Inghilterra di ieri, o perlomeno dell’immagine di sé che quel paese fino a ieri riusciva a trasmettere. Mi son fatto l’idea (e quando mi faccio un’idea rimane ben radicata) che quello inglese sia un popolo che ha saputo mediare tra la volontà di fuga e di rottura e l’attaccamento alla terra e alle convenzioni. Ha attraversato gli oceani non per dimenticare la sua isola, ma per espanderla, per portarne un pezzo altrove, e magari per rigenerarla. Credo anche che il suo rapporto col mare sia stato in gran parte determinato dalle condizioni di temperatura e di violenza di quest’ultimo. Il mare inglese, lo dico per esperienza diretta, non è fatto per starci ammollo ma per essere affrontato: le sue onde, le sue correnti e le sue maree vanno conosciute e rispettate. Conrad ne era consapevole, tanto da scrivere che “Il mare non è mai stato amico dell’uomo. Tutt’al più è stato complice della sua irrequietezza”. Ma questo non implica un rifiuto, anzi: “Scoprii quanto ero uomo di mare, nel cuore, nella mente e, per così dire, nel corpo: un uomo esclusivamente di mare e di navi; il mare, l’unico mondo che contasse, e le navi, un banco di prova di virilità, di carattere, di coraggio, di fedeltà e d’amore”. Anche qui mi riconosco.
Naturalmente parlo dell’Inghilterra di ieri, o perlomeno dell’immagine di sé che quel paese fino a ieri riusciva a trasmettere. Mi son fatto l’idea (e quando mi faccio un’idea rimane ben radicata) che quello inglese sia un popolo che ha saputo mediare tra la volontà di fuga e di rottura e l’attaccamento alla terra e alle convenzioni. Ha attraversato gli oceani non per dimenticare la sua isola, ma per espanderla, per portarne un pezzo altrove, e magari per rigenerarla. Credo anche che il suo rapporto col mare sia stato in gran parte determinato dalle condizioni di temperatura e di violenza di quest’ultimo. Il mare inglese, lo dico per esperienza diretta, non è fatto per starci ammollo ma per essere affrontato: le sue onde, le sue correnti e le sue maree vanno conosciute e rispettate. Conrad ne era consapevole, tanto da scrivere che “Il mare non è mai stato amico dell’uomo. Tutt’al più è stato complice della sua irrequietezza”. Ma questo non implica un rifiuto, anzi: “Scoprii quanto ero uomo di mare, nel cuore, nella mente e, per così dire, nel corpo: un uomo esclusivamente di mare e di navi; il mare, l’unico mondo che contasse, e le navi, un banco di prova di virilità, di carattere, di coraggio, di fedeltà e d’amore”. Anche qui mi riconosco.


 Terra e mare è stato scritto da Schmitt nel 1942, in un periodo nel quale il giurista, attento a non crearsi ulteriori problemi discettando di politica, si era dedicato piuttosto agli studi storici, e cercava conferme a una sua lettura quasi gnostica della storia: conferme che non aveva difficoltà a trovare, stante l’infuriare del conflitto e la convinzione di essere in presenza di cambiamenti epocali. Lo faceva presumendo per sé una condizione da iniziato, quella di chi va oltre la pura conoscenza dei fatti e delle vicende contingenti, e si spinge fino a riconoscere la trama segreta (che definisce ripetutamente “arcana”) entro la quale gli eventi si inseriscono e vanno letti. Di chi in sostanza cerca una verità esoterica, nascosta e negata anche agli “addetti ai lavori”, agli storici più qualificati. È un’interpretazione che sotto certi aspetti non esiterei a definire “complottista”, e questo è forse il motivo per cui avevo rimosso il testo: non manca tuttavia di offrire spunti di riflessione che, opportunamente depurati, possono rivelarsi fecondi.
Terra e mare è stato scritto da Schmitt nel 1942, in un periodo nel quale il giurista, attento a non crearsi ulteriori problemi discettando di politica, si era dedicato piuttosto agli studi storici, e cercava conferme a una sua lettura quasi gnostica della storia: conferme che non aveva difficoltà a trovare, stante l’infuriare del conflitto e la convinzione di essere in presenza di cambiamenti epocali. Lo faceva presumendo per sé una condizione da iniziato, quella di chi va oltre la pura conoscenza dei fatti e delle vicende contingenti, e si spinge fino a riconoscere la trama segreta (che definisce ripetutamente “arcana”) entro la quale gli eventi si inseriscono e vanno letti. Di chi in sostanza cerca una verità esoterica, nascosta e negata anche agli “addetti ai lavori”, agli storici più qualificati. È un’interpretazione che sotto certi aspetti non esiterei a definire “complottista”, e questo è forse il motivo per cui avevo rimosso il testo: non manca tuttavia di offrire spunti di riflessione che, opportunamente depurati, possono rivelarsi fecondi.
 L’evidenza di una conflittualità primordiale tra i due ordini Schmitt la trova già nella narrazione biblica, laddove si fa riferimento a più riprese all’epica lotta tra Behemoth, bestia terrestre, e Leviathan, mostro marino. Non insiste poi sui riferimenti che potrebbe rintracciare anche nella mitologia greca, ma passa direttamente alla protostoria, con la vicenda di Creta, civiltà marittima che impone il suo controllo sul Mediterraneo orientale, e alla storia, con Atene che sconfigge soprattutto sul mare la potenza terranea persiana. Per contro Roma, civiltà “terrestre”, trionfa qualche secolo dopo sulla marittima Cartagine (ma solo in virtù di un rapidissimo adeguamento alla nuova “guerra ibrida”, combattuta sia per terra che sul mare). E dopo il crollo dell’Impero d’occidente, è Bisanzio con le sue navi a fungere da freno (ovvero, come dice Schmitt, da katechon) alle forze storiche avversarie. Nel frattempo a nord e nel Mediterraneo sudorientale si affermano altre potenze marinare: i vichinghi e i pirati saraceni. Poco più tardi le crociate saranno guidate da condottieri che sono espressione di una cultura militare e politica tutta terranea, ma a trarne il maggior profitto sarà la potenza marittima veneziana (stranamente Schmitt ignora quella genovese).
L’evidenza di una conflittualità primordiale tra i due ordini Schmitt la trova già nella narrazione biblica, laddove si fa riferimento a più riprese all’epica lotta tra Behemoth, bestia terrestre, e Leviathan, mostro marino. Non insiste poi sui riferimenti che potrebbe rintracciare anche nella mitologia greca, ma passa direttamente alla protostoria, con la vicenda di Creta, civiltà marittima che impone il suo controllo sul Mediterraneo orientale, e alla storia, con Atene che sconfigge soprattutto sul mare la potenza terranea persiana. Per contro Roma, civiltà “terrestre”, trionfa qualche secolo dopo sulla marittima Cartagine (ma solo in virtù di un rapidissimo adeguamento alla nuova “guerra ibrida”, combattuta sia per terra che sul mare). E dopo il crollo dell’Impero d’occidente, è Bisanzio con le sue navi a fungere da freno (ovvero, come dice Schmitt, da katechon) alle forze storiche avversarie. Nel frattempo a nord e nel Mediterraneo sudorientale si affermano altre potenze marinare: i vichinghi e i pirati saraceni. Poco più tardi le crociate saranno guidate da condottieri che sono espressione di una cultura militare e politica tutta terranea, ma a trarne il maggior profitto sarà la potenza marittima veneziana (stranamente Schmitt ignora quella genovese).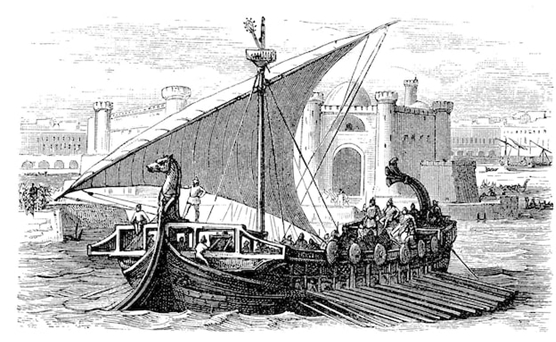












 Come vivere? Allora questa domanda ce la dobbiamo porre non soltanto alla fine di un millennio, di un secolo, di un anno, ma tutti i giorni, e tutti i giorni svegliandoci, si dovrebbe dire: “Oggi che cosa ci aspetta?”. Allora io considero che si dovrebbero fare le cose bene, perché non c’è maggiore soddisfazione di un lavoro ben fatto. Un lavoro ben fatto, qualsiasi lavoro, fatto dall’uomo che non si prefigge solo il guadagno, ma anche un arricchimento, un lavoro manuale, un lavoro intellettuale che sia, un lavoro ben fatto è quello che appaga l’uomo. Io coltivo l’orto, e qualche volta, quando vedo le aiuole ben tirate con il letame ben sotto, con la terra ben spianata, provo soddisfazione uguale a quella che ho quando ho finito un buon racconto. E allora dico anche questo: una catasta di legna ben fatta, ben allineata, ben in squadra, che non cade, è bella; un lavoro manuale quando non è ripetitivo è sempre un lavoro che va bene, perché è anche creativo: un bravo falegname, un bravo artigiano, un bravo scalpellino, un bravo contadino. E oggi dico sempre quando mi incontro con i ragazzi: voi magari aspirate ad avere un impiego in banca, ma ricordatevi che fare il contadino per bene è più intellettuale che non fare il cassiere di banca, perché un contadino deve sapere di genetica, di meteorologia, di chimica, di astronomia persino. Tutti questi lavori che noi consideriamo magari con un certo disprezzo, sono lavori invece intellettuali.
Come vivere? Allora questa domanda ce la dobbiamo porre non soltanto alla fine di un millennio, di un secolo, di un anno, ma tutti i giorni, e tutti i giorni svegliandoci, si dovrebbe dire: “Oggi che cosa ci aspetta?”. Allora io considero che si dovrebbero fare le cose bene, perché non c’è maggiore soddisfazione di un lavoro ben fatto. Un lavoro ben fatto, qualsiasi lavoro, fatto dall’uomo che non si prefigge solo il guadagno, ma anche un arricchimento, un lavoro manuale, un lavoro intellettuale che sia, un lavoro ben fatto è quello che appaga l’uomo. Io coltivo l’orto, e qualche volta, quando vedo le aiuole ben tirate con il letame ben sotto, con la terra ben spianata, provo soddisfazione uguale a quella che ho quando ho finito un buon racconto. E allora dico anche questo: una catasta di legna ben fatta, ben allineata, ben in squadra, che non cade, è bella; un lavoro manuale quando non è ripetitivo è sempre un lavoro che va bene, perché è anche creativo: un bravo falegname, un bravo artigiano, un bravo scalpellino, un bravo contadino. E oggi dico sempre quando mi incontro con i ragazzi: voi magari aspirate ad avere un impiego in banca, ma ricordatevi che fare il contadino per bene è più intellettuale che non fare il cassiere di banca, perché un contadino deve sapere di genetica, di meteorologia, di chimica, di astronomia persino. Tutti questi lavori che noi consideriamo magari con un certo disprezzo, sono lavori invece intellettuali.







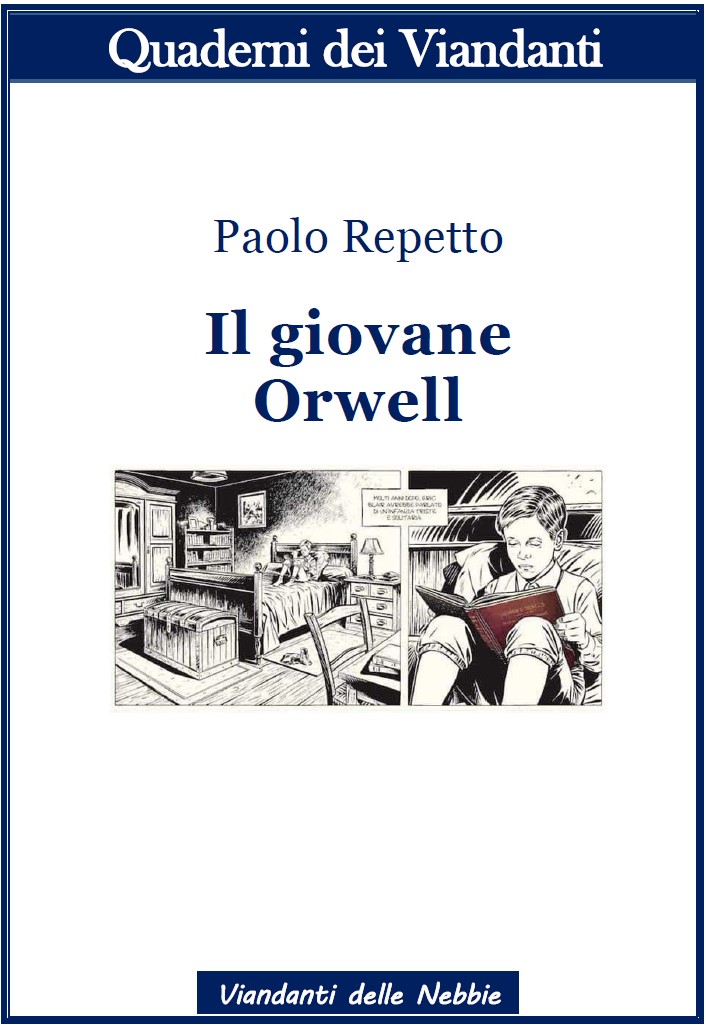

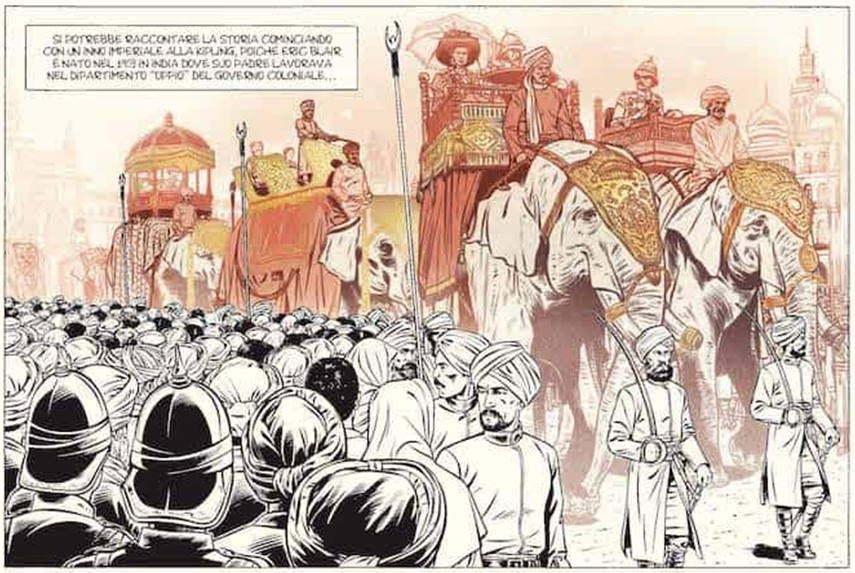
 Orwell è in genere presentato come il contraltare di Kipling; in tutta la sua opera, e non solo in Giorni in Birmania, c’è una indignata condanna del colonialismo e di ogni forma di imperialismo. In tal senso gli autori a lui più prossimi sono senz’altro Multatuli e Conrad (dei quali troverò modo di parlare altrove). Ma al netto delle differenti esperienze – e del fatto che Orwell abbia preso progressivamente le distanze da Kipling, fino a dichiarare senza mezzi termini di odiarlo – sono convinto che i loro atteggiamenti non fossero poi così lontani, se li leggiamo scomodando il parametro del “razzismo”: nel senso che “razzista” non era neppure il secondo, a dispetto delle sue idee sul “fardello dell’uomo bianco”. In fondo, davanti alla cultura indiana Kipling semplicemente sospendeva il giudizio: “Io ho vissuto abbastanza in questa India per sapere che è meglio non sapere nulla, e posso raccontare solo com’è andata”
Orwell è in genere presentato come il contraltare di Kipling; in tutta la sua opera, e non solo in Giorni in Birmania, c’è una indignata condanna del colonialismo e di ogni forma di imperialismo. In tal senso gli autori a lui più prossimi sono senz’altro Multatuli e Conrad (dei quali troverò modo di parlare altrove). Ma al netto delle differenti esperienze – e del fatto che Orwell abbia preso progressivamente le distanze da Kipling, fino a dichiarare senza mezzi termini di odiarlo – sono convinto che i loro atteggiamenti non fossero poi così lontani, se li leggiamo scomodando il parametro del “razzismo”: nel senso che “razzista” non era neppure il secondo, a dispetto delle sue idee sul “fardello dell’uomo bianco”. In fondo, davanti alla cultura indiana Kipling semplicemente sospendeva il giudizio: “Io ho vissuto abbastanza in questa India per sapere che è meglio non sapere nulla, e posso raccontare solo com’è andata”

 «Un albergo va avanti perché chi vi lavora è sinceramente fiero di quello che fa, per quanto possa essere stupido e orribile il suo lavoro. Se uno batte la fiacca, gli altri se ne accorgono subito e cospirano contro di lui per farlo licenziare […] Anche il cameriere è, in certo modo, fiero della propria abilità, che però consiste soprattutto nell’essere servile. Il lavoro gli conferisce l’abito mentale non già dell’operaio, ma dello snob. Vive sempre con gente ricca sotto gli occhi, ne ascolta le conversazioni, sta in piedi accanto al loro tavolo, li adula con sorrisi e piccole facezie discrete. Ha il piacere di spendere denaro per procura.
«Un albergo va avanti perché chi vi lavora è sinceramente fiero di quello che fa, per quanto possa essere stupido e orribile il suo lavoro. Se uno batte la fiacca, gli altri se ne accorgono subito e cospirano contro di lui per farlo licenziare […] Anche il cameriere è, in certo modo, fiero della propria abilità, che però consiste soprattutto nell’essere servile. Il lavoro gli conferisce l’abito mentale non già dell’operaio, ma dello snob. Vive sempre con gente ricca sotto gli occhi, ne ascolta le conversazioni, sta in piedi accanto al loro tavolo, li adula con sorrisi e piccole facezie discrete. Ha il piacere di spendere denaro per procura. Rientrato alla fine in patria, cambia scenario, ma non condizione. L’esistenza vagabonda Orwell la conduce per altri tre anni. Finisce persino in carcere, per ubriachezza (sia pure volutamente, per conoscere dall’interno anche quell’ambiente). Si concede delle rare pause quando gli capita qualche offerta per brevi periodi di insegnamento o di collaborazione a piccole riviste, poi torna a peregrinare con gli altri disgraziati seguendo la mappa delle stagioni dei raccolti, del luppolo o delle mele. È talmente impegnato a sopravvivere che non ha molto tempo per pensare. Lo farà solo dopo, al momento di tirare le somme di quell’esperienza: e sarà un bilancio tutt’altro che esaltante.
Rientrato alla fine in patria, cambia scenario, ma non condizione. L’esistenza vagabonda Orwell la conduce per altri tre anni. Finisce persino in carcere, per ubriachezza (sia pure volutamente, per conoscere dall’interno anche quell’ambiente). Si concede delle rare pause quando gli capita qualche offerta per brevi periodi di insegnamento o di collaborazione a piccole riviste, poi torna a peregrinare con gli altri disgraziati seguendo la mappa delle stagioni dei raccolti, del luppolo o delle mele. È talmente impegnato a sopravvivere che non ha molto tempo per pensare. Lo farà solo dopo, al momento di tirare le somme di quell’esperienza: e sarà un bilancio tutt’altro che esaltante.


 Tutto questo non mi indignava e non mi disturbava affatto, anzi: se una cosa non sopporto è proprio l’ipocrisia che sta dietro la mistica del proletariato, la presunzione di saperne cogliere e interpretare le aspettative e le paure, addirittura meglio dei proletari stessi, di esserne insomma la coscienza avanzata. Questa sì, mi è sempre parsa una forma insopportabile di ‘colonialismo sociale’. Persino io, che di quel proletariato facevo parte senza ombra di dubbio, avvertivo una distanza, e non perché fossi stato educato a “percepirne gli odori” (che tra l’altro, l’igienizzazione sempre più diffusa ha cancellati, reali o metaforici che fossero, così come la standardizzazione dell’abbigliamento o la scomparsa dei dialetti ha livellato gli altri indicatori sociali più eclatanti), quanto per il fatto che bene o male avevo potuto accedere a un certo livello d’istruzione e già vedevo la mia condizione da un altro punto di vista. Percepivo (e pativo) la differenza nelle aspettative “di senso”, individuali e sociali, rispetto alla maggior parte dei miei compagni del paese: ma ho patito ancor più quella rispetto ai miei compagni di studi, soprattutto all’università, e di militanza politica successivamente, che si arrogavano l’interpretazione autentica delle “istanze proletarie” e si candidavano ad avanguardie.
Tutto questo non mi indignava e non mi disturbava affatto, anzi: se una cosa non sopporto è proprio l’ipocrisia che sta dietro la mistica del proletariato, la presunzione di saperne cogliere e interpretare le aspettative e le paure, addirittura meglio dei proletari stessi, di esserne insomma la coscienza avanzata. Questa sì, mi è sempre parsa una forma insopportabile di ‘colonialismo sociale’. Persino io, che di quel proletariato facevo parte senza ombra di dubbio, avvertivo una distanza, e non perché fossi stato educato a “percepirne gli odori” (che tra l’altro, l’igienizzazione sempre più diffusa ha cancellati, reali o metaforici che fossero, così come la standardizzazione dell’abbigliamento o la scomparsa dei dialetti ha livellato gli altri indicatori sociali più eclatanti), quanto per il fatto che bene o male avevo potuto accedere a un certo livello d’istruzione e già vedevo la mia condizione da un altro punto di vista. Percepivo (e pativo) la differenza nelle aspettative “di senso”, individuali e sociali, rispetto alla maggior parte dei miei compagni del paese: ma ho patito ancor più quella rispetto ai miei compagni di studi, soprattutto all’università, e di militanza politica successivamente, che si arrogavano l’interpretazione autentica delle “istanze proletarie” e si candidavano ad avanguardie. Anche London, come Orwell, era un socialista. Sia pure in una maniera tutta sua, molto americana, che combinava Marx con Nietzsche e con Sorel. E anche lui, come Orwell, col socialismo, o meglio, coi socialisti, ebbe un rapporto conflittuale, soprattutto dopo che si rese conto che la gran parte dei suoi consistenti contributi economici alla causa era finita nelle tasche dei capi. Ciò lo aveva indotto, ad un certo punto, a prendere le distanze dal movimento e dalle organizzazioni sindacali, per coltivare un socialismo personalissimo e molto disincantato.
Anche London, come Orwell, era un socialista. Sia pure in una maniera tutta sua, molto americana, che combinava Marx con Nietzsche e con Sorel. E anche lui, come Orwell, col socialismo, o meglio, coi socialisti, ebbe un rapporto conflittuale, soprattutto dopo che si rese conto che la gran parte dei suoi consistenti contributi economici alla causa era finita nelle tasche dei capi. Ciò lo aveva indotto, ad un certo punto, a prendere le distanze dal movimento e dalle organizzazioni sindacali, per coltivare un socialismo personalissimo e molto disincantato.
 Malgrado ciò, per molti aspetti Gissing è molto più prossimo ad Orwell di quanto potrebbe sembrare. Nel suo unico libro di viaggi, Sulle rive dello Ionio, scrive ad un certo punto: “Ogni uomo ha un suo anelito intellettuale; io ho quello di sfuggire alla vita che conosco e di tornare, per virtù del sogno, in quell’antico mondo che deliziò la mia immaginazione di fanciullo” (nel suo caso si tratta del mondo greco e romano). Le vestigia di questo mondo le trova ad esempio nel Meridione italiano, e segnatamente nella sua area più arretrata, in Calabria: ne è talmente suggestionato da tollerare la miseria delle popolazioni calabresi, che gli appare comunque solare, mentre considera torbida e insopportabile quella delle masse londinesi. (In questo è simile a molti suoi contemporanei in fuga dalla società vittoriana, ma molto diverso da Dickens, che nel suo resoconto di un viaggio in Italia parla di “Città sporche e tristi, paese decadente, umanità ambigua” e scrive, in una lettera ad un amico: “Se tu potessi vedere i lazzaroni come sono in realtà: meri animali, squallidi, abietti, miserabili, per l’ingrasso dei pidocchi; viscidi, brutti, cenciosi, avanzi di spaventapasseri!”).
Malgrado ciò, per molti aspetti Gissing è molto più prossimo ad Orwell di quanto potrebbe sembrare. Nel suo unico libro di viaggi, Sulle rive dello Ionio, scrive ad un certo punto: “Ogni uomo ha un suo anelito intellettuale; io ho quello di sfuggire alla vita che conosco e di tornare, per virtù del sogno, in quell’antico mondo che deliziò la mia immaginazione di fanciullo” (nel suo caso si tratta del mondo greco e romano). Le vestigia di questo mondo le trova ad esempio nel Meridione italiano, e segnatamente nella sua area più arretrata, in Calabria: ne è talmente suggestionato da tollerare la miseria delle popolazioni calabresi, che gli appare comunque solare, mentre considera torbida e insopportabile quella delle masse londinesi. (In questo è simile a molti suoi contemporanei in fuga dalla società vittoriana, ma molto diverso da Dickens, che nel suo resoconto di un viaggio in Italia parla di “Città sporche e tristi, paese decadente, umanità ambigua” e scrive, in una lettera ad un amico: “Se tu potessi vedere i lazzaroni come sono in realtà: meri animali, squallidi, abietti, miserabili, per l’ingrasso dei pidocchi; viscidi, brutti, cenciosi, avanzi di spaventapasseri!”). 6. In una delle primissime recensioni italiane ad Orwell, Giuseppe Bonura scrive che aveva la tempra del martire laico. Questa definizione richiama immediatamente il confronto con un’altra esperienza simile e pressoché coeva, quella vissuta da Simone Weil, e raccontata poi dalla filosofa francese ne “La condizione operaia”.
6. In una delle primissime recensioni italiane ad Orwell, Giuseppe Bonura scrive che aveva la tempra del martire laico. Questa definizione richiama immediatamente il confronto con un’altra esperienza simile e pressoché coeva, quella vissuta da Simone Weil, e raccontata poi dalla filosofa francese ne “La condizione operaia”.






 Le motivazioni che avevano portato Auden e Spender in Spagna sono espresse invece molto chiaramente dal secondo nella sua autobiografia, Un mondo nel mondo: andare a combattere dalla parte comunista in Spagna sembrava il solo modo possibile di essere antifascisti. «Il comunismo “occidentale” – scrive – in quegli anni era una cosa molto diversa. Uscivamo dal disastro del 1929, il capitalismo sembrava un sistema finito, incapace di trovare soluzioni, pareva invece che in Urss avessero la risposta, e la risposta stava in un modello economico e sociale ideale applicabile anche qui […] Eravamo consapevoli dell’abisso ma non vedevamo nuovi valori che potessero sostituire quelli che ci avevano sorretto nel passato. Nel giro di poche settimane, la Spagna divenne un simbolo di speranza per tutti gli antifascisti. Offriva un 1848 al ventesimo secolo».
Le motivazioni che avevano portato Auden e Spender in Spagna sono espresse invece molto chiaramente dal secondo nella sua autobiografia, Un mondo nel mondo: andare a combattere dalla parte comunista in Spagna sembrava il solo modo possibile di essere antifascisti. «Il comunismo “occidentale” – scrive – in quegli anni era una cosa molto diversa. Uscivamo dal disastro del 1929, il capitalismo sembrava un sistema finito, incapace di trovare soluzioni, pareva invece che in Urss avessero la risposta, e la risposta stava in un modello economico e sociale ideale applicabile anche qui […] Eravamo consapevoli dell’abisso ma non vedevamo nuovi valori che potessero sostituire quelli che ci avevano sorretto nel passato. Nel giro di poche settimane, la Spagna divenne un simbolo di speranza per tutti gli antifascisti. Offriva un 1848 al ventesimo secolo». In un primo momento Campbell non prende posizione, ma si è da poco convertito al cattolicesimo e le sue simpatie non vanno certo agli anarchici e ai comunisti. Tanto più dopo che assiste all’incendio delle chiese di Toledo, ai roghi di libri e di immagini sacre e alle fucilazioni di frati e suore. A questo punto si arruola nelle truppe carliste (ufficialmente come corrispondente di guerra), e in queste continuo militare sino alla fine del conflitto. Come Auden, non racconta direttamente la sua esperienza, ma la traduce in una serie di poesie, alcune delle quali molto efficaci “I nostri fucili erano troppo caldi per tenerli / La notte era fatta di acciaio lacerante, / E lungo la strada le raffiche rotolarono / Dove come in preghiera i cecchini si inginocchiano.” Nel ‘39, al termine del conflitto, scrive il poema Fucile Fiorente, e questo gli vale la patente definitiva di filo-fascista. In effetti è un’ode a Franco, ma Campbell protesterà sempre di credere non solo nella famiglia e nella religione, ma soprattutto nella tolleranza.
In un primo momento Campbell non prende posizione, ma si è da poco convertito al cattolicesimo e le sue simpatie non vanno certo agli anarchici e ai comunisti. Tanto più dopo che assiste all’incendio delle chiese di Toledo, ai roghi di libri e di immagini sacre e alle fucilazioni di frati e suore. A questo punto si arruola nelle truppe carliste (ufficialmente come corrispondente di guerra), e in queste continuo militare sino alla fine del conflitto. Come Auden, non racconta direttamente la sua esperienza, ma la traduce in una serie di poesie, alcune delle quali molto efficaci “I nostri fucili erano troppo caldi per tenerli / La notte era fatta di acciaio lacerante, / E lungo la strada le raffiche rotolarono / Dove come in preghiera i cecchini si inginocchiano.” Nel ‘39, al termine del conflitto, scrive il poema Fucile Fiorente, e questo gli vale la patente definitiva di filo-fascista. In effetti è un’ode a Franco, ma Campbell protesterà sempre di credere non solo nella famiglia e nella religione, ma soprattutto nella tolleranza.























 E allora il viaggio è proseguito fino alla frontiera con il Ruanda, una frontiera terrestre assolutamente non turistica, dove si ha netta la percezione che in certe parti del mondo puoi ritrovarti in qualsiasi momento alla mercé di persone con una divisa addosso e con una pistola in mano che diventano padrone della tua vita; noi eravamo con un viaggio organizzato e abbiamo passato solo un’ora di disagio e d inquietudine, ma da soli sarebbe stata tutta un’ altra storia, e sicura-mente una bella mazzetta di dollari che cambiavano di tasca alla luce del sole per poter uscire da quella terra di nessuna che è una dogana africana … e poi ancora via verso i monti Virunga, il parco nazionale dei vulcani, territorio condiviso con l’ Uganda a nordest e con il Congo a nordovest.
E allora il viaggio è proseguito fino alla frontiera con il Ruanda, una frontiera terrestre assolutamente non turistica, dove si ha netta la percezione che in certe parti del mondo puoi ritrovarti in qualsiasi momento alla mercé di persone con una divisa addosso e con una pistola in mano che diventano padrone della tua vita; noi eravamo con un viaggio organizzato e abbiamo passato solo un’ora di disagio e d inquietudine, ma da soli sarebbe stata tutta un’ altra storia, e sicura-mente una bella mazzetta di dollari che cambiavano di tasca alla luce del sole per poter uscire da quella terra di nessuna che è una dogana africana … e poi ancora via verso i monti Virunga, il parco nazionale dei vulcani, territorio condiviso con l’ Uganda a nordest e con il Congo a nordovest. Ruanda, dove i gorilla di montagna sono protetti e dove convergono visitatori da tutto il mondo per questo incontro emozionante. I nostri secondi cugini con-dividono con noi il 97,7% del materiale genetico. Ne sono rimasti all’incirca 700 esemplari. Vivono in alta montagna, immersi nell’umidità e nella nebbia alle pendici di queste montagne vulcaniche che superano i 4500 m di quota. Ci si sveglia all’alba, le jeep ci portano all’ingresso del parco a circa 2000 m, si selezionano i gruppi in base all’età e all’attitudine fisica alla marcia e allo sforzo perché alcuni gruppi di gorilla sono più vicini, altri più nascosti in alta quota. Noi 5, più due ragazzi spagnoli, veniamo stimati molto abili perché ci destinano al gruppo più lontano.
Ruanda, dove i gorilla di montagna sono protetti e dove convergono visitatori da tutto il mondo per questo incontro emozionante. I nostri secondi cugini con-dividono con noi il 97,7% del materiale genetico. Ne sono rimasti all’incirca 700 esemplari. Vivono in alta montagna, immersi nell’umidità e nella nebbia alle pendici di queste montagne vulcaniche che superano i 4500 m di quota. Ci si sveglia all’alba, le jeep ci portano all’ingresso del parco a circa 2000 m, si selezionano i gruppi in base all’età e all’attitudine fisica alla marcia e allo sforzo perché alcuni gruppi di gorilla sono più vicini, altri più nascosti in alta quota. Noi 5, più due ragazzi spagnoli, veniamo stimati molto abili perché ci destinano al gruppo più lontano. Senza che quasi ce ne accorgiamo il paesaggio cambia, si suda ancora di più e all’improvviso ci si trova nel cuore della foresta equatoriale; vegetazione esuberante, ad altezza d’uomo, liane, alberi alti 10-15 metri che oscurano il cielo, torbiere, marcia nel fango fino a 2700 m. Il primo gorilla ti guarda di soppiatto da dietro un cespuglio di foglie, assolutamente non spaventato, abbastanza abituato alla presenza umana; un silverback non ci degna di uno sguardo entrando in una foresta di bamboo, il dorso ha il pelo argentato in segno di anzianità e di autorità. Sono alti fino a 220 cm e pesano fino a 200-230kg. I cuccioli sono curiosissimi, verrebbero vicino a toccarci e a giocare se non fosse che da una parte le loro mamme, dall’altra le nostre guide ci impediscono ogni contatto fisico, per evitare contagi pericolosi di microorganismi e reazioni aggressive dei genitori per proteggere i piccoli. Si osserva la loro vita, sono ancora più umani, se possibile, degli scimpanzé. Hanno una socialità elevatissima, scandita da tempi, rituali, norme fatte rispettare dai maschi alfa, i capibranco. C’è il tempo del risveglio, della colazione, della pulizia e dell’igiene, del gioco per i cuccioli, del pranzo, del riposo, della ricerca del posto migliore per dormire e per cercare cibo il giorno successivo.
Senza che quasi ce ne accorgiamo il paesaggio cambia, si suda ancora di più e all’improvviso ci si trova nel cuore della foresta equatoriale; vegetazione esuberante, ad altezza d’uomo, liane, alberi alti 10-15 metri che oscurano il cielo, torbiere, marcia nel fango fino a 2700 m. Il primo gorilla ti guarda di soppiatto da dietro un cespuglio di foglie, assolutamente non spaventato, abbastanza abituato alla presenza umana; un silverback non ci degna di uno sguardo entrando in una foresta di bamboo, il dorso ha il pelo argentato in segno di anzianità e di autorità. Sono alti fino a 220 cm e pesano fino a 200-230kg. I cuccioli sono curiosissimi, verrebbero vicino a toccarci e a giocare se non fosse che da una parte le loro mamme, dall’altra le nostre guide ci impediscono ogni contatto fisico, per evitare contagi pericolosi di microorganismi e reazioni aggressive dei genitori per proteggere i piccoli. Si osserva la loro vita, sono ancora più umani, se possibile, degli scimpanzé. Hanno una socialità elevatissima, scandita da tempi, rituali, norme fatte rispettare dai maschi alfa, i capibranco. C’è il tempo del risveglio, della colazione, della pulizia e dell’igiene, del gioco per i cuccioli, del pranzo, del riposo, della ricerca del posto migliore per dormire e per cercare cibo il giorno successivo. Sono momenti da vivere secondo per secondo perché si rimane tassativa-mente un’ora e non un minuto di più, l’abitudine dei gorilla alla presenza umana non può sorpassare questi limiti di tempo. Li guardi, li fotografi, li filmi, ti sembra che fotografarli sia sprecare tempo, che sarebbe più giusto guardare tutto senza l’intermediazione dell’obiettivo della reflex, ma tutti cedono all’impulso quasi frenetico di catturare immagini. Forse è un errore, ma è quasi inevitabile. Alla fine ci si chiede se siamo noi a guardare loro o viceversa, ti chiedi cosa pensano, non se pensano, perché su questo non può esserci nessun dubbio, e anche in questo caso, come per gli scimpanzé, ti chiedi quale infinitesima percentuale di ulteriore sviluppo neuropsichico sarebbe sufficiente affinché venga totalmente pareggiata ogni differenza fra noi e loro, proprio come nel famoso film di fantascienza … ti chiedi anche se, in un ipotetico salto in avanti di sviluppo, diventerebbero esattamente come noi, con tutte le capacità distruttive del genere umano, o se invece manterrebbero una differenziazione virtuosa nei confronti dello sfruttamento della tecnologia e nell’uso perverso di essa, come facciamo noi.
Sono momenti da vivere secondo per secondo perché si rimane tassativa-mente un’ora e non un minuto di più, l’abitudine dei gorilla alla presenza umana non può sorpassare questi limiti di tempo. Li guardi, li fotografi, li filmi, ti sembra che fotografarli sia sprecare tempo, che sarebbe più giusto guardare tutto senza l’intermediazione dell’obiettivo della reflex, ma tutti cedono all’impulso quasi frenetico di catturare immagini. Forse è un errore, ma è quasi inevitabile. Alla fine ci si chiede se siamo noi a guardare loro o viceversa, ti chiedi cosa pensano, non se pensano, perché su questo non può esserci nessun dubbio, e anche in questo caso, come per gli scimpanzé, ti chiedi quale infinitesima percentuale di ulteriore sviluppo neuropsichico sarebbe sufficiente affinché venga totalmente pareggiata ogni differenza fra noi e loro, proprio come nel famoso film di fantascienza … ti chiedi anche se, in un ipotetico salto in avanti di sviluppo, diventerebbero esattamente come noi, con tutte le capacità distruttive del genere umano, o se invece manterrebbero una differenziazione virtuosa nei confronti dello sfruttamento della tecnologia e nell’uso perverso di essa, come facciamo noi. Un pensiero sorge spontaneo, magari cinico, egoistico, ma inevitabile: che ogni esperienza di questo genere potrebbe essere l’ultima, e allora ci si tiene dentro l’emozione ed il ricordo come un enorme privilegio che ci è stato concesso. Magari sperando di avere le parole giuste, efficaci, e delle immagini sufficientemente belle per poter condividere queste emozioni con gli amici e con chiunque abbia a cuore questi animali, ammesso che si possa chiamarli così.
Un pensiero sorge spontaneo, magari cinico, egoistico, ma inevitabile: che ogni esperienza di questo genere potrebbe essere l’ultima, e allora ci si tiene dentro l’emozione ed il ricordo come un enorme privilegio che ci è stato concesso. Magari sperando di avere le parole giuste, efficaci, e delle immagini sufficientemente belle per poter condividere queste emozioni con gli amici e con chiunque abbia a cuore questi animali, ammesso che si possa chiamarli così. E poi ancora per l’ultima volta a Kampala, capitale africana come Nairobi, Addis Abeba e tante altre, enorme, caotica, inquinata, vitale, sempre in movi-mento, con la vita sempre vissuta in strada, nei mercati, sui marciapiedi, perennemente in coda sui suoi viali, ma tanto non importa a nessuno perché la concezione del tempo è radicalmente diversa dalla nostra, non siamo noi ad influenzare il tempo, ma semplicemente ci si adegua ad esso: non è male come filosofia di vita, ci si stressa di meno, con più fatalismo e meno rabbia.
E poi ancora per l’ultima volta a Kampala, capitale africana come Nairobi, Addis Abeba e tante altre, enorme, caotica, inquinata, vitale, sempre in movi-mento, con la vita sempre vissuta in strada, nei mercati, sui marciapiedi, perennemente in coda sui suoi viali, ma tanto non importa a nessuno perché la concezione del tempo è radicalmente diversa dalla nostra, non siamo noi ad influenzare il tempo, ma semplicemente ci si adegua ad esso: non è male come filosofia di vita, ci si stressa di meno, con più fatalismo e meno rabbia.