Stefano Oberti e i fuorusciti parigini
di Paolo Repetto, 23 maggio 2025
La memoria crea talvolta connessioni inattese e singolari. Anzi, per la precisione non le crea, ma le scopre, perché erano già lì ad aspettarci nella realtà, in quella storica o in quella naturale. Accende solo la luce. Accade che ci occupiamo di una vicenda, di un ambiente, di un personaggio, e poco a poco esce dall’ombra tutto ciò che sta attorno, si allarga il nostro campo visivo, si schiudono nuove curiosità.
A me è capitato proprio recentemente, mentre scrivevo il pezzo su Andrea Caffi. Fantasticavo come al solito su come sarebbe stato conoscerlo, quando all’improvviso ho realizzato che se Caffi non avrei potuto incontrarlo comunque, non fosse altro per ragioni anagrafiche, ho conosciuto però qualcuno che probabilmente l’aveva incrociato, dal momento che entrambi avevano vissuto come fuorusciti a Parigi negli anni Trenta e avevano frequentato più o meno gli stessi circoli antifascisti. Non ho testimonianze certe di una loro frequentazione diretta, ma le probabilità che ci sia stata mi paiono altissime.
Ora, il motivo che mi ha spinto a scrivere queste righe non è il compiacimento per la possibilità di essere collegato a Caffi da una catena molto corta di relazioni: è invece la curiosità destata dagli sviluppi e dagli esiti diversi di due storie che almeno nella condizione iniziale presentano molte somiglianze. A dimostrazione del fatto che l’ambiente agisce sino a un certo punto, ma è poi l’indole a fare la differenza.
È andata così. Nell’autunno-inverno tra il ‘68 e il ‘69 mi fermai a Genova, dove, oltre a seguire (molto saltuariamente) i corsi universitari e vivere gli ultimi fuochi della contestazione studentesca, avevo trovato un’occupazione part time presso un mobiliere (non in ufficio, camallavo frigoriferi e lavatrici). Alloggiavo in una camera in subaffitto in Castelletto, uno dei quartieri più eleganti della città, scovata da un compagno che aveva un’altra camera nello stesso alloggio. Il costo era irrisorio. Scoprimmo più tardi che potevamo permettercela perché il tizio che ci ospitava non pagava a sua volta l’affitto alla proprietaria.
Il tizio era un signore anziano, alto e corpulento, segnato in viso da diverse cicatrici, simpatico ma decisamente fuori dagli schemi. Si chiamava Stefano Oberti (“dottor” Oberti puntualizzava lui), e vantava un passato interessante. Era infatti stato esule in Francia per più di un decennio, dalla fine degli anni Venti, per sfuggire alla persecuzione dei fascisti. Tra le amicizie che raccontava di avere lì contratto spiccavano quelle col nipote di Nitti e con Rosselli (il futuro Presidente della Repubblica, Sandro Pertini, lo aveva già conosciuto prima), ma in pratica non era possibile citare qualcuno di quel giro col quale non vantasse confidenza. Sospettavamo che buona parte del suo racconto fossero millanterie, ma al tempo stesso eravamo divertiti dalle stravaganze e dall’assurdità del personaggio. Girava per casa quasi sempre inguainato in un capo unico maglia-mutandoni di lana, di quelli che Terence Hill indossa in Trinità, abbottonato davanti e con lo sportelletto sul fondoschiena, che gli dava una silhouette da orso Yogi. Ad un certo punto ho persino cominciato a invidiargli quella tenuta, perché il riscaldamento era sempre spento.
Oberti seguiva e ci segnalava tutti gli eventi culturali e politici della città, compresi quelli cui non era invitato, ma nei quali riusciva ad infiltrarsi invariabilmente tra gli organizzatori o tra gli ospiti d’onore. Una sera ci chiese di accompagnarlo ad una conferenza alla Terrazza Martini, il luogo più elegante di Genova, in cima ad un grattacielo dal quale si vedeva tutta il golfo. Lo stipammo sulla 500 del mio socio, con l’auto che dalla parte in cui era seduto lui raschiava quasi l’asfalto, e dovemmo anche arrischiare l’ascensore per salire i Trenta piani che portavano alla terrazza. Arrivammo naturalmente a conferenza già iniziata, ma non fu un problema, perché guidati dall’addome perentorio di Oberti ci dirigemmo immediatamente al buffet, imbandito su un lato del salone. Ci fu un mormorio di disapprovazione, che distrasse e irritò anche il conferenziere, ma a quanto pare l’argomento proposto non era granché, perché di lì a breve gli astanti cominciarono ad alzarsi, uno o due alla volta, e a raggiungerci ai tavoli. Avevano visto come noi, e soprattutto Oberti, stavamo spazzolando salatini e beveraggi. Credo sia stata la conferenza più breve di tutta la stagione.
Qualche serata la trascorremmo anche a discorrere di politica col nostro locatore, ma non riuscivamo a cavarne molto, perché lui era impallato con la massoneria e con una statua che avrebbe dovuto essere eretta a Mazzini nel cimitero di Staglieno (dove già peraltro le spoglie del patriota erano raccolte in un mausoleo scavato nella roccia). Ci dettagliava anche sulle annose schermaglie di potere che caratterizzano da sempre gli ambienti massonici, e tanto più quelli di provincia, sui voltafaccia e i tradimenti e su quanto fossero infidi i suoi rivali. Ma l’impegno maggiore era rivolto in quel periodo a raccogliere fondi per il monumento, e a lamentarsi della tirchieria dei genovesi, che a quanto pare non si rivelavano particolarmente entusiasti dell’iniziativa. (All’epoca noi non avevamo dubbi che non se ne sarebbe fatto nulla, ma come vedremo ho dovuto poi ricredermi).
Della sua vita di fuoruscito, oltre ad elencare le conoscenze, non raccontò praticamente nulla: sembrava gli fosse rimasta solo una fortissima ammirazione per le donne francesi (confermata nell’autobiografico Esilio a Parigi, dove almeno tre capitoli sono dedicati alle sue presunte conquiste e alla frequentazione di un postribolo d’alto bordo) e aveva maturato una vera passione per Marie Laforet. Una sera dovemmo scarrozzarlo fino al cinema di una delegazione periferica dove proiettavano Delitto in pieno sole: per tutta la durata del film la Laforet recita in bikini, e in qualche scena anche senza. Ne uscì entusiasta.
Una cosa comunque devo riconoscergliela. Quando gli proposi di assistere assieme a me al Cinema Centrale, la sala più “di sinistra” della Genova dell’epoca, alla proiezione di Ottobre di Eisenstein, mi rispose, anticipando di molto Fantozzi, che non solo era una boiata pazzesca, ma travisava anche rozzamente la verità storica. Non ci misi molto ad arrivare alle stesse conclusioni, ma gli avessi dato ascolto mi sarei risparmiato almeno il penoso dibattito che seguì la proiezione.
Alla fine di marzo purtroppo dovetti lasciare la camera, la campagna aveva bisogno di me. Tornai a Genova solo per dare una manciata di esami a giugno, e non rividi mai più Oberti. Il mio coinquilino mi raccontò poi di altre scorribande in cui era stato coinvolto, ma anche lui l’autunno successivo dovette cambiare sistemazione.
L’impressione che entrambi avevamo maturato era quella di un personaggio simpaticissimo, ma decisamente mitomane e inaffidabile. Infatti mi sorprese, ma non mi meravigliò più di tanto, trovare alla fine degli anni Ottanta il suo nome in capo ad una lista elettorale della Lega Nord. Mi confermò l’immagine di un uomo pronto a cavalcare qualsiasi cavallo, pur di stare in sella, e l’idea che il fuoriuscitismo non raccogliesse soltanto idealisti come Gobetti, Caffi, Chiaromonte, Rosselli e Berneri, ma anche diversi opportunisti e qualche sballato, per tacere del gran numero di infiltrati dalla polizia politica del regime.
Per questo, nel raccontare Caffi mi è tornato immediatamente in mente Oberti. E per questo ho voluto indagare un po’ più a fondo il personaggio, ricavandone una storia sorprendente.

Ciò che ho sin qui raccontato attiene alla mia personalissima memoria. È tutto ciò che posso dire dell’uomo Oberti come io l’ho conosciuto quasi sessant’anni fa, o almeno tutto ciò che mi era parso significativo.
Quanto segue appartiene invece alla Storia, non solo alla sua, ma a quella di un particolare fenomeno in un particolare momento. L’ho desunto confrontando diverse fonti, tutte quelle cui mi è stato possibile attingere, e penso che quanto ne viene fuori si avvicini accettabilmente alla verità dei fatti.
Infine, l’ultima parte di questo scritto ospita delle riflessioni di carattere generale, che niente hanno a che vedere con una valutazione o un giudizio storico. Dalle letture e dalle ricerche che ho fatto sono nate delle impressioni, che non riguardano solo il personaggio Oberti, e che propongo in funzione interlocutoria, sperando che il discorso non si chiuda qui.
****
Stefano Oberti nasce a Genova nel 1903. Il padre, Zaccaria, è un massone, repubblicano convinto e anticlericale, imprenditore di un certo successo ma sin da giovanissimo portato a cacciarsi nei guai per le sue idee politiche libertarie (anche lui sarà costretto, dopo l’avvento del fascismo, ad emigrare in Francia, dove rimarrà poi sino alla morte).
Stefano si distingue invece in gioventù soprattutto per le passioni sportive, il canottaggio e il calcio: quest’ultimo lo fa entrare in contatto con Sandro Pertini, presidente della compagine universitaria genovese. Non tarda però a seguire le orme del padre e ad essere iscritto nella lista nera dalle autorità del nuovo regime. Come studente di legge fonda infatti l’Unione goliardica italiana per la libertà, che osteggia la riforma Gentile, e ad un convegno internazionale delle federazioni universitarie tenutosi a Varsavia, nel 1924, attacca decisamente gli altri esponenti della delegazione italiana, già allineati col fascismo. La sua attività politica si intensifica dopo il delitto Matteotti, sino a che, una notte del gennaio 1925, viene aggredito da un gruppo di squadristi che lo bastonano fino a sfigurargli il volto. Nell’immediato non vuole demordere, ma quando alla fine dell’estate successiva gli è ritirato il passaporto capisce che è venuto il momento di cambiare aria ed emigra clandestinamente in Francia.
«A Parigi arrivai a fine settembre 1925. Ben consigliato sul da farsi, presi alloggio in un albergo del Quartiere Latino […]. Presentai domanda alle Autorità francesi per ottenere asilo politico e m’iscrissi all’ “Alliance Française” per perfezionare il mio francese. La Sûreté Nationale fece le sue indagini e tutto risultò a mio favore. […] Poi andai ad abitare […] sulla riva destra della Senna, oltre Passy, presso una signora francese che ospitava un altro studente straniero. Questa signora aveva due figlie […]. Esse mi furono di grande utilità, insegnandomi come dovevo comportarmi con le famiglie parigine, molto restie a legarsi con gli stranieri. […] A noi italiani, tutto sommato, il trapianto in Francia è stato facilitato dalla presenza di una forte comunità di connazionali e dalla benevolenza del Governo francese. Io avevo amici fedeli […]. Un anno dopo fui raggiunto in esilio da mio padre. […] Facevamo colazione assieme e con noi c’erano italiani come il figlio del presidente Nitti, […], francesi e spie italiane di cui ingoiavo la presenza assieme alla pastasciutta e ai sughi all’italiana che cucinavano per noi.»

Fa a tempo ad incontrare Gobetti poco prima della morte di quest’ultimo e stringe amicizia con l’avvocato siciliano Teocrito Di Giorgio, personaggio che ricomparirà nella sua vita a più riprese: con la gran parte degli altri esuli, invece, e con le diverse formazioni in cui sono raggruppati, entra quasi subito in conflitto. In un libello sollecitamente pubblicato (Episodi della lotta antifascista) ci va giù particolarmente duro: “Qualche mezza dozzina di persone che pretendono di costituire e monopolizzare il fuoruscitismo ufficiale a Parigi sono un’accozzaglia acefala di esseri privi di senso storico, di coraggio personale molto discutibile, di scarsa volontà e iniziativa e quasi totalmente sprovvisti di quello spirito di indipendenza e di sacrificio richiesto dalla grandiosità della lotta”. Al tempo stesso li accusa di offrire dell’Italia all’estero “l’immagine di un Paese immerso nel terrore da un manipolo di bravi […] ciò che significava divenire ancora una volta lo zimbello dell’Europa”.
I suoi atteggiamenti a volte assurdamente intransigenti, spesso sconcertanti, e comunque sempre confusi e dettati da smania di protagonismo, creano non poco imbarazzo nell’ambiente dei fuorusciti; in qualche occasione però tornano utili e sono sfruttati strumentalmente dalle diverse fazioni dell’antifascismo parigino in funzione delle rivalità che più o meno scopertamente allignano (ad esempio, quella tra i togliattiani e tutte le altre). Di fatto comunque Oberti finisce sempre più isolato, se si escludono tre o quattro “seguaci” che gli si associano per calcolo o per spirito gregario, e di conseguenza diventa sempre più insofferente della sua vita di esule e rancoroso nei confronti dei compagni.
Anche sopravvivere materialmente, in questo isolamento, non è facile, a dispetto delle conoscenze di cui può avvalersi tramite il padre. Per un certo periodo sbarca il lunario grazie al denaro che quest’ultimo gli invia dall’Italia. Quando poi questo viene meno comincia a passare per una serie di occupazioni le più diverse, comunque sempre molto precarie: operaio alla Renault, agente di commercio, corrispondente estero, persino comparsa alla Comédie Française . Non è particolarmente portato per il lavoro, mentre è invece attivissimo nella polemica e nelle iniziative di organizzazione: dà vita a gruppi scissionisti all’interno della Concentrazione antifascista, cerca contatti a destra e a sinistra, pubblica opuscoli come Notre bataille dans les Universités et à l’Etranger, avec versions espagnole et italienne. Fino ai primi anni Trenta continua comunque a ruotare nell’ambito dell’organizzazione, e per qualche tempo è in rapporto anche col gruppo di Giustizia e Libertà.
La situazione internazionale sta però evolvendo. Il governo francese comincia a cercare approcci con il fascismo, che nel frattempo ha ammorbidito i toni e le rivendicazioni. Cresce, di qua e di là delle Alpi, il timore per una possibile salita al potere di Hitler, e vengono opportunamente rispolverate le affinità culturali e i possibili interessi comuni. Anche all’interno del mondo dei fuoriusciti le idee non sono chiare: la maggioranza chiaramente è contraria, ma c’è anche chi vede di buon occhio un riavvicinamento pacifico tra i due paesi.
Di questa posizione si fa immediatamente alfiere Oberti, che su iniziativa personale, senza consultare nessuno, si reca ad esporre direttamente al console italiano di Parigi la concordanza d’intenti del suo sparuto gruppo di seguaci con i due governi in riconciliazione, esprimendosi a nome di tutto l’antifascismo. La notizia si diffonde con la pubblicazione di un’intervista rilasciata al quotidiano La République, e la cosa scatena le ire dei dirigenti in esilio, che si affrettano a sconfessare Oberti e lo espellono dal raggruppamento. Ciò non gli impedirà comunque, nel giugno 1933, in occasione dei funerali di Claudio Treves, di sfilare nella processione silenziosa che segue il feretro, al fianco di Emilio Lussu, di Carlo Rosselli, di Raffaele Rossetti e di Camillo Berneri, e accanto a personalità di spicco della sinistra francese.

Nel frattempo però Oberti ha già intrapreso una nuova strada. È stato chiamato da Alberto Giannini, altro bizzarro e sfuggente personaggio e fuoruscito “pentito”, a collaborare alla rivista satirica Il Merlo. Giannini aveva dovuto rifugiarsi in Francia per aver pesantemente satireggiato col suo giornale Il becco giallo il regime fascista, e ha continuato per un certo periodo a farlo riprendendo la pubblicazione oltralpe e introducendola clandestinamente in Italia: ma ad un certo punto i finanziamenti elargiti dai fuorusciti hanno cominciato ad assottigliarsi ed è venuto meno anche il rapporto di fiducia che lo legava a Carlo Rosselli. Fonda allora una nuova testata, finanziata stavolta dal regime stesso, e finisce sul libro paga dell’OVRA, il servizio segreto mussoliniano. Come racconta Gaetano Salvemini parlando del gruppo dei fuoriusciti a Parigi: “Alberto Giannini era il più faceto della compagnia, finché non passò, nel 1934, dalla sera alla mattina, armi e bagagli, nel campo dei fascisti, il più svergognato caso di voltafaccia che io abbia mai visto”.
Non risulta che anche Oberti sia diventato a pieno titolo un informatore, ma senz’altro non gli par vero scrivere articoli denigratori contro esponenti del gruppo che lo ha cacciato, e più in particolare contro quelli del partito socialista in esilio.
Intanto sta già muovendosi per regolarizzare la propria situazione di emigrato presso il Consolato italiano. Tenuto ormai forzatamente fuori dalla politica, da Parigi si trasferisce a Nancy, e si butta assieme al padre in un tentativo di rientrare nell’imprenditoria, che si rivela fallimentare.
A questo punto non gli rimane che rientrare in Italia, approfittando di una serie di condoni e della prescrizione dei reati per i quali era stato condannato in contumacia (la renitenza alla leva e l’espatrio clandestino). Decide per questa soluzione alla fine del 1938, e se la cava a buon mercato, con soli due mesi di effettiva reclusione. Nel maggio del 1940, all’entrata in guerra dell’Italia, è nuovamente un uomo libero.
Nei primi anni del conflitto Oberti risiede a Milano, dove, a quanto lui stesso afferma, svolge un’attività di intermediazione industriale (della quale peraltro non si ha alcun riscontro). L’occasione di tornare alla ribalta gliela offrono paradossalmente la caduta di Mussolini e la successiva nascita della repubblica sociale italiana nel settembre del 1943. Agli inizi dell’anno successivo rivolge al ministro della Cultura Popolare del regime collaborazionista una serie di richieste dal tono perentorio, com’è nel suo stile, proponendosi come custode dell’autentica tradizione mazziniana contro l’opera di oscuramento e di travisamento compiuta dalla monarchia sabauda. È assecondato in questo tentativo delirante da vecchi compari anch’essi ex transfughi, come l’avvocato Di Giorgio, e addirittura da ex acerrimi nemici, come Gian Gaetano Cabella, fascista della prima ora, direttore de Il popolo di Alessandria (una delle più feroci gazzette dei fasci repubblichini), specializzato in falsi (nel 1948 sarà arrestato per aver pubblicato un falso testamento di Mussolini: ma pubblicherà anche un romanzo, Dieci anni a Parigi, ispirato probabilmente proprio alle vicende di Oberti).
Per quanto confuse e velleitarie le sue richieste (il trasferimento di tutto l’archivio mazziniano da Genova in Alessandria, per sottrarlo al pericolo di bombardamenti, e l’apertura di un Istituto di Studi Mazziniani in quest’ultima città, con lui e i suoi sodali naturalmente a dirigerlo) sono in linea con il tentativo del nuovo regime di prendere le distanze dalla monarchia e di dare una legittimità e una continuità storica alla repubblica pescando nel Risorgimento, e trovano udienza. Insomma, si ripete la storia, anche se cambiano gli interlocutori, che ora sono le autorità repubblichine: Oberti è percepito chiaramente anche da queste ultime come uno spostato (nelle informative dell’OVRA sul suo periodo parigino era definito il “ragazzo semipazzo”), tanto più che ormai va a briglia sciolta e affastella un mare di proposte farneticanti per pubblicazioni (una storia d’Italia illustrata per ragazzi), per cerimonie ufficiali celebrative e rievocative (l’inaugurazione di una lapide alla cittadella di Alessandria, dove era stato imprigionato Andrea Vochieri, con tanto di divi del cinema fascista che officiano in costume), per lavori teatrali, sempre su tematiche patriottiche (una storia d’Italia raccontata per quadri scenici). Eppure alle sue stravaganti iniziative si interessano, e le appoggiano e le finanziano, persino un paio di ministri di Salò, oltre alle autorità locali (anch’esse evidentemente in gran confusione). Questo mentre nei dintorni di Genova e di Alessandria il grande rastrellamento nazifascista di primavera porta alla strage della Benedicta e all’arresto e alla deportazione di centinaia di giovani.
Tanto fervore si spegne però nell’estate del ‘44, dopo che un bombardamento su Alessandria ha coinvolto anche la sede del neonato istituto mazziniano. Oberti si eclissa. Di cosa combini da quel momento non ho trovato notizia negli archivi, ma è certo che non collabora con le bande partigiane genovesi, come invece lui stesso sostiene. Riesce poi evidentemente ad attraversare indenne il periodo post-liberazione, così che nel giro di qualche anno torna sulla scena.
Sul dopoguerra e su come la sfanga nei quaranta e passa anni successivi, a parte la breve parentesi di “convivenza” di cui ho raccontato, so soltanto quel che ho potuto trovare spulciando qualche periodico e qualche quotidiano. Frammenti che sono comunque indicativi e mi confermano quel che già all’epoca avevo intuito del personaggio.
Naturalmente Oberti è sempre in rotta con qualcuno. Dal periodico Il pensiero mazziniano (Anno VI, N. 6, 10 Giugno 1951) veniamo a sapere che “A proposito del comunicato inserito nel numero scorso in cronaca da Genova, ove è citato il dott. Stefano Oberti, questi ci scrive per contestare che l’espulsione sua dalla Sezione di Genova dell’A.M.I. (Associazione Mazziniana Italiana) sia stata allargata all’indegnità morale, oltre a quella politica)”. Sarei curioso di sapere a cosa alludeva l’indegnità morale, ma avendo potuto apprezzare da vicino la sua disinvoltura economica l’allargamento dell’accusa non mi stupisce affatto.
Quindici anni dopo la stessa fonte ci fa capire però che il nostro è stato riaccolto, tanto che «Il 7 settembre, a Parigi, l’amico Stefano Oberti di Genova ha deposto sulla tomba di Piero Gobetti un fascio di garofani rossi di Liguria: sui nastri tricolori era la scritta: “A Piero Gobetti e ai duemila combattenti antifascisti morti in esilio”. Si sono voluti ricordare, nel ventennale della Repubblica, quanti all’estero, a fianco dei repubblicani spagnoli e dei resistenti francesi, si sacrificarono per la libertà» (Il pensiero mazziniano, Anno XXI, N. 8-9, 25 settembre 1966. L’iniziativa è commentata anche su La Stampa dell’8 settembre 1966, pag. 7: Commemorati gli esuli italiani morti in Francia durante il fascismo.)
Sempre La Stampa, nella sua edizione serale (Stampa Sera, 20 luglio 1970, pag. 2: Roma deve darci le spoglie di Mameli), qualche anno dopo ci informa che Oberti ha chiesto il trasferimento della salma di Mameli da Roma al Pantheon di tutti gli esuli invitti dell’umanità costruito a Staglieno. E lo ha fatto in qualità di presidente del Comitato Nazionale per le onoranze agli esuli morti in esilio difensori della libertà dei popoli.
Nella stessa veste l’ho trovato menzionato in GRECIA (mensile di informazione della resistenza greca, Anno II, N. 10-11, ottobre 1970, Nel Pantheon degli esuli) in occasione dell’autoimmolazione dello studente Costas Georgakis. «Il nome di Costantino Georgakis è stato inciso nel Pantheon di tutti gli esuli invitti dell’Umanità al Cimitero di Staglieno. La decisione stata comunicata dal presidente del Comitato Nazionale per le onoranze agli esuli morti in esilio difensori della libertà dei popoli, dott. Stefano Oberti, alla fidanzata di Kostas, con una lettera inviata alla Casa dello Studente. Nella lettera tra l’altro, si legge: “Oggi, dopo avér attraversato quasi mezzo secolo di cedimenti e conosciuto tanti traditori, testimonio che Costas Georgakis fu un eroe, perché volle sacrificare soltanto se stesso, sottraendo ogni altra persona a lui cara agli aguzzini di oggi, di domani e di sempre. Lenito il Suo dolore, Ella ritroverà la pace dei giusti; quella che Costas Georgakis ha certamente ritrovata, morendo in esilio senza compromessi con coloro che umiliano oggi la patria di Eschilo, di Socrate e di Platone, ponendola al servizio dell’imperialismo straniero. Se può esserLe di un piccolo conforto, sappia prima di ogni altro, che, per decisione del Comitato Nazionale per le onoranze agli esuli morti in esilio combattendo per la libertà dei popoli, il nome di Costas Georgakis sarà inciso nel Panthéon di tutti gli ‘esuli invitti dell’Umanità, nel cimitero monumentale di Staglieno in Genova, accanto a quello del drammaturgo greco Eschilo, del poeta inglese George Byron e del patriota interalleato italiano Santorre Annibale di Santarosa, morti per la libertà della Grecia”».
È sempre lui. L’enfasi retorica, gli accostamenti peregrini e l’autocelebrazione recriminatoria sono tipicamente suoi. E a quanto pare è anche riuscito a realizzare, nel 1970, il Panthéon di tutti gli esuli invitti dell’Umanità. Segno che qualcuno ha continuato a dargli fiducia. Tanto da riproporlo, dopo quasi altri vent’anni, come capolista in una competizione elettorale.

Contavo di trovare qualche ulteriore notizia nello scritto autobiografico Esilio a Parigi, redatto quando Oberti aveva ormai superato l’ottantina, ma tutto ciò che ne ho ricavato è l’accenno del prefatore a un eccezionale impegno del nostro per la causa del divorzio. Per il resto è una somma piuttosto confusa di ricordi, tra i quali primeggiano quelli dei sughi e delle pastasciutte, o di avventure galanti piuttosto improbabili. Unica notazione interessante: ha lavorato alle officine Renault quasi contemporaneamente a Simone Weil, ma ne ha tratto un’impressione ben più positiva. In compenso, ci ha resistito ancor meno. C’era da aspettarselo.
****
Non mi sono soffermato così a lungo su questa vicenda per il suo intreccio con la mia aneddotica personale, o per quella malintesa voglia di un protagonismo tutto di riflesso che sembra essere diventata l’unica modalità di autorealizzazione (l’io c’ero, o l’io l’ho conosciuto, i selfie al funerale del papa o sui luoghi di un incidente o di un delitto, ecc.). L’ho raccontata, come dicevo sopra, perché mi sembra aprire ad alcune considerazioni di carattere più generale.
Il tema immediato cui mi rimanda è quello della memoria, e più specificamente quello della “memoria condivisa”. La memoria non coincide con la Storia (intesa etimologicamente, come narrazione dei fatti), anche se ne è uno strumento indispensabile. È una lettura della Storia alla luce di esperienze personali o collettive, vissute o tramandate, comunque sempre parziali, vuoi nei contenuti, vuoi nel punto di vista. Anche la Storia non ci racconta la verità, sappiamo che generalmente la scrivono i vincitori, ma il suo carattere di “disciplina” impone confronti e riscontri che dovrebbero, col tempo, farci approssimare almeno a grandi linee a quanto è veramente accaduto. Insomma, la Storia ci dovrebbe informare di quanto è successo, la memoria ci dice come è stato vissuto quel che è successo.
Ciò rende decisamente improbabile pensare di arrivare un giorno ad una “memoria condivisa”, mentre avrebbe un senso puntare a scrivere una “Storia” il più possibile condivisa. Quanto alla prima, è più probabile che si arrivi ad una sua perdita, che già incombe con la scomparsa degli ultimi protagonisti o degli ultimi depositari dei loro racconti. Per cui, anziché condivisa credo diverrà una memoria confusa, una nebbia entro la quale tutti i gatti saranno grigi e all’interno della quale ciascuno potrà pescare ciò che più gli conviene, e farsene bandiera (come accade oggi, ma come è accaduto anche per tutta la seconda metà del Novecento).
Il problema dunque sta a monte, proprio nel fatto che si insiste sulla memoria, che per forza di cose è partigiana, e non ci si sforza di ricostruire un po’ più fedelmente la storia. Il che vale allo stesso modo per tutte le parti in causa, ivi compresa la sinistra, così che gli argomenti che potrebbero risultare più scabrosi, che andrebbero ad intaccare alcuni miti sui quali si sono costruite le narrazioni e le rivendicazioni politiche dei diversi schieramenti, vengono accuratamente evitati.
Quanto detto sopra è perfettamente applicabile alla storia del fuoriuscitismo italiano. Dopo il libro di Aldo Garosci (Storia dei fuorusciti, Laterza, 1953) scritto settant’anni fa da uno storico più che serio e onesto, ma coinvolto direttamente nella vicenda e uscitone da pochissimi anni, sembra che a nessuno importi di riprenderla, nemmeno infedelmente. Il libro non è mai più stato ristampato, è rarissimo ed è un miracolo se te lo lasciano consultare nelle biblioteche, sempre che lo si trovi. Non a caso, l’argomento trova poco o zero spazio nei programmi di divulgazione storica che vanno per la maggiore in tivù, i vari Barbero e Cazzullo, ma anche Mieli, Augias and co. Non mi è mai capitato, ad esempio, di sentir rievocare il maggio barcellonese del ‘36 e l’uccisione di Berneri. C’è un tabù che ostacola la ricostruzione “critica” dell’opposizione al fascismo: del tipo, gioca coi fanti, ma lascia stare i santi.

Il risultato di non fare mai seriamente i conti col proprio passato, con la propria storia, è quello di lasciare aperta la strada alla rilettura, naturalmente altrettanto poco obiettiva, che ne daranno gli avversari. La motivazione sottintesa (anche quando in realtà ne esistono altre meno nobili) è che non si vogliono concedere armi alla polemica revisionista: ma il non dire tutta la verità, il coprire le macchie confidando che il tempo le cancelli, non è solo fuorviante, è altresì il miglior regalo che si possa fare a quest’ultima. Perché allunga l’ombra del dubbio anche su ciò che è ormai assodato e incontestabile. È accaduto con i vari punti oscuri della Resistenza stessa, con lo stalinismo togliattiano, persino con il Sessantotto. E tanto più questo vale per ciò di cui mi sto oggi occupando. Sono trascorsi novant’anni, ma sembra non ci sia stato verso di imparare la lezione.
Lo dimostra anche un altro fatto. Alla vicenda dei fuorusciti in Francia la nostra letteratura non ha prestato la minima attenzione. Ci sono alcuni libri di memorie, anche notevoli, alcuni diari, qualche saggio, ma non c’è un’opera letteraria che abbia offerto, ai giovani e ai meno giovani, l’opportunità di incuriosirsi per questa pagina di storia. A vent’anni avevo già letto le descrizioni degli espatriati (volontari) americani, da Hemingway a Miller, o di quelli (forzati) russi come Herzen, o alcune cose di Benjamin, ma non avrei potuto trovare alcun italiano che raccontasse queste cose. E temo che chi ne avrebbe avuto magari le capacità si sia astenuto per timore (fondato, stante l’egemonia che per tutta la seconda metà del secolo la sinistra, ortodossa e non, ha esercitato sulla cultura storica) di apparire sacrilego e di essere immediatamente colpito dall’ostracismo.
Prima di proseguire penso dunque mi convenga ricordare sinteticamente in quale reale scenario si sono svolte le vicende che ho scelto di raccontare (quella di Caffi e quella di Oberti, ma già ne avevo parlato nella storia di Berneri): non credo sia molto conosciuto.

Dopo l’avvento del fascismo (ma anche prima del ‘22) ha inizio la diaspora degli attivisti e degli intellettuali di sinistra presi di mira dal regime, spesso aggrediti anche fisicamente e comunque impediti a svolgere qualsiasi attività, non solo quella politica. La migrazione verso la Francia procede a ondate, aumenta dopo il delitto Matteotti e conosce un ulteriore incremento dopo che nel 1926 vengono emanate le leggi speciali. A metà degli anni Trenta gli aderenti ai movimenti politici antifascisti ospitati in terra francese possono essere valutati in oltre diecimila, e ad essi va aggiunto un numero almeno doppio di simpatizzanti, reclutati direttamente in loco tra i migranti economici. I più attivi e i più organizzati in questo senso sono i comunisti, che lavorano soprattutto attraverso l’UPI (Unione Popolare Italiana) e dispongono anche di un organo di stampa.
Socialisti riformisti e massimalisti, repubblicani, liberali, mazziniani, massoni, ecc… confluiscono invece nella Concentrazione d’azione antifascista, all’interno della quale però ciascun gruppo mantiene la propria autonomia e ampia libertà di azione. Come a dire che poi ciascuno fa un po’ come gli pare.
Gli esuli purtroppo si portano appresso le rivalità che già avevano caratterizzato la sinistra in patria nell’immediato dopoguerra. Lo schieramento antifascista rimane quindi costantemente diviso, sia per divergenze di ordine ideologico, sia per il contrasto di tipo generazionale. Tanto che la maggioranza degli oppositori preferirà il silenzio alla militanza attiva. E le contrapposizioni sono anche accese, risentendo delle continue oscillazioni provocate a metà degli anni Trenta dal mutare delle direttive politiche di Stalin: così che quando si passa dal tacciare di social-fascismo le componenti che non orbitano attorno al bolscevismo ad incoraggiare la costituzione dei “fronti popolari”, e i comunisti entrano a far parte della Concentrazione antifascista, la convivenza si rivela da subito problematica. Ancor più lo sarà verso la fine del decennio, dopo la negativa esperienza spagnola e di fronte ai voltafaccia dell’URSS nei confronti della Germania nazista.

Quale sia l’atmosfera nell’ambiente dei fuorusciti italiani in Francia tra la metà degli anni Venti e la Seconda guerra mondiale lo si evince bene, forse ancor meglio che dal saggio già citato di Garosci, dalle Memorie di un fuoruscito (Feltrinelli, 1960) di Gaetano Salvemini. Rispetto ai compagni d’esilio Salvemini era senza dubbio un privilegiato, visto che i suoi lavori storico-giuridici gli avevano già procurata un notorietà internazionale che gli permetteva di trascorrere molto tempo all’estero, ad esempio negli Stati Uniti e in Inghilterra, con incarichi di insegnamento nelle più prestigiose università o per giri di conferenze; mentre il suo passato di intransigente antifascista della prima ora gli garantiva credibilità e autorevolezza presso tutti i diversi gruppi. Questa condizione gli consentiva d’altro canto un punto di vista più equilibrato rispetto a quello di coloro che al di là dell’antifascismo propugnavano poi specifiche soluzioni politiche o ideologiche (primi tra tutti naturalmente i comunisti, che infatti lo avversarono costantemente).
La sua posizione è perfettamente espressa nel documento di presentazione di Giustizia e Libertà che redasse nel 1932 (ma l’organizzazione era già nata nel 1929). «Giustizie e Libertà è un’organizzazione di lotta rivoluzionaria antifascista in Italia, e raggruppa a questo scopo in Italia gli uomini di tutti i partiti di sinistra, e gli uomini fuori partito, purché di idee democratiche e repubblicane, che sono disposti a mettere a rischio la vita per la lotta rivoluzionaria contro la dittatura fascista […] Questi uomini, che in tutti i partiti e fuori di tutti i partiti formano una esigua minoranza – una vera e propria “compagnia della morte” che si batte nelle trincee più avanzate e più pericolose, non debbono rimanere in gruppi indipendenti. Debbono coordinare i loro sforzi contro il nemico comune. Debbono tenersi affiatati gli uni agli altri. Non hanno tempo e non vogliono discutere quel che sarà l’Italia dopo che la dittatura fascista sarà abbattuta.»
Quanto poco questo intento fosse comune lo si vide proprio in occasione dei diversi atteggiamenti assunti rispetto ai fronti popolari che si avvicendarono nell’Europa occidentale negli anni Trenta. L’interesse di partito veniva sempre anteposto a quello della causa comune.
Ma c’è dell’altro, ed è questo che tengo a mettere in luce. Sempre Salvemini, nelle sue memorie scrive: “La mia persuasione era – ed è tuttora – che su tre cospiratori uno è una spia; il secondo è uno scioccone, che per vanità di parere bene informato, racconta alla spia quanto sa sul terzo; e il terzo e il secondo vanno in galera, grazie al primo. D’altra parte il terzo, se non fa niente per paura dello scioccone e della spia, non andrà in galera, ma non farà niente, cioè lascerà padrone delle acque il nemico”. Ragion per cui: “bisogna correre il rischio di andare in galera, e alla fine andarci. Cioè bisogna obbedire alla legge del proprio temperamento, quanto al resto, sarà quel sarà”.
Cosa ci sta dunque dicendo Salvemini? Innanzitutto che prima di accapigliarsi su quel che sarà il futuro sarebbe bene affrontare il più possibile uniti, e provare a sconfiggere, l’avversario presente. Cosa che a leggere un resoconto sull’atteggiamento dei fuorusciti antifascisti nei due anni precedenti lo scoppio del conflitto c’è da mettersi le mani nei capelli (cfr. Leonardo Rapone, I fuorusciti antifascisti, la Seconda Guerra Mondiale e la Francia). Divisi sino all’ultimo momento e ostinatamente decisi a farsi la guerra, come i capponi di Renzo.
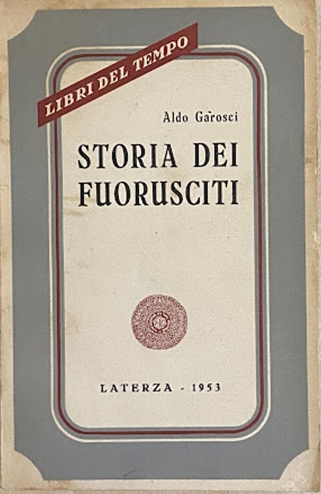
Poi, che anche prescindendo dalle divisioni e dalle contrapposizioni politiche occorre tenere conto di quelle che sono le differenze umane. Che cioè non sono tutti eroi e sinceri paladini della libertà coloro che bazzicano l’opposizione, e che la bontà di una causa e l’eccezionalità della condizione di espatriati politici non è da sola una garanzia di genuinità. Dice cioè ciò che sappiamo tutti (o che dovremmo sapere): le situazioni vanno affrontate con realismo, se vogliamo darci almeno una possibilità di uscirne vincitori. E realismo non significava, nella particolare situazione in cui Salvemini si trovava ad operare, cinismo o spregiudicatezza, ma massima prudenza, discrezione, parsimonia nell’accordare fiducia. Invece “In Parigi nessuno credé necessario preoccuparsi […]. L’ambiente formicolava di spie, ma anche di persone che non capivano la necessità di tenersi in guardia dalle spie”. Persone che alla fine hanno obbedito “alla legge del proprio temperamento”, hanno cioè scelto di correre coerentemente il rischio, ma troppo spesso questa scelta l’hanno pagata cara
Realismo perciò significa anche, se applicato alla rilettura storica di quella vicenda, mettere in evidenza questa debolezza, l’autolesionismo derivante dai facili e malriposti entusiasmi che hanno da sempre caratterizzato la storia della sinistra. Se si rimuovono queste cose per non scalfire l’immagine di eroi e martiri ormai incorniciati in santini (oggi magari in poster), se si imbelletta la realtà per farla coincidere con le proprie ideologie e strategie, si ottiene l’effetto opposto: i valori etici della resistenza ad ogni forma di totalitarismo vengono affidati al mito, così come i suoi protagonisti, e questo significa imbalsamarli in una dimensione che non ha più alcuna valenza di esemplarità, perché troppo lontana dalla realtà.
Prendiamo il caso di Camillo Berneri, che è quello che conosco meglio. Se qualcosa ho amato nella sua personalità, insieme alla schiettezza e al coraggio, è la capacità di prendere atto dei tanti errori commessi per eccessiva fiducia nella lealtà altrui, senza comunque arretrare di un passo nell’impegno. Al tempo stesso però non posso negare che, al netto della fulgida testimonianza di eroismo, la lezione più importante da trarsi dalla sua vicenda sia quella dell’inutilità, oltre che dell’inopportunità, delle azioni “dimostrative” mirate (come recitava ancora il terrorismo degli anni di piombo) a “colpire il cuore dello Stato”. Si può tenere il suo ritratto nello studio, come faccio io, si può opporre la sua lucidità e coerenza, nonché tutta la complessità del pensiero anarchico, all’imbecillità, all’ignoranza e alla riduzione in slogan omeopatici che ne fanno i sedicenti anarco-rivoluzionari odierni, ma si deve avere ben chiaro che su un piano prosaicamente pratico tutto quell’eroismo non ha sortito granché.

Lo stesso realismo andrebbe poi impiegato nella narrazione dell’acquiescenza di quasi tutto il popolo italiano al regime, quella che era già denunciata, prima ancora che la guerra avesse termine, da un altro giovanissimo fuoruscito (questo in Svizzera): «Va anzitutto definito quello che si intende precisamente col termine «fascista» per colpirlo e eliminarlo inesorabilmente come realtà – insieme al vocabolo “antifascista” (troppo generico ormai e ambiguo) – dalla vita italiana. Non è mai esistita una dottrina fascista; sono invece esistiti (e esistono tuttora, ben lungi dal tramontare) una mentalità e un costume fascisti: irridenti – sul piano politico – alle nozioni di libertà, di democrazia, di dignità civile (cose degne dello “stupido diciannovesimo secolo” per gli “uomini nuovi”), e – sul piano morale – alle forme del vivere onesto, prudente, vigilato (“vecchio gioco” per chi voleva forzare gli altri a “vivere pericolosamente”). […] Da allora l’abdicazione è venuta crescendo, la responsabilità allargandosi per cerchi concentrici a masse sempre più vaste fino ad abbracciare la quasi totalità del popolo italiano. La complicità – tolta qualche voce clamorosa – è stata fatta di silenzio e d’assenso». (Ariberto. Mignoli, Epurazione, su Giovane Italia, 10 aprile 1945, n. 5).
Vent’anni prima queste cose le aveva già scritte anche Andrea Caffi, che sull’anelito degli italiani alla libertà (e alla verità) nutriva giustamente i suoi dubbi. E infatti: ancora oggi noi sappiamo tutto su I volenterosi carnefici di Hitler, e quanto alla complicità collettiva del popolo tedesco ci chiediamo se sia vero che “La Germania si che ha fatto i conti col nazismo”, ma su un sincero esame di coscienza nostro ci andiamo cauti. Tanto cauti che a furia di autocompiacerci per l’immagine artificiosa di una gente italica disposta comunque al buono e al bello stiamo già arrivando alla riabilitazione del regime.
C’entra tutto questo con le vicende parallele eppure divergenti (per cui non si incontrerebbero neppure all’infinito) di Caffi e di Oberti? C’entra eccome, perché l’accostamento riguarda solo la condivisione della condizione di fuorusciti, mentre il modo in cui questa condizione è stata vissuta dai due e quello in cui è stata recepita da coloro che l’hanno condivisa con loro mettono a fuoco piuttosto il contrasto.
Senz’altro entrambi viaggiavano in asincrono rispetto ai loro compagni di sventura: ma mentre a questa differenza di ritmo il primo cercava di ovviare con una presenza ferma e tuttavia discreta, non invasiva, anzi piuttosto elitaria, che lo faceva apprezzare da tutti coloro che lo conoscevano, l’altro la differenza la rimarcava costantemente, autoproclamandosi unico genuino custode dei valori dell’antifascismo ed entrando immediatamente in conflitto con tutti. La differenza non concerneva però solo i modi della partecipazione, il primo sempre sottotraccia, nell’ombra, il secondo amante delle celebrazioni, dei rituali, del centro della scena; riguardava anche, e soprattutto, i valori per i quali si battevano. Caffi europeista, cosmopolita, anarchico, Oberti nazionalista sfegatato, cultore del mito della patria e della nazione, legato alle consorterie massoniche, ecc.
Ora, capisco che il parallelo tra i due possa sembrare già in partenza assurdo: in effetti, pur con tutta la divertita simpatia che all’epoca della coabitazione Oberti mi ispirava, mi rendo conto che sto mettendo a confronto due livelli di umanità incomparabili. Caffi era un puro, con tutto ciò che di affascinante, ma anche in qualche misura di escludente, questa disposizione comporta. E infatti si è tenuto, ed è poi stato volutamente confinato, a margine, perché la sua intransigente purezza fissava dei parametri troppo alti. Oberti era un mitomane squinternato, e d’altro canto lui stesso confidava che “i ferri del chirurgo penetratimi mediante incisioni all’interno delle fosse nasali mi hanno scosso la cassa cranica”. Non so quanto i suoi squilibri fossero stati determinati o acuiti dalla bastonatura, sono propenso a pensare che non fosse del tutto in quadra nemmeno prima. Anche se, a scanso di equivoci, rimango convinto che pure in mezzo a tutte le sue palesi contraddizioni Oberti fosse sempre sinceramente convinto della legittimità e bontà del proprio operato (il che poi in molti casi è ancora più grave, ed è un problema comune a tanti apparentemente più coerenti di lui). Ma, ripeto, non è tanto il personaggio in sé ad intrigarmi quanto piuttosto il fatto che per settant’anni qualcuno abbia potuto continuare a prenderlo sul serio.

Li ho accomunati solo perché mi sembrano incarnare significativamente gli estremi dell’ampio spettro di modalità nelle quali la condizione dell’esule, e nella fattispecie dell’esule antifascista, poteva essere declinata. E perché giustificano le domande che Garosci si poneva a caldo nella presentazione del suo tempestivo studio: “Chi sono stati i fuorusciti? Come hanno influito sul destino dell’Italia? Si può porre un problema generale dei fuorusciti, oppure si danno problemi e soluzioni diverse per diversi periodi e personalità?” Domande cui la ricerca storica, della quale Garosci auspicava che la sua Storia fosse solo un punto di partenza, non ha in realtà ancora dato risposte soddisfacenti.
Quanto poi al motivo per cui due vicende e due personaggi ciascuno a suo modo così singolari sono finiti nell’oblio, potrebbe sembrare legato al fatto che in definitiva entrambi, sul piano pratico, hanno combinato poco o nulla. Ma questo, se vogliamo essere sinceri, vale in fondo anche per tutti gli altri loro compagni d’esilio. Io credo invece che il motivo stia per l’uno nel non aver lasciato eredi “istituzionali”, partiti, movimenti, congreghe, che avessero interesse a coltivarne la memoria, magari anche strumentalizzandola; per l’altro in una rimozione mirata a spazzare la polvere sotto il tappeto. Rispetto al quadro che della resistenza degli esiliati si voleva dare, uno ne era fuori, l’altro è stato coperto dal bordo esterno della cornice. A volte la “menzogna utile”. contro la quale si battevano tra i fuorusciti soprattutto Caffi e Chiaromonte, non ha nemmeno bisogno delle “post-verità”, può servirsi altrettanto proficuamente dei silenzi. Nel caso dei miei due protagonisti, poi, l’esclusione dalla memoria e l’assenza di una lettura distintiva non solo dà luogo ad una palese ingiustizia, ma tace una realtà, e quindi non insegna nulla.
Qui volevo arrivare. Ho forzato questo confronto, senza la pretesa di dare il minimo contributo alla ricostruzione della verità storica, semplicemente per offrire un esempio di come la melassa acritica e celebrativa finisca per appiattire o addirittura azzerare i valori, e di quanto sarebbe invece necessario operare delle distinzioni proprio per ristabilire e riaffermare la pregnanza di questi ultimi.
Al di là dei risultati concreti, infatti, rimane comunque l’importanza della testimonianza etica, in positivo o in negativo, che può essere lasciata in eredità, e che tanto più in questi tempi di carestia morale andrebbe recuperata. Proprio per questo il loglio andrebbe separato dal grano, con una ricostruzione documentata di chi ha fatto davvero cosa, e di come, e del perché. Quanto ai nostri, senza scendere ulteriormente nel dettaglio, è evidente che se Caffi apparteneva al novero ristretto di coloro che vivono sentendosi sempre in debito, Oberti è il prototipo, al di là della sua ‘stranezza’, di chi si sente sempre in credito. E tutta la vicenda racconta di come anche nei gruppi più selezionati, addirittura nei gruppi in cui la selezione la fa la sventura, questi ultimi esistono, e non sono pochi, e nella gran parte dei casi sopravvivono e hanno modo di raccontarla alla loro maniera.
Mentre i primi, come testimonia Primo Levi ne I sommersi e i salvati, le rare volte in cui scampano provano quasi rimorso per non avere seguito la sorte di chi è rimasto sul terreno.

vignetta di Mauro Biani, 2024
Riferimenti bibliografici
Per le notizie relative alla vita e alle attività di Oberti sia in Francia che Italia sono debitore soprattutto degli studi (e delle indicazioni) di:
Donato D’Urso, Quando la pietà era morta. Aspetti della guerra civile 1943-1945, Bastogi libri, 2015
Donato D’Urso, Stefano Oberti, in Tuttostoria.net, 29/03/2015
Altre informazioni le ho attinte in:
Emanuela Miniati, La migration antifasciste de la Ligurie à la France dans l’entre-deux-guerres: familles et subjectivité à travers les sources privées (Tesi di dottorato in Storia contemporanea discussa presso Université Paris X Ouest Nanterre-La Défense, Anno accademico 2014-2015)
Emanuela Miniati, Antifascisti liguri in Francia. Caratteristiche e percorsi del fuoriuscissimo regionale, in Percorsi Storici, 1 (2013)
Trattazioni più generali sulla migrazione antifascista in Francia sono in:
M. Franzinelli, I tentacoli dell’OVRA, Torino. 1999
Aldo Garosci, Storia dei fuorusciti, Laterza, 1953
Leonardo Rapone, I fuorusciti antifascisti, la Seconda Guerra Mondiale e la Francia, in Persée pubbl. dell’École Française de Rome 1986 n. 94 (fa parte del numero tematico: Les Italiens en France de 1914 à 1940)
Gaetano Salvemini, Memorie di un fuoruscito, Feltrinelli, 1960
Fedele Santi, Storia della Concentrazione antifascista, 1927-1934, Feltrinelli, 1976
Fedele Santi, I Repubblicani in esilio nella lotta contro il fascismo (1926-1940), Le Monnier, 1983
Simonetta Tombaccini, Storia dei fuorusciti italiani in Francia, Mursia, 2022
Degli scritti di Oberti ho potuto consultare solo
Esilio a Parigi. 1922-1943 Il ventennio fascista raccontato da un fuoruscito, Lanterna, 1984
Non Ho rintracciato Mazzini perseguitato dai Savoia (Alessandria, 1944), né Episodi della lotta antifascista, mentre presso l’Istituto Storico Toscano della Resistenza, Archivi di Giustizia e Libertà è consultabile Notre bataille dans les Universités et à l’Etranger, avec versions espagnole et italienne (Parigi, 1927?)



