a cura di Paolo Repetto, 30 ottobre 2018
 Salva diversa indicazione, tutti gli scritti riportati nella presente raccolta sono tratti dal sito http://www.bibliotecaginobianco.it
Salva diversa indicazione, tutti gli scritti riportati nella presente raccolta sono tratti dal sito http://www.bibliotecaginobianco.it
La verità del dialogo. Un ritratto di Nicola Chiaromonte
Fra cinici e gesuit
La nuova sinistra
Prigioni in Spagna
Pierre J. Proudhon – un pensatore scomodo
Parole confuse
A lume di ragione
Carissimo Andrea
Violenza e non violenza
Stato e minoranze rivoluzionarie
Chiaromonte, l’America e “l’etica del limite” nell’età dell’estremismo
di Matteo Marchesini
Nel Novecento, la mitizzazione più appariscente ed equivoca della Grecia antica è stata tentata dai filosofi che hanno esaltato le fonti presocratiche, giudicando tutta la storia del pensiero da Socrate e Platone fino alla modernità come un compatto processo di razionalizzazione – cioè di tradimento e d’impoverimento – delle originarie verità tragiche e sapienziali racchiuse in quelle fonti. Per questi filosofi, la scienza strumentale e tecnocratica che asservisce l’uomo moderno è figlia legittima dell’idealismo platonico. Si tratta di un mito derivato dalle intuizioni antropologiche ed estetiche di Nietzsche, addomesticate in senso metafisico o magari esoterico, e accordate alla fascinazione primitivistica di molta cultura “decadente”. Il suo cantore più noto è Heidegger, ma sue versioni degradate e spesso involontariamente parodiche sono diventate luoghi comuni tardonovecenteschi grazie a numerosi ripetitori del tipo di Emanuele Severino. Questo mito non è rimasto estraneo neppure a correnti filosofiche molto distanti: come la Scuola di Francoforte, che ha cercato a sua volta di stabilire un legame tra l’“illuminismo” tracotante della società di massa e le sue presunte origini classiche.
Ma altri intellettuali, più o meno coetanei del secolo breve, hanno proposto un modello di rapporto meno appariscente, meno pretenzioso e forse più fecondo con queste origini. La loro passione politica, e il bisogno d’interrogare i testi per capire “come vivere”, li hanno preservati da ogni sacerdotale profondismo e da ogni retorica accademico-apocalittica, esattamente per le stesse ragioni per cui li hanno tenuti lontani dalle ideologie del progresso. La loro Grecia non ha nulla di ebbro o estetizzante; e non ha neanche i lineamenti sommari di chi se n’è fabbricato una immagine di comodo solo per leggervi in controluce i destini moderni. Gli intellettuali a cui alludiamo amano il loro oggetto di studio, e quindi ne rispettano la complessità e la distanza; ma al tempo stesso, e proprio per questo, sentono l’urgenza di dialogare in modo insieme umile e coraggiosamente diretto con le parole e le idee dei poemi epici e dei tragici, dei primi filosofi e di Platone.
Pensiamo ad Hannah Arendt, a Simone Weil. Ma pensiamo anche al meno noto Nicola Chiaromonte (1905-1972), che si confrontò con entrambe: che, come la Weil impegnato nella guerra civile spagnola, ragionò con parole simili alle sue sull’incapacità moderna di sottoporre a un «limite» i comportamenti e di esaminare eticamente la «forza»; e che come la Arendt, conosciuta negli Stati Uniti, sostenne l’irriducibilità della violenza a «mezzo» teoricamente giustificabile e analizzò i paranoici circoli viziosi delle ideologie contemporanee, contrappose al loro cieco dinamismo un immaginario spazio politico dai connotati teatralmente greci e radunò attorno a sé piccoli gruppi di amici con cui leggere i classici
2.La storia di Chiaromonte, liberalsocialista sui generis o meglio libertario singolarmente religioso, si potrebbe raccontare almeno in parte riferendosi a quella delle riviste con le quali entrò in contatto, senza peraltro quasi mai identificarcisi. Ventenne già convinto dell’assolutezza dei valori morali, esordì sul «Mondo» di Giovanni Amendola e sulla protestante «Conscientia». Collaborò a «Solaria», che attraverso lo schermo della letteratura riuscì ad aprirsi alla cultura europea, e a preservare alcuni frutti dell’eredità gobettiana, negli anni in cui Mussolini eliminava le opposizioni. Consegnò lungimiranti analisi del fascismo ai «Quaderni» di Giustizia e Libertà, gruppo che frequentò nell’esilio parigino degli anni Trenta e che poi abbandonò con gli altri giovani “proudhoniani” legati ad Andrea Caffi. Sbarcato in America all’inizio della seconda guerra mondiale, lasciò una forte impronta nel dibattito degli intellettuali radical newyorchesi scrivendo sulla «Partisan Review» e su «politics», oltre che sulla salveminiana «Italia libera». Infine, tornato nel dopoguerra in patria, divenne il critico teatrale del «Mondo» liberal-progressista di Mario Pannunzio, e redasse con Ignazio Silone «Tempo presente», un mensile che criticò senza sconti il totalitarismo comunista ma anche la cultura e la tecnica politica delle società affluenti occidentali, e che, pur traendo ispirazione dalle tradizioni del socialismo democratico care a entrambi i direttori, non si fece portavoce di nessuna proposta terzaforzista.
Purtroppo, a differenza di quelli di Arendt e Weil, gli scritti di Chiaromonte restano quasi introvabili. Da decenni, i grandi editori italiani li rifiutano o li mandano rapidamente al macero. Onore quindi a «Una città», bellissima rivista libertaria forlivese e degna erede dei migliori periodici politico-culturali del secolo scorso, che oggi si fa editrice pubblicando Fra me e te la verità. Lettere a Muska. Si tratta di un carteggio tra Chiaromonte e Melanie von Nagel (1908-2006) curato da Wojciech Karpiński e Cesare Panizza, e venuto alla luce dopo un lungo lavoro di scelta svolto nei decenni scorsi dalla corrispondente insieme alla vedova dello scrittore.
In un intellettuale così socratico, che non si preoccupò di pubblicare libri, e che alimentò le sue riflessioni saggistiche attraverso un continuo dialogo con gli amici, le lettere non sono una trascurabile appendice all’opera. Specie se i destinatari somigliano alla von Nagel. Nata dall’unione tra un aristocratico bavarese e una ricca newyorchese, cresciuta in Italia e vissuta in America, sposata a un pittore daghestano e poi, dopo la morte del marito, entrata in un’abbazia del Connecticut come suora benedettina, questa donna coltissima e poliglotta doveva avere una qualità magnetica, se colpì tanto l’austero Chiaromonte – che secondo la sua amica Mary McCarthy diffidava per istinto delle donne intelligenti – e se in seguito riuscì a nutrire anche le idee di un altro critico radicale della modernità come Ivan Illich. La qualità della von Nagel non possiamo verificarla qui direttamente (nella raccolta, purtroppo, di suo ci sono soltanto due lettere, qualche verso e alcuni disegni), ma traspare dal pathos e dall’insolita esaltazione del suo sobrio corrispondente italiano.
Nicola e Melanie, affettuosamente chiamata Muska, si conobbero nel ’57 a Roma, subito prima che lei intraprendesse il noviziato; ma il coup de foudre risale al viaggio statunitense compiuto da Chiaromonte nel ’66 per tenere a Princeton le lezioni da cui nacque la sua raccolta di saggi Credere e non credere (Bompiani 1971, già pubblicata l’anno prima in Gran Bretagna col titolo The Paradox of History). Dopo quel viaggio, il magro carteggio precedente diventa un dialogo fittissimo. Per un lustro, fino alla morte, Nicola scrive a Melanie più di seicento lettere, circa una ogni tre giorni. E nel frattempo si attenuano anche le sue perplessità sulla monacazione dell’amica: perplessità ben comprensibili, se si pensa a quel chiaromontiano animo “greco” che – lontano in ciò dalla Weil – non crede alle risoluzioni personali delle crisi religiose, perché ritiene queste crisi dipendenti dall’esistenza collettiva, e quindi superabili solo collettivamente.
Citando i sonetti di Shakespeare, Chiaromonte definisce il rapporto con Muska un «marriage of true minds»; si riferisce più volte al Simposio, e arriva a parlare di «amor cortese». Tra questi due esseri umani così fuori dell’ordinario, così affamati di vita e insieme così a disagio nel mondo, era nato un legame molto stretto. La lontananza, e le differenti scelte esistenziali, contribuivano a sublimarlo: ma senza placare un bisogno fortissimo di condivisione. Spesso Nicola esprime la sua sofferenza per l’impossibilità di un dialogo faccia a faccia; e quasi per fisicizzare la relazione, oltre a scambiare foglie, fiori e immagini, si sofferma sulla salute di lei, si preoccupa dei suoi dolori, o si commuove con tenerezza tra amorosa e paterna davanti alle confessioni della sua sonnolenza.
Ma ciò che più importa è che in queste 250 pagine di carteggio si ritrovano in scorcio tutti i temi centrali della riflessione chiaromontiana, espressi a volte in una forma sintetica e lapidaria di rara efficacia, anche perché irrobustita da quei riferimenti biografici che negli articoli sono di solito pudicamente esclusi.
Com’è naturale, le lettere riflettono in primo luogo i fatti, le circostanze e le occasioni che nell’ultimo scorcio degli anni Sessanta caratterizzarono la vita di Chiaromonte e l’attualità pubblica. Si parla del movimento studentesco e dei faticosi traslochi romani, della fine di «Tempo presente» (con la morte di Pannunzio, la fine di un’era) e dell’inizio della collaborazione col non amato «Espresso», dei viaggi tra i circoli intellettuali europei e degli articoli sul Vietnam della McCarthy, delle passeggiate con l’impegnativa vedova Camus e della solida amicizia con Gustaw Herling, dello strutturalismo e di Aleksandr Solženicyn, del nuovo teatro grotowskiano e della stesura di Credere e non credere (per cui l’autore cerca un titolo diverso dall’esatto ma pomposo L’uomo e l’evento).
Ognuno di questi argomenti è però quasi sempre filtrato dal riferimento a un contesto classico, è contrapposto o associato a una dominante “passione greca”. Da questa passione scaturisce anche lo stile, che è poi più o meno lo stesso dei taccuini antologizzati in Che cosa rimane (Il Mulino 1995): quei taccuini da cui Nicola ricopia brevi brani per Melanie, e da cui trae lo scheletro dei saggi più impegnativi. Si tratta di uno stile spoglio e geometrico, incolore e perentorio. Ogni argomentazione vi appare scarnificata da un implacabile rasoio occamiano. In Chiaromonte, come nella Weil, un rigore intransigente e una quasi fanatica castità intellettuale tendono a bruciare tutti i falsi intrichi “psicologici”, tutte le capziose zavorre culturalistiche, per arrivare a contemplare le questioni nella loro nuda, platonica essenzialità. Per questi autori, riflettere significa subito verticalizzare, portare alle conseguenze estreme un’ipotesi e accettarne stoicamente, fino in fondo, la logica e fatale cupezza. Ma è una cupezza che, come la disperazione della lirica leopardiana, regala anche il rovescio di una gioia energetica, corroborante: la gioia che si prova, weilianamente, davanti a tutto ciò che ci restituisce un primario e irrefutabile senso di realtà, davanti a tutto ciò che ci strappa alla confusa opacità in cui ci agitiamo quando restiamo invischiati nei compromessi quotidiani, o chiusi nell’immaginario dei nostri desideri. Sia Weil che Chiaromonte pensano che vivere in pienezza significhi scontare la sofferenza senza menzogne, esporvisi senza alibi o risarcimenti ideologici. Solo così s’impara a circoscrivere ciò che dura, oggettivo e indistruttibile, al di là dei torbidi, passeggeri e dunque “irreali” stati d’animo privati, e al di là delle moderne riduzioni del vero, del bello e del buono a questioni d’impressione soggettiva. Solo così si può sperare di spezzare le catene della «bestia sociale», e di sottrarsi per un attimo alla cattiva infinità di un mondo centrato sui miti dell’individuo e della Storia.
- A questo proposito, anche nelle lettere a Muska è centrale la polemica chiaromontiana contro l’«egomania» dei contemporanei, cioè contro la loro totale mancanza di senso del limite. Al Leitmotiv dell’hybris Nicola ritorna sempre, qualunque sia lo spunto cronachistico della lettera. Ci torna, magari, dopo aver tracciato per la sua corrispondente “reclusa” qualche schizzo delle civiltà in cui si muove nei suoi rapidi viaggi culturali: una Venezia ancora umana ma architettonicamente improbabile, un’Inghilterra che il tradizionalismo mantiene meno alienata e più coesa del resto d’Europa, una Parigi mutante ai cui stanchi riti da chiesa moderna partecipano giovani ormai simili a una nuova «razza», una Trieste ariosa e «strana» (aggettivo già usato dallo “psicologo” Saba, comprensibilmente mai citato), una Napoli irredimibile eppure capace di umanizzare perfino la paccottiglia plastificata della nuova industria… Ma sempre al suo Leitmotiv ritorna, Nicola, soprattutto quando fisicamente torna a Roma: massimo simbolo decadente, squallido e intollerabile, dell’atomizzazione e dell’insensatezza della vita tardonovecentesca. Questa vita, ribadisce a Muska, concepisce se stessa come una «pura fuga d’istanti». Gli uomini che la sperimentano, nuovi «barbari per volontà», non trovandovi un senso che superi i loro volubili desideri diventano incapaci di una vera, durevole comunicazione, e guardano alla morte come a un fatto insopportabile perché non redimibile da nessun “progresso”. Così non resta loro che lasciarsi trascinare da un’avida quanto disperata volontà di successo, e dall’illusione di poter possedere sempre più oggetti.
Per Chiaromonte, l’egomania è il frutto di un umanesimo privo del senso del sacro: un umanesimo che è assoluto proprio perché relativizza tutto, facendo degli individui l’unico metro di misura, e destinandosi quindi a sfociare in una disumanità massificatrice o pseudoribelle. L’obiettivo panumanistico resta «le plus grand bonheur du plus grand nombre». Ma ciò che davvero si può procurare non è la felicità, bensì soltanto il surrogato del benessere: e per produrlo, i moderni hanno dovuto piegarsi in massa alla logica dello sviluppo meccanico. La maggiore felicità del maggior numero si è tradotta perciò nella maggiore servitù del maggior numero.
Il primo vero profeta di questo umanesimo resta Rousseau, il «teorico della democrazia totalitaria» che in una folgorante lettera a Muska Chiaromonte associa agli hippie, citando una frase in cui il filosofo contrappone al teatro del suo tempo un progetto di feste spettacolari all’aria aperta già simile all’«invito a un “love-in”». L’autocoscienza ultima dell’egomania è invece l’esistenzialismo alla Sartre, un pensiero dove la libertà assume un aspetto mostruoso, prefigurando una condizione umana insieme gratuita e coatta.
L’umanesimo assoluto esclude dal suo orizzonte ciò che trascende l’uomo, ma proprio per questo non ha poi il coraggio di confrontarsi senza paracadute ideologici con l’effimero, con la fragilità intrinseca della vita. E’ il contrario della visione greca, per la quale l’individuo vive fino in fondo la fugacità della sua esperienza proprio perché si sente «tramite del durevole». In questo senso Chiaromonte dice a Muska che i Greci sono il popolo più religioso del mondo mediterraneo. A differenza di romani ed ebrei – di cui anche la Weil diffida – tra il «sentimento diretto delle cose» e il loro «modo d’essere» non frappongono infatti la volontà di stabilire leggi e convenzioni che li proteggano dal mutamento: e «il sentimento del “sacro” è molto più profondo nell’animo di colui che si considera “inerme” di fronte al tempo». I greci chiaromontiani sono una comunità permeata da un rispetto oggi inconcepibile del «divino», ossia di ciò che nella natura, nelle azioni e nei sentimenti degli uomini resta sempre nascosto, e indica il confine delle nostre forze e della nostra capacità di comprensione: «il senso del sacro non è altro che il senso del “limite” (…) di essere parte di un tutto che non si conosce».
Mentre scrive queste riflessioni a Muska, così Chiaromonte le fissa nel saggio La bestia meccanica, pubblicato su uno degli ultimi fascicoli di «Tempo presente»: «L’egomania, che solo la necessità materiale e la forza tirannica possono contenere, è il male della società contemporanea; l’odiosa prigione dell’io in cui l’individuo viene a trovarsi rinchiuso è la forma della schiavitù di cui siamo vittime. Male e schiavitù provengono dalla convinzione radicalmente empia secondo cui il mondo appartiene all’uomo, ed egli può farne quel che gli talenta; e così la vita è proprietà esclusiva di ogni individuo, e ogni individuo ha il diritto di usarne e abusarne come vuole. Una tal convinzione nega tutto ciò che nel mondo è nascosto, indicibile, arcano; si fonda su un’ignoranza cocciuta del mondo stesso e delle più umili verità d’esperienza, prima delle quali è la dipendenza in cui ognuno si trova dai propri simili per cominciare, ma, più profondamente e essenzialmente, dall’insieme delle cose, dal loro ordine, quale esso sia e comunque lo si chiami».
- Di questa dipendenza, di questo «arcano» non sappiamo nulla, e pretendere d’imbrigliarlo in qualche legge o d’intravedere nel mistero un disegno è tracotanza: in questo senso, per Chiaromonte anche la Provvidenza è un’idea che «diminuisce la divinità del divino», come scrive a Muska senza nessun accento polemico, ma senza nemmeno velare ciò che lo separa dal cattolicesimo di lei. Anzi, con la sua opera l’autore di Credere e non credere vuole mostrare anche come l’abominevole culto moderno delle azioni storiche e dei fatti compiuti non sia altro che la laicizzazione di questa idea cristiana. Il solo fatto di concepire un Dio incarnato nella Storia induce infatti a leggerla come un unico sistema, e a ricondurre tutte le vicende umane sotto un unico significato generale. Nasce allora il provvidenzialismo, che rapidamente viene mediato dalla Chiesa, la quale finisce per vedere nella durata del suo puro potere mondano un segno della propria santità. Nel frattempo, dalla stessa teologia sorge e si libera un razionalismo tritatutto che porta alla reincarnazione del divino nelle cose, al mito laico del progresso. Poi, tra Sette e Ottocento, davanti ai contraccolpi inauditi della rivoluzione francese, questo mito inizia a trasferirsi dall’interpretazione della natura a quella dei rapporti sociali, partorendo il determinismo storicista. In modo più tirannico di qualsiasi religione, un tale determinismo aliena all’uomo il senso della propria vita, perché lo rende schiavo della società e delle manifestazioni della sua stessa volontà di potenza. Ignorando la dipendenza delle loro esistenze dal cosmo, cioè da un «tutto» inconoscibile, i moderni credono di possedere incondizionatamente e di potere incondizionatamente controllare, con la ragione e con l’azione, le dinamiche sociali e tecniche che vanno via via scatenando. A differenza dei greci, dice la Weil, considerano la forza sprigionata dal gioco delle loro relazioni come un fatto meramente fisico e non morale: sono così convinti dell’idea secondo cui ognuno si forgia da sé il proprio destino, che non hanno neppure una parola adatta a esprimere il concetto di «nemesi». Il loro errore sta nell’estendere il paradigma delle scienze naturali, e in particolare della fisica, alla storia, al mondo umano, alla realtà tout court e ai problemi ultimi, impoverendoli e condannandosi a un deprimente vuoto ideale. In una lettera a Muska, Nicola cita un passo dove Bertrand Russell osserva come la «astratta fisica del nostro tempo» ci chiuda in una prigione «senza splendore», senz’anima. E’ un passo in cui il progressista, l’empirista per eccellenza della filosofia novecentesca sembra avvicinarsi a culture da lui lontanissime. Nelle sue parole riecheggiano quelle del fenomenologo Husserl, e perfino quelle di Rimbaud sul «forçat (…) sur qui se referme toujours le bagne», citate altrove da Chiaromonte per descrivere lo Stato moderno. Ma soprattutto, il giudizio di Russell richiama in questo contesto la diagnosi della platonica e iperidealista Weil, secondo cui «dal rinascimento in poi (…) l’idea della scienza è quella di uno studio il cui oggetto è posto al di fuori del bene e del male», e «se i fatti, la forza, la materia vengono isolati e considerati di per sé, senza relazione con altro, non v’è in tutto ciò proprio nulla che un pensiero umano possa amare». La Weil fa esplicito riferimento alla differenza con la scienza greca, ancora fortemente connessa a una compatta visione etica e cosmica. Abbozza addirittura una critica dell’algebra come pratica livellatrice (la paragona al denaro), e in generale stigmatizza le tecniche che non producono saggezza, che permettono di inventare senza pensare. Anche la Arendt affronta il tema, e si chiede che effetto abbia l’impossibilità di tradurre il codice sempre più influente della scienza moderna nel linguaggio pubblico: ossia che effetto politico produca l’evidente incapacità di questo codice di dare un senso alla realtà comune, la sua tendenza a creare un mondo artificiale dove la conoscenza si scolla dalla riflessione. Si può rispondere che l’effetto è appunto la nascita di una ideologia della scienza, cioè di una pseudoteoria che estende ingannevolmente il paradigma scientifico all’intera cultura anche quando in apparenza vi reagisce, come ostentano di fare gli storicismi idealistici e finalistici che inseguono una verità superiore a quella matematica, fisica o biologica. Questa ideologia pretende di assimilare gli atti umani ai fatti di natura, e quindi di poter spiegare e prevedere razionalmente le dinamiche relative a esseri mai analizzabili nella loro integrità: pretende, in definitiva, di poter rivelare una volta per tutte le origini sempre oscure del complesso di moventi che ci induce a muoverci e a condizionarci a vicenda. Così, caduta ogni fede nel trascendente, si cerca la verità proprio dove non può darsi: cioè nel terreno dell’azione, della Storia, della suprema contingenza. Ne risulta quello che il Chiaromonte di Credere e non credere definisce come un paradossale «scetticismo teologico» o «dogmatismo scettico»: da un lato si è così sfiduciati da puntare tutto sull’attimo nel quale si agisce, ma dall’altro lato si giustifica il più effimero dei gesti affermando che «la storia lo esige». Qui sta l’aporia dello storicismo, per cui «l’Oggi è il Domani, il senso della vita di oggi sta nel Domani, un Domani storico di cui l’oggi non è che l’oscura cifra. La formula è oracolare, ma riassume molto efficacemente quella fede ottimistica nella Storia – cioè nell’armonia prestabilita fra le aspirazioni umane e il corso degli eventi – che fa dell’esistenza il fantasma di se stessa, rinviandone il significato all’infinito, cioè annullandolo».
E questo oracolo grottesco, com’è ovvio, è elaborato in primo luogo dagli intellettuali: che quindi, anziché essere autentiche guide e “avanguardie” della società, nel mondo contemporaneo tendono a massificarsi prima delle masse, a sacrificare il proprio pensiero ai feticci ideologici e alla Storia con maggior zelo e con più imperdonabile falsa coscienza.
Fino all’inizio del Novecento, prima del ’14, questi feticci erano ancora in parte un mito vero, una credenza diffusa e legittima nel progresso storico. Ma la carneficina assurda della guerra l’ha fatta crollare («E’ ciò che fa rovinare i miti, la realtà», dice Chiaromonte nella Bestia meccanica). Da allora in poi, la gran parte degli uomini finge di confidare nel progresso, ma in verità non fa altro che arrendersi, tra ipnotizzata e inerte, a un meccanico succedersi di eventi schiaccianti, a un mondo «nudo e insensato», e alla fatalità di una crescita puramente tecnologica. E’ ormai in malafede che si pronuncia il proprio credo nella democrazia e nel miglioramento universale: nei comportamenti quotidiani, si oscilla invece tra nichilismi e improbabili restaurazioni “religiose”.
- La guerra, secondo Chiaromonte, ha colpito al cuore soprattutto la versione più avanzata della credenza nel progresso umano, e cioè il socialismo, che dagli anni Venti in poi s’è irrigidito in una ortodossia sempre più tirannica quanto più profonda era la disillusione riguardo alla sua autentica vitalità. E l’ortodossia ideologica, di nuovo, non è altro che una versione laicizzata, umiliata e parodica della fede cristiana. Il cristianesimo infatti, afferma Chiaromonte, ha trasformato il flessibile significato antico del «credere» in un dogmatico «voler credere» (e qui si pensa ancora alla Arendt, che in La vita della mente spiega come la civiltà cristiana, gettando una luce inedita sull’esistenza interiore, abbia posto al centro delle sue riflessioni appunto la «volontà», tema quasi assente nei filosofi antichi). Il credere greco, il credere naturale implica una costante coscienza dell’ambiguità che è inscindibile dalla relativa robustezza sociale di ogni credenza; implica, soprattutto, la capacità di accettare e assorbire nella propria visione la mutevolezza del mondo così come appare, in tutte le sue sfaccettature: quella mutevolezza che i greci rappresentavano guardacaso nelle figure di mutevoli dèi, sottoposti anch’essi a un Fato impenetrabile. Invece il Dio dei monoteismi, isolato e onnipotente, si stacca dalla realtà umana in un modo che costringe poi chi tenta di concepire il loro legame a impantanarsi in volontaristici sofismi. Il cristiano, per aver fede, deve escludere dal proprio orizzonte religioso una gran parte di ciò che sperimenta nell’esperienza quotidiana, e in cui dunque, nel senso greco e chiaromontiano, dimostra comunque di “credere”: crea cioè nella vita quella scissione, notata suo malgrado anche dalla Weil, che tende a sfociare in un irrigidimento pericoloso e che a un certo punto si fissa nella doppiezza del gesuitismo. E’ dalla mondanizzazione moderna di un simile irrigidimento che scaturisce la tendenza ad addomesticare empiamente la realtà, a leggere un univoco senso della vita nella Storia, a fornire «spiegazioni ultime» che pretendono di disfarsi della varietà delle apparenze. L’esempio più chiaro è quello di Marx, secondo cui l’economia sarebbe “più reale” di tutto il resto, ossia costituirebbe l’essenza dei fenomeni più diversi. Ancora peggiore è l’ortodossia dei marxisti del pieno Novecento, che trasformano un’ipotesi teorica in un angusto dogma, e che poi si disfano anche del dogma per imporre una tattica di partito impermeabile non solo alla realtà, ma anche alla logica, e destinata a mutare ora per ora. Propagandati con le armi, sostenuti da una disciplina coercitiva sempre più capillare e spietata, i tattici “dogmi del giorno” coincidono col potere terrorizzante delle dittature comuniste. E tuttavia, come Chiaromonte ha visto per tempo e come hanno visto con lui Orwell e la Arendt, la rapidità del loro succedersi denuncia la corsa dei sistemi totalitari verso un fatale autoannichilimento: per quanti sforzi di sottomissione faccia, la coscienza normale degli uomini non è in grado di adattarsi a venerare idoli che cambiano volto ogni mattino.
- Mentre tenta di chiarire queste intuizioni nei saggi di Credere e non credere, Chiaromonte ripete a Muska che la storia non può avere in sé la sua ragione, che è solo un seguito di «atti insensati», e che somiglia alle «rovine che lascia dietro di sé un cataclisma – o anche i rifiuti che trascina un torrente». Parole così lapidarie spiegano l’irritato interesse con cui, nel frattempo, segue un fenomeno che sembra appunto condensare e bruciare in un’estrema, cupa parodia le falsità enfatiche della recita politica e culturale otto-novecentesca, le sue oscillazioni apparentemente schizofreniche tra idolatria del Corso Storico e pseudoanarchia nichilistica. Questo fenomeno è il Sessantotto occidentale, presto egemonizzato dai giovani che in una lettera alla sua corrispondente americana definisce «pedanti ribelli». Approdato, come in modo diverso il suo coetaneo Adorno, a una riflessione sempre più geometricamente pessimistica riguardo alla possibilità d’intrecciare teoria e prassi, anche Chiaromonte giudica la rivolta «conformista». E il conformismo sta nel fatto che per contestare la società esistente i rivoltosi ne accettano e ne estremizzano le patologie, cedendo al suo caos senza avere il coraggio di andare al cuore dei problemi. I giovani occidentali non mettono in questione il meccanismo dell’estensione illimitata dei bisogni, e non si pongono domande radicali sul significato dell’esistenza. Ereditano placidamente il culto del Nuovo, del successo egomaniaco che tutto assolve, dell’azione per l’azione e magari della guerriglia per la guerriglia. Il loro guevarismo, il loro maoismo è solo una moda, un atteggiamento assunto a costo zero. Come Pasolini e Arbasino, e come oltreoceano il suo amico Dwight Macdonald, anche Chiaromonte nota che questa ripetizione frivola di vecchi errori è legata al rifiuto di confrontarsi con le generazioni precedenti. E’ un rifiuto comprensibile, dato che quelle generazioni sono prive di ogni autorevolezza; ma ciò non toglie che il suo prezzo sia un’ennesima versione del moderno settarismo. Da una parte si diffonde la pedanteria subculturale, dall’altra dilaga un attivismo giovanilistico senza argini né obiettivi seri, che a un ex ragazzo degli anni Venti non può non ricordare un’esperienza sinistra. In particolare il Sessantotto italiano, nato in una società senza ordine né libertà, ma «fondata invece sul disordine illiberale e sulla disobbedienza coercitiva», rischia di sfociare subito in una demagogia del tutto o niente, e in una ricattatoria sofistica da demoni dostoevskiani in sedicesimo.
Questo almeno, dice Chiaromonte, accade a ovest. Diversa è la rivolta dei giovani dell’est, che si battono per liberarsi dall’oppressione politica, cioè per qualcosa di molto più chiaro e importante. Ma ai giovani intellettuali d’Occidente, e agli intellettuali non più giovani che li corteggiano pateticamente per inseguire l’ultima incarnazione dello Spirito del Tempo, una tale rivolta sembra “ottocentesca”, “sorpassata” dalle punte più avanzate della Storia. Convinti di possedere già la libertà «come si possiede un mobile», considerano questa esigenza basilare della vita umana meno rilevante di qualunque nebulosa ideologia palingenetica dell’ultimo minuto, di qualunque pseudonovità “storica” pubblicizzata dalle cronache dei media.
Come si vede, i giudizi di Chiaromonte sulle azioni dei movimenti politici occidentali sono duri almeno quanto quelli che dà del comunismo applicato. Tutto gli appare ormai inquinato dall’idolatria degli «atti insensati». Ma se le cose stanno così, cosa opporre in concreto al fatalismo storicistico? Le lettere a Muska, e gli scritti coevi, sembrano avvicinare lo scrittore a un altro tipo di fatalismo, che potremmo definire laotsetiano. Dopo avere attraversato le tragedie del Novecento, Chiaromonte è ormai lontanissimo dal suo volontarismo di ventenne cresciuto nella cultura dei Gobetti e dei Tilgher. Ora non vede più nella massificazione un’opportunità per disfarsi dell’inerzia individuale e per riaffermare le istanze morali assolute con una decisione finalmente pura e libera da equivoci. Nato in una terra dove il passaggio d’innumerevoli popoli ha lasciato in eredità alla gente un misto indefinibile di rassegnazione e orgoglio, questo maturo uomo del sud rifiuta in modo sempre più netto non soltanto l’idea della violenza rivoluzionaria, ma anche ogni visione che attribuisce più importanza alla volontà di fare il bene anziché alla volontà di tenere fermo il vero.
Di nuovo, davanti a questi passi delle lettere, torna in mente la Weil. Ci si ricorda delle parole con cui la pensatrice francese contesta il catechismo cattolico (così cavilloso che non basterebbe una vita a esaminarlo), e della nettezza con cui gli oppone il bisogno dell’intelligenza di restare totalmente libera nel suo legittimo campo d’azione. E’ altra, per lei, la facoltà destinata a contemplare e onorare i dogmi. «L’intolleranza» dice con una frase quasi chiaromontiana «deriva da una confusione tra i modi di credere»; e aggiunge senza reticenze che il potere amministrativo della Chiesa e la formula «anathema sit», con la conseguente confusione dei piani e il conseguente tentativo di ostacolare la ricerca del vero in nome di un malinteso bene, ha aperto la strada alle derive totalitarie moderne.
Partendo da una concezione distante del cristianesimo, ma da un’idea platonica del bene pur sempre sorella di quella weiliana, Chiaromonte insiste con altrettanta forza sulla necessità che l’intelletto rispetti nella sua sfera soltanto i vincoli che si pone da se stesso. La sua polemica però, anche quando tocca la religione, lo fa per puntare dritto alla politica. Nelle lettere, con una definitività brusca e quasi liberatoria, ripete che qualunque progetto umano finalizzato al bene, quando offende il vero, è destinato a sfociare nella violenza. E’ la violenza di chi crede di poter forzare gli esseri e le cose a diventare ciò che non sono. «Voler “cambiare” significa voler far violenza a ciò che è», scrive a Muska, «non credere nella semplicità delle cose che sono (…) credere fanaticamente alle apparenze, ossia che cambiando, per così dire, la disposizione degli oggetti nel mondo si cambi radicalmente il mondo stesso. Mentre a me sembra che il mondo si cambi unicamente (…) grazie a norme accettate, al modo di vivere degli uomini stessi».
Le speranze palingenetiche di origine cristiana, e la fede moderna nel progresso che ne deriva, coincidono con l’idea che sia possibile introdurre nel mondo una novità radicale. Chiaromonte non lo crede. Come non crede alla concezione lineare del tempo che questa idea implica, e che anche la filosofa della Vita della mente associa al modo tutto cristiano e moderno di concepire la libertà e la volontà. Toccando un tema caro a Karl Löwith (non a caso, come la Arendt, discepolo di Heidegger), Nicola dice a Muska che la saggezza sta invece nell’intuire i segni di quella sostanziale, greca ciclicità del tempo che Nietzsche sbandierava in modo ancora volontaristico, e che la vita ci mette davanti agli occhi ogni giorno contraddicendo le nostre ideologie. L’universo che abitiamo non sembra affatto trasformabile nei suoi oscuri elementi primi, ma semmai infinitamente «mutevole» nella sua permanenza, come il mare così amato dal mediterraneo Chiaromonte e dal mediterraneo Camus.
I sogni di novità assoluta hanno sempre qualcosa di empio o retorico: vogliono disconoscere la realtà così come ci è data, o non tenerne conto, in nome di una pretesa centralità delle aspirazioni umane. Indimenticabile, a questo proposito, è l’esempio che Chiaromonte propone nella Lettera a Caffi edita in Il tarlo della coscienza (Il Mulino 1992). La dichiarazione di Ivan Karamazov, tanto celebre e universalmente amata, secondo cui varrebbe la pena di rifiutare il proprio biglietto per il Paradiso davanti al pianto di un solo bambino, a lui sembra «teatrale e incomprensibile», perché «l’idea di un mondo senza bambini che piangono» è «coestensiva di un mondo senza bambini affatto». Viceversa, «senza pretendere al Paradiso», Chiaromonte vuole soltanto «vedere le cose come sono (e non create da me)». Secondo la Weil, questa visione della realtà si ottiene sospendendo la volontà che il mondo si pieghi ai nostri desideri. E Nicola, rivolgendosi a Muska, le fa eco assimilando la purezza di un tale sguardo alla capacità di «fermarsi al limite», «riconoscere il sacro – e il divino – piegare il capo – inchinarsi». Un simile riconoscimento morale non può tradursi in leggi o convenzioni, come vorrebbe la mediocre saggezza, ma può solo derivare di volta in volta da un ambiguo “avvertimento” davanti alla situazione concreta.
Chiaromonte tende dunque a identificare i progetti di palingenesi con una violenza menzognera. E per spezzare la catena di azioni e reazioni che questa violenza accerchiante produce, per contrastare gli atti di forza con cui gli uomini provano a imporre alla società la loro visione del mondo, gli sembra non rimanga altra risorsa che una mite separatezza, una saggia inazione interrotta solo per concedere alla politica quel che le è strettamente dovuto dal punto di vista del «buon cittadino» (a questo dovere limitato si può ricondurre, nel ’56, la eccezionale adesione chiaromontiana al Partito Radicale).
Al limite, manifestazione di un tale spirito potrà essere la «non violenza», su cui ragionò in modo analogo anche la Arendt. Ma Chiaromonte è convinto che la non violenza non possa diventare norma d’azione pratica e universale senza rischiare di tradursi essa stessa in violenza, o comunque di snaturarsi: resta, per lui, niente di più e niente di meno del comportamento che alcuni singoli individui altamente civilizzati sono in grado di tenere allo scopo di arrestare l’effetto domino del male, o, come direbbe la Weil, allo scopo di sospendere l’ordine inerziale della forza. Rappresenta, insomma, una nobile accettazione del destino: è la coscienza, fatalmente destinata a un’autentica aristocrazia, che vale ciò che cresce nella sua intrinseca verità senza forzature – è il rifiuto di violare più del necessario la natura delle cose, la capacità d’indirizzare il proprio amore sulla realtà circostante in maniera non dispotica e non servile.
In sintesi, all’orizzonte non si vede alcuna soluzione collettiva dei mali moderni: forse, anzi, l’idea stessa è contraddittoria. E Chiaromonte, teorico delle credenze che si consolidano senza volontarismi, si tiene ben lontano da velleità edificanti. Tuttavia, tornando sempre da capo alle stesse conclusioni fosche, anche nelle lettere a Muska insiste sulla sola immagine di speranza offerta da tutta la sua opera, un’immagine che è in qualche modo l’altra faccia del “laotsetismo”. Si domanda, Chiaromonte, se prima o poi l’illimitato e coatto bisogno di dominio non condurrà i moderni davanti a un’aporia così insormontabile, a un baratro così profondo da costringerli a tornare a misurarsi con le eterne questioni essenziali, a fermare lo sguardo sul problema del divino senza equivoci deterministici o soggettivistici arbitrii. Allora forse, dietro le false fedi, dietro i nichilismi irriflessi e perciò tracotanti, nascerà in loro un «nichilismo positivo», un modo d’essere in grado di confrontarsi nuovamente con le nude cose e con le scelte elementari tra il vero e il falso a cui i contemporanei sfuggono istante dopo istante fino alla morte. Solo a quel punto si potrà ritrovare la comune consapevolezza del fatto che la realtà degli eventi e la realtà del pensiero, la contingenza di ciò che accade e l’ordine continuo delle idee sono separati da un confine sacro e inviolabile. Si riscoprirà così che le utopie sono modelli destinati a nutrire la vita spirituale, cioè a tradursi solo mediatamente e per vie inimmaginabili nei comportamenti pratici; e che perciò volerle trattare come progetti politici palingenetici è mostruoso come sarebbe mostruoso per il poeta voler vivere la sua poesia. Coloro che sbandierano le utopie come programmi d’azione immediata cadono nell’equivoco bovaristico intrinseco a ogni storicismo: si vedono cioè come «personaggi storici». E negli ultimi due secoli, dall’età napoleonica al Sessantotto, le prime vittime di questo equivoco dagli effetti stupefacenti sono stati prevedibilmente i giovani: il Fabrizio stendhaliano che vuol essere sicuro di vivere una «vera battaglia», i Sorel e i Raskolnikov che si atteggiano a Napoleoni, e i loro eredi novecenteschi di Sartre e di Kundera che mitizzano le nuove figure rivoluzionarie.
«Nella mentalità “storicista”» scrive Chiaromonte a Caffi «la Storia diventa quel che è (…) la Prosa per il Borghese Gentiluomo», o «quel che l’America è per i selvaggi di Pascarella», e per i beoni romani che ne raccontano le avventure all’osteria. Nella vita collettiva moderna, e da ultimo nella fiammata movimentista dei giovani sessantottini travestiti da guerriglieri, a causa della confusione tra i ragionamenti e i fatti «il pensiero diventa una forma immaginaria d’azione, e l’azione una forma immaginaria di pensiero». Con l’effetto di una pessima recita, al tempo stesso potenzialmente sanguinosa e kitsch. Una recita ingigantita, nel pieno del Novecento, da quei media di massa che danno un senso ancora più semplificato e mistificatorio all’aggrovigliata frammentarietà degli eventi, e a poco a poco addirittura li producono e li sostituiscono.
- Come la Arendt, ma senza la sua fiducia “agostiniana”, Chiaromonte ritiene che ogni azione inneschi processi irreversibili quanto imprevedibili, sia «un atto libero e nuovo, un’aggiunta al mondo e una modifica dello stato di fatto». Non sopporta quindi di essere considerata come l’esecuzione di un modello teorico che separi disinvoltamente mezzi e fini. In politica, ciò squalifica ogni machiavellismo, sia quello di piccolo cabotaggio, sia quello che pretende di realizzare le utopie: perché entrambi la riducono a tecnica, ad applicazione di un meccanismo, cioè pretendono di «possedere il segreto del reale», quasi che la loro “realtà” non sia la riduzione indebita del «segreto» a un modello quantitativo semplicistico e fazioso, sorretto quando può e come può dall’argomento della forza.
La Arendt, però, fa risalire l’errore addirittura a Platone, osservando che già nei suoi testi l’«agire» tende a confondersi col «fabbricare». Chiaromonte, invece, non muove accuse al suo mito filosofico. Secondo lui, Platone non fa altro che proporre le sue utopie come «statue di parole». Scrivendo a Muska, ripete che l’autore della Repubblica non è un idealista nel senso moderno, ossia un uomo che s’illuda di realizzare le proprie idee. E forse, al contrario di quel che dicono le storie della filosofia, non è nemmeno un idealista in senso assoluto. Forse, come suggeriva Caffi, Platone è addirittura uno «scettico»: un ragionatore che sottopone continuamente le ipotesi alla prova del dialogo, lasciandole sospese in una zona ambigua e non smettendo mai d’interrogarsi. Si tratterebbe, insomma, di un filosofo che ha già ben chiara la differenza indicata dalla Arendt in La vita della mente: quella che corre tra la «conoscenza», sempre strumentale, e il «pensiero», incapace di raggiungere obiettivi stabili, e mai applicabile alla realtà senza conseguenze violente o nichilistiche. E’ attribuendo al suo Platone questa gratuita e feconda mobilità teorica che Chiaromonte può opporlo ai moderni, e trarre dalla sua lettura la liberatoria «allegria» di cui dice a Muska. La proverbiale spietatezza delle utopie platoniche, spiega alla corrispondente americana, non ha niente a che vedere coi fanatismi del Novecento. Dipende semplicemente dal fatto che quando si costruisce un’architettura ideale, le si può dare un senso non effimero soltanto estremizzandone con coerenza i presupposti. «Riflettere significa proprio spingersi al limite dei significati possibili», afferma altrove; ed è infatti questa consequenzialità netta, estrema e magari unilaterale, che Chiaromonte insegue negli scritti suoi e dei suoi autori. E’ questa necessità di andare fino in fondo che lo appassiona nella tragedia greca e nel Tolstoj critico dell’arte, davanti a cui continuano a scandalizzarsi i tanti «spiriti mediocri» a tal punto immersi nei sofismi moderni da essere ormai incapaci di tornare alle questioni prime dalle quali quei sofismi sono derivati.
Confrontarsi con la coerenza, con la purezza economica e con la verticalità proprie del vero pensiero, non significa affatto perdersi nell’irreale: perché in questi caratteri sta anzi la peculiare, specifica realtà delle idee e delle rappresentazioni scaturite dalla mente umana, una realtà che solo il fanatismo e il filisteismo si ostinano a negare, riducendo artificiosamente l’esperienza a ciò che si vede, si fa e si tocca.
Questo bisogno di ricordare ai suoi contemporanei l’esistenza di una realtà non pratica riconduce spesso Chiaromonte a un episodio della storia filosofica ricco d’implicazioni metaforiche: la prova ontologica dell’esistenza di Dio. Anche nelle lettere a Muska, come nei taccuini e nei saggi, lo scrittore la cita affascinato. E ciò che lo affascina è il fatto che l’Essere immutabile e perfetto, concepito da quell’essere imperfetto e transeunte che è l’uomo, ha davvero una esistenza necessaria, ma come «esigenza del pensiero», di quel pensiero che è appunto una parte ineliminabile della nostra vita. «Il fatto di concepire “un essere del quale è inconcepibile che ne esista uno più grande” – l’Essere Supremo» argomenta Chiaromonte «ne implica l’esistenza non come di un “oggetto” – ma di una necessità tale del pensiero che, senza di essa, il pensiero non può pensare che il contingente – l’occasionale – questa o quella cosa, come capita, ma non mai esser certo di essere in rapporto con la realtà delle cose. Soltanto che io direi che ciò non “dimostra” il Dio dei teologi, bensì il “divino” in sé – l’inevitabile necessità del “vero” – al di là di ogni fatto casuale e, soprattutto, di ogni cosiddetta “verità di fatto”».
Non a caso, negli stessi anni, la Arendt che nella Vita della mente separa conoscenza e pensiero, verità di fatto e ricerca di «significato», fa proprio lo stesso esempio, e indica nella dimostrazione di Sant’Anselmo una di quelle ricerche mai concluse in cui l’uomo pensa attraverso sistemi di idee eterne e inverificabili (nei termini della mistica Weil, invece, l’inverificabilità riguarda il piano dell’amore soprannaturale necessario a contemplare i dogmi di fede).
Chiaromonte, come Arendt e Weil, mira insomma a restituire alla riflessione non immediatamente traducibile in prassi quel suo insostituibile posto nel mondo reale che i moderni a torto le negano. Anche perché la sua astrattezza, la sua “inconcludenza” non coincidono affatto con una sua presunta inutilità in senso assoluto. Sebbene esista un confine sacro che separa eventi e idee, non si può infatti dimenticare la funzione essenziale che le idee hanno nel metterci in rapporto «con la realtà delle cose». Nei taccuini, Chiaromonte cita una dichiarazione di Tolstoj secondo cui la realtà più vera è addirittura quella che non esiste, e che tuttavia proprio per questo conosciamo con certezza: «la linea dritta, la verità esatta e la virtù perfetta». Soltanto «grazie all’ideale», dice Tolstoj, «sappiamo qualcosa» del mondo, cioè diamo forma a ciò che altrimenti è insensato. Così, ricorda Chiaromonte, solo nella «irrealtà» dell’arte, nella contemplazione teorica delle sue figure ci è dato conoscere davvero le passioni, le figure, le vicende umane che nella quotidianità rimangono un brulichio d’impressioni opache e ottuse.
- Ma questi discorsi acquistano il loro significato pieno solo se legati a un altro tipico concetto chiaromontiano, il concetto di «comunità»: unico spazio, secondo lo scrittore, in cui potrebbe ricostituirsi un certo equilibrio tra azioni sensate e pensieri non sofistici. Questa «comunità» è l’opposto di quell’anonima società globale dove gli uomini, soli in mezzo alla massa, fronteggiano alienati e impotenti dei fenomeni che minacciosamente li sovrastano. Per Chiaromonte la cosiddetta comunità mondiale è un’astrazione, perché «la comunità reale non può mai essere universale». E pur non rinunciando a ragionare, com’è ovvio, sui grandi problemi del suo tempo – le architetture teoriche, dopotutto, servono anche a questo – arriva a scrivere a Muska che anche «la “sorte dell’umanità” mi sembra un concetto astratto». Non dimentica che tutto è in qualche modo collegato a tutto: ma sa che è velleitario pensare di muoversi su un palcoscenico planetario come se fosse il proprio giardino. La comunità ha senso solo se mantiene una misura umana. Ed è, naturalmente, la misura mitica della polis: quella che la Arendt tenta di ritrovare in certe «repubbliche elementari» moderne, e che il più fiducioso Illich prova a realizzare nelle sue antiburocratiche istituzioni «conviviali». Ma si tratta di forme fragilissime. Scomparsa la miracolosa invenzione cittadina dei greci, semplifica Nicola nel suo dialogo con Muska, sembra di assistere a una enorme interminabile diaspora di individui erranti. Qua e là, alcuni di questi individui hanno provato a ricreare delle labili forme di “città”: prima con il monachesimo (altrove Chiaromonte cita entusiasta i versi di Dante sui seguaci di San Benedetto resistenti alla «brutalità del secolo»: «Qui son li frati miei che dentro ai chiostri/fermar li piedi e tennero il cor saldo»), e in seguito con le alleanze tra i dotti. Nelle sradicate società moderne, è comunque difficile che la comunità possa darsi come realtà visibile: quando c’è, sarà piuttosto formata da pochi individui sparsi per il mondo che nutrono idee abbastanza simili sulla vita umana.
E’ questa l’esile «comunità» che Nicola costruisce coi corrispondenti come Muska, e che ogni tanto riacquista una provvisoria concretezza fisica grazie agli incontri di qualche gruppo di studio. E’ interessante, a questo proposito, il rapporto che legò Chiaromonte ai suoi amici libertari newyorchesi. Durante l’esilio statunitense, di comunità concrete l’intellettuale italiano parlò molto, stimolato anche dal suo empatico confronto con Camus, che durante una visita a New York aveva auspicato la nascita di piccole «società nella società». E non a caso la McCarthy – che considerava la conoscenza di Chiaromonte un evento decisivo della propria vita – ne fece l’ispiratore e «Fondatore» della cittadina rurale di Utopia, rappresentata nel suo romanzo L’oasi. Ma l’autrice sapeva bene quanto il suo amico diffidasse delle immediate realizzazioni delle utopie, perfino di quelle così circoscritte: e infatti lungo tutto il racconto, che lo evoca in un leggendario Monteverdi il cui limpido metafisico pensiero si riassume tutto nella «idea di limite», Chiaromonte resta lontano e invisibile, impegnato a lottare in un’Europa pericolante; mentre i compagni, ritiratisi nella loro utopica comunità di campagna, finiscono per smarrirsi in battibecchi goffi e sterili, descritti con una verve critica e satirica che utilizza molti argomenti chiaromontiani. Le idee dell’italiano, che aveva corretto le superstizioni attivistiche e ancora un po’ marxistiche degli amici americani col suo rigore filosofico e col suo esempio morale, servono insomma alla McCarthy non soltanto per evocare un sogno, ma anche e soprattutto per indicare l’improbabilità della sua realizzazione.
A Muska, Nicola dice che è stato Caffi, suo «solo vero amico e maestro», a insegnargli il valore delle comunità ristrette. Però il vagabondo Caffi, se da un lato appare più solitario e idiosincratico, dall’altro resta assai più affamato di socievolezza del suo allievo. In questo ultimo rappresentante del socialismo libertario fiorito prima del ’14, il mito comunitario è legato a uno spirito caotico ancora ottocentescamente, fiduciosamente agitatorio e malgrado tutto “pansociale”, che non si ritrova più nei discorsi chiaromontiani sulla possibile «secessione» e «separazione» di piccoli gruppi dal complesso della società.
In ogni caso, il modello resta: solo, ora il suo valore politico è tutto indiretto, e la comunità immaginata sembra raccogliersi sostanzialmente intorno alle idee e alla cultura, a una “scettica” discussione socratica da cui emergono però seri giudizi morali ed estetici. Questo modello non nasce da uno sprezzo elitario, ma dalla consapevolezza che in certe situazioni, come nelle società di massa occidentali del tardo Novecento, ogni tentativo d’impegnare le proprie convinzioni in qualche azione ad ampio raggio mette inevitabilmente gli uomini in una posizione irreale e falsa. Ma a dire il vero, anche qui il comunitario Chiaromonte è più netto e più radicale. Senza alcuna soddisfazione pseudoaristocratica, ma anzi col dolore di chi è costretto a prendere atto di una inspiegabile ingiustizia, si ritrova a constatare che il «numero» svaluta e disumanizza fisiologicamente qualunque esperienza. Così è per la scuola, così è in generale per le organizzazioni sociali; e così è per quella comunicazione di massa in cui ormai consistono e si annullano sia l’agire cosiddetto politico sia le relazioni sociali quotidiane. Questa comunicazione, proprio perché si vuole universale, si riduce a un codice di segnali poverissimo, che tende a svuotare ogni vero dialogo. «Sono arrivato alla convinzione» scrive Chiaromonte a Muska «che la parola ha senso solo per quelli per i quali è stata pronunciata – ed è stata pronunciata nella convinzione che potessero capirla. Ogni parola. Ossia che non c’è falsità più grande di quella di un supposto linguaggio “per tutti”: cinema, televisione o altro congegno che sia. Un linguaggio “per tutti” dev’essere necessariamente una convenzione, un artificio, una falsità – giacché, essendo rivolto a tutti per essere (soi-disant) compreso da tutti, sarà anche necessariamente rivolto a nessuno in particolare: a nessun “individuo”, voglio dire». Solo in una comunità ristretta i gesti hanno un senso, e solo lì esiste una «parola significante». «Stia fra me e te la verità, il più vero dei beni», dicono i versi di Mimnermo tradotti da Nicola per Muska, da cui è stato tratto il titolo del loro carteggio. La verità è relazionale, o non è. Ma la relazione deve riguardare individui legati da un retroterra comune, persone che non siano nella condizione di anonimi uomini-massa: «piaccio a quelli cui devo piacere», dice l’Antigone cara a Chiaromonte. E tanto basta.
Queste sono le condizioni necessarie per pronunciare quel genere di parola sensata che «dà luogo a “discorso”»; e «solo dal “discorso” (e dal “dialogo”) nasce l’ordine, e con l’ordine la possibilità d’armonia». Dal che s’intende che la comunità non è solo il presupposto del vero dialogo e dell’azione significativa, ma anche, di conseguenza, la cornice di ogni vera contemplazione estetica. Quando, con termini simili a quelli che identificano la sfera pubblica arendtiana, descrive a Muska lo «spazio libero creato in comune perché serva a tutti – e tutti possano manifestarvisi per quello che sono», Chiaromonte ha in mente sia il modello della polis che le armonie severe delle sue architetture e del suo teatro. Emblematico, da questo punto di vista, è il passo in cui individua una delle caratteristiche più notevoli di Venezia, e di certe città toscane, nel fatto che vi «si vedono le persone. Il campo visuale è ristretto – i “fondali” sono sempre oltremodo ravvicinati, e si sta sempre “de plain pied” (…) e ogni persona o gruppo che avanza è come se entrasse in scena»; il contrario di quel che avviene nelle metropoli, specie nelle metropoli americane, dove «il volto umano è parte di un magma di volti, e non si vede nessuno perché non si può guardare».
Questo campo visuale «ristretto» offre un’immagine plastica dello spazio comunitario chiaromontiano. Che già così, lo si vede bene, è uno spazio intrinsecamente teatrale. E il teatro, per Chiaromonte, non è infatti nient’altro che la mise en abîme formale della comunità, il «tribunale» che ha il compito di schematizzare e giudicare il suo legame coi singoli e con il cosmo, rappresentando i modi in cui l’uomo si rapporta a «il mondo, gli altri, la verità».
Nel pensiero di Chiaromonte, discorso ordinato, comunità e «situazione drammatica» sono quindi termini strettamente connessi. Per questo, quando recensisce una pièce, può passare dal giudizio estetico a una riflessione sul contesto sociale senza soluzione di continuità, e senza mai trattare lo spettacolo come pretesto. Ed è per la stessa ragione che, malgrado i suoi molti dubbi sul confuso miscuglio di cerebralità e brutalità realistica delle nuove tendenze sceniche, nelle lettere a Muska parla con simpatia di Eugenio Barba, dopo averlo sentito descrivere il suo gruppo come una «piccola società» monacale in cui ognuno occupa il proprio posto in piena libertà e responsabilità.
Chiaromonte ha maturato le sue opinioni teatrali sotto l’influenza di Pirandello, e dell’interpretazione che ne ha dato Adriano Tilgher. A differenza di Gramsci e Silvio D’Amico, Tilgher insisteva sul contenuto filosofico dei drammi pirandelliani, proponendo così una concezione dell’arte come discorso intelligibile che era quasi estranea alla cultura italiana, e soprattutto ai contemporanei letterati variamente crociani o dannunziani. Da questa concezione nasce il pensiero estetico di Chiaromonte, e in particolare la sua idea di teatro come «azione ragionante». E’ un’idea che riporta la letteratura drammatica alla sua origine e al suo valore comunitario, identificando nella scena l’unico luogo in cui gli uomini siano in grado di realizzare il sogno di Malraux: quello di una coincidenza limpida e totale tra agire e ragionare. Nel gioco estetico, dove mezzi e fini s’identificano strutturalmente, le trame ambigue di fatti e pensieri che definiscono i rapporti umani, e le umane credenze sul mondo, si concentrano e convergono in un contrasto di trasparenza geometrica. Qui la trasparenza è resa possibile, tra l’altro, da quell’annullamento del tempo che anche per la Weil caratterizza il teatro più grande. Nel dramma perfetto, quando si alza il sipario, le avventure, le storie, i «casi» che hanno formato la biografia dei personaggi sono già bruciati: resta solo una situazione da svolgere con implacabile necessità logica, e un dialogo attraverso cui si mostra come l’eroe che agisce sia condotto dal destino a subire gli effetti di una forza collettiva e naturale senza scampo. Perciò il teatro puro schiva il realismo storico e quello psicologico, inevitabilmente legati al tempo. La sua problematicità è tutta razionale, astratta: e l’abilità del drammaturgo sta nell’isolare dal corso della vita sociale il tema che meglio ne rappresenta le contraddizioni insolubili.
Nell’apparenza scenica, «fingere» significa eliminare il «casuale» in nome dell’autentico, la cronachistica “realtà” in nome dell’essenziale “verità”. In questo senso, per citare ancora un passo dove si stringono in un solo nodo vita e “teatro”, è molto interessante la lettera a Muska in cui Chiaromonte se la prende con Ernesto De Martino e con la sua idea che la supposta interiorizzazione cristiana del dolore costituisca un “progresso” rispetto agli antichi lamenti funebri. Gli sembra infatti che l’espressione aperta e rituale delle lamentatrici greche o lucane sia “teatrale” in senso alto. E’ cioè una forma che riesce a portare alla luce e a comunicare a tutti la sofferenza proprio perché la stacca dal «linguaggio servile del quotidiano», perché non la affida al mero istinto ma a un vero «gesto», appropriato in quanto regolato comunitariamente, tramandato, «ieratico». Non ha nessun senso, secondo Chiaromonte, parlare di banale «finzione» o di banale «sincerità»: la verità emerge qui grazie all’apparenza. E da una situazione simile scaturisce il dramma in senso stretto.
- Pur attribuendo una evidente preminenza al teatro, Chiaromonte chiede qualcosa di simile anche alle altre forme d’arte. In tutte, cerca la stessa semplicità chiara e intelligibile a cui invita anche la Muska poetessa: «quella dei templi greci, di Santa Sofia, dei mosaici bizantini, di Masaccio». Ama l’arte che dà forma alle essenze ideali, non a un’espressione dell’io. Il modello di questa estetica è ancora greco, e a Muska Nicola ne confessa l’origine. Se torna così spesso sulle figure classiche, le dice, dipende forse dalla forte impressione provata da ragazzo davanti a una colonna dorica vista in un libro di Reinach, e rimasta per lui «l’immagine della pura e severa bellezza»: la bellezza che sprona a un’austera limpidezza morale, che ispira una pace armoniosa, e insieme addita un persistente enigma. Un enigma non molto diverso, forse, da quello che lo affascina nelle parole e nei versi della sua corrispondente, assimilati a una «statua arcaica» e a «un’immagine di mosaico, tutta splendida e impenetrabile», cioè a forme che indicano ancora il «divino».
Ma se tutto questo è vero, ci si potrebbe chiedere come mai Chiaromonte abbia speso tante pagine sul romanzo, l’arte per eccellenza moderna e realistica. Certo, le sue analisi gli servono a inquadrare e a criticare le credenze della modernità; e tuttavia, come spiegare la sua indubitabile ammirazione per le creazioni narrative più emblematiche di quell’Otto-Novecento da lui così bersagliato e detestato? In realtà, basta leggere attentamente per capire che anche qui il suo discorso teoretico-estetico mantiene una mirabile e per nulla volontaristica coerenza. Alla forma-non forma del romanzo, l’autore di Credere e non credere e della Situazione drammatica riserva un atteggiamento costantemente e motivatamente ambiguo, una specie di ammirata perplessità che non è affatto un segno d’incertezza critica, bensì il riflesso esatto delle contraddizioni intrinseche all’oggetto esaminato. Infatti, da un lato il romanzo si sviluppa col trionfo della Weltanschauung storicista; ma dall’altro lato, i suoi esemplari più autentici non fanno che contrapporsi ai referti ufficiali della Storia, tentando di raccontare una contro-storia più vera. Questo però, s’intende, non è sufficiente a sottrarli all’ideologia dominante. Perché anche le contro-storie si basano sulla convinzione che esista un’omologia tra i destini privati e i fenomeni sociali; e poco importa, poi, se da una tale convinzione si ricavano rappresentazioni ottimistiche o pessimistiche. A volte, tuttavia, capita che l’antagonismo sia portato così a fondo da mettere in crisi perfino la concezione organicistica su cui si regge il genere. Allora il romanzo tende a esorbitare dai suoi confini. Si dirà che questi confini sono molto malleabili: che si tratta della forma letteraria per eccellenza indefinita, e anzi destinata, se vuol restare genuina, a reinventarsi ogni volta da capo. Ma Chiaromonte ribatte che c’è un tipo di discorso davanti al quale il romanzo deve per forza arretrare: ed è la discussione aperta – non mediata dai personaggi, non ridotta a un puro ingrediente narrativo – delle idee e delle visioni del mondo che gli consentono e gli impongono il suo realismo, la sua fiducia intuitiva nell’intelligibilità psicologica e sociologica delle vicende umane. Il romanziere, finché resta del tutto romanziere, non può ragionare, affrontare un problema nei suoi elementi primi e nelle sue implicazioni ultime, senza depotenziarlo e trasformarlo in uno dei tanti contenuti che sostanziano il flusso dell’intreccio: questa nudità è consentita solo al teatro.
Il genere principe della modernità, figlio delle peripezie cristiane, può insomma raggiungere altissime vette d’arte, ma non può interrogarsi senza schermi sulla propria ideologia umanistica senza diventare qualcos’altro. In questa incapacità di darsi una rigorosa forma logica somiglia allo Stato moderno, che è quasi il suo corrispettivo politico. In un saggio giovanile, in cui tra l’altro anticipa Orwell e Arendt descrivendo gli effetti dei regimi totalitari sul linguaggio e la loro impermeabilità alle verità di fatto, Chiaromonte parla dello Stato appunto come di una istituzione compromissoria, di una forma informe destinata a ricevere dall’esterno i suoi contorni. Il fascismo è il fenomeno che rompe questa indefinitezza, traendo tutte le conseguenze implicite nell’idea moderna del potere: e così, in qualche modo, porta a compimento il destino della macchina statale mentre la riduce all’assurdo. Stato e romanzo sono forme “medie”, destinate a sopravvivere solo finché una crisi traumatica non rimette gli uomini faccia a faccia coi problemi elementari della vita comune, e insomma finché non torna a imporsi l’urgenza di pensare a questa vita con una coerenza più radicale, preclusa per principio ai loro compromessi tra singoli e collettività. Davanti alla crisi novecentesca, l’equilibrio fittizio, il mito di un’armonia prestabilita tra “interno” ed “esterno” su cui sorgono le narrazioni politiche e letterarie della modernità, si rivela ormai un meccanismo inerte, una pelle secca da strappare via per far emergere la realtà che preme sotto. E questa realtà può indurre gli uomini a inventare con coraggio nuove coerenti istituzioni, o ripresentarsi nella totale informità dei nichilismi distruttori che sono dilagati dopo il 1914. Velleitari, comunque, diventano tutti i tentativi moderati, ossia tutti i tentativi di restaurare forme ormai vuote.
Sul piano delle istituzioni politiche, furono queste idee a provocare l’allontanamento di Chiaromonte e degli altri «novatori» da Giustizia e Libertà. L’ideologia “media” e ibrida dei Rosselli, infatti, non approfondiva con coerenza né il contenuto del socialismo né quello del liberalismo, finendo per manovrare dei vaghi pseudoconcetti e per inquadrarli nella vecchia cornice del parlamentarismo prebellico e dello Stato centralizzato. I Rosselli rifiutavano di prendere atto della tara fisiologica di questa cornice – tara rivelata una volta per tutte dal fascismo – e quindi di ripensare radicalmente il teatro della democrazia, che per Chiaromonte, e in parte per i suoi compagni caffiani, poteva acquistare un senso e inverarsi sul serio soltanto in comunità di base autonome. Come in letteratura i narratori del Novecento che scrivono romanzi epigonali, improbabilmente ottocenteschi, così in politica i Rosselli continuano a credere nell’astrazione dell’Individuo Liberale, quell’Individuo che sottovaluta il potere del fato, che si ritiene fabbro della propria fortuna, e che s’inserisce “naturalmente” nel quadro di istituzioni borghesi refrattarie a porsi domande sui loro fondamenti ultimi, sulle conseguenze estreme quanto inevitabili della loro logica interna. Il “contratto” su cui i liberali fondano la società è il romanzo politico che serve ai moderni per esorcizzare ciò che di necessariamente oscuro resta sempre alle origini dei legami sociali e naturali. Ma quando una tale forma si evolve secondo i suoi principi, il volontarismo che la sostiene si ribalta a poco a poco nel fatalismo storicista, in una sclerotizzazione burocratica e in un immobilismo a loro volta liquidati dalla soluzione finale dei totalitarismi. E’ la stessa parabola che tocca al romanzo in senso stretto, specchio poetico di questa Storia.
La perfetta corrispondenza che si riscontra nel pensiero di Chiaromonte tra i due lati della questione ne dimostra una volta di più la compattezza. E’ una compattezza mai esibita, impermeabile agli orgogli autopubblicitari della filosofia sistematica e professorale, ma perciò anche molto meno superficiale e più credibile. Tra il Chiaromonte libertario, che difende un’idea platonica di libertà ma rifiuta di fissarla nelle definizioni del liberalismo classico, e il Chiaromonte teorico dell’arte che al tempo delle narrazioni moderne oppone l’atemporalità del teatro antico, c’è fin dagli esordi un rapporto stretto e spontaneo.
Ma a differenza dello Stato, come si diceva, il vero romanzo oltre che specchio delle ideologie moderne è anche una loro critica impietosa. E a Chiaromonte interessano gli esperimenti nei quali questa contraddizione si estremizza fino a incrinare l’impianto formale. Lo interessano cioè i romanzieri che tengono fermo lo sguardo sulla vanità di quelle ideologie con un coraggio e una lucidità tali da spingerli a tagliare il ramo su cui sono seduti. Il caso più esemplare è ovviamente quello di Tolstoj. Ma anche l’altro protagonista di Credere e non credere, l’autore della Certosa di Parma, mostra sullo stesso piano una spregiudicatezza sorprendente, tanto più se si considera che scrive ancora nell’età eroica del romanzo. Già in Stendhal, spiega Chiaromonte, questa forma è messa sottilmente ma strutturalmente in discussione: tende a divenire una “favola”, un apologo che illustra l’estraneità degli “eventi” e dei “sogni”, accomunati solo da un’uguale inconsistenza. «Tutto Stendhal sta, si può dire, nella capacità di tenersi allegramente alla punta estrema del paradosso per cui né il cosiddetto mondo esterno – la società con le sue trame, gli altri con i moti imprevedibili del loro animo – è reale, né i sentimenti e le immaginazioni dell’individuo: reale è sempre e soltanto lo scontro fra i due ordini di fatti, la “commedia di equivoci” che ne scaturisce», scrive Chiaromonte. Questo scontro è l’argomento fondamentale di Stendhal: e se riesce a trattarlo in una forma ancora apparentemente romanzesca, è perché quel suo mondo narrativo, in cui il vissuto e la Storia rischiano di dissolversi a ogni pagina, è tenuto in piedi da un ultimo fragile mito individualista, il mito della vulnerabile ma indomabile energia giovanile, della fresca sensibilità adolescente che s’impone poeticamente su tutto e malgrado tutto.
Anche Tolstoj ha un mito: la naturalezza della vita “semplice”, la vita fatta di passioni pure, elementari, e dunque rousseauianamente morali. Ma questo mito è ancora più fragile. Nei capolavori del romanziere russo, infatti, la naturalezza si scopre illusoria non appena un’emergenza, un improvviso disordine esistenziale e soprattutto il disordine della guerra mostrano la «grave dipendenza» che lega tra loro gli uomini, denudando quelle relazioni dal cui groviglio si sprigionano le forze incontrollabili di un potere malvagio e impuro. Nella Storia, nelle gravi faccende pubbliche non c’è alcuna verità; ma infine anche la vita semplice si rivela un’illusione in sé. Anche la quotidianità, come prova Anna Karenina, viene inevitabilmente scossa dalla furia arcana del destino e della nemesi. Anzi, per apparente paradosso, quel sentimento del divino che nelle vicende umane sembra il solo spiraglio offerto alla ricerca del vero, getta sui personaggi la sua luce più pura proprio davanti alla violenza bellica. La guerra, certo, tende a trasformarli in oggetti con brutalità inaudita: ma proprio per questo, assai più dell’esistenza normale, li obbliga anche a intuire ciò che in loro non può mai essere ridotto a materia, sottomesso o distrutto. Questa, in Guerra e pace, è l’esperienza totale di Andrej e di Pierre. Ma si tratta pur sempre di un’epifania istantanea, di un’intuizione e di un sentimento che balenano un attimo squarciando le opacità della coscienza per poi subito svanire, o comunque per perdersi in una ineffabilità inutile e incondivisibile. Non si possono esprimere, trasformare in durata e discorso, se non al prezzo di tradirne la purezza: ed è ciò che avviene quando Tolstoj prova a tradurli in una religiosità universale, dando nomi sempre più improbabili o quasi filistei a una fame di verità che di filisteo non ha nulla. Ma questo difetto, che riguarda il Tolstoj pedagogo, non inficia la superiore onestà del romanziere, la cui obiettività di sguardo è tale da escludere o comunque problematizzare al massimo ogni mitizzazione della vita “naturale”. E a metterlo in guardia è prima di tutto la scoperta decisiva compiuta al tempo di Guerra e pace: la coscienza, cioè, del fatto che è impossibile naturalizzare davvero la vita degli uomini, interpretarla e modificarla come s’interpreta e modifica il mondo della natura.
- Niente come l’atteggiamento di Chiaromonte verso Tolstoj spiega il suo modo di guardare alla narrativa moderna: il romanziere che più ama è quello che col suo estremismo etico e teoretico mette sotto scacco il romanzo, è lo scrittore che porta questa forma al suo massimo splendore ottocentesco, ma al tempo stesso si mostra già novecentescamente insofferente dei suoi limiti. Tolstoj muore nel 1910. Nell’ottica chiaromontiana, imbastire plot romanzeschi senza peccare di volontarismo e malafede diverrà di lì a poco quasi impossibile, come diverrà quasi impossibile tentar di restaurare senza volontarismo e malafede lo Stato liberale e le credenze su cui poggiava. La “realtà” compatta da cui emanavano le narrazioni moderne si rivela nel Novecento un mito, una fantasia ormai logora e staccata dai fatti. Perciò le riproposizioni del realismo ottocentesco suonano false, e la trama del romanzo “medio” diventa un succedersi di meri casi insignificanti, del tutto surrogabile dal succedersi dei fotogrammi cinematografici. A questo punto, delle due l’una: o si dissolve il romanzo dall’interno, immergendosi nelle pieghe e nei tempi interiori della psicologia e fabbricandosi una «eternità» estetica come Proust; oppure si abbandona il campo, e si torna alle domande extraestetiche e primarie, interrogandosi sulle ragioni per cui le vecchie credenze sono morte. Così, almeno, vorrebbe il rigore chiaromontiano. Nei fatti, ovviamente, la situazione è molto più ambigua. E uno dei casi più interessanti di ambiguità glielo offre il suo amico Moravia: che, come Forster, trucca superstiziosamente da romanzi realistici parabole il cui pregio è invece la nuda e non più romanzesca esemplificazione di un mondo ormai carente di realtà.
In ogni caso, ciò che rimane di romanzesco e di naturalistico nell’arte sembra ormai inservibile e tendenzialmente menzognero. Del resto è proprio per mentire, per escludere artificiosamente una parte di esperienza vera, che gli artisti engagés e soprattutto i cosiddetti “realisti socialisti”, cioè le incarnazioni intellettuali dell’ortodossia politica, si rifanno a modelli ottocenteschi piegandoli alla propaganda. Il fatto, nota Chiaromonte, è particolarmente evidente nelle arti figurative: qui i rappresentanti del realismo socialista credono di potersi servire del naturalismo dell’Ottocento come i gesuiti si servivano del classicismo del Cinquecento e del Seicento. Ma poiché l’arte postromantica non è normativa, e il suo realismo esiste solo come continua e anarchica ridefinizione del reale, se s’irrigidisce la sua tradizione in norma si scade subito in un eclettico poncif.
Per fortuna, però, proprio dall’est schiacciato sotto i sistemi del socialismo reale e del realismo socialista sembra venire anche la reazione più promettente alla crisi estetica novecentesca, almeno a quella letteraria. A leggere certi autori dissidenti, sembra anzi che di là possa perfino rinascere una forma non volontaristica di romanzo, magari ancora pervasa dalle vaste aspirazioni d’integrità spirituale della tradizione russa e tolstojana. E’ per questo che nelle lettere a Muska Chiaromonte insiste speranzoso sul nome di Solženicyn. L’autore di Arcipelago Gulag gli sembra una miracolosa alternativa all’intellettualismo egomaniaco, una straordinaria incarnazione dell’umanità che ama il mondo ma ne rifiuta l’illusorio possesso, e che nelle condizioni più estreme sa ritrovare i modi giusti per comunicare le verità basilari e durevoli della vita. Per la stessa ragione, nelle lettere ragiona su Pasternak, cita Brodskij, e scrive di apprezzare il Kundera dello Scherzo. Pare quasi che l’emergenza, la sofferenza, l’oppressione da cui nascono i libri di alcuni di questi autori siano le uniche condizioni perché la letteratura torni credibile, e in particolare perché torni credibile la narrativa romanzesca prosciugata dall’Occidente del pieno e tardo ventesimo secolo.
Ma si tratta, appunto, di casi eccezionali. In assoluto, per Chiaromonte il romanzo non è più il centro della letteratura. I traumi bellici, e quelli economico-mediatici, impongono di progettare soprattutto opere in cui sia possibile interrogarsi esplicitamente, senza mediazioni, sui rapporti tra arte e società, e sulle ragioni per cui si è rimasti privi di vere credenze, cioè di credenze condivise. Perciò, caduti i miti fondanti del realismo, riacquista un senso nuovo il teatro, «luogo dove la realtà è messa pubblicamente in questione». Pur con molta cautela, Chiaromonte suggerisce allora che forse per la prima volta dopo duemila anni, anzi per la prima volta dopo la fine della civiltà greca classica, la «situazione drammatica» potrebbe risorgere nella sua purezza. Ma s’intende che il teatro degli orfani del cristianesimo, ai quali la realtà appare come una serie di evidenze nude, irrelate e dunque incredibili, non può che essere speculare al teatro greco: una «azione ragionante» tutta tesa a rendere intelligibile non la coesione, il «cosmo», ma il caos a cui il fato novecentesco ci condanna.
Tuttavia, anche quando accenna a una prospettiva, a una speranza di cambiamento, Chiaromonte si guarda bene dal trasformarla in un programma campato in aria, e quindi in un’ennesima forma di compensazione ideologica. Nell’idea ossimorica del «nichilismo positivo», il sostantivo importa quanto l’aggettivo, e riflette tutta la sua disapprovazione per i troppi censori della modernità che credono di poter sottovalutare la crisi di credenze e valori. La verità è che nessuno può superarla da solo e di colpo, nessuno può tirarsi su per i capelli alla Münchhausen: nemmeno gli artisti. Si dirà che questa posizione potrebbe in qualche modo giustificare l’afasia dell’arte otto-novecentesca. E’ vero. Ma la giustifica solo a patto che gli autori dei suoi abbozzi informi e assurdi accettino di considerare le loro opere per quello che effettivamente sono: sintomi dolorosi dell’impossibilità di un’arte autentica, e non frutti compiuti di una legittima, soddisfacente concezione estetica. Chiaromonte pretende che non si chiami l’informe nuova forma, e che si abbia il coraggio di scontare la crisi in tutto il suo peso senza rifugiarsi in un presunto privilegio di casta. Perché l’arte non può vivere sdegnosamente staccata dal mondo da cui affiora, e non può essere fondata sull’arbitrio soggettivo o sulla capziosità teorica. In una delle prime lettere a Muska riporta un passo dei suoi taccuini sulla bellezza, Leitmotiv del carteggio, che spiega bene il suo punto di vista antimoderno: «La differenza fra godimento estetico e senso della Bellezza», scrive, «si può paragonare a quella che esiste fra la verità secondo la logica formale (che è una verità negativa, nel senso che ci offre la regola del falso, ma non il modo di accedere al vero) e la verità vissuta e contemplata, che è accordo fra l’esperienza del reale e la necessità propria del pensiero».
La bellezza nasce da un mondo ideale costruito in comune: concentrandosi sulla sensibilità del soggetto, ciò che si ottiene è solo un’effimera impressione (piacevole o shockante) o un’effimera ideologia poetica. In un saggio famoso su una terzina di Dante, Chiaromonte osserva che noi siamo così abituati a delibare l’arte secondo i presupposti del soggettivismo estetico, che fatichiamo a onorare in pieno la complessa bellezza intelligibile di testi costruiti su altri fondamenti. Generalizzando quell’analisi, e opponendosi alle strumentalizzazioni ermeneutiche, afferma decisamente che se il senso di un’opera sta in ogni esecuzione o lettura, tuttavia «l’opera rimane al tempo stesso una realtà in sé, inesauribile. Così della “lettura” del mondo che noi vivendo facciamo: ne siamo interamente responsabili e autori. Ma “leggiamo” il mondo, non il nostro “ego”»
.11. E così, siamo tornati a quello che insieme con la Storia è l’altro bersaglio grosso di Chiaromonte: l’ego, e nello specifico l’ego delle sedicenti scienze psicologiche. Le quali scienze, poi, non sono altro che il côté “individualistico” delle ideologie storiciste. Per Chiaromonte, platonico e husserliano, l’idea di trattare la persona e le sue ragioni come un oggetto “obiettivo” delle scienze naturali, quasi che chi le giudica non si trovi profondamente implicato nel giudizio, è una bestemmia, un sintomo di tracotanza intollerabile estremizzato nella psicanalisi. Pretendere di avere per specialità «l’animo umano» significa coltivare di fatto una tendenza «totalitaria». La psicologia accettabile è per lui una faccenda d’intuizioni, di tatto e di verosimiglianza: è quella, senza pretese di verità obiettiva, proposta dai più acuti moralisti, filosofi e romanzieri. Ha senso se «negativa» e «ironica», cioè se serve a demistificare un’idea dogmatica della natura umana. Il resto è truffa; ed è, come la psicanalisi, la parodia delle narrazioni moderne. Questo giudizio ferocemente liquidatorio è determinato anche dal fatto che il sogno «totalitario» degli psicanalisti intende portare l’uomo a uno stato del tutto opposto all’equilibrio sognato da Chiaromonte. Anche su questo tema, le lettere a Muska offrono passi sintetici e definitivi, che si possono associare alle requisitorie della Weil contro i cedimenti agli impulsi e alle immaginazioni interiori. «Che cosa significa “manifestarsi”?», le scrive Nicola. «Non certo, assolutamente no, quello che intendono gli psicanalisti. Ma arrivare al punto in cui c’è equilibrio di verità fra il proprio “essere interiore” (il “meglio” di sé) e quello esteriore. Gli psicanalisti per “essere interiore” intendono l’opposto: il subbuglio mostruoso degli istinti, impulsi, voglie, appetiti – e questo, io direi, non è niente di “reale”: è quello che Blake intendeva per “pestilence”. In sostanza, è il cattivo sogno del quotidiano». E di questo sogno, dei fantasmi passeggeri e non chiarificabili degli «stati d’animo», il teatrale Chiaromonte è così insofferente da avvisare Muska che cercherà di non condividerli con lei: anche se poi, per fortuna, infrange la regola e ci restituisce vivacemente gli umori da cui nasce la sua nettezza teorica.
- Il rifiuto d’interpretare la realtà mettendo al centro i moti che si agitano nel singolo da una parte, e il puro seguito delle sue azioni “storiche” dall’altra, favorisce un curioso rapporto tra l’autore di queste lettere e la cultura antiumanistica che negli anni Sessanta conquista l’egemonia contro il vecchio umanesimo storicistico. Come e più che altrove, Chiaromonte dichiara qui la sua ammirazione per lo strutturalismo di Lévi-Strauss e di Foucault – con cui ha modo di dialogare in pubblico – oltre che per il loro antenato Saussure. Sempre in cerca di modelli astorici e puri da contemplare, è affascinato dalla loro lettura astratta del mondo e del linguaggio. Al tempo stesso, però, non può accettarne una caratteristica decisiva: la vocazione alla tecnocrazia, la tendenza a ritenere l’uomo superato da strutture concepite come meccanismi. Perché per Chiaromonte, al contrario, i modelli e gli ordini che sovrastano fatalmente le contingenze della vita umana non sono mai del tutto afferrabili. Tipico il caso del linguaggio, da lui così amorevolmente indagato, anche in queste lettere, attraverso le etimologie. Ogni idea sulla sua origine si dimostra a suo avviso insufficiente. La sua natura resta inspiegabile, la sua nascita un mistero; ed è da questo mistero che deriva il resto, l’ordine propriamente e solamente umano. Ciò equivale a dire che le “strutture” hanno a che fare col divino: mentre gli strutturalisti lasciano intendere che somigliano a schemi calcolabili e magari manipolabili. Riemerge qui di nuovo la diffidenza di Chiaromonte davanti a tutte le visioni che cercano la verità e il senso nelle tecniche, ricadendo così in una ingannevole semplificazione antidealista anche quando dal gioco puro delle idee erano partite.
Nel carteggio, una notevole ramificazione della polemica contro la “obiettività tecnica” riguarda la fotografia e il film. Per Chiaromonte il cinema, al contrario della vera arte drammatica, propone solo una successione di meri segni incapaci di trasformarsi in significati complessi: sta tutto nell’effetto immediato, e appena cerca di proporsi mete intellettuali, magari pretendendo che indugi e lentezze rendano un paesaggio o un volto oscuramente significativi, rischia di cadere nella comicità involontaria di certo Antonioni e certo Bergman. Scrive a Muska che la fotografia, l’immagine meccanica, riporta «a un falso primitivismo e pre-logismo». Nella ottusità fotografica, nel puro documento non può esserci verità. Ricopiando passi dei taccuini, arriva a proporre all’amica un esempio eloquente. Se avessimo una registrazione totale, una documentazione assoluta delle vite di Socrate e Cristo, le dice Nicola, ciò non ci aiuterebbe affatto a conoscerli davvero, come una fotografia del Cristo e della Vergine dentro una chiesa non favorirebbe per nulla l’adorazione. La verità, il senso della loro presenza sta solo nell’idea: sta, cioè, solo nel mito e nel discorso ordinato che l’esperienza del rapporto con queste figure e con le loro parole hanno prodotto.
- Come si vede, dal carteggio con la suora benedettina emergono davvero quasi tutti i motivi salienti dell’opera chiaromontiana. Ed emerge, con più aperta insofferenza, l’opposizione a un modo d’essere contemporaneo che sembra lasciare come sola via d’uscita una sorta di fatalistica saggezza. Ma in realtà Chiaromonte è troppo combattivo per diventare del tutto “laotsetiano”. Diciamo piuttosto che la sua è una forma molto personale di resistenza stoica. Con un’assertività drastica, antica, impaziente di ridurre l’importanza dei problemi sociali e individuali, ripete a Muska ciò che dice nei taccuini: che la vita è «intera» in ogni condizione, che la differenza tra gli stati e le fortune è disprezzabile. Quel che resta da fare, in ogni caso, è tenere fermo il vero e la propria identità; accettare il dolore, e fissarne senza paura l’aspetto indecifrabile. Bisogna, insomma, far la parte del Sisifo di Camus: avere il suo senso del limite e del fato, ma conservare anche il suo sempre rinascente pathos della libertà, una libertà da condividere con individui in carne e ossa, al di qua e al di là di ogni fanatica astrazione. Però bisogna fare tutto questo senza perdere di vista quella religiosità “greca”, che a Camus era velata dall’insistenza sull’assurdo e su un troppo generico umanismo.
A questo punto, tuttavia, è davvero difficile dire cosa davvero «rimane» dell’uomo, del suo senso. E non è un caso che quando cerca di farlo, il piano Chiaromonte si avvicini quasi alla mistica Weil o al non amato Kafka, e in genere a un linguaggio impensabile senza la modernissima tradizione kierkegaardiana. Se la vita umana somiglia a un frammento, a una serie di occasioni insensate e di situazioni incompiute, «conta (…) alla fine, questo fatto soltanto: ciò che si sentiva o si avvertiva di significato possibile della vita – ciò che dell’Essere del mondo arrivava fino a noi, insomma – e non era in ogni caso – né poteva essere – che l’ombra di un’ombra. Eppure questo resiste al Nulla. Non può essere distrutto perché non è mai appartenuto al mondo del cambiamento: è stato, se si vuole, un miraggio fermo e fisso, più forte in noi di ogni supposta “realtà”!».
Ma in Chiaromonte, lo stoicismo da cui nasce un pensiero così vertiginosamente antimondano non è mai scindibile dai destini generali. Come ribadisce ovunque, il singolo individuo può capire o vedere alcune cose che restano oscure ad altri, ma non può sfuggire alle credenze comuni attraverso cui una società concepisce il rapporto tra l’uomo e il cosmo: «del mondo nel suo insieme non si può credere che quel che ce ne appare attraverso i modi d’essere e di pensare dei nostri simili». Perciò Nicola scrive a Muska che «non si può essere superiori al destino che vi colpisce». Questo pensatore antimarxista, e così platonicamente convinto della realtà del puro mondo ideale, comprende benissimo la dialettica che lega ciascuno al suo tempo, e a quelle visioni che non coincidono né con idee astratte né con contingenti stati d’animo, ma rinascono ogni giorno negli scambi sociali. Così, sa che è impossibile separare dalla massa delle élites d’irriducibili individui integri: perché siamo tutti in parte individui integri, o almeno resistenti, e in parte uomini-massa arresi all’apatia e all’ignavia, abituati a vivere rimandando le scelte nette tra bene e male e agendo «senza persuasione e, nel contempo, senza violare chiaramente nessuna norma intima; ma anche senza osservarne chiaramente nessuna». Anche a Chiaromonte, nel suo lavoro di pubblicista controvoglia, capita perciò di sentirsi «metà compromesso e metà intransigenza», incapace di attingere quella «estrema semplicità» senza schermi che sola riporta alle circostanze elementari della vita e dunque alla verità. E’ questa consapevolezza che lo distingue da tanto aristocraticismo in finto oro del Novecento, cioè da chi crede o finge di credere a una restaurazione dei valori, e pensa di potere salvarli e salvarsi restando immune dall’involgarimento del mondo in cui vive. E’ una consapevolezza che si riflette anche nello stile. Come osserva Karpiński, Chiaromonte non vuole sedurre il lettore, strappare l’applauso da aforista brillante, ma mettersi a ragionare con lui, scrivere in modo che in primo piano appaia sempre il nocciolo essenziale del problema trattato; e se accosta bruscamente esperienze culturali lontane nel tempo, non lo fa per stupire postmodernisticamente il pubblico, ma perché una volta spogliate degli involucri rivelano nuclei di pensiero che si fecondano a vicenda e aiutano il ragionamento a procedere. Non è illegittimo ritenere che questi tratti della sua opera abbiano contribuito alla sua sfortuna presso gli editori (i curatori del carteggio con Muska ricordano il rifiuto di Adelphi): certo è quasi impossibile stilizzare Chiaromonte in uno scintillante e vendibile logo culturale. Così i suoi scritti, spesso usciti in prima battuta all’estero – sulle riviste polacche della dissidenza, negli ambienti anglosassoni – o in edizioni italiane ormai quasi introvabili, rimangono pressoché sconosciuti ai lettori del Duemila. Hanno fecondato le riflessioni delle sue esili e prestigiose comunità cosmopolite novecentesche; ma oggi che quelle comunità non ci sono più, rischiano di non poter nutrire con la loro energia intatta le nuove generazioni di cittadini dell’Italia, dell’Europa e del mondo. E’ anche questo un piccolo esempio dello sconfortante gioco di forze in cui si concretizza la poca sensatezza della Storia – storia della cultura compresa. Chiaromonte insegna a non farne un idolo, a preservare la propria vita mentale dai suoi ricatti e dalle sue immagini stereotipate, ma sa che non si sfugge al loro manifestarsi; non li si controlla: ma non si può fare a meno, tenendo fermo il vero, di scontrarcisi e di tornare di continuo a denunciarli. Spesso, nel carteggio con Muska, torna il riferimento a una grotta di Paros, emblema di uno spazio puro e alieno dal caos; e spazio puro, mentale, è il giardino immaginario che la suora disegna per l’amico. A un certo punto, la fame platonica di idee che Nicola mostra nelle sue lettere deve averla indotta a ricordargli l’importanza della vita “reale”, dei «piatti da lavare». Lui risponde rassicurandola sul fatto che «i piatti», volente o nolente, li lava ogni giorno: nei “fatti” ci si urta sempre e comunque. Eppure non si può non notare che anche accennando ai lavori pratici, Chiaromonte mette subito l’accento su un loro valore in qualche modo ascetico. Per quanto la vita umana sia incoerente e frammentaria, è probabile che questo intellettuale platonico riuscisse a render visibile anche nell’esistenza quotidiana una coerenza, una integrità dai contorni straordinariamente netti e plastici. E forse questo spiega perché alla McCarthy e a Malraux sia venuto in mente di trasformarlo rispettivamente nel Fondatore Monteverdi dell’Oasi e nel «piccolo Scali» che, con una discrezione e un disagio pari all’eroismo, partecipa alla guerra aerea spagnola della Speranza: cioè in quelle figure per eccellenza ideali, e quindi capaci di rivelarci chi siamo davvero, che sono i personaggi dei romanzi.
In Da Pascoli a Busi. Letterati e letteratura in Italia, Quodlibet 2014
Da: www.claudiogiunta.it/2017/09/la-verita-del-dialogo-un-ritratto-di-nicola-chiaromonte/
Fra cinici e gesuiti
La straordinaria figura di Nicola Chiaromonte, discepolo di Andrea Caffi, amico di Moravia, Camus e Malraux, con cui combattè in Spagna, critico radicale di ogni ideologismo, di ogni totalitarismo, di ogni società che vive in malafede, pronta a credere a ogni menzogna. Fu nemico spietato del mito dello Stato, nato con la modernità, che accomunò Mussolini, Stalin e Hitler. L’esperienza feconda di Tempo Presente, condivisa con Ignazio Silone. Grande libertario, incompreso dalla sinistra, stalinista e non, continuò a credere nella necessità di gruppi e comunità che si opponessero alla deriva, oppressiva e permissiva insieme, della società occidentale. Intervista a Gino Bianco.
Gino Bianco, studioso del movimento operaio e socialista, giornalista e saggista, è stato amico e collaboratore di Nicola Chiaromonte.
\r Nicola Chiaromonte, che fino alla morte è stato un intellettuale molto discusso, oggi viene riscoperto come possibile ispiratore di una sinistra post-comunista…
\r Per me, Chiaromonte è stato un maestro non solo per il pensiero, ma anche per la vita. Come il suo amico e maestro Andrea Caffi, fu innanzitutto un uomo con la passione della politica e del pensiero ed è per questo che anche i suoi scritti, parte dei quali è stata ripubblicata da Il Mulino, non hanno un carattere sistematico, né possono averlo, perché sono il riflesso dell’itinerario travagliato di un pensatore originale ed anticonformista, di un militante politico, di un cittadino del mondo. Di lui, Gustaw Herling ha scritto: “Dai saggi giovanili sul fascismo fino alle riflessioni sui temi dell’arte c’è in tutta l’opera di Chiaromonte la critica alla nostra età che pratica il divorzio fra etica e politica. Scriveva in modo da trasmettere non solo un pensiero chiaro e libero, ma una continua tensione morale, in modo che nella parola viveva tutto intero e la esprimeva come una verità lungamente soppesata e sofferta. Provava ribrezzo davanti ai grandi sistemi e alle interpretazioni generali, sfiducia di fronte ai cavilli dialettici che storpiano la vita e alle ombre ideologiche che coprono la realtà, disprezzava lo psicologismo. Lo interessava invece l’uomo concreto di fronte agli avvenimenti concreti. Era, nel modo tolstoiano, capace di giudizio etico e allo stesso tempo consapevole di qualcosa d’imperscrutabile che l’oltrepassa. La tradizione greca era da lui intesa come una medicina contro il morbo della banalità plateale”. Per tutta la vita, infatti, Chiaromonte si è occupato di politica, di filosofia, di teatro -fu per molto tempo critico teatrale, prima al Mondo di Pannunzio e poi a L’Espresso- e di letteratura, cercando sempre di andare alla radice delle idee e facendo giustizia delle tante sciocchezze correnti in una cultura formalista e provinciale quale era quella italiana in cui visse. Sempre animato dalla passione per la meditazione sull’azione politica e, in senso lato, sul significato della storia, come emerge dai saggi su Tolstoj, Stendhal, Martin du Gard, Pasternak e, naturalmente, su Malraux e Camus, di cui fu grande amico.
\r Chiaromonte, così come l’ho conosciuto io, fu una voce solitaria, sdegnosa contro ogni opportunismo politico, un pensatore scomodo, vittima della sinistra ipocrita. Personalmente, come ha ricordato recentemente Arbasino, era austero, ma tutt’altro che arcigno. Era invece amabile e spiritoso, estremamente piacevole nella conversazione, senza un’ombra di boria e d’ipocrisia, privo di quella gravità falsa e tronfia che è propria di quei retori e pavoni che la demagogia e il conformismo promuovono spesso al rango di maestri.
\r Nemico dei mediocri soddisfatti, odiava la retorica in tutte le sue forme, e i suoi scritti testimoniano la sua scrupolosa personalità d’intellettuale, la sua cultura europea, il suo rigore, la sua intransigenza nell’impegno politico, la sua ripulsa per ciò che chiamava “il gesuitismo moderno” e “le menzogne utili”.
\r Ciò che lo interessava di più era la comunicazione, il confronto delle idee, verso cui aveva un grandissimo rispetto, anche quando non le condivideva. Auspicava il ritorno a una cultura consapevole del suo compito formativo, dove l’individuo si ritrovasse a tu per tu con se stesso, con la società e con il mondo, per trovare ciò che è essenziale e ciò che non lo è, ciò che importa e ciò che non vale. Non a caso scriveva: “Il solo linguaggio fra uomini è quello che si può intessere sulla trama di credenze autenticamente condivise, in quanto costituiscono il presupposto per il fondamento di ogni discorso e non uno schema prestabilito o un insieme di dogmi”, mentre il suo giudizio sul mondo in cui viviamo e sul ruolo che l’intellettuale è chiamato ad assolvervi lo espresse con molta efficacia in uno dei suoi ultimi scritti, Il tempo della malafede, in cui sosteneva: “La nostra non è un’epoca di fede, ma neppure d’incredulità, è un’epoca di malafede, cioè di credenze mantenute a forza in opposizione ad altre e soprattutto in mancanza d’altre genuine”, ed in cui i politici contemporanei “agiscono come se ci credessero, e invece…”
\r In virtù di questo suo atteggiamento rigoroso ebbe, fra l’altro, una vita avventurosa…
\r Era nato in Lucania nel 1905, ma visse la sua gioventù a Roma, dove si laureò in giurisprudenza, anche se questi furono studi che non ebbero alcun effetto formativo su di lui. Chi invece lo influenzò molto fu Adriano Tilgher, di cui Nicola si considerò in un certo senso un discepolo, che fu un grande pensatore, anche se per un breve periodo simpatizzò per il fascismo. Tilgher fu una sorta di “irrazionalista” italiano e, pur influenzato dal pensiero di Gentile, tentò di elaborare una filosofia indipendente sia da questi -fu, tra l’altro, autore di un famoso pamphlet contro Gentile, Lo spaccio del bestione trionfante-, sia dal marxismo come dall’idealismo crociano. Grande polemista, spirito eclettico, è a Tilgher che probabilmente si deve gran parte del profondo interesse che Nicola ebbe sempre per il teatro, così come l’amore per Pirandello e un certo esistenzialismo ante litteram, quando ancora non si conoscevano i nomi di Heidegger o di Sartre.
\r Da giovanissimo Nicola, come fece anche Salvemini, simpatizzò per un brevissimo periodo col “diciannovismo”, cioè con quel movimento proto-fascista che nei primi anni Venti, in odio alla tradizione pseudo-democratica dell’Italia dei Giolitti, dei Facta, degli Orlando, pensava fosse meglio tenersi per qualche tempo Mussolini piuttosto che tornare alla “palude parlamentare”, come si diceva allora. Naturalmente, Chiaromonte, come del resto Salvemini, cambiò subito idea e col delitto Matteotti si schierò decisamente contro il fascismo, tant’è che a vent’anni scrisse il primo articolo sul Mondo di Giovanni Amendola. Nel ’34, seppe di essere ricercato dalla polizia come terrorista -aveva pensato di attentare a Mussolini, anche se il progetto non andò in porto- e scappò a Parigi. Fu a Parigi che conobbe Caffi, che gli fu presentato da Moravia, di cui Chiaromonte era molto amico, e che per Nicola divenne il vero maestro nelle idee e nella vita.
\r Sempre in quel periodo parigino aderì a Giustizia e Libertà e collaborò ai Quaderni e al settimanale che Giustizia e Libertà pubblicava, ma dopo qualche tempo fu, con Mario Levi, Caffi e Renzo Giua, animatore del gruppo dei “novatori” che si separò da Giustizia e Libertà perché in contrasto col modo con cui Carlo Rosselli conduceva il movimento. Il motivo principale della separazione fu la loro convinzione che Rosselli si muovesse in una prospettiva di restaurazione della vecchia democrazia parlamentare, che aborrivano, mentre erano convinti che, una volta sconfitto il fascismo, fossero da ricercare soluzioni diverse dal ripristino puro e semplice della vecchia democrazia “borghese”. Dopo questa separazione, aderì per un certo periodo al Partito Socialista in esilio, trovandosi nelle posizioni del gruppo “frondista” di Angelo Tasca. Andò poi volontario nella guerra civile spagnola, dove fu fra i quattro o cinque aviatori della piccola squadriglia comandata da André Malraux. La guerra di Spagna fu per lui una grande delusione e vi rimase meno di un anno perché vide l’intollerabile comportamento del Partito Comunista. Tornato in Francia, quando questa fu occupata dai tedeschi fuggì in Algeria, dove conobbe Camus, e da lì andò negli Stati Uniti, dove rimase fino alla fine della guerra. Fu frequentando l’ambiente degli esuli antifascisti e antinazisti e della sinistra di New York che conobbe Mary McCarthy, Hannah Arendt, Dwight McDonald e cominciò a collaborare con riviste come Politics e Partisan review. Finita la guerra tornò per qualche anno a Parigi, dove ritrovò Camus e Andrea Caffi, ed infine rientrò in Italia, dove è rimasto fino alla morte.
\r Quali furono i temi principali della sua attività e della sua ricerca?
\r Chiaromonte, come del resto Caffi, non fu un pensatore organico, cosa che, del resto, nemmeno gli interessava essere. Nei suoi scritti e nella sua vita, anzi, testimoniò sempre un ribrezzo profondo per i sistemi di pensiero organici, per le costruzioni ideologiche, metafisiche o epistemologiche ed era certamente anche per questo che rifiutava di sottomettersi al dominio degli imperativi della politica. Polemizzò sempre con le ideologie “scientifiche” e con quelle basate sull’esaltazione del progresso tecnologico, diceva che nel mondo moderno non c’è possibile salvezza se si accetta il progresso tecnico per principio, senza riserve, se si applica tutto ciò che esso può suggerire. All’opposto, gli interessava profondamente quello che c’è a fondamento delle idee e della conoscenza. Era vivissima in lui la convinzione che nel cuore di ogni uomo fosse celato il segreto della moralità e di quella “socialità” tanto amata anche dal suo maestro Caffi. Chiaromonte pensava comunque che la morale non fosse “insensibile”, non si collocasse cioè sul terreno dell’assoluto, ma fosse fatta di un’eleganza e di un “sapere” nelle relazioni personali, familiari, “etniche”, che rimandano all’insieme delle tradizioni e alle modifiche che le tradizioni subiscono nella storia, fino a sgretolarsi nella nostra epoca, che lui considerava di grande crisi.
\r Per Nicola la tradizione era importantissima per la costruzione dell’uomo, ed infatti, in un suo bellissimo saggio sui greci, diceva che senza tradizione l’uomo non esiste, perché, per dirla con le sue parole: “All’oppressione del despota o alla disumanità della casta ci si ribella, ma non ci si può più ribellare alla regola impersonale e razionale, cioè all’oppressione che scaturisce dal riconoscimento razionale del fatto di vivere in società”.
\r Anche grazie a questo continuo meditare sul rapporto con la tradizione non era un adoratore della ragione con la maiuscola, sapeva che la ragione era una piccola fiamma in una foresta buia, anche se apprezzava come un fatto sacro lo sforzo della ragione di dare un senso, di mettere ordine nel caos…
\r Una volta -eravamo in vacanza insieme a Bocca di Magra- mi disse, ripensando alla sua vita passata, che avrebbe voluto essere non un uomo di lettere, ma un matematico, perché era nella matematica che forse c’era la possibilità di dare forma e razionalità, “immagine”, al mondo attuale, mentre la letteratura aveva perso la capacità di farlo. Era certo uno sfogo perché lui, in realtà, aveva un dono affine a quello di certi romanzieri, che sanno darci la sensazione di una presenza diretta della trama della vita, cioè non semplicemente la sensazione del flusso caotico dell’esperienza, ma dell’emergere in essa della distinzione profonda fra ciò che conta e ciò che non conta.
\r A tutto questo non erano sicuramente estranee neppure le sue continue riflessioni su Sartre, Heidegger, Hegel e soprattutto Platone, come sul pensiero greco classico, di cui lo affascinava sia la concezione del destino, -e non a caso scriveva che “Una certa saggezza, e non più alcune specie di razionalità deduttiva, è la conquista più alta e più degna dell’uomo”- sia la possibilità di partire da esso per articolare un rapporto con la realtà diverso da quello impostato dalla razionalità scientifica. Chiaromonte, infatti, diceva che la realtà non è il dato empirico, ma è l’interdipendenza fra esso e l’apparizione di quello che sembra, di quello che ci appare, quindi delle nostre visioni, dei nostri “tentativi di realtà”, fra cui metteva anche le utopie. A questo proposito Nicola sosteneva che non c’è civilizzazione senza molteplicità di utopie. Ma attenzione: molteplicità e non unicità, poiché escludeva l’interpretazione volgare secondo cui le utopie debbono essere realizzate per essere significative, per cambiare la vita degli uomini. All’opposto, per lui le utopie erano uno specchio della vita intellettuale, che non è affatto opposta alla vita perché, diceva, si vive, anche al più basso livello, d’intelletto e di utopia. Nell’amore, per esempio, che cosa si fa se non creare un’utopia?
\r Un altro tema che Nicola affrontò continuamente fu quello del totalitarismo. Per lui i totalitarismi nazista, comunista, fascista, trovavano la loro origine storico-politica nella prima guerra mondiale, che considerava lo spartiacque della crisi della modernità e quindi della civiltà europea. Va tuttavia tenuto presente che, per quanto critico con le linee-guida della civiltà europea, non parlava di “tramonto dell’occidente” in senso spengleriano, cioè di ineluttabile fine di una civiltà, ma appunto di “crisi”, cioè di necessità di ripensare questa stessa civilizzazione e soprattutto il ruolo in essa assunto dallo stato-nazione, che sempre più era per lui anche “stato-fabbrica” e soprattutto “stato-mito”. Era convinto che il mito dello stato fosse l’elemento che accomunava la dittatura di Mussolini, la statocrazia di Stalin e il “terzo impero” di Hitler, e che, appunto per questo, rimanesse il pericolo maggiore che il Ventesimo secolo doveva affrontare. Per Chiaromonte questa mitizzazione dello stato affondava le sue radici nella modernità stessa, nella crisi da questa aperta, che per lui significava soprattutto crisi della coscienza religiosa. Proprio per questo far coincidere modernità e crisi della coscienza religiosa Nicola apprezzava moltissimo Proudhon. Oltre a concordare con molte delle sue idee sul federalismo e sulla socializzazione libertaria dell’economia, riteneva infatti che Proudhon fosse il pensatore che per primo aveva capito che la vera rivoluzione moderna non era stata tanto lo sviluppo industriale, ma il processo di secolarizzazione che, distruggendo la coscienza religiosa, metteva in discussione la base stessa della società e preparava la decomposizione della civiltà europea e la distruzione della società da parte dello stato-nazione.
\r La questione della religiosità fu un altro tema attorno a cui Nicola meditò sempre -aveva, fra l’altro, un fratello gesuita. Affermava che dire: “Dio esiste” è altrettanto stupido che dire: “Dio non esiste” ed era quasi ossessionato dal problema di un “piano teleologico” che determinasse gli esseri umani senza che essi potessero comprenderlo. La sua era, e lo si vede in moltissimi scritti, una specie di “religiosità laica” che per certi aspetti lo avvicinava a Simone Weil, che amava moltissimo, o a Bernanos. Comunque, rispetto alla religione e alla Chiesa mantenne sempre un atteggiamento critico, che però non sfociò mai in un laicismo aprioristico. Da una parte, infatti, difese il Papa quando questi fu accusato di essere responsabile dell’Olocausto e polemizzò con il laicismo radicale di Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi, che lui riteneva totalmente estraneo alla realtà e alla cultura italiana, mentre, dall’altra, polemizzò duramente con gli aspetti deteriori della tradizione cattolica, in particolare contro l’Italia della Controriforma, che dopo i trionfi fascisti si avviava a continuare indenne la sua lunghissima storia. Il senso della sua polemica è per me rappresentato da un passo di uno scritto intitolato Il gesuita, in cui dice che a Roma si possono incontrare gesuiti e cinici, ma non c’è posto per gli eretici.
\r La sua polemica con lo “stato-mito” lo rendeva consapevolmente un libertario?
\r Si considerava un libertario, era consapevole che quel che pensava lo avvicinava ai movimenti e alle correnti libertarie, e credo sia stato uno dei libertari più acuti, più intelligenti, del nostro tempo.
\r Il pensiero libertario italiano del Novecento ha avuto certo grossi personaggi, come Malatesta o Berneri, ma Chiaromonte, che dopo la guerra di Spagna non aderì più ad alcun partito o movimento politico, era intellettualmente più attrezzato di loro, più capace di cogliere le grandi questioni poste da questo secolo.
\r \r Nicola si sentiva vicino alla tradizione socialista non marxista, soprattutto a Goodwin, Paine, Saint-Simon, Proudhon, Herzen, un altro autore che ammirava tantissimo. Va inoltre detto che, nonostante le accuse di cui fu oggetto da parte del Partito Comunista, Nicola era antistalinista, non anticomunista. Non amava Marx e il marxismo e pensava che il comunismo si sarebbe veramente potuto fare soltanto in comunità religiose, ma non era pregiudizialmente un anticomunista. Concordava con molte delle posizioni della sinistra socialista, con la critica di Rosa Luxemburg, e non era pregiudizialmente nemmeno un antisovietico. Non a caso faceva risalire la degenerazione della rivoluzione sovietica all’attacco che questa dovette subire da parte delle potenze occidentali nel ’18-’19. Era convinto che fosse stato questo attacco alla neonata repubblica dei soviet e l’isolamento che ad esso era seguito ad innescare il processo che portò prima all’autoritarismo leninista e poi allo stalinismo. Alcuni dei suoi migliori amici, poi, erano, o divennero, comunisti: con Mario Levi fu sempre in rapporti fraterni, nonostante quest’ultimo avesse aderito al Partito Comunista Francese e sia morto comunista francese, così come fu sempre amicissimo di Moravia. A questo proposito ricordo che, nei primi anni Sessanta, quando gli dissi che a Milano, dove allora lavoravo, viveva con me Valentin Gonzales, “il Campesino” (il contadino, ndr), volle a tutti i costi conoscerlo. Il “Campesino” durante la guerra di Spagna era stato un leggendario comandante comunista, poi scappò in Russia, dove venne fatto generale dell’Armata Rossa, ma dopo la seconda guerra mondiale cadde in disgrazia e venne mandato in un campo di lavoro, da cui riuscì a scappare tornando in Occidente. Nel periodo di cui stiamo parlando “il Campesino” aveva appena scritto La vie et la mort en Russie, pubblicato in Francia con una prefazione di Julian Gorkin, direttore di Tribuna obrera, organo di quel che rimaneva del Poum (il piccolo partito della sinistra comunista massacrato dai comunisti di osservanza sovietica durante al guerra di Spagna) e aveva rotto completamente col mondo comunista filosovietico.
\r L’incontro di Nicola col “Campesino” fu emozionante, fu un confronto sulla Spagna fra due reduci che ancora avevano quegli avvenimenti nel cuore, che ancora sentivano “la follia della Spagna”, come la chiamava Nicola. Ovviamente si finì per parlare del ruolo che in Spagna ebbero i comunisti, e soprattutto Togliatti. Da quanto emerse in quella conversazione commovente ho poi ricavato il saggio Togliatti in Spagna, che fu pubblicato su Tempo presente e che mi valse per molti anni l’odio degli stalinisti.
\r Critico radicale del bolscevismo era ugualmente nemico della “plutocrazia” americana, anche se non lo era per principio, come succedeva, e ancora succede, all’antiamericanismo di molti marxisti.
\r A lui dell’America non piaceva soprattutto la cultura di massa e il modo di fare politica che là si erano imposti, ma tutto ciò non lo portava a demonizzare gli Stati Uniti. Fu molto critico verso l’intervento statunitense in Vietnam -le pagine di Tempo presente, che fra gli altri ospitò un saggio di fuoco di Mary McCarthy, lo documentano- non per ragioni moralistiche, ma perché sentiva che era spropositato, che era un errore strategico, ed infatti finì come è finita.
\r Anche rispetto alla situazione italiana era tutto sommato un isolato, a parte una certa consonanza con i redattori e collaboratori di Tempo presente. Come ho detto, collaborava col Mondo di Pannunzio, che era un po’ il portavoce della sinistra laica, non comunista, ma era critico anche rispetto ad esso. Sentiva come un vestito stretto gli editoriali di Pannunzio, che considerava troppo tatticista per ragioni politiche, troppo legato e condizionato da La Malfa e da Ernesto Rossi, dai prodromi del centrosinistra e dalla logica dell’”arco costituzionale”, che considerava fumosa. Fu non a caso il primo a dirmi, molti anni prima del “revisionismo” di De Felice, che la Resistenza era stata esaltata in modo retorico. Sottolineava che prima del 1943 l’intelligence inglese in Italia non riusciva a trovare contatti e diceva che la Resistenza non ci sarebbe stata senza l’avanzata delle armate alleate.
\r Riguardo alla situazione italiana, a quella che lui chiamava la “democrazia cifrata”, c’è un suo saggio, intitolato Uno Stato fuorilegge, in cui la sua critica all’apparato di potere è feroce, perché vi è una “oppressione burocratica di tipo orientale sulla società civile italiana” e non risparmia nemmeno la magistratura, che definisce una “casta di mandarini con automatismo di stipendio”. Per dare un’idea di che tipo di intellettuale fosse può valere quanto mi disse Montanelli a proposito di Silone e Chiaromonte: “Persone molto più serie di me, ma in definitiva, considerando quello che sono gli italiani, ho avuto ragione io”.
\r Quale era il progetto che stava alla base di Tempo presente, la rivista fondata da Chiaromonte con Ignazio Silone?
\r Il progetto che la animava era essenzialmente culturale -c’era una grande attenzione ai temi della cultura in generale, fra gli altri ci scrivevano Quinzio, Flaiano, Arbasino, il giovane Mario Perniola- e nacque per dare voce a quella parte della cultura italiana che non si era sottomessa alle chiese cattolica e comunista, ed infatti dalla cultura ufficiale dell’epoca fu sempre considerata con sospetto, emarginata. Gustaw Herling, un altro importante collaboratore della rivista, ricorda: “Ci consideravano dei lebbrosi”.
\r In questa impronta culturale si rifletteva l’impostazione di Chiaromonte (i cui rapporti con Silone non furono privi di contrasti ed ambiguità, soprattutto perché Nicola pensava che Silone fosse troppo tatticista e un po’ arrivista), che non credeva più nella politica e pensava che, se una trasformazione era da aspettarsi, lo era solo in quanto si riusciva a fare emergere nella cultura e dalla cultura degli aspetti nuovi, non conformisti rispetto alla logica clericale, da una parte, e al marxismo dall’altra.
\r In questa volontà di dare voce alla cultura non conformista Tempo Presente trovò il suo filo rosso nella difesa e nella valorizzazione del dissenso nei paesi del totalitarismo comunista. Difese Pasternak, Solzenicyn, Sinjavskj, pubblicò le memorie di Nadezda Mandel’stam, diede conto della rivoluzione ungherese pubblicando saggi ed articoli sia di ungheresi esuli che di altri residenti a Budapest, altrettanto fece poi con la Primavera di Praga. C’era in Tempo presente una predisposizione al dissenso e all’opposizione alla politica sistematica che la affratellava a riviste come Survey e Encounter a Londra, Der Monat a Berlino, Preuve a Parigi, Politcs a New York, con cui si scambiavano articoli e collaborazioni. Tempo presente, fra l’altro, fu la prima rivista italiana a pubblicare saggi e articoli di Hannah Arendt, Mary McCarthy, Dwight McDonald, grazie all’amicizia che c’era fra questi e Nicola.
\r Con Tempo presente Chiaromonte ebbe modo di dare visibilità a tutti gli aspetti della sua ricerca, dalle riflessioni sui limiti del linguaggio e sulla filosofia alle riflessioni sull’arte. Era affascinato dall’intreccio fra politica ed arte e pensava che l’arte con la maiuscola non potesse che essere mezzo di cultura attiva, coscienza, ammaestramento a vedere, mentre diceva che, dopo il Rinascimento, l’arte era stata spesso concepita, anche dagli artisti, come una fabbrica di bambocci, neutra quanto ai significati e ai valori della vita.
\r Da questo intreccio nasceva il suo interesse per il teatro e per il cinema, anche se, dopo aver molto amato il cinema degli anni Trenta -cioè il cinema della fase romantica, eroica, registi come Pabst o Eisenstein- col passare degli anni se ne distaccò perché considerò che fosse divenuto un fenomeno sempre più industriale, un aspetto della cultura di massa e della meccanizzazione del mondo moderno.
\r Come critico teatrale era per certi versi un “critico militante” -di lui Carmelo Bene, ha detto che era “l’unico critico che capisse davvero il teatro e la situazione drammatica”- e si lamentava molto della mancanza, a parte Pirandello, di un autentico teatro italiano, la qual cosa per lui significava l’incapacità della società italiana d’interrogarsi, di guardarsi allo specchio, di mettersi in discussione. Era poi furioso con il teatro sovvenzionato, con i funzionari del Ministero del Turismo e dello Spettacolo che spesso gli telefonavano per lamentarsi di quello che aveva scritto o per raccomandare Tizio o Sempronio.
\r Dicevi prima della sua amicizia con Moravia, Camus, Malraux…
\r Con Moravia erano amici fin da giovanissimi -come ho detto fu Moravia a presentare Caffi a Chiaromonte- e rimasero sempre amici, anche se non mancarono fra loro polemiche e scontri. Chiaromonte stimava moltissimo Moravia, ne apprezzava la grande intelligenza e la qualità di scrittore -pensava, fra l’altro, che con La noia avesse forse scritto le migliori pagine della letteratura di questo secolo sull’atto sessuale-, e avrebbe voluto che Moravia esercitasse il ruolo che Camus aveva esercitato nella cultura francese, mentre dissentiva profondamente da lui per le ambiguità che a suo parere Moravia dimostrava sul problema della libertà nel mondo dell’Est, sull’Urss e la Cina, come anche nei confronti del Pci e dell’industria culturale.
\r Con Camus, invece, questi problemi non c’erano. Nicola ammirava Camus sin da quando si erano conosciuti ad Algeri e con lui sentì sempre una profonda consonanza. Pensava non solo che Camus fosse un grande scrittore e un grande artista, ma che fosse soprattutto un grande uomo di pensiero e un simbolo per il suo esistenzialismo, non dichiarato ma vissuto, per le sue posizioni ferme, per la sua integrità morale, per il suo essere coscienza critica nei confronti della deriva nichilista del mondo contemporaneo e del totalitarismo. Per questo Nicola vide subito la differenza fra Camus e Sartre, che pure apprezzava come filosofo, ma a cui non perdonava il tatticismo, l’inchinarsi alle logiche della politica.
\r Con Malraux, invece, l’amicizia fu meno profonda che con Camus o Moravia, anche se si conobbero bene, visto che avevano combattuto insieme in Spagna.
\r L’amicizia con Malraux si raffreddò quando questi diventò ministro della cultura di De Gaulle. Chiaromonte pensava che Malraux si fosse come “acquattato” su De Gaulle e che per questo De Gaulle lo avesse premiato. In un certo senso riteneva che questo fosse un po’ il destino di Malraux. Di André Malraux, che riteneva un grande testimone del nostro tempo, lo affascinava il totale disincanto e il “demone dell’azione” che sembrava animarlo, il suo “agire senza credere”. Proprio in questa chiave analizzò in un saggio molto bello, Malraux e il demone dell’azione, tutta la sua attività culturale, letteraria, politica, e questo molto prima che il maggior biografo di Malraux, cioè il teorico della postmodernità François Lyotard, indicasse proprio in questo demone la “cifra” dell’”enigma Malraux”.
\r Nonostante il suo porsi contro le chiese cattolica e marxista e per un pensiero non conformista, Chiaromonte non fu tuttavia un entusiasta del ’68…
\r Chiaromonte non è stato un “filosessantottino”, ma non è stato neppure un nemico del ’68, almeno di quello che conobbe, visto che nel ’72 morì. Secondo lui non si poteva parlare di un “Sessantotto” perché le ragioni dei giovani che nell’Est, nei paesi comunisti, contestavano l’oppressione della dittatura erano diverse dalla contestazione di Berkeley e questa era a sua volta diversa da quella in Germania, in Francia o in Italia.
\r Appoggiava quasi incondizionatamente la rivolta dei giovani nell’est europeo e diceva che i giovani di Berkeley facevano bene a battersi contro la guerra nel Vietnam, così come riconosceva che in Italia i giovani avevano ragione nel pretendere un sistema universitario migliore, ma non approvava la “contestazione globale” perché sosteneva che se si contesta tutto si finisce col non contestare nulla.
\r Riteneva che nella rabbia dei giovani ci fosse soprattutto il disprezzo per una classe dirigente odiosa e per una politica che altro non era che “burocratismo di tipo zarista sulla società civile italiana”, ma secondo lui, ed è questo uno dei motivi della sua critica al ’68, l’ammutinamento degli studenti italiani aveva preso subito l’aspetto di una confusione tumultuosa sia nelle idee che negli atti, e questo era per lui inaccettabile, anche perché rifiutava l’idea che i giovani avessero ragione solo perché erano giovani.
\r Pensava che i nati dopo il 1940 si fossero trovati a vivere in una società che non poneva né meritava rispetto e contro questa mancanza di autorità da rispettare, contro questa assenza di guida morale, i giovani si ribellassero in una rivolta che esprimeva anche l’esigenza di avere un’autorità in cui riconoscersi, una disciplina a cui affidarsi, cosa che non c’era e che l’Occidente, non solo l’Italia, non era in condizioni di dare.
\r A quei tempi scriveva: “Il compito veramente storico dei nostri tempi, quello che merita e richiede l’entusiasmo di un giovane, è la ricostruzione della società devastata dalla forza e accasciata dalla soggezione alla forza. E’ un’opera questa che comincia necessariamente dall’esempio personale. Secondo Simone Weil tra le esigenze essenziali dell’anima vi sono la libertà insieme all’ordine, l’ubbidienza insieme alla responsabilità, l’uguaglianza insieme alla gerarchia, mentre la società contemporanea, oppressiva e permissiva, conformista e senza valori, è fondata invece sul disordine illiberale e sulla disobbedienza coercitiva. E’ contro questa mostruosità che i giovani si sono ribellati”.
\r Pensava anche che i miti esotici dei giovani di allora -Che Guevara, Ho Chi Minh, Mao Tze Tung- fossero per natura vacui o totalitari e portassero alla demagogia di massa e all’autoritarismo tecnocratico più o meno ammantato di ideologia. Non a caso presagiva la deriva terroristica che contribuì ad affossare i movimenti nati nel ’68. All’opposto del militantismo imperante in quel periodo,
Da . www.unacitta.it/newsite/intervista.asp?id=183
Nicola Chiaromonte
La nuova sinistra
Tratto da «Tempo Presente», settembre-ottobre 1967
Pubblicato in Cesare Panizza (a cura di), Nicola Chiaromonte, La rivolta conformista. Scritti sui giovani e il 68, Una Città, 2009
In realtà, un’opinione di sinistra inorganica e fluttuante esisteva fin dall’immediato dopoguerra. Pochi di quelli che aderirono al partito comunista durante la guerra e dopo, e nessuno di quelli che gravitarono intorno al medesimo partito negli stessi anni, erano comunisti. Comunisti erano i dirigenti e i funzionari, mentre la massa operaia, tutto sommato, rimaneva nel solco della tradizione socialista; ma comunisti non erano certo i molti compagni di strada, simpatizzanti, anti-anticomunisti e intellettuali marxisteggianti che fecero, fino al 1956 circa, la fortuna e il prestigio dei partiti comunisti. Erano, quelli, i seguaci approssimativi e confusionari di un’estrema sinistra di fantasia che si mettevano dalla parte del comunismo sia perché ritenevano doveroso aggregarsi alla marcia della Storia, sia perché credevano di trovare lì quello che non si trovava da nessun’altra parte politica: l’Idea, più l’efficienza.
Esisteva, fin da allora, una sinistra indefinita e mollemente eretica; anzi, si può ben dire che la sinistra era quella: del nucleo duro del comunismo ufficiale si cercava d’ignorare l’esistenza, ed esso stesso si camuffava in varie fogge. Ma, da tre o quattro anni a questa parte, è venuta formandosi una corrente d’opinione politica la quale non solo è completamente fuori da ogni partito, ma sfugge anche a ogni definizione ideologica chiara. Negli Stati Uniti, ha preso il nome di «nuova sinistra».
S’è formata, questa «nuova sinistra», per dato e fatto della politica americana: a essere esatti, in seguito alla guerra del Vietnam. Negli Stati Uniti, il movimento degli studenti dell’Università di Berkeley (ormai disperso) prese forza dalla ripugnanza per quella guerra, oltre che dal desiderio di agire -e non soltanto parlare- in favore dell’eguaglianza civile della popolazione negra. Anche in Europa, la guerra del Vietnam ha fatto cristallizzare, specie fra i più giovani, una corrente (o meglio si direbbe: uno stato) d’opinione le cui componenti sono abbastanza ovvie: antiamericanismo considerato sinonimo di anticapitalismo (e di antimperialismo); anticapitalismo inteso come rifiuto di quella che si usa chiamare «civiltà dei consumi» ed è concepita come l’ultimo stadio della degradazione della società borghese occidentale, la quale società sarebbe destinata a esser spazzata via dalla rivolta delle genti di colore o comunque vittime dell’imperialismo, Cina e Cuba in testa, Paesi dell’America latina e dell’Africa al seguito, magari con l’aggiunta degli arabi, vittime del colonialismo israeliano.
Questa sequela di tesi, nella quale si possono facilmente distinguere le influenze di J. P. Sartre e di Frantz Fanon, ma che in sostanza rappresenta una specie di riduzione all’estremo di taluni concetti che chiameremo marxisti tanto per intenderci, non costituisce certo un corpo di dottrine. Non varrebbe la pena di discuterla se non fossero in massima parte dei giovani a propugnarla e se, d’altro canto, il campo della politica offrisse attualmente a questi giovani altre e migliori indicazioni per manifestare l’insofferenza per il presente, lo sdegno per l’ingiustizia e il disgusto per la falsità che sono le passioni diremmo doverose della gioventù.
La questione potrebbe finire qui: con la constatazione che i fatti giustificano il ribellismo, sia pure incoerente, di questi giovani e che, visto che nessuno sa offrir loro un ideale politico più valido, è naturale che essi si servano di quello che son riusciti a fabbricarsi con i relitti e residui delle idee che hanno ereditato dai loro padri e fratelli maggiori.Ma non può finir qui, la questione. Per confusionari che siano, questi giovani vanno presi sul serio, e l’unico modo di non prenderli in giro è quello di trattarli da pari a pari, discutere le loro idee senza indulgenza né disprezzo.
Ora, il fatto è che le idee della «nuova sinistra» non peccano tanto per incoerenza quanto perché rappresentano un tentativo di uscire dal vicolo cieco in cui si dibatte da decenni la sinistra europea spingendo all’assurdo precisamente le tendenze che l’hanno portata nel vicolo cieco medesimo. Il che vale quanto dire che le idee della «nuova sinistra» non sono in realtà né un ripensamento delle idee socialiste o libertarie né un nudo, crudo e pragmatico piano d’azione, ma una mera operazione cerebrale: letteralmente, un sogno a soggetto politico, il quale può diventare tema di discorsi, e magari anche di libri, ma non per questo esce dall’irrealtà intrinseca che lo distingue. Giacché questi giovani e meno giovani aderenti della «nuova sinistra» non devono immaginare di essere i soli a riconoscere le ingiustizie, brutture, brutalità e insensatezze del mondo in cui viviamo. Che la guerra del Vietnam, per esempio, è orribile e assurda lo sanno anche i più alti dignitari del mondo cosiddetto «capitalista»: lo sa anche il Papa, oltre a saperlo la gente della sinistra vecchia e nuova. Il problema, per il Vietnam come per la questione dei negri e per le altre, è in qual modo efficace l’opinione contraria possa farsi valere. Ed è a questo punto che la «nuova sinistra» fugge per la tangente della rabbia, e proclama la guerra santa contro gli Stati Uniti o, per esser precisi, applaude alla guerriglia e alle sommosse razziali.
La nuova sinistra, cioè, non riconosce le cause, anzi la causa, da cui essa stessa ha origine. La quale non è la perversità dei governi o la pusillanimità dei socialdemocratici, ma l’impotenza apparentemente irrimediabile dell’opposizione, di ogni opposizione, nell’attuale condizione del corpo politico. È dall’esasperazione per l’apparente paralisi della politica interna (ossia della vita politica essa stessa) che nasce lo stato d’animo della «nuova sinistra». Ma quando poi si tratta di rispondere alle questioni di politica interna, tutto quel che essa sa produrre è o una surenchère massimalista sulla politica governativa o l’evasione nella politica estera.
Il fatto invece è che, in Europa come negli Stati Uniti, la questione cruciale oggi non è affatto quali scopi si debbano opporre alla politica governativa: in genere, basta mettere al negativo la politica del governo per avere un eccellente programma d’opposizione. Il problema è come fare perché il programma dell’opposizione diventi una politica: insomma, come fare perché, nelle attuali condizioni della società industriale, ci sia una vita politica e non soltanto delle decisioni che scendono dall’alto dopo esser state combinate negli altissimi consessi dei tecnici e dei burocrati, negli uffici di partito e nelle lobbies dei gruppi di potere.
Finché non si risolve questo problema, l’opposizione, ribellista o meno, rimarrà un fatto verbale e un sogno rabbioso. Verbo per verbo e sogno per sogno, tanto varrebbe allora ragionare sui dati elementari della situazione, mettendo fra parentesi ogni presupposto ideologico.
Ora, il dato più elementare della situazione è che l’attuale società industriale ammette in teoria prosperità quanta se ne vuole, e in più una grande e quasi illimitata libertà d’indifferenza (della quale anzi ha strettamente bisogno per funzionare); ma, quanto alla libertà politica in senso proprio, essa è tutta da restaurare: i meccanismi burocratici e tecnici l’hanno esautorata. Ora, la libertà politica non è un bisogno di massa, benché, senza libertà politica, tutto quel che le masse possono sperare è una porzione congrua di beni di consumo; di giustizia è inutile parlare; e, quanto alla pace, dipende dai calcoli geopolitici e strategici.
Dal che discende che la restaurazione della libertà politica (che poi è quanto dire di una vita politica reale e non cifrata) è oggi inevitabilmente compito di una minoranza di volontari, ed esige molta più risolutezza e tenacia che non ne occorra per propugnare la guerriglia in Paesi lontani.
Ma questo non è lavoro che si possa esigere dai giovani della «nuova sinistra». Dai padri e dai fratelli maggiori, essi hanno appreso a correr dritto alle conclusioni, non a esaminare le premesse; hanno appreso ad ammirare e seguire chi agisce in modo spettacolare, non chi ragiona; hanno imparato che il mondo è quello che è e bisogna prenderlo per quello che è, non sognarne un altro che non esiste. E allora, quando si trovano dinanzi a una realtà che non li soddisfa, non possono fare altro che decidere verbalmente in favore del più estremo e del più violento. Dunque si schierano con Mao Tse e con Guevara. A parole, s’intende. Infatti, oggi, un giovane europeo ribelle che cos’altro può fare se non dire di essere in favore della rivoluzione culturale in Cina e della guerriglia in America latina, nonché magari nelle città degli Stati Uniti, secondo predica Stokely Carmichael[1]? Non troverà neppure contraddittorio, un tal giovane, dopo aver detto cose simili, marciare per la pace e contro la bomba atomica. Quanto all’effetto di un tal dire, c’è la soddisfazione di sentirsi dalla parte non solo della giustizia, ma anche della potenza (nel caso della Cina) e della violenza avventurosa (in quello dei guerriglieri castristi).
In ultima analisi è il culto della potenza e della violenza che si diffonde, sotto specie di «nuova sinistra». E, con questo, il cerchio dell’involuzione della sinistra europea, cominciata nel 1914, si chiude.
Giacché è come rivolta contro la potenza e la violenza che la «sinistra» liberale, democratica e socialista nacque, in Europa. Anche se portò sempre in sé un certo culto romantico dell’azione violenta, il movimento libertario e socialista del secolo scorso rimase sempre, nel fondo, pacifico e pacifista. Il culto dell’azione e dell’eroe guerriero, liberali, democratici e socialisti lo lasciarono sempre ai reazionari, ai militaristi, ai nazionalisti. La cosa diventò più che chiara col fascismo e col nazismo. Ma la seconda guerra mondiale (senza parlare di ciò che l’aveva preceduta, in Russia e altrove) non scatenò soltanto la bestialità hitleriana, bensì dappertutto e in tutti (tranne un’infima minoranza) la convinzione «realista» che nulla, nella storia, si ottiene senza violenza e, per converso, con la violenza bene organizzata si ottiene tutto.
Questo è il punto a cui siamo. A questi princìpi sta tornando, sotto specie di perfetta tecnicità, la società organizzata. Ma c’è da notare che, nel frattempo, i mezzi di far violenza sono diventati, più che efficaci, assoluti, e sono proprietà esclusiva dei ricchi e dei forti. Sicché l’appello alla violenza per il supposto riscatto dei deboli oppressi non può avere da ultimo altro risultato che di rafforzare i potenti. È quindi condannato a fallire, non foss’altro che perché si riduce ad affrontare l’avversario sul terreno sul quale esso è più forte, tattica sbagliata anche in termini guerreschi.
Nicola Chiaromonte
Prigioni in Spagna
Pubblicato in Dedicato a Nicola Chiaromonte nel trentennale della morte, quaderni dell’altra tradizione, 1, Una Città, 2002
I viaggi sono ridiventati molto lunghi. Ero in America da otto mesi e questa donna non era ancora arrivata. Eppure aveva lasciato la Francia con suo marito molto prima di me. Mi ricordo di lei con amicizia perché a Tours, poche ore prima dell’arrivo dei Tedeschi, fu lei a trovare un posto in un’auto per un amico ammalato, aprendosi un varco nella mischia delle macchine e delle persone a piedi che lasciavano la città, fermando le macchine al volo, gridando, imprecando, litigando con le persone con questa specie di energia assurda che solo le donne sono ancora capaci di conservare quando gli uomini vedono ragioni solo per la calma del fatalismo. L’ho incontrata qualche giorno fa in un “Caffè Viennese” della 72° Strada, da sola.
Ero contentissimo di rivederla. Ogni volta che si ritrova da questa parte una persona che viene da oltre oceano, si ha l’impressione che finalmente la vita riprenda come prima. Non è vero. Mi ha sorriso con la stessa intensità ed evidentemente con la stessa illusione.
«Sono così contento di rivederla. E suo marito?»
«In Germania. Gli Spagnoli ci hanno arrestato alla frontiera. Siamo rimasti sei mesi in prigione. Un giorno hanno portato Friedrich a Hendaye. L’ho saputo una settimana dopo». Insieme con l’imbarazzo, ho provato una sorta di gelosia. Avevo conosciuto solo la prigione di Marsiglia. Non si finisce mai di essere snob. Questa amica di un giorno di giugno del 1940 si è messa allora a raccontare. Raccontando, tirava fuori dalla borsa ogni sorta di carte, foto, piccoli oggetti: prove, souvenir, i bigliettini scambiati col marito in prigione, la foto di una compagna di cella, lo specchio e il pettine e il tubetto di rossetto che era riuscita a tenere durante la prigionia. Ero sorpreso dal tono del suo racconto: raccontava quasi alla terza persona come se si fosse trattato di un’altra persona conosciuta benissimo tempo fa ma che si comincia a dimenticare. Anche parlando di suo marito, era stranamente apatica. Avevo la sensazione di parlare a qualcuno ormai convinto che la fatalità esiste.
«Lei conosce queste storie di consolati, di visti, di permessi, di timbri, di biglietti di passaggio. A un certo punto, con mio marito, decidemmo che il fatto di avere il visto americano, il visto di transito spagnolo, e il visto portoghese fosse sufficiente. Passammo a piedi la frontiera franco-spagnola in direzione di Figueras. Trovammo Figueras, ma non il posto di dogana. Ci mettemmo a cercarlo affinché i nostri passaporti venissero debitamente timbrati. Fu allora che ci avvicinarono dei poliziotti in uniforme, molto cortesi, molto miti, che ci dissero: “Ma sì, naturalmente, è semplicissimo. Dateci i vostri documenti, vedremo”. Uno di loro restò con noi, un giovane uomo gentilissimo ma poco loquace, che insistette perché andassimo a cena in un certo ristorante. Lo seguimmo. Era buio. Figueras è una cittadina di 16 mila abitanti, che porta ancora le tracce della guerra: case demolite, facciate screpolate e crivellate di proiettili. Hanno lasciato tutto com’era. Tutto in una semi-oscurità. A Figueras c’è solo la prigione a essere illuminata, a giorno, dai fari. E’ molto strano: una specie di pubblicità. Questa luce la si vede dappertutto».
«Nel ristorante, c’era una cameriera bella come la “bellezza spagnola” dei film. Il nostro poliziotto le rivolgeva dei complimenti, le chiedeva quando si sarebbe decisa a sposarlo, e lei rispondeva con sorrisi e piccoli gesti divertiti. Sembrava che ci fosse una specie di “fiesta” quella sera a Figueras: una celebrazione militare e nazionalista, qualche cosa di importante, non so più a proposito di cosa – il 3 ottobre. Cosa poteva essere?»
«El Dia de la Rosa probabilmente, il “Columbus Day” visto dall’altra parte».
«Bene, così, per dire qualcosa, chiesi alla graziosa ragazza se avesse intenzione di andare. Rispose molto tranquillamente: “No, non usciamo per questo”. Non c’era gran che da mangiare, i clienti non erano numerosi. Chiedemmo alla nostra guida se credeva fosse tempo di andare a prendere i nostri documenti. Apparve seccato, ma disse che ci accompagnava a vedere. Per strada, cambiò idea. Disse che sarebbe andato da solo, e che potevamo aspettarlo in un caffè. Sempre gentilissimo, ma allo stesso tempo molto evasivo. Nel caffè, mentre beveva un anice, mio marito mi disse: “Ho come l’impressione che sarebbe meglio tagliare la corda e tentare di tornare in Francia”. Ma ci avevano preso tutti i documenti: dove trovare il coraggio di abbandonare il visto americano? L’osservazione di Friedrich mi fece preoccupare. Provavo il bisogno di mettermi a spiegare la nostra situazione alla padrona, una donna magra e triste, di età incerta. Ascoltò e rispose con due parole e un gesto: “Mio marito” e il gesto delle sbarre fatto incrociando le dita fra loro».
«Fu in quel momento che il giovane poliziotto tornò. Aveva, nei nostri confronti, l’aria personalmente soddisfatta di prima, ma un po’ più evasiva e distante: “Bisogna che veniate al posto di polizia. Chiedono delle spiegazioni”. Lo seguimmo, molto preoccupati. Se ne accorse e disse: “Oh, non sarà niente”. Al posto di polizia, ci fecero ogni sorta di domande, e infine ci dissero che erano costretti a chiedere istruzioni a Madrid prima di lasciarci liberi. Può immaginare come abbiamo cercato di protestare: dopo tutto, per la Spagna, i nostri documenti erano in regola, eccetera – rimostranze giuridiche, genere S.J.N. Siamo proprio contaminati da abitudini borghesi per non capire immediatamente che quando si viene afferrati da questo genere di meccanismi, non ce la si può cavare con scaltrezze da avvocato; ormai si entra nella zona dell’arbitrario, della fortuna, del miracolo – e nel caso di un’eventuale lotta, i mezzi da usare in ogni caso sono ben altri. La cosa migliore forse è accettare passivamente fino a che non si capiscono le regole del gioco e non si scorge il punto debole dell’ingranaggio».
«Così, facemmo il nostro ingresso nella prigione di Figueras. E’ – gliel’ho detto – un edificio immerso nella luce. Si entra attraverso tre mura di cinta concentriche – e ogni cinta è violentemente illuminata da fari potentissimi. E’ per impedire le evasioni». «Ai tempi dei “rossi”, durante la guerra, c’erano 80 prigionieri in questa prigione. Quando ci entrammo ce n’erano 750 – e non erano i soli; anche “El Castillo”, una vecchia costruzione del XVIII secolo, era stata trasformata in prigione. Ma là c’erano solo uomini. Inoltre, molte delle persone di Figueras venivano mandate nella grande prigione di Gerona. Così mi hanno detto. Figueras conta 16 mila abitanti. Credo non sia esagerato dire che, degli abitanti di Figueras, uno su dieci vive in prigione».
«Non ero mai stata in prigione. La cosa tremenda, il vero incubo, era la sporcizia. Avevo sentito parlare dei soldati nelle trincee durante l’altra guerra, e dei parassiti che facevano camminare le camicie da sole non appena i soldati se le toglievano di dosso. Naturalmente, credevo fosse una metafora. Ma la biancheria che lavavamo e mettevamo ad asciugare nel cortile della prigione di Figueras, la riprendevamo poi coperta di pidocchi perché le prigioniere restavano appoggiate ai muri la maggior parte del tempo e là le bestie viaggiavano. Nel cortile stavamo all’aria aperta. Ma cosa c’era nella sala comune in cui sono rimasta tre mesi, lei non può immaginarlo. La maggior parte delle mie compagne erano delle politiche. Ma per tutto il tempo c’era un andirivieni di mendicanti, zingare, prostitute miserabili. Molte di loro erano spossate, inebetite, affamate, si facevano arrestare apposta per avere qualcosa da mangiare – le dirò poi cosa. Si buttavano sul loro giaciglio e non si spostavano di là per nessuna ragione o necessità. Al mattino dovevamo pulire la sala e i gabinetti. Era talmente disgustoso. Ci provavo due o tre volte e poi offrivo dei soldi perché qualcuno lo facesse al posto mio: non ci resistevo».
«In queste condizioni, il meno che potesse capitare era la scabbia. Non c’era infermeria, né visita medica, né alcun tipo di farmacia. Ma per lottare contro i pidocchi una volta la guardia si decise a far tagliare i capelli a due prostitute talmente sporche che pure le zingare ne erano rimaste disgustate e avevano protestato. Contro la scabbia, davano una specie di liquido giallastro che bruciava la pelle e causava un’altra specie di eczema. Un giorno decisero di vaccinarci contro il tifo, e ci fecero l’iniezione: tutte in fila e lo stesso ago per tutte, senza alcool né niente. Era il genere di cose che spaventava di più, me e le altre donne straniere. Le spagnole non si preoccupavano di niente, convinte com’erano che si può morire per una cosa come per un’altra».
«In effetti, le persone morivano in quella sala: ogni mattina la guardia mi chiedeva uno specchietto che avevo conservato in una tasca e con questo strumento scrutava le bocche delle persone sdraiate. I corpi che non respiravano più venivano trasportati nei gabinetti. Li lasciavano là alcune ore e poi li portavano fuori. Quando la sala era piena, con più di 200 prigioniere, tutte le mattine trovavano uno o due cadaveri».
«Vedo che lei mi guarda. Gli orrori. Sa, quando entrai per la prima volta in quella sala, ebbi l’impressione di capire d’un tratto tutto, e altrettanto immediatamente accettai tutto. Non so come spiegarmi, ma decisi che la sola cosa da fare era restare estranea a tutto quello che poteva capitarmi e non comportarmi in modo egoista. Sono stata aiutata molto dalle mie compagne. Non tanto dalle straniere quanto dalle spagnole».
«Ad esempio c’era Maria Gracia, una maestra socialista di Gerona, condannata a trent’anni. Era in prigione dal 1939. Pure suo marito, maestro, era stato condannato all’ergastolo; era nella grande prigione di Gerona. Maria Gracia era timida e pudica come una suora. Viveva in una malinconia tranquilla e senza speranza, si interessava solo ai libri che poteva procurarsi. Quando vide arrivare in prigione tante straniere, belghe, ceche, tedesche, polacche (tutte arrestate perché mancava il timbro sui loro documenti) ebbe l’idea di imparare le lingue, e si mise a prender da ognuna dei nomi di oggetti, verbi, piccole frasi che ripeteva tre o quattro volte pregandole di correggere i suoi errori di pronuncia. Aveva un altro desiderio molto vivo – di avere alcune immagini da guardare. Voleva immagini serie, immagini di vere opere d’arte. E quando la lasciai quel che mi chiese fu di inviargliene dall’America. Come idee, era socialista. Sulla situazione presente, ecco quello che pensava: “I fascisti sono i padroni. L’Unione Sovietica ci ha traditi. Siamo socialisti, e sarebbe disonorevole aspettare la nostra salvezza dal capitalismo inglese. Per noi, non c’è speranza quindi. Ma un giorno il popolo si ribellerà di nuovo e vincerà”. Non sperava di vedere quel giorno. Ogni tanto i suoceri le portavano da Gerona i suoi due figli a farle visita. Dopo queste visite, Maria Gracia non era né più triste né più allegra. Viveva realmente e con calma nella disperazione».
«C’era anche Annucion, una donna di una quarantina d’anni condannata a sei anni. Perché sei anni – e non 15 o 30? Forse perché lei era solo una contadina, mentre Maria Gracia era un’intellettuale. Ma Concepcion e Sara, due cugine, una di 24 l’altra di 25 anni, non erano intellettuali, neanche loro. Erano delle modiste, molto incolte, che parlavano solo di ballo e di cinema, e tuttavia le avevano condannate tutte e due a 15 anni perché si sapeva che erano fidanzate a due ragazzi del partito che chiamano “trozysta”».
«Poi c’erano quelle che non erano condannate a una pena determinata e che molto semplicemente venivano tenute in prigione. Ad esempio, due donne di più di quarant’anni, tutte e due rimandate in Spagna dal governo francese. Una di loro aveva perduto il marito in Francia e un bambino di 3 anni, e non faceva che piangere tutto il giorno. Era infermiera e fu lei un giorno ad aiutare una prigioniera polacca a partorire. Fu molto difficile a causa di un’emorragia. Non avevamo niente di pulito, dovemmo fare alla poveretta una sorta di letto coi giornali, per evitare che il materasso si inondasse di sangue. Gliel’ho detto, non c’era modo di avere un medico, per nessuna ragione. Non credo fosse una crudeltà calcolata. Più probabilmente, vigeva il principio che, primo, non avendo dietro di noi alcuna potenza che potesse proteggerci, per così dire non esistevamo. Secondo, con tanti prigionieri, era già abbastanza complicato tenere in ordine le carte amministrative per preoccuparsi di questioni sanitarie».
«Del resto, le condanne inflitte ai prigionieri maschi avevano un carattere ancora più capriccioso. Friedrich mi raccontò che con lui c’era un giovane di Gerona che, per cominciare, era stato condannato a morte. La sua famiglia era abbastanza influente, avevano ottenuto la revisione del processo. E alla revisione del processo i giudici avevano commutato la pena di morte in tre mesi di prigione. Nello stesso tempo, un amico di Maria Gracia, condannato a morte, era stato dimenticato per dodici mesi nella prigione di Figueras. Poi, un giorno, erano venuti a prenderlo per condurlo a Gerona, e là, nel cortile della prigione, l’avevano infine fucilato in presenza di tutti i detenuti: “per dare l’esempio”».
«Per quel che riguarda noi stranieri, poiché avevamo voluto fuggire da Hitler, dovevamo essere tutte persone “che avevano qualcosa da nascondere”. Se non ci davano le stesse pene dei “rossi spagnoli” è perché, non essendo spagnoli, non spettava formalmente allo stato spagnolo il dovere di “darci una lezione” o di eliminarci. Ma occorreva “accertare” i nostri casi uno per uno. Questo richiedeva molto tempo, molta noncuranza, molto capriccio. Dopo tutto, non eravamo neanche dei condannati a morte»
«C’era ad esempio il caso di Erna J., una ceca di 25 anni. Era la figlia di un sarto residente in Belgio da quindici anni. Il suo fidanzato era emigrato in Argentina prima della guerra. A un certo momento Erna aveva deciso di raggiungerlo ed era partita da Bruxelles senza visto, senza passaporto, con pochissimi soldi. Dalla Francia aveva attraversato a piedi la frontiera spagnola. L’avevano arrestata. Dopo alcune settimane l’avevano mandata a Madrid, alla “Seguridad” per “accertare il suo caso”. La Seguridad l’aveva rimandata a Figueras. Dopo sei mesi di detenzione a Figueras, l’avevano fatta uscire, l’avevano portata in montagna, e le avevano detto: “Lei è libera, ritorni in Francia”. Non la trovò la Francia, si perse fra le pietre dei Pirenei e fu ritrovata dopo due giorni da un doganiere spagnolo, svenuta e mezza morta. Il doganiere la riportò a Figueras. A Figueras la dichiararono in stato d’arresto e fu di nuovo rinchiusa».
«A quel tempo, con Friedrich c’era un francese fuggito dalla Francia grazie a un passaporto spagnolo comprato da un calzolaio spagnolo di Montauban. Avevano scoperto il broglio. Il fatto è che scoprirono che nel 1934 questo calzolaio era stato condannato dai tribunali spagnoli a tre mesi di prigione per avere ingiuriato una “guardia civile”. I tre mesi di prigione li fecero fare a Morand, poi lo liberarono».
«Fra gli uomini, nella situazione più penosa c’erano quelli che la polizia francese prendeva dai campi di concentramento francesi per consegnarli alla Spagna oppure che fuggivano da soli dai campi francesi sperando di potersela cavare, una volta nel loro paese. In particolare, quelli che venivano dal campo di Argelis morivano dopo alcuni giorni di inedia».
«Non so se questo le dà un’idea di come le cose funzionavano. Per quel che riguarda me e Friedrich, eravamo continuamente sballottati fra l’idea che “dopo tutto, non c’è ragione di disperare”, e l’altra: “Ci si può aspettare di tutto”. Chiedemmo di parlare al direttore. Trovò che avevamo troppa paura; di certo c’era che un giorno o l’altro Madrid avrebbe risposto. “Dopo tutto – fu la sua conclusione – qui non state molto peggio che fuori”. In generale, era inutile rivolgersi a lui. La sua posizione era quella del tiranno che ha risolto tutti i suoi problemi, i suoi sudditi sono nell’impossibilità di nuocergli e non gli restano da risolvere che i piccoli dettagli amministrativi. Sospettavo che complicasse apposta il caso delle persone che avevano soldi, per costringerle a spenderne il più possibile nel suo istituto di pena. La famiglia di Friedrich ci aveva inviato da New York 500 dollari, e noi decidemmo di rivolgerci a un avvocato. Il direttore sollevò tutte le difficoltà del mondo alla nostra decisione, dicendoci che l’avvocato era un imbroglione, che era inutile in ogni caso, ecc. Si arrese infine alle nostre insistenze, ma evidentemente contrariato. Bisogna dire che effettivamente l’avvocato non servì a niente».
«Quei soldi ci furono molto utili per comprare qualcosa da mangiare fuori. Con la sporcizia e il freddo, la fame era il terzo supplizio. Ci davano due minestre al giorno: un mezzo litro di acqua calda con dentro alcuni oggetti indefinibili e nauseabondi, compresi mozziconi di sigaretta e insetti. In più una fetta di pane di ceci molto sottile e molto pesante. Capii molte cose della condizione umana quando vidi la folla delle detenute cominciare ad agitarsi una mezz’ora prima della distribuzione di queste materie alimentari, poi accalcarsi, impazienti, inquiete, davanti alla porta, e infine precipitarsi attorno alle pentole lottando fra loro per avere una cucchiaiata di minestra in più. Un pasto comprato fuori costava 50 pesetas. Il dollaro veniva scambiato nella proporzione di 12 pesetas per un dollaro. Così un po’ di prosciutto, del formaggio e due banane costavano da 6 a 8 dollari. C’era solo qualche straniero fra i detenuti che potesse pagarsi un tale lusso, ma non tutti i giorni ovviamente. A proposito di fame, Friedrich era considerato dai suoi compagni un signorino schizzinoso perché non mangiava le bucce delle banane».
In Francia avevo letto un articolo della Revue des deux mondes in cui si spiegava che in Spagna i prigionieri politici erano oggetto di un lavoro di “rieducazione”. E’ vero. La mattina, verso mezzogiorno, al momento della passeggiata, i prigionieri erano costretti a cantare l’inno falangista, “Cara al sol”. Le guardie erano particolarmente esigenti con gli uomini, arrivavano a far loro ripetere l’inno fino a sette o dieci volte se sbagliavano una parola o non mostravano abbastanza brio. Alla domenica questo diventava un vero concerto: bisognava cantare non solo “Cara al Sol”, ma anche “El Requete” e l’inno nazionale “Triunfa España”. Alla fine, la guardia preposta ai canti gridava: “España!”. E bisognava rispondere in coro: “Una! Grande! Libre!”».
«Al sabato veniva il prete per ricevere le confessioni dei peccatori. Era un brav’uomo di una cinquantina d’anni che non insisteva molto sulle preghiere e accettava, con un’aria mezzo burbera mezzo spaventata, di fare delle commissioni all’esterno».
«La domenica, nel pomeriggio, c’era la visita delle dame cattoliche. Ci riunivano in una sala detta “della scuola”, tutta tappezzata delle parole storiche dell’eroe nazionalista, Antonio Prima de Rivera. Là dentro, le dame non si limitavano a tenerci discorsi sulla morale cattolica e nazionale. Spingevano il loro zelo fino ad organizzare rappresentazioni teatrali edificanti che avevano per tema la vita della Vergine, di Santa Teresa e di altri santi nazionali»
«Infine, c’era un avvocato che era stato in prigione sotto la Repubblica e veniva a tenere conferenze sugli “orrori” dei Rossi. I detenuti si vendicavano come potevano, cantando in sordina parecchie volte al giorno l’inno anarchico “Hijos del Pueblo”. Nonostante il pericolo, i “non-politici” si univano a questi cori, perché il bisogno di sfogarsi era veramente molto forte. Se non si alzava troppo il tono, le guardie facevano finta di non sentire. Ma se per caso qualcuno si lasciava trascinare dalla musica, il castigo andava da 15 giorni a un mese di cella, a pane e acqua».
«In genere, l’atteggiamento delle guardie era molto strano. La loro insensibilità alle sofferenze dei prigionieri sembrava totale. Mute e sorde, vi ascoltavano senza rispondere, guardandovi senza vedervi e non si poteva ottenere da loro il più piccolo favore se non coi soldi e neanche sempre. E poi, ogni tanto, senza che si chiedesse loro niente, ci portavano delle cose da mangiare: mele, fichi secchi, olive. Sempre senza parlare, sempre con un’aria di assoluta ripugnanza: talmente assoluta che assomigliava a rabbia o a paura – mal represse».
«C’era Torrejo, il vero bruto, colui che vi rivela immediatamente il carattere della prigione. Per lui il lavoro terribile era quello di fare l’appello dei prigionieri e contarli. La paura di sbagliarsi, o di essere ingannato, e di lasciar scappare uno dei dannati lo faceva andare fuori di sé. Tutte le mattine era la stessa scena grottesca, e questo finiva la maggior parte delle volte con qualche condanna alla segreta».
«Il più strano era Salvador, un ragazzo di 19 anni, originario di Pamplona. Era ufficiale in una delle sei o sette polizie speciali create da Franco. Dicevano che suo padre era stato ucciso dai fascisti nel 1936 e che aveva simpatie segrete per i “rossi”. In ogni caso, aveva fatto carriera sotto Franco e, per essere stato nominato ufficiale così giovane, doveva certo essersi guadagnato meriti speciali. Per me, resta una specie di simbolo oscuro della sorte della gioventù negli Stati totalitari. Gli piaceva sorvegliare il canto degli inni franchisti nel cortile. Assisteva alla cerimonia con una specie di smorfia sprezzante stereotipata sul viso. Provava piacere ad ordinare di ricominciare. Questo, sicuramente non perché fosse arrabbiato nel sentir deformare quelle armonie falangiste. Ma l’assurdità della cerimonia lo affascinava, e sembrava compiacersi a renderla esasperante senza remissione. Friedrich mi raccontò che un giorno, durante questo esercizio, uno dei prigionieri più giovani era stato preso da una crisi nervosa e si era buttato a terra, singhiozzando. Sempre col suo sorriso freddo, Salvador gli si era avvicinato e, toccandolo con la punta dello stivale, senza fermarsi, gli aveva sibilato fra i denti: “Un politico che piange: non ti vergogni?”. Come un ufficiale che redarguisce un suo soldato. Ognuno doveva fare la sua parte: ai condannati toccava soffrire con dignità per l’ideale; quanto a lui, era dall’altra parte e intendeva fermamente restarci. La sola cosa che gli importava era il suo grado, perché questo rappresentava il potere, e soprattutto l’immunità. Perché la prigione lo spaventava. Le maniere da ufficiale di cavalleria che ostentava, la sua freddezza e il suo sorrisino non smettevano di evocare l’immagine dell’apprendista-acrobata che cammina sulla corda rigida, in preda alla paura di cadere. Aveva un debole per le donne e si divertiva, ad esempio, a fare irruzione nella nostra sala quando ci stavamo lavando; sempre con la stessa aria sarcastica. Restava là immobile, come un cattivo ragazzo sfacciato piuttosto che come un carceriere convinto che tutto gli sia permesso. Un giorno, esasperata, gli ho gridato: “Lei non ha il diritto di fare questo”. Mormorò una parola – “Sciocchezze” – e se ne andò. Questo genere di divertimento gli costò un mese di prigione, perché una notte si lasciò sorprendere dal sorvegliante-capo nella sala delle prostitute. Nonostante quel che si diceva, il suo atteggiamento verso i “rossi” non tradiva alcuna simpatia. Ma neanche alcun odio ideologico. Piuttosto, il suo sembrava sempre una sorta di sogghigno assurdo rivolto, in generale, a tutti coloro che avevano creduto che “ci sono delle cose che non possono succedere”. Non c’erano limiti, tutto poteva succedere, il mondo poteva uscire dai gangheri del tutto normalmente, seguendo rigorosamente la catena delle cause e degli effetti. Ciò che urtava, con lui, era il fatto che ostentasse questa convinzione con una specie di snobismo e di soddisfazione. Gli altri carcerieri che ho visto in Spagna esprimevano la stessa idea con più semplicità e arrivavano anche, di tanto in tanto, ad avere ricordi di un passato umano».
«Dopo tre mesi a Figueras, ci trasferirono, Friedrich e me, a Madrid. Facemmo il viaggio insieme. Ancora una volta parlammo di fuga e, ancora una volta, l’idea di restare senza documenti ci fermò. C’era anche la speranza imbecille che, siccome “non avevamo fatto niente”, avrebbero finito col liberarci. Arrivati a Madrid, ci separarono. Friedrich fu condotto alla prigione di Commendadores, io a Claudio Cuello, una delle due prigioni femminili della capitale, un vecchio convento».
«Una sede posta sotto l’autorità esclusiva dei falangisti, con un regolamento più duro che a Figueras, e il mangiare molto peggiore. Una sola minestra orribile e una libbra di pane al giorno, distribuiti senza alcuna regolarità, la qual cosa è molto demoralizzante quando si vive rinchiusi e affamati. Ma avevamo diritto a tre docce al mese e i locali erano puliti. Al sabato e alla domenica avevamo diritto a leggere, ma solo i libri della biblioteca della prigione. I “politici” erano separati dagli altri. Di solito, c’erano 1500 politici. Al momento dei transiti, arrivavamo a essere fino a 4 o 5 mila. Bisogna contare che a Madrid c’è un’altra prigione di donne, quella di Ventas, con più di 3 mila prigioniere».
«Dopo la perquisizione d’uso mi portarono in un’enorme sala di mattoni bianchi, molto fredda e assolutamente spoglia. “Ci si procura da fuori quello di cui si ha bisogno”, mi disse la donna in uniforme falangista che mi portò là dentro. In effetti, non c’erano giacigli né sgabelli, là dentro, e non mi avevano dato né materasso né coperta. Fui accolta da una vecchia signora che mi introdusse nella “élite” della sala. Quasi tutte le prigioniere avevano ricevuto dalle loro famiglie un materasso e delle coperte. Ma questa sala era così fredda che si erano messe d’accordo per mettere due o tre materassi uno sull’altro e dormire in due o tre nello stesso spazio ristretto. Questo aveva il vantaggio di mettere strati di lana fra il cemento ghiacciato e il corpo e, nello stesso tempo, di sfruttare il calore naturale».
«La prima notte, dormii con la vecchia signora. Era una russa che abitava in Spagna da più di 15 anni. Durante la guerra, aveva fatto l’interprete per i piloti sovietici. Passava il tempo a insegnare il tedesco, il francese e il russo alle detenute».
«E’ a Claudio Cuello che capii la prigione. Mi avevano parlato degli strani sentimenti che provano coloro che hanno passato lunghi anni in prigione: la nostalgia della cella, la tenerezza morbosa con la quale parlano dei prigionieri, i sogni che fanno di una forza misteriosa che li riconduce irresistibilmente verso il luogo delle loro pene. Ero convinta che si trattasse di cattiva letteratura. Ebbene, ora so che non solo è vero, ma naturale. So che coloro che non hanno conosciuto la prigione non conoscono in ogni caso che la metà della verità sull’esistenza. Non solo: laggiù ho fatto l’esperienza di un’immensa collettività, la collettività dei prigionieri che abbraccia un paese per tutta la sua estensione. Fra prigioni e campi di concentramento si parlava di due o tre milioni di detenuti politici. Non posso dire se è esatto, ma posso dire che ho sentito vibrare tutti i giorni una vita che abbracciava tutte le regioni della Spagna, dalla Catalogna all’Andalusia, dalla Castiglia ai Paesi Baschi. Tutti i giorni si ricevevano notizie da tutta la Spagna, dalla Spagna delle prigioni, naturalmente, perché anche le notizie da fuori erano viste unicamente in relazione agli interessi e alle speranze della comunità dei prigionieri. Si potevano seguire centinaia e migliaia di condannati da luogo a luogo, riceverne notizie, inviarne. Era come una grande centrale telegrafica. Questo si faceva tramite i prigionieri in transito, la cui preoccupazione più urgente era sempre quella di informarsi e informare, ma anche con altri mezzi innumerevoli. Queste astuzie e sottigliezze, questa prontezza ad approfittare di possibilità microscopiche, le ingegnosità infinitesimali e semplici che finiscono col produrre l’effetto dell’”inspiegabile mistero”».
«Così, un giorno, ho ricevuto l’anello che Friedrich aveva fatto fare per me nella prigione di Commendadores con una moneta francese da dieci franchi. Una donna me lo portò, con un piccolo messaggio. Come era potuto avvenire il passaggio? Aveva ricevuto l’anello da una donna che veniva trasferita a Malaga e non ne sapeva di più».
«D’acciaio, d’alluminio, d’argento o di rame, questi anelli sono il segno di riconoscimento dei prigionieri in tutta la Spagna. Non occorrono strumenti per farli; basta avere un pezzetto di materia sufficientemente dura per battere il metallo».
«Sono dei simboli come questo che vi fanno sentire che soltanto l’ultimo superstite della specie umana proverà veramente l’orrore della solitudine, ma prima di lui…»
(traduzione dal francese di Vanda Fava)
Nicola Chiaromonte
Pierre J. Proudhon – un pensatore scomodo
Tratto da «Europa socialista», 1946
E’ un detto di Fouché: «Datemi un pezzo di carta con la firma d’un uomo, ed io lo farò giustiziare». Questo può essere un principio basilare della procedura cui s’informa la Polizia di Stato, ma nelle istanze intellettuali non è davvero un buon criterio.
Con delle citazioni artificialmente strappate dal loro nesso, il sig. Schapiro (*) si propone di dimostrare che Proudhon era: 1) «un precursore delle idee fasciste… che si fece il propagatore del concetto fascista di un superamento rivoluzionario della democrazia e del socialismo… il portavoce spirituale dei ceti medi francesi»; 2) un sostenitore della dittatura in generale e di Luigi Napoleone in particolare; 3) un antisemita; 4) un nemico dei negri americani; 5) un guerrafondaio; 6) un nemico dell’uomo comune; 7) un antifemminista.
Il primo di questi capi d’accusa viene provato dal sig. Schapiro nel modo seguente: Proudhon era un piccolo borghese ed un precursore del fascismo perché non credeva nella nozione marxista della «lotta di classe», né in quella di una rivoluzione violenta coronata dalla vittoria del proletariato; per contro egli pensava che, nei tempi moderni, una rivoluzione violenta non poteva significare altro che la dittatura e condurre al trionfo dei ceti medi. Tuttavia, aggiunge Schapiro, Marx ed i socialisti avevano torto, in quanto essi non compresero esattamente il carattere ed il ruolo storico delle classi medie, mentre l’intuizione «disarmonica» di Proudhon è stata avallata dagli eventi contemporanei.
Da tutto ciò risulta in modo evidente che il sig. Schapiro, pur non credendo nella fondatezza delle nozioni marxiste, se ne serve tuttavia per caratterizzare Proudhon e per dimostrare che questi in fin dei conti non aveva del tutto torto, ma era un cattivo soggetto. In questo sta tutta la stranezza del suo modo di ragionare. Perché da un punto di vista marxista si può giustamente affermare che Proudhon è stato un piccolo borghese, un traditore, un fascista, dato che non credette nella lotta di classe, nella dittatura del proletariato, e cosi via. Ma se l’autore è del parere che le concezioni marxiste sono ad ogni modo sbagliate (e soprattutto nei riguardi dei problemi fondamentali come il ruolo storico delle varie classi), allora si ha il diritto di pretendere da lui che giudichi Proudhon partendo da qualche altra base chiaramente definita, e tenendo conto di ciò che è realmente il pensiero di Proudhon.
La disinvoltura del Sig. Schapiro
Io ritengo che le idee di Proudhon (se siano giuste o sbagliate è un’altra questione) si trovano enunciate nella sua opera con perfetta chiarezza per chiunque voglia fare un piccolo sforzo per comprenderle. Se dovessi riassumerle in poche parole, io direi che la preoccupazione principale di Proudhon è stata quella di scoprire nella vita della società umana una verità che non fosse una verità «classista», affinchè il trionfo della giustizia sociale fosse un trionfo della ragione e non della violenza, una creazione della società stessa e non una imposizione dall’alto, qualunque fosse il nome di questo ente superiore -Iddio, coercizione statale o dittatura di classe. Questa verità egli chiamò Giustizia, intesa sia come «idea», sia come realtà concreta, inerente -in un senso positivo e negativo- ad ogni ordinamento sociale. Di questa idea che ispira tutta la sua opera, Proudhon fece un’esposizione poco sistematica, ma tanto più suggestiva, nelle duemila pagine del suo libro «De la Justice dans la Révolution et dans l’Eglise». Queste duemila pagine sono completamente trascurate dal signor Schapiro il quale, d’altra parte, fa un uso abbondante di estratti dalla corrispondenza di Proudhon, presentandoli come se si trattasse di formule teoriche anziché di opinioni personali occasionali e strettamente private.
Dallo studio di Schapiro si può inoltre apprendere che Proudhon è stato un anarchico, ma nulla è detto sulla sostanza e sul significato profondo della lotta instancabile che Proudhon condusse contro ciò che egli definì il «principio di governo». In tal modo riesce facile al sig. Schapiro di impiccare Proudhon in effigie come sostenitore della dittatura, in considerazione del suo atteggiamento nei confronti di Luigi Napoleone. Che una simile accusa abbia potuto essere pronunciata è talmente assurdo che non varrebbe la pena di confutarla, se non avessimo oggigiorno tanti esempi che ci dimostrano come il pregiudizio intellettuale e la tendenza a spacciare delle formule al posto di pensieri riescono a traviare l’intelletto di tante persone peraltro rispettabili. Per ben comprendere l’atteggiamento di Proudhon nei confronti di Luigi Napoleone, basta leggere ciò che egli scrisse a proposito dello stesso, tenendo presenti gli avvenimenti del tragico anno 1848. La rabbia, la disperazione, il disprezzo per i politicanti socialisti e democratici, che si trovano in quegli scritti, erano sentimenti ben comprensibili in un uomo, che fin dal 1840 aveva previsto la disfatta, la dittatura e la guerra come conseguenze della stupidità dei demagoghi i quali (ubbriacati dai ricordi del 1793 e da fantasie barricadiere) erano disposti a mandare gli operai al macello per il gusto di frasi vuote o di meschine combinazioni ministeriali. E fu proprio questo che essi fecero nel giugno 1848.
Senza parlare del fatto che il famoso pamphlet «La Révolution démontrée par le Coup d’Etat» era un pamphlet così poco bonapartista che al suo autore fu proibito di pubblicare in seguito qualsiasi scritto di carattere politico, basta accennare ad un altro fatto ben noto, e cioè che Proudhon è stato tre anni in carcere e sette anni in esilio per la sua strenua lotta contro il bonapartismo, per poter affermare che la sua presa di posizione contro Luigi Bonaparte era non soltanto perfettamente chiara, ma anche intelligente e onestissima. Egli vide con grande chiarezza (come lo stesso Schapiro riconosce) che la combinazione di un apparato statale paternalistico e di una massa popolare abbandonata in uno stato di depressione, di delusione e di caotico smarrimento avrebbe inevitabilmente generato la dittatura, l’Impero ed infine la guerra. Per Proudhon non si trattava affatto di un problema di antagonismo fra ceti medi e proletariato. Infatti, egli non si stancò mai di mettere in rilievo come l’inerzia (o «l’appoggio passivo») degli operai disgustati era stato il fattore essenziale nel determinare il successo del colpo di stato, mentre i ceti medi «liberali» erano profondamente allarmati all’idea di perdere i loro privilegi politici, che essi stessi, d’altronde, avevano contribuito ad annientare quando colpirono gli operai di Parigi. Quando Proudhon disse che Luigi Napoleone poteva essere «la Rivoluzione o niente», egli non intese con ciò esprimere fiducia in un uomo che egli aveva combattuto con tutte le sue forze e per il quale non aveva nessuna stima, ma piuttosto proclamare la sua convinzione che, con Napoleone o senza di lui, la Rivoluzione non poteva essere arginata, e che il ridicolo Cesare aveva soltanto la scelta tra l’andare volontariamente verso la Rivoluzione e l’esservi trascinato per necessità storica.
Insieme ai migliori uomini del suo tempo, Proudhon vedeva (con occhi aperti e senza sentimentalismi o illusioni circa gli inevitabili sviluppi della storia) il sollevamento sociale dei tempi moderni nella forma di un «progresso irresistibile». Questo sollevamento era per lui un fatto così fondamentale ed evidente, e coincideva a tal punto con la necessità della Verità stessa, che sarebbe stato per lui una cosa grottesca il pensare che un signor Charles Louis Napoléon Bonaparte potesse essere qualcos’altro che uno strumento di quel movimento.
L’ardore politico, l’intelletto ardito e l’amore per le visioni grandiose hanno spesso condotto Proudhon a formulare delle affermazioni che possono sembrare strane ed anche assurde. Ma, in fin dei conti, se Proudhon è famoso per qualche cosa, lo è appunto per il suo odio indomabile contro ogni forma di coercizione. Per ammettere che egli abbia pensato ad appoggiare la dittatura di Luigi Napoleone, bisognerebbe supporre che egli abbia nutrito qualche torbida ambizione personale. Ma nello stesso istante chiunque abbia qualche nozione della vita e delle opere di Proudhon sentirebbe risuonare la eco delle parole che egli gettò in faccia al signor Thiers, in pieno Parlamento: «Signor Thiers, io sono disposto a raccontare tutta la storia della mia vita, qui da questa tribuna. Io vi sfido a fare la stessa cosa».
Fin qui l’attacco del sig. Schapiro contro Proudhon sembra essere il risultato di malintesi e di antipatìa; piuttosto che di decisa ostilità. Ma quando egli se la prende con Proudhon accusandolo di essere guerrafondaio e antisemita, la sua ignoranza ed i suoi travisamenti sono veramente inescusabili.
II socratismo di Proudhon
La Guerre et la Paix di Proudhon è uno sforzo appassionato di indagare «sui legami misteriosi che uniscono forza e diritto». Con questo intento l’autore parte dal presupposto che la guerra è nella natura umana, che mediante la guerra l’umanità ha realmente cercato, in un modo fosco e terribile, di appagare il bisogno di giustizia, da cui essa è assillata.
Chi ha letto il libro sa che nella sua prima parte esso prende la forma di una apologia della guerra. Infatti, questa impostazione del problema è tipica per Proudhon e costituisce una delle caratteristiche più originali del suo metodo il quale è, in un certo senso, veramente socratico. Ma chi ha letto il libro sa anche che esso finisce col dimostrare che, mentre la guerra può essere compresa e giustificata soltanto come una violenta aspirazione verso la giustizia nella società, la giustizia stessa non può essere realizzata attraverso la guerra, ma soltanto attraverso l’instaurazione di giusti rapporti fra gli uomini e le nazioni, e che non vi può essere né giustizia né pace se non in una libera federazione di popoli.
Schapiro ignora tutto ciò. E la descrizione del suo atteggiamento non sarebbe completa se tralasciassimo di ricordare che, proprio poche pagine prima di accusare Proudhon come guerrafondaio, egli gli rinfaccia di essere un traditore del proletariato ed un nemico del socialismo, perché egli non credeva nella rivoluzione violenta.
Ma nello stesso libro, scritto alla vigilia della Guerra Civile Americana, Proudhon dichiara francamente che questa «guerra di liberazione» non libererà i negri, che questi, nella migliore delle ipotesi, passeranno da una specie di servitù ad un’altra e che , tutto sommato, sarebbe meglio per essi rimanere sotto i loro padroni del Sud e lottare per la loro emancipazione attraverso la riforma e l’autoeducazione anziché essere liberati dagli eserciti del Nord. Ognuno è padrone di dissentire da questa opinione. Ma chi conosce Proudhon sa anche da quale premessa egli parte in questa sua affermazione. La premessa basilare per Proudhon è questa: che è cosa priva di senso dire che l’uomo possa essere liberato da un apparato qualunque, sia esso statale o no. L’uomo, secondo Proudhon, può liberarsi soltanto da sé e può essere aiutato soltanto dai suoi compagni nella vita in comune e negli sforzi comuni. Sempre a proposito della Guerra Civile Americana, si può forse dire che Proudhon si sia lasciato trascinare ad una generalizzazione affrettata, per quanto io pensi che oggigiorno c’è più di uno disposto a dargli ragione. Ma il sig. Schapiro è, per quanto io sappia, l’unica persona alla quale sia venuto in mente di accusare il grande erede dei filosofi del diciottesimo secolo di essere un «anti-negri».
Per quanto riguarda l’antisemitismo dì Proudhon, l’accusa del sig. Schapiro si basa sul fatto che Proudhon usa parecchie volte la parola «ebreo» in rapporto con banchieri, borsa, capitalismo finanziario ed istituzioni di questo genere. A parte il fatto che questi riferimenti non sono del tutto arbitrari e senza fondamento, allo stesso modo si potrebbe classificare Voltaire come antisemita perchè non gli piaceva la Bibbia e perché la parola «ebreo» era per lui praticamente sinonimo di superstizione.
D’altra parte, sarebbe inutile voler negare che Proudhon è stato un antifemminista. Alessandro Herzen, che nutriva grande rispetto ed amore per Proudhon, era scandalizzato dalla sua grettezza di vedute per quanto riguarda i diritti della donna e la famiglia come istituzione. Quando Proudhon parla delle donne e della disciplina paternallstica nella famiglia, egli ci rivela i caratteri peggiori della sua natura di «cafone». Non solo questo, ma facendo propria la nozione romana della famiglia fondata sulla patria potestà, Proudhon contraddice la sostanza stessa della sua filosofia sociale che è tutta un attacco a fondo contro le basi filosofiche e sociali della legge romana e napoleonica.
Un nemico dell’uomo qualunqueIn un punto sono disposto a dare ragione al sig. Schapiro, e lo faccio volentieri e con grande entusiasmo. E ciò quando Schapiro dice che Proudhon era «un nemico dell’uomo comune». Sì, vivaddio, egli lo era. Proudhon odiava l’uomo «comune», odiava l’uomo «medio», odiava l’uomo «di classe», odiava profondamente e spietatamente qualsiasi finzione mediante la quale la genuina e nuda realtà umana potesse essere comunque mascherata, distorta e falsata -e quindi oppressa e soppressa. Per dì più, Proudhon non era propriamente un innamorato dell’umanità. Era qualche cosa di meglio. Era un uomo, un uomo raziocinante e libero.
Tutto sommato, siccome il sig. Schapiro ha scelto il metodo di dipingere Proudhon mediante citazioni arbitrarie, egli potrebbe anche accusarlo di essere stato:
1) un nemico delle nazioni libere, perché ai suoi occhi i patrioti polacchi ed italiani erano dei confusionari sentimentali, i quali pensavano che la liberazione dalla dominazione straniera unitamente ad una forma di governo costituzionale, avrebbero automaticamente apportato una reale libertà ed autonomia delle nazioni, mentre egli pensava che la realtà si traduceva invece nella seguente operazione aritmetica: nazionalismo più uno Stato rafforzato eguale a dispotismo, guerra e tramonto di ogni speranza di una unità europea;
2) un nazionalista perché, in virtù della_convinzione anzidetta, egli criticava violentemente Napoleone III e la sua «guerra di liberazione» in Italia denunciandola come una guerra contrastante con gli «interessi nazionali» della Francia, in quanto la nazione francese non poteva avere alcun interesse alla formazione di una nuova potenza militare alle sue frontiere;
3) un fautore della legge e dell’ordine, perché egli ripetutamele sosteneva che «governo politico» significava in realtà anarchia sociale, mentre la libera associazione ed il principio federale erano la sola base possibile per un reale diritto ed un reale ordine nella società;
4) un filisteo, perché egli attaccava alcuni fra i più noti scrittori ed artisti del suo tempo -Victor Hugo, George Sand, Delacroix ed altri- come «immorali e falsi»;
5) un futurista perché, scrivendo di arte, egli non soltanto ammirava Courbet come un grande artista, ma attaccava anche il «culto assolutistico della Forma», prediceva che «veri artisti sarebbero stati perseguitati come nemici della Forma e della moralità pubblica», ed esprimeva una concezione di idealismi critici nella quale la verità circa il mondo umano e la negazione delle convenzioni morali, sociali ed artistiche erano sintetizzate in una maniera non molto dissimile da quella di Tolstoi e Van Gogh.
In realtà, tutto ciò prova soltanto la grande originalità di Proudhon come pensatore, la sua ansia di scoprire nuovi aspetti della realtà e nuovi metodi di dimostrazione delle verità in cui credeva, la sua abilità dialettica che prendeva sempre lo spunto dagli argomenti fondamentali dell’avversario -ciò che è uno degli aspetti del suo socratismo e lo conduce a delle affermazioni che sono straordinariamente vicine ad alcune tesi fondamentali della filosofia moderna.
In tutto ciò, è però implicita una questione più generale. Essa non riguarda specificamente né il sig. Schapiro né Proudhon, ma piuttosto due tipi di mentalità interamente diversi. Ciò che colpisce nel «caso Schapiro» è l’incapacità di questi ad intendere un tipo di mentalità complesso come quello rappresentato da Proudhon. Perché?
Io penso che sia impossibile comprendere l’atteggiamento del sig. Schapiro se non si premette che ciò che egli cerca effettivamente è una teoria unitaria, monolitica, una teoria che possa fornire tutte le risposte richieste, complete di istruzioni sul modo come saggiarle e confutarle.
Una simile teoria dovrebbe essere costruita su un piano di semi-verità dogmaticamente asserita. Si ha il sospetto che il sig. Schapiro voglia ridurre le idee di Proudhon ad una affermazione di questo genere: « II mondo è cattivo perché i crediti finanziari non sono concessi liberamente. Una banca di libero credito metterebbe tutto a posto». In questo caso egli avrebbe la scelta fra due alternative. Potrebbe dire: «In fondo la cosa non è del tutto assurda, poiché il credito libero sarebbe effettivamente una buona cosa», oppure potrebbe (alla stregua di Marx) indignarsi e trattare Proudhon come un facilone che pretende di risolvere la questione sociale con il colpo di bacchetta magica del libero credito. La cosa essenziale in ambedue i casi è però che non ci troviamo di fronte a delle affermazioni «contraddittorie» e «disarmoniche», ma solamente di fronte a posizioni semplicistiche.
Fortunatamente Proudhon è ben lungi dall’essere uno di quei pensatori comodi con i quali il signor Schapiro (e cento altri) amano aver commercio. Proudhon è uno di quei pensatori che, credendo nella verità, si sentono liberi di sfidare qualsiasi cosa, eccettuata la verità stessa. Per Proudhon le soluzioni pratiche non possono essere che parziali e l’essenza del problema sociale è che esso rimane aperto. Infatti, alla radice del pensiero di Proudhon si trova la convinzione incrollabile che la società umana costituisce un problema sempre presente e sempre risorgente, il quale potrà o non potrà avere una soluzione finale, ma esige ad ogni modo di essere tenuto aperto attraverso tutte le vicende della storia. Questa è, per Proudhon, la missione dell’uomo onesto e dell’intellettuale, missione che non può essere compiuta se non attraverso la libertà intellettuale ed il lavoro comune.
Ma difendere Proudhon contro certi malintesi può sembrare, in ultima analisi, cosa superflua. Poiché il semplice fatto che, dopo essere stato per tanto tempo sepolto sotto il terribile epitaffio «piccolo borghese», egli venga ancora vilipeso, costituisce una prova sufficiente della vitalità e veridicità di ciò che ci è rimasto di Pierre-Joseph Proudhon «uomo del popolo».
(*) J. Salwyn Schapiro: P. J. Proudhon, precursore del fascismo, nella «American Historical Review».
Nicola Chiaromonte
Parole confuse
Tratto da La Stampa, 30 dicembre 1969
Pubblicato in Cesare Panizza (a cura di), Nicola Chiaromonte, La rivolta conformista. Scritti sui giovani e il 68, Una Città, 2009
Perché stai così zitto?
Perché parlare dell’inutilità di parlare mi sembra piuttosto inutile. È di questo che si tratta. Tutti dobbiamo constatarlo nella vita di ogni giorno: la parola è diventata un’appendice del fatto. Soltanto fra i pochi che già s’intendono, essa serve a comunicare. Fra i più l’abitudine delle epoche civili e socievoli, di rispondere alla parola con la parola, al discorso coerente col discorso coerente, si è perduta. Alla parola oggi si risponde con l’atto, col gesto, con la lusinga, con la minaccia, o semplicemente col silenzio. Quando si parla, è solitamente solo per accompagnare o sottolineare il fatto, che è sempre un fatto compiuto o un’opinione prestabilita.
Eppure, ecco, noi stiamo parlando. E, attorno a noi, fra carta stampata, radio, televisione, cinematografo, le parole diluviano.
Naturalmente. Noi parliamo fra di noi, e attorno a noi la moneta cattiva scaccia la buona. La svalutazione della parola è un fenomeno galoppante. Ed è già un fatto di violenza, anzi il principio stesso della violenza. Sicché viene da ridere amaro, a leggere i molti predicozzi che si vanno impartendo per deprecare la violenza. La violenza è istallata nella forma stessa dei rapporti umani quali oggi si svolgono, meccanici, forzosi e inerti.
Allora i giovani violenti hanno ragione
No, non hanno ragione affatto. Son presi in una trappola. Giustificare la violenza con delle ragioni ideali non ha senso; rispetto a una qualsiasi ragione ideale, socialismo, anarchismo o comunismo, la violenza è stata sempre considerata un male: necessario, al momento giusto, ma male sempre, da ridurre al minimo e tenere sotto stretto controllo. Che poi il demone, una volta evocato, non abbia più obbedito all’apprendista stregone, è un’altra faccenda. Ma l’apologia della violenza, la convinzione che solo con la violenza si cambia il mondo, è stata, da un secolo a questa parte, il proprio dei politici realisti e dei teorici della forza, non di quelli che cercavano la giustizia.
D’altra parte è vero che non si può fare appello alla violenza senza darne una qualche giustificazione. Teorizzare la violenza pura è come teorizzare la pazzia furiosa. Ma, nel momento che la si giustifica con qualche ragionamento, allora è il ragionamento che conta, e vale quel che valgono le sue premesse e le sue conseguenze, né più né meno.
Con i giovani rivoltosi d’oggi, però, sembra inutile ragionare.
Doppiamente presi in trappola, i giovani violenti. Vogliono l’azione efficace e finiscono col dire, di fatto, che qualunque azione violenta è efficace. Efficace a che? A scardinare il «sistema». In realtà, la violenza non fa che rafforzare il cosiddetto sistema, in quanto, creando un disordine che non mena a nulla, costringe a rimettere bene o male le cose in ordine: non è un’operazione di polizia, è una necessità organica della vita collettiva. La quale, oggi, ha questa particolarità, che da una parte funziona secondo regole meccaniche, non in base a leggi sacre o credute tali; dall’altra, appunto per questo, può sopportare molto più disordine che non si creda, perché la meccanicità del suo funzionamento è sostanzialmente imperturbabile, neutra, e presto ristabilita. Lo esige l’inerzia irresistibile della collettività medesima, molto più che i padroni o i governanti.
La violenza, nella società industriale, o prende la forma di un colpo di Stato ben concepito e rapidamente eseguito, impresa per la quale i giovani rivoltosi non sembrano particolarmente indicati (e d’altra parte la rifiutano a favore della spontaneità rivoluzionaria), oppure diventa una sorta di happening, o, come ha ben detto Raymond Aron, di «psicodramma», anch’esso necessariamente di breve durata.
Allora, insomma, non c’è da preoccuparsi.
No, anzi, c’è da preoccuparsi moltissimo. Che la violenza fisica non porti a nulla, non cambia la natura della situazione in cui ci troviamo. Il fatto che i giovani ribelli non sanno riconoscere, e che li porta all’estetismo della violenza e insieme a un moralismo politico il quale consiste nel dividere una volta per tutte il mondo in buoni e cattivi, è questo: la strada a quella che dal 1848 al 1917 s’è chiamata «rivoluzione sociale », oggi è chiusa. Ed è chiusa perché la società stessa è in rivoluzione nelle credenze religiose e nelle idee.
Rivoluzione, o meglio: dissoluzione. Tutto è in questione e tutto è in confusione. La violenza sporadica non fa che aggiungere confusione a confusione: è uno dei fenomeni caratteristici dello stato di fatto; fa parte del quadro, e i giovani sovversivi non si accorgono fino a che punto la loro rivolta contribuisce a fomentare il disordine e i mali propri del disordine, quindi a ritardare l’avvento di quel «nuovo ordine di cose» che essi desiderano.
In queste condizioni, quello che sarebbe veramente nuovo e necessario sarebbe una restaurazione: un movimento per la restaurazione delle basi prime della società, anzi della convivenza umana. Ma un tal movimento non può cominciare altrove che nelle coscienze e nei rapporti fra persona e persona. Per questo, i giovani ribelli dovrebbero rinnegare molti idoli ai quali viceversa sacrificano: gl’idoli della novità, della sregolatezza supposta liberatrice, della violenza e dell’incoerenza, che sono gl’idoli stessi della società contro la quale essi credono di ribellarsi.
Insomma, il ritorno all’ovile.
No, perché non ci sono ovili cui ritornare. Ci sono delle trame antiche da riprendere, che sono quelle della semplicità del vivere e del pensare. Ed è un compito talmente contrario al nostro attuale modo d’essere che fa paura solo a pensarci.
Nicola Chiaromonte
A lume di ragione
Tratto da «Tempo presente», marzo-aprile 1968
Contro l’Università?
Fra i documenti che abbiamo letto per renderci conto delle idee che ribollono nella rivolta degli studenti, uno dei più radicali e sostanziati ci è parso quello di Guido Viale «Contro l’Università», stampato nel fascicolo 33 dei “Quaderni piacentini”, rivista che ha fornito al movimento studentesco (o alla parte estrema di esso) l’essenziale dei suoi motivi ideologici. Nell’articolo di Viale si trova espressa, in modo alquanto ponderoso e professorale, ma in ogni caso esauriente, la posizione detta di «contestazione globale». Oltre a essere un esempio considerevole dell’attuale polemica studentesca, esso è dunque un testo che vale la pena di discutere senza indulgenza né sufficienza.
L’articolo comincia con la seguente perentoria affermazione: «Il primo compito del movimento studentesco è operare delle distinzioni di classe all’interno della popolazione scolastica».
La frase, e le asserzioni che la seguono, non lasciano dubbi. Siamo nell’orizzonte di un linguaggio prestabilito, quello marxista (diciamo «linguaggio» e non «ideologia» per scrupolo d’esattezza, perche non è chiaro dove precisamente conduca il linguaggio adottato da Viale). Si tratta di un linguaggio chiuso il quale comunica solo con se stesso (ossia con chi lo condivida) e non è certo destinato a persuadere chi, per esempio, non veda l’utilità, a proposito di una questione che riguarda il buon corso degli studi, d’introdurre un concetto non solo controverso (è il meno che se ne possa dire) come quello marxista di classe, ma obnubilante, essendoché non sembra affatto evidente che la «popolazione scolastica» sia unita da un interesse anche minimamente simile a quello marxista del «rapporto di produzione». Per definizione, direbbe il senso comune, lo studente non produce, ma riceve semmai i mezzi per una produzione futura. Dato e non concesso che la cultura si possa assimilare sic et simpliciter a un mezzo di produzione
Ma vediamo che cosa intende Viale per «distinzioni di classe all’interno della popolazione scolastica». Egli intende quanto segue:
Se è vero che nel periodo della loro formazione tutti gli studenti sono assolutamente privi del potere e sottoposti alle manipolazioni delle autorità accademiche, è altrettanto vero che per alcuni inserirsi nella struttura di potere dell’università non è che un primo passo del loro inserimento nelle strutture di potere della società, mentre per la maggioranza degli studenti la subordinazione al potere accademico non è che l’anticipazione della loro condizione socialmente subordinata all’interno delle organizzazioni produttive in cui sono destinati a entrare.
Eccoci di fronte alla ben nota questione del «potere studentesco», debitamente confusa con quella del potere sociale in senso lato, sicché diventa praticamente impossibile sbrogliare l’imbroglio. Il quale imbroglio consiste in questo: l’autoritarismo, anzi l’arbitrarietà sciatta e indecorosa, che regna nella scuola italiana (e non solo nell’università) è un fatto ampiamente riconosciuto. Che il rapporto fra docenti e studenti vada riformato nel senso di abolire «baronie», despotismo, camorre varie, nessuna persona sensata lo negherà. Ma quando si parla di «potere», si crea un equivoco al quale nessuna persona sensata vorrà prestarsi. In primo luogo, l’università non appartiene né agli studenti né ai docenti, ma, semmai, alla nazione: lì non può essere questione di potere, ma che ciascuno faccia l’ufficio suo onestamente. II potere, propriamente parlando, appartiene al ministero dell’Istruzione, ed è a questa centralizzazione assurda che burocratizza e umilia sia l’insegnamento che l’apprendimento che sono dovuti i massimi mali. Per conto nostro, vedremmo con sollievo una riforma che abolisse puramente e semplicemente il ministero dell’Istruzione, e instaurasse una completa libertà d’insegnamento, abrogando quel principio della scuola di Stato che non solo ha fatto il suo tempo, ma di fatto è stato abolito dalla licenza assoluta data alla scuola «libera». Non si vede proprio, in particolare, perché il prestigio di un’università debba dipendere da altro che dalla qualità dell’insegnamento che essa fornisce, qualità che nessun ministro e nessun funzionario ha numeri per giudicare, ma che invece risulta immediatamente chiara agli interessati, che sono da una parte gli studenti e dall’altra la società nel suo insieme. Un sistema che sostituisse al ministero dell’Istruzione un organo di semplice coordinamento e ispezione risolverebbe di per sé la questione del «potere studentesco», ossia di un rapporto di comunanza e relativa eguaglianza. Giacché eguaglianza quanto al fondo, ossia al fatto che da una parte c’è chi, sapendo, comunica il proprio sapere e dall’altra chi, non sapendo, lo riceve, non è sennatamente concepibile, come non è sennatamente concepibile la commedia dei controcorsi e degli esami per acclamazione d’assemblea. Che poi la discussione libera faccia parte dell’insegnamento è certo, ma è anche certo che viene dopo.
Insomma, abolire l’autoritarismo accademico, sì, quanto si vuole. Ma sostituire ad esso un «potere studentesco» irresponsabile, arbitrario e carico di pretese ideologico-politiche significherebbe in sostanza immettere anche nella scuola il sistema delle influenze e pressioni di partito che domina così bellamente la nostra vita pubblica. Senza contare che i sostenitori estremi del potere studentesco non hanno affatto l’aria di voler dividere il loro «potere» con altri, bensì di esercitarlo in condizioni di maggioranza assicurata e secondo una ideologia prestabilita di «contestazione globale». Di un tale progetto, l’unica cosa da dire è che non ha senso.
Ma, continuando, quali sono le «distinzioni di classe» che Viale discerne fra gli studenti? Eccole:
Fin dall’inizio dell’occupazione abbiamo individuato grosso modo tre strati della popolazione universitaria: quelli che l’università la usano (come base di lancio verso il conseguimento di posizioni di potere nella struttura sociale); quelli che l’università la subiscono (come fase necessaria attraverso cui bisogna passare per andare a occupare una condizione sociale predeterminata nella fittizia gerarchia di una mistificatoria stratificazione sociale); e quelli che dall’università vengono soltanto oppressi (in quanto essa funziona come strumento di legittimazione della loro posizione sociale subordinata).
Diciamo subito che queste asserzioni ci sembrano logicamente prive di base, oltre che di riferimento a una qualsiasi situazione specifica e concreta. Giacché, insomma, la linea di confine fra quelli che, per parlare il linguaggio di Viale, «usano» l’università e quelli che la «subiscono», ci si può domandare se esista davvero, e in che senso.
Si può certamente subire al fine di usare e, per conto nostro, da quello che ricordiamo dei nostri anni d’università, i due strati si confondono in uno, il quale poi costituisce semplicemente la maggioranza. Minoranza sono quelli che studiano perché vogliono studiare e riuscir bene nella vita; e minoranza ancora più esigua quelli che studiano per amore dello studio. I socialmente privilegiati poi (contrariamente a una strana analisi fatta dal Comitato d’agitazione dell’università di Torino e citata da Viale) di solito non credono né nella scienza né nella cultura, e hanno un bisogno molto relativo di studiare seriamente, dato che appunto sanno di avere comunque un posto che li attende.
Quanto agli «oppressi», non si capisce proprio che cosa voglia dire Viale quando accusa l’università di ribadire le catene della schiavitù sociale. Questa è un’asserzione dedotta nel vuoto dalla premessa che nella società «capitalista» (o «neocapitalista») ogni istituzione (e a maggior ragione quelle della sovrastruttura culturale) è uno strumento della classe dominante. Ma, a parlar concreto, in qual mai senso una laurea in legge o un diploma di farmacista è «uno strumento di legittimazione di posizione sociale subordinata»? Forse perché non sempre il suo detentore farà una gran carriera? Ma è davvero nel fatto di non far carriera che si rivela l’oppressione sociale? In qual senso che non sia bassamente «borghese» e «capitalista», la funzione degli studi si misura dalla garanzia di carriera che essi forniscono? Una cosa è imparare, si direbbe, e una cosa tutt’altra sapersi far strada nella vita. Doversi «far strada nella vita» non sembra, d’altro canto, una schiavitù peculiare della società borghese. Negli Stati detti socialisti, è pur vero che lo Stato provvede a dare impiego a ogni diplomato; ma è anche vero che, non potendo allogare tutti al vertice della piramide, ribadirà non pochi in «posizione sociale subordinata». E si vorrebbe aggiungere che è normale, se non giusto, che così sia, dato che non s’è mai visto né mai si vedrà un sistema sociale attivo e funzionante nel quale alcuni individui non si trovino, per continuare a parlare il linguaggio di Viale, «ad andare ad occupare una condizione sociale predeterminata nella fittizia gerarchia di una mistificatoria stratificazione sociale».
Quale gerarchia non è fittizia? si potrebbe domandare a Viale. E quale stratificazione sociale non è mistificatoria? si potrebbe insistere. Di non fittizio, c’è solo il vero: in questo caso, il merito personale. Ma il merito personale, in una determinata situazione sociale, quale essa sia, diventa immediatamente relativo alla «funzione» in cui può essere esercitato; e le funzioni sociali non si creano su misura se non al vertice della gerarchia. Comunque, una società la cui gerarchia, giudicata in assoluto, non sia al tempo stesso fittizia e mistificatoria non s’è mai vista. Quel che s’è visto e si vede sono delle società in cui le carriere sono più o meno largamente aperte al talento. Concetto, questo, borghese e democratico (napoleonico, per precisare), com’è borghese e democratico l’ideale di una scuola aperta a tutti e di una cultura a disposizione di tutti. Ma inerente a tale ideale è l’accettazione del fatto che, se va perseguito per principio, esso d’altra parte non è realizzabile di colpo e in assoluto. Onde la società democratica e «borghese» accetta senz’altro il fatto della propria imperfezione e della relativa necessità di riformarsi continuamente. Mentre lo Stato socialista puro postulato evidentemente dal discorso di Viale si limita a dichiarare giuste e rispondenti alle esigenze della Storia e dell’Umanità le proprie «stratificazioni»; e, in quanto alle proprie «mistificazioni», non sa che dichiararsene immune per natura e dannare chi per avventura ne sospetti l’esistenza.
«Mistificazione», «mistificatorio», «de-mistificazione»: si fa un grande uso di queste parole, fra i giovani d’oggi. Sarebbe più semplice e meglio verificabile parlare di vero e di falso. Ma, appunto, quel che un tal gergo intende evitare è la verifica. Il vero e il falso sono fatti specifici e limitati per natura, e riguardano determinate situazioni di fatto espresse per mezzo di proposizioni egualmente determinate. La «mistificazione», invece, è un fatto globale, totalitario. Se, per esempio, uno stato di cose non è giusto in assoluto (cioè in astratto, giacché solo in astratto può uno stato di cose coincidere assolutamente con la giustizia), esso è assolutamente ingiusto, dunque totalmente «mistificatorio», con le relative «stratificazioni» e «subordinazioni». Quindi va «demistificato» senza pietà, contestato «globalmente» e immediatamente. Il che porta con eguale immediatezza alla azione violenta. Ma se d’azione violenta deve trattarsi, si esca allora dai recinti dell’università, e si parli di rivoluzione, di come farla, con quali mezzi, e a quali scopi. C’è qualcosa di peggio che infantile nell’idea di fare la rivoluzione rimanendo barricati nelle aule scolastiche: qualcosa che sminuisce e discredita tutto ciò che v’è di legittimo nella protesta degli studenti. Dopotutto, per fare la rivoluzione, dal 27 al 29 luglio del 1830 gli studenti parigini andarono sulle barricate, non in Sorbona; e la rivoluzione, gli studenti russi la prepararono per cinquant’anni, passando dalla scuola alla galera e dalla galera alla scuola, non rimanendo seduti sui banchi a discutere eventuali controcorsi. Parlare di «contestazione globale» sembra veramente una maniera di evitare sia ciò che v’è di serio nei problemi dell’università, sia ciò che v’è di ancora più serio, oggi, nella questione politica. La quale, se è «mistificata» alla radice, non è per il gran machiavellismo della classe dirigente, ma in primo luogo e anzitutto perché il pensiero autentico se ne è ritirato, e al suo posto regnano incontrastate le idee prefabbricate e le formule fisse.
Quanto al resto, ci son molte osservazioni giuste, nell’articolo di Viale. Ma sono quelle sulle quali ogni cittadino cosciente è in sostanza d’accordo, o sulle quali l’accordo sarebbe comunque facile da raggiungere. è l’ideologia che è non solo sbagliata, ma diremmo perversa, in quanto fondata su quello che non esiteremo a chiamare «il ricatto dell’assoluto». Ricatto che in buona logica si riduce all’assurda proposizione che quando non c’è tutto non c’è niente e se non si ha tutto non si ha nulla. Proposizione dalla quale il nostro articolista deduce rivendicazioni come quella di sottoporre la vita dell’università alla «critica politica», ossia di abolirvi i residui di libertà che pur vi lascia il «despotismo accademico», riducendola a una specie di tumulto totalitario.
Nel «despotismo accademico», d’altra parte, il Viale (in uno con i suoi colleghi) fa rientrare anche il fatto che si esiga «un criterio di qualificazione professionale nella preparazione del curriculum». Secondo lui (e i suoi colleghi) ciascuno studente dovrebbe esser libero di programmarsi detto curriculum «a proprio piacimento». Onde «la preparazione universitaria diventa l’autoprogrammazione del proprio curriculum di studi che ciascuno studente fa in modo non individuale, ma sottoponendolo almeno parzialmente alla discussione dell’assemblea». Tra corsi, controcorsi, discussioni di ogni curriculum individuale e esami plebiscitari, davvero è un’università «di pieno impiego» che questi giovani sembrano avere in mente. Tutto ciò partendo dalla «critica del concetto di cultura come dato oggettuale reperibile in qualsiasi sede».
Al qual punto, c’è veramente da domandarsi di che cosa si stia parlando. Perché, certo, la cultura non è patrimonio dell’università, né tanto meno dei singoli docenti. E certo la cultura non è un «dato oggettuale» da andar «reperendo». Ma se si tratta di questo, si ammetta una volta per tutte che all’università si va per acquistare alcune nozioni e compiere alcuni esercizi, e che la cultura -la vera- è quella che ognuno si fa da sé e nella libera compagnia degli individui che si sceglie per amici e maestri, e la si smetta di chiedere alla scuola al tempo stesso una formazione professionale efficace e una cultura disinteressata. Le due cose non vanno insieme. E il gran problema della scuola d’oggi sta proprio lì, non nel fatto che gli ingegneri formati dal Politecnico di Torino vadano poi per lo più a lavorare alla Fiat, fatto di scarsissima importanza culturale, ma insomma, praticamente parlando, positivo, dato che, a Torino, a Mosca o all’Avana, quel che la maggior parte degli ingegneri cerca è un impiego. E se proprio dovessimo dir la nostra su questa situazione di base della scuola nella società odierna, la quale non può esistere se non fornisce a tutti un certo grado piuttosto alto d’istruzione, noi diremmo che in essa la cultura «disinteressata», la conoscenza per amore della conoscenza sono diventate praticamente impossibili tranne in privato. Il problema, quindi, sembra duplice: da una parte organizzare una «scuola per tutti» che funzioni, ma essendo chiaramente inteso che una tal scuola non può fornire che nozioni da usare in officine, laboratori o altre scuole (per fabbricare nuovi specialisti e formatori di specialisti, includendo in questa categoria anche i cultori delle cosiddette «scienze umane»); dall’altra, creare una scuola senza obblighi né sanzioni né diplomi, il cui unico scopo sia la cultura disinteressata e l’acquisizione di conoscenze pure, cioè «inutili»
Oggi come oggi, crediamo che nessuno Stato, capitalista, neocapitalista, demosocialista, comunista o altro, darebbe il suo accordo a un tal principio. Né alcun Comitato di agitazione studentesca. Perché quel che tutti vogliono è precisamente la cultura che «serve»: la cultura serva. La quale è, più o meno bene organizzata, già a loro disposizione, e se non vi provvede l’università vi provvede l’industria culturale.
Fatto che, d’altra parte, non dà allo studente Viale il diritto di uscirsene a dichiarare che «come nella società medievale chi decideva se una teoria era vera o falsa era il papa, così in quella industriale chi decide della validità delle teorie scientifiche è il Pentagono». Questo è un genere di volgarità molto stantio, se ne renda conto Guido Viale.
Nicola Chiaromonte
Carissimo Andrea…
Provenienza: Archivio privato Adriana Bianco
Pubblicata in Dedicato a Nicola Chiaromonte nel trentennale della morte, quaderni dell’altra tradizione, 1, Una Città, 2002
New York, 10 aprile 1946
Carissimo Andrea,
mi perdoni se non ho risposto prima alla sua lettera, così incantevole (penso alla messa in guardia contro le “sirene”… suvvia, davvero pensa che il bravo Husserl abbia una voce così pura e melodiosa?). Albert Camus è qui -gli faccio un po’ da guida per New York- talvolta questo mi prende una mezza giornata, e ho anche dovuto scrivere un articolo che mi ha affaticato oltre misura.
Aldo si scusa di non scriverle più spesso. E’ molto preso dalla faccenda di […] che fatica molto ad avviare.
Domenica scorsa, Camus è venuto a pranzo a casa mia. C’era Tucci (purtroppo si era invitato anche Santillana, ha prodotto l’impressione spiacevole, che lei ben conosce, di chi parla tanto per parlare). Si parlava del “che fare?” Mi ha colpito udire Camus insistere sulla necessità di creare “una società nella società”. Uomini legati da una solidarietà materiale spontanea – conducono vita semplice e modesta (ma senza regole ascetiche o sospetti di “falansterismo”) e si limitano, per lo meno all’inizio, a manifestare integralmente la loro opinione sui problemi della polis senza concedere nulla all’opportunismo politico, allo spirito di parte, o alla prudenza pratica in conformità ad un limitato numero di principi chiaramente definiti, i quali, tanto per iniziare, avrebbero probabilmente una forma “negativa”. Mi ha detto che i suoi amici, Brice Parain e Pascal Pia, sono d’accordo con lui.
Non voglio aggiungere altro per paura di cadere nell’ottimismo (stimolato dalla grandissima simpatia personale che ho per Albert Camus). Le sottopongo questo episodio come un “segno”. Aggiungerò che Camus ha anche osservato che l’Assurdo e la Disperazione sono fatti “privati”, e come tali vanno considerati.
Le racconto tutto ciò perché, venendo da un uomo che mi sembra essere uno dei pochi (fra quelli che si rivolgono al “pubblico”) a prendere veramente sul serio i problemi di oggi, mi pare rilevante.
Riguardo ai miei rapporti con la filosofia, carissimo Andrea, il mio unico rimpianto è di essere così ignorante in storia, come in medicina e matematica. In altre parole, mi creda, il mio desiderio più profondo sarebbe riuscire a spiegarmi nella forma del linguaggio corrente e nutrito di esempi terra-terra. Se non ci riesco, è perché sono confuso ed ignorante. Il mio soggiorno in America mi avrà aiutato un po’ ad evitare il linguaggio astratto, ma non è così facile porre rimedio ad una pessima educazione.
La filosofia, desidero soprattutto servirmene per sistemare non tanto le mie conoscenze (che sono quanto di più frammentario e periclitante ci possa essere) quanto la mia esperienza personale, nella quale faccio fatica a mettere ordine, e che fatico a comprendere tout-court. Ciò detto, le analisi di Husserl sono alquanto affascinanti – anche quando cadono nel banale. Riguardo a “politics”, sono completamente d’accordo con lei. Ho messo a parte Dwight delle sue preoccupazioni. Anche lui si è detto d’accordo; ma lui, io lo conosco, le interpreta nel senso che potrebbe essere un po’ più “politica”, e non nel senso di spingere la critica molto lontano. Dwight è gentile e ingovernabile, gliel’ho già detto (nel senso del “timone” e non del “governo”), il che andava bene, perché risolutamente non conformista, durante la guerra; diventa inutile oggi. Devo insistere che la posizione anti-stalinista e anti-guerra di molti americani ha sempre avuto un che di astratto – un partito preso per fedeltà alla logica di una dottrina e alquanto privo di esperienza vissuta. Il “trotzkismo”, qui, è stato una setta, come tante altre che da sempre si costituiscono e si dissolvono in questa caotica società. Dwight non ne può più della setta – andava bene, ma oggi il puro e coraggioso “non conformismo” non ha molto senso, senza una chiara decisione intellettuale, c’è il rischio di non avere altro risultato che aggravare la confusione generale, se ne renderà conto di persona, del resto – perché la prima parte di “The root is man” sta per uscire. Il fatto, caro amico, è che se c’è qualcuno che avrebbe bisogno davvero di un’iniezione di “metafisica” questi sono proprio gli americani. Perché non hanno l’abitudine di provar stupore. Un abbraccio, Nicola (traduzione dal francese di Marco Bellini)
Nicola Chiaromonte
Violenza e non violenza
Tratto da «Tempo presente», agosto 1968
Anche in Nicola Chiaromonte, La rivolta conformista. Scritti sui giovani e il 68, a cura di Cesare Panizza, Una città, 2009
Non è arbitrario far risalire l’impulso decisivo che condusse Tolstoi a fare del principio di «non resistenza al male» il fulcro del messaggio cristiano al I° marzo 1881, giorno in cui un gruppo di giovani terroristi fra i quali due donne, Sofia Perovskaia e Vera Figner, eseguirono la sentenza di morte pronunciata dal Comitato esecutivo della Narodnaia Volia contro lo zar Alessandro II.
Ciò che colpì Tolstoi nell’atto di quei giovani fu l’astrattezza del motivo: «Un assassinio di teorici, perpetrato senza odio, senza necessità reale, solo perché giusto in teoria…». Come si sa, Tolstoi rimase molti giorni sconvolto da quell’evento: pensava alle sue conseguenze politiche, ma soprattutto alla sorte che attendeva i giustizieri, e in particolare Sofia Perovskaia. Scrisse un appello al nuovo zar, Alessandro III, in cui lo supplicava: «Date al mondo il più grande esempio di sottomissione alla dottrina di Cristo: rendete bene per male…». La supplica fu fatta consegnare al procuratore del Santo Sinodo, Pobiedonesev, perché la rimettesse d’urgenza allo zar. Il procuratore la trattenne finché le sentenze di morte contro cinque degli imputati, compresa la Perovskaia, non furono eseguite, e poi la fece restituire allo scrittore senza neppure averla mostrata allo zar.
Tra l’astratta giustizia dei rivoluzionari e la bieca cecità del potere, che fare?
«Voi avete udito che fu detto: occhio per occhio e dente per dente. Ma io vi dico: Non resistete al male; anzi, se alcuno ti percuote la guancia destra, volgigli anche l’altra. E se alcuno vuol contender teco, e toglierti la tunica, lasciagli anche il mantello… Voi avete udito che fu detto: Ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono, fate del bene a coloro che vi odiano, e pregate per coloro che vi fanno torto e vi perseguitano. Giacché siete figli del Padre vostro che è nei cieli, ed egli fa levare il suo sole sopra i buoni e sopra i malvagi, e piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti»: queste le parole del Sermone della Montagna sulle quali Tolstoi non cessò d’insistere dal 1881 fino alla morte, rifiutandosi di recedere anche minimamente, anzi ragionandole con sempre maggiore fermezza.
Nel 1908, l’interpretazione tolstoiana delle parole di Cristo raggiunse, attraverso una lettera di Tolstoi al direttore della rivista indiana Free Hindustan, l’avvocato Mohandas Karamciand Gandhi, allora impegnato nella difesa dei diritti degli immigrati indiani nel Transvaal. L’anno dopo, Gandhi scrisse a Tolstoi per dirgli quale profonda impressione gli avesse fatto il suo scritto e come l’avesse trovato d’accordo sul principio della «non violenza». L’incontro fra il messaggio di Tolstoi e la vocazione di Gandhi ebbe conseguenze non piccole. A parte l’azione propriamente politica che ne derivò, Gandhi ripensò a fondo, in termini propri alla tradizione indiana, il principio tolstoiano. Come si sa, nella sua predicazione, la «non violenza» divenne il satyagraha o «forza della verità».
Si potrebbe dunque dire che, per forti, anzi travolgenti che siano state nel corso del ventesimo secolo le tendenze contrarie, e anzi la vera e propria ripugnanza mostrata anche (se non soprattutto) dalla classe intellettuale per il principio della «non violenza», questo ha tuttavia avuto un’influenza tale che merita ampiamente di esser chiamata «storica», secondo il linguaggio culturale tuttora prevalente. Ciò senza parlare dei grandi predecessori, da Lao Tse al Budda alle molte sette cristiane, fino agli americani William Lloyd Garrison e David Henri Thoreau e oltre.
Insomma, l’idea che c’è qualcosa di assurdo nel voler combattere la violenza con la violenza, cioè la sopraffazione con la sopraffazione, per ottenere la libertà e la giustizia, è perlomeno altrettanto antica quanto il fatto stesso della violenza organizzata. Però, la verità è che il principio che Tolstoi credette di derivare dal Vangelo e chiamò «non resistenza al male», facendone un principio risolutivo di azione morale e sociale, è stato generalmente deriso come inefficace se non stolto (in quanto non farebbe che lasciar libero il campo alla malvagità dei malvagi) e sostanzialmente negativo (perché non potrebbe costituire né uno scopo né un ideale) sin da quando lo scrittore lo proclamò. Il fatto che Gandhi lo riprendesse con successo e lo portasse al trionfo, ottenendo alla fine lo scopo che si era prefisso, ossia la liberazione dell’India, non sembra convincente, dato che il trionfo dell’azione di Gandhi per la libertà del suo Paese significa non già il trionfo della non violenza, ma piuttosto la costituzione di uno Stato indipendente analogo agli Stati della società occidentale, dei quali Tolstoi aveva detto, senza che nessuno potesse smentirlo in sede di ragione, che erano «fondati sull’assassinio», ossia sulla repressione violenta dei propri sudditi all’interno, e sulla distruzione violenta dei rivali all’esterno. Senza parlare degli orrendi massacri cui procedettero senza tardare, appena proclamata l’indipendenza, i musulmani contro gli indù e gli indù contro i musulmani, in uno scoppio di fanatismo collettivo di cui Gandhi stesso cadde vittima; com’era, per chi consideri la follia intrinseca della cosiddetta Storia, degno destino di quel giusto.
L’ idea della «non violenza» conserva tuttavia qualche prestigio fra i gruppi di dissidenti che hanno cercato e cercano di applicarla, in forma di metodo d’azione non violenta alla lotta per il miglioramento della condizione dell’uomo nella società contemporanea, la quale è erosa non soltanto dal razzismo e da simili forme di oppressione brutale, ma da quel male anche più nefasto che è l’indifferenza al proprio destino e quindi, a maggior ragione, a quello delle minoranze (o maggioranze) reiette che vivono nel suo seno.
Questi movimenti, anche se son stati guardati con simpatia (come quello guidato da Martin Luther King), son rimasti tuttavia marginali: alla fine, sotto la pressione se non della violenza, dell’inerzia sociale, tendono a esaurirsi e, anche se non si esauriscono, vengono oscurati e almeno apparentemente sommersi da movimenti violenti i quali mirano a ottenere risultati tangibili nel minor tempo possibile; e in apparenza anche li ottengono, se non altro con la minaccia di esplosioni sempre più furiose e devastatrici che fanno pesare sulla società. Oggi come oggi, nel campo dei «rivoluzionari» (che è quello al quale si rivolgeva in special modo Tolstoi), la violenza è più che mai in onore, più che mai idealizzata. «Senza violenza, non si ottiene nulla» ha proclamato il capo degli studenti parigini in rivolta, Daniel Cohn-Bendit. Screditate le ideologie macchinose che tenevano il campo fino a pochi anni fa, l’idea della guerriglia, di origine cinese e vietnamita, e ulteriormente teorizzata da Ernesto Che Guevara e dal suo seguace Régis Debray, è quella che sembra affascinare i giovani ribelli europei. E, così com’è concepita attualmente, l’idea della guerriglia quale punto di partenza di ogni azione rivoluzionaria si riduce veramente all’esaltazione della violenza come un bene assoluto, e perdipiù assolutamente efficace, nella lotta contro il male capitalista. O meglio, la questione del male e del bene neppure si pone: si tratta di agire nel modo più risoluto e immediato possibile contro l’ingiustizia. Non per nulla, Ernesto Che Guevara, eroe e martire di quest’idea, ha potuto lasciar scritto: «In qualunque luogo ci sorprenda la morte, sia benvenuta, a condizione che questo nostro grido di guerra sia giunto a un orecchio ricettivo e che un’altra mano si levi per impugnare le nostre armi e gli uomini si apprestino a intonare i canti di lutto con il crepitare delle mitragliatrici e nuovi gridi di guerra e di vittoria».
In parole come queste si esprime un romanticismo della violenza che, quale che sia il rispetto che si deve avere per un uomo che ha testimoniato della sua convinzione sacrificando la vita, non può non suonare antiquato e sinistro al tempo stesso. Certo, esso non sarebbe stato condiviso dagli uccisori di Alessandro II, i quali concepivano la «lotta sanguinosa» come una «triste necessità» e per i quali -come si legge nelle memorie di Vera Figner- l’uccisione di un uomo, per tiranno che fosse, rimaneva tutta la vita un peso soffocante sulla coscienza.
Ma è qui il paradosso: la questione della violenza è in apparenza priva di contenuto, giacché la maggioranza delle persone diranno senz’altro che la violenza è certo deprecabile, ma talvolta necessaria, e crederanno con questo di aver parlato secondo il senso comune più irrefutabile. Ma, appunto, quest’atteggiamento dei più dimostra il contrario di quel che sembra dimostrare: dimostra, cioè, che la violenza, quali che ne siano le circostanze, non comporta, anzi non tollera, giustificazioni. Essa può scaturire da una situazione violenta, o di violenza accumulata e repressa, ma rimane sempre un fatto, non diventa mai un mezzo, per quanto ne dicano i suoi apologeti. Giacché nel momento in cui si parla di mezzo, bisogna anche discutere il fine, e che allora il mezzo appaia in qualche modo commisurato al fine. Ora, il solo fine chiaro della violenza è l’eliminazione fisica del nemico. Ma come si misurerà il male causato da ogni parte per ottenere un fine che da ultimo si rivela puramente fisico? Dov’è, qui, il contrappasso morale senza di cui un’azione umana rimane al di fuori di ogni possibilità di giudizio, quasi un fatto di natura o un «atto di Dio»?
Tale, seriamente parlando, sembra rimanere la violenza, sia considerata in sé e per sé, sia nella forma attuale di azione efficacemente organizzata a fine di distruzione sanguinosa. Ed è per questo -perché intendeva essere azione giusta e non semplicemente scoppio furioso- che a Tolstoi l’uccisione di Alessandro II apparve come «un assassinio di teorici»: una specie di contraddizione in termini, ma più enigmatica che assurda. Non si poteva condannarla o approvarla, solo rimanerne sbigottiti e cercar di capire.
Ci sono nell’uomo fatti più enigmatici della violenza, la quale anzi è uno dei moti più elementari e relativamente più comprensibili: enigmatiche sono le vie dell’amore e quelle dell’odio, la brama di possesso e di dominio, l’ambizione, il tradimento, il gusto del male. Queste sono passioni, e ognuno ammette che la ragione non vi ha parte. Mentre la violenza giustiziera ha questo di particolare, che si vuole razionale sia nei mezzi che nei fini. Nelle forme di violenza che si sentono teorizzare e esaltare oggi, che si tratti del «potere nero», della guerriglia in America Latina o persino del «potere studentesco», c’è poi un’assurdità supplementare: qui, infatti, la violenza viene considerata come l’inizio e l’origine di un atto di giustizia, l’incarnazione attiva di una volontà di riscatto che si rifiuta addirittura di dar conto delle sue operazioni perché si considera semplicemente ideologia in atto, libera finalmente da ogni scolastica e da ogni burocrazia organizzativa.
A questo punto, la violenza assume in pieno il carattere inconcepibile di «assassinio teorico» che sbigottiva Tolstoi, e sfugge a ogni argomento. Eppure, essa non può mai affermarsi fine a se stessa. Anzi, più terribili sono le forme che essa prende, più idealistica (nel senso di omaggio ipocrita al mondo delle idee) è la giustificazione che se ne deve dare.
Qual è, d’altra parte, il punto di vista dal quale la violenza può esser condannata senza che la condanna cada nel vuoto e nel risibile, dato che si tratta di un fatto che sfugge per natura a ogni presa della ragione?
Se continuiamo a seguire le tracce di Tolstoi, vediamo subito che tutta la sua argomentazione contro la violenza e in favore della «non resistenza» si basa sul postulato evangelico che impone di amare non solo il prossimo, ma anche i propri nemici. La parola di Cristo è l’autorità su cui si fonda esplicitamente la predicazione tolstoiana. La quale non si limita -notarlo è importante- a raccomandare l’insegnamento di Cristo come esemplare, ma ne deriva la «non resistenza» come norma d’azione pratica più efficace della violenza (anche se per vie diverse e a più lunga scadenza) ai fini di stabilire una società più giusta. In altri termini, Tolstoi faceva della «non resistenza» un imperativo di carattere universale applicabile non solo da pochi credenti, ma da qualunque individuo volesse comportarsi da vero cristiano, che per lui era sinonimo di vero uomo. Dopo di lui, Gandhi farà dello stesso imperativo un principio praticabile da grandi masse di popolo, e al quale perciò alla lunga nessun potere avrebbe potuto resistere, proprio come, secondo Marx e secondo Lenin, nessun potere avrebbe potuto resistere all’urto finale delle masse organizzate.
È su questo punto cruciale che verte la questione della violenza, oggi. Giacché, evidentemente, l’obiezione secondo la quale opporre il metodo dell’assassinio a un mondo fondato sull’assassinio è una contraddizione in termini, per quanto logicamente giusta, non tocca la questione principale, la quale è quella dell’efficacia, della praticabilità, del valore universale del principio della «non violenza»
Il principio su cui Tolstoi fondava il suo messaggio di «non resistenza al male» si trova espresso con grande semplicità fra gli altri testi in quello che toccò così profondamente l’animo di Gandhi: la «Lettera a un indiano». Si legge in questa, insieme ad argomenti di tolstoiana semplicità e forza, un passo in cui la difficoltà -per non dire la debolezza- principale del ragionamento di Tolstoi si manifesta, per così dire, allo stato puro: «La verità, naturale all’umanità, secondo la quale la vita umana dovrebbe esser guidata dalla sorgente spirituale che è il fondamento dell’umana esistenza e si manifestò nell’amore, per poter permeare la coscienza dell’uomo si è trovata a dover lottare con l’incompletezza della sua espressione e le distorsioni volute o involontarie di essa, come pure con la violenza istituzionale che costringe, mediante punizioni e persecuzioni, ad accettare le spiegazioni della legge religiosa sancite dall’autorità, e la quale contrasta con la verità rivelata. Tale distorsione e tale offuscamento della nuova, ma ancora imperfettamente rivelata, verità, si è verificata dovunque: nel confucianesimo, nel taoismo, nel buddismo, nel cristianesimo, nell’islamismo, come pure nel bramanesimo di cui voi siete seguace».
Si sono sottolineate, in questa citazione, le parole «naturale all’umanità», che non sono sottolineate nel testo, lasciando invece non sottolineata la frase che segue, sottolineata dallo scrittore, al fine di far risaltare la petizione di principio evidente che il passo contiene: è insomma l’umanità stessa che, secondo Tolstoi, ha, per umana perfidia da una parte e debolezza dall’altra, lasciato distorcere e offuscare la verità più naturale di tutte, fondamento di ogni altra, che sarebbe la legge dell’amore.
Dato che Tolstoi annette grande importanza al fatto che la legge dell’amore si ritrova in tutte le tradizioni religiose, ma unita sempre al fatto, pure da lui notato, che fin dal principio della storia conosciuta gli uomini hanno vissuto divisi in tribù e nazioni, discordi e rivali tra loro, e in seno alle quali la forza di coercizione di una minoranza s’imponeva alla gran maggioranza degli individui, egli stesso autorizza a concludere che non v’è ragione di sperare o anche pensare che la «non resistenza al male», corollario di quella legge dell’amore per tanto tempo così efficacemente (e bisognerebbe aggiungere: naturalmente) pervertita, non subirebbe la stessa sorte.
E allora? Da dove verrà la fiducia in un metodo d’azione così paradossale come quello proposto da Tolstoi? Forse dalla fiducia nel progresso morale dell’umanità più che dal messaggio cristiano esso stesso; nella sostanza del quale, tuttavia, Tolstoi certamente credeva, il sentimento d’amore per il prossimo essendo considerato da lui fin dai primi scritti come segno e sinonimo di gioia traboccante. Giacché, mentre l’orgoglio dell’uomo moderno per il progresso materiale non trovava in lui altra risposta che il più sprezzante sarcasmo, gli rimaneva certo tenacemente ancorata nell’animo la fiducia nella possibilità di un progresso morale se non unanime, però almeno generale, dell’umanità. E questa gli veniva, sì, dal sentimento cristiano della vita, ma forse ancor più dalla philosophie des lumieres di cui era profondamente impregnata la sua mente. In questo senso, la «non resistenza» si potrebbe considerare la risposta razionale al fatto irrazionale della violenza organizzata, e a quello ancora più irrazionale e contraddittorio della violenza sistematica concepita come mezzo di stabilire sulla terra il regno di una giustizia concreta.
Tuttavia, se il progresso materiale, fondato sulla scienza e sulla tecnica, appare poca cosa quando lo si confronta al vero problema, che è quello di un mutamento stabile per il meglio della disposizione di intere masse d’individui, i suoi effetti, per quanto grossolani li si giudichi, hanno almeno il vantaggio di essere tangibili. Mentre il progresso morale armonico dell’umanità tutta intera appare, più che improbabile, inconcepibile. Tranne, beninteso, che non lo si voglia postulare come conseguenza automatica del progresso materiale, cosa che Tolstoi non era certo disposto ad ammettere.
Qual è dunque il vero movente della predicazione tolstoiana contro la violenza, e quale il fondamento vero del principio di «non resistenza»?
Per chi legga oggi i suoi scritti morali senza prevenzioni, la risposta non è dubbia: la contestazione veramente globale che Tolstoi opponeva alla societa contemporanea, la quale era secondo lui «fondata sull’assassinio» non solo perché fondata sulla divisione delle genti in tribù nazionali armate le une contro le altre, e ognuna contro i propri soggetti, ma soprattutto perché la violenza ne costituiva l’anima e il principio ispiratore; ed era una violenza che cominciava con l’esercitarsi sull’animo del fanciullo nella cosiddetta «educazione» e continuava con i costumi e i vizi della classe privilegiata, alimentati grazie alla violenza fatta agli «inferiori», per finire in quella delle istituzioni politiche e della scienza stessa, tutta tesa a far violenza sia alla natura che all’uomo stesso, in nome di una supposta razionalità. Al che bisognava aggiungere, secondo Tolstoi, la profonda vanità della cultura ufficiale e dell’arte stessa.
Dal punto di vista di tale contestazione davvero globale, l’idea che, usata contro una società radicata in modo così essenziale nella violenza, la violenza stessa, purché impiegata efficacemente da un determinato gruppo di persone, potesse riuscire ad altro che a perpetuare una tale pessima condizione di cose, non poteva che apparire assurda.
Insomma, quella contro cui Tolstoi si ribellava in nome di una religione che chiamò in un primo tempo cristianesimo, ma per la quale si può dire (sulla base di ciò che si legge nei diari degli ultimi anni della sua vita) che alla fine non trovava più nome, era la falsa religione della scienza.
Nella «Lettera a un indiano» si leggono su questo parole di una virulenza particolare: «Con la parola scientifico -scrive Tolstoi- s’intende la stessa cosa che era implicita un tempo nella parola religione, e cioè tutto quello che si chiamava religione si supponeva fosse sempre indubitabilmente vero per la sola ragione che si chiamava appunto religione. Esattamente nello stesso modo, tutto ciò che oggi si chiama scienza è presunto essere indubitabilmente vero per la sola ragione che si chiama scienza. Sicché, in questo caso, l’antiquata giustificazione religiosa della violenza, che consisteva nell’unicità e divinità dei personaggi che si trovavano al potere, è stata sostituita dalla giustificazione che consiste nel dire che, siccome la coercizione c’è sempre stata, questa è la prova che tale violenza deve continuare indefinitamente. L’idea che l’umanità non debba vivere secondo ragione e coscienza, ma obbedendo a ciò che è avvenuto da molto tempo a questa parte, si manifesta in quella che la scienza denomina legge della Storia… La seconda giustificazione scientifica della violenza è che, siccome fra le piante e gli animali esiste una continua lotta per l’esistenza che culmina sempre nella vittoria del più adatto, la stessa lotta dovrebbe esistere fra gli uomini… La terza giustificazione scientifica della violenza, la più autorevole e, sfortunatamente, anche la più diffusa è, in realtà, la vecchia giustificazione religiosa leggermente modificata. L’argomento è il seguente: nella vita sociale, l’uso della violenza contro alcuni per il bene della maggioranza è inevitabile; quindi, per quanto desiderabile sia l’amore del prossimo, la coercizione è inevitabile. La differenza fra la giustificazione della violenza da parte della pseudo-scienza e quella della pseudo-religione consiste nelle diverse risposte che esse danno alla domanda: perché certe persone, e non altre, hanno il diritto di decidere contro chi la violenza possa e debba esser usata? La scienza non dice che tali decisioni sono giuste perché pronunciate da persone investite di un potere che viene da Dio, ma che esse rappresentano la volontà del popolo…». E, in un’irruenta perorazione finale, lo scrittore conclude: «L’indiano, come l’inglese, il francese, il tedesco, il russo, non ha bisogno di Costituzioni, di rivoluzioni, conferenze, congressi, di nuovi ingegnosi congegni per la navigazione sottomarina o aerea, di esplosivi potenti, o degli aggeggi d’ogni sorta per il piacere delle classi ricche e governanti; e neppure di nuove scuole e università che propinino istruzione in scienze innumerevoli, né dell’aumento del numero dei giornali e del libri, dei grammofoni e dei cinematografi, e neppure delle sciocchezze infantili e in gran parte corrotte che vanno sotto il nome di arti. Una sola cosa è necessaria: la conoscenza di quella semplice e chiara verità… secondo la quale la legge della vita umana è la legge dell’amore, e che essa dà sia al singolo individuo sia all’umanità tutta intera la più grande felicità possibile».
La contestazione non potrebbe essere più globale, né l’affermazione più netta. Ma, mentre la contestazione appare oggi in una luce singolarmente vivida, e quasi profetica, l’affermazione rimane soggetta a un grande se, il se supremo, se così si può dire. Tolstoi lo esprime in un’iterazione molto significativa: «Se la gente si liberasse dalla credenza di ogni specie di Ormuzd, Brama e Sabbaoth, con le loro incarnazioni in Krisna e Cristi… nonché dall’idea di un Dio che interferisce nella vita dell’universo; se la gente si liberasse anche dalla fede cieca in ogni sorta di dottrine scientifiche su infinitesimi atomi e molecole, e ogni sorta di mondi infinitamente grandi e infinitamente remoti, i loro movimenti, la loro origine, e le forze relative; se si liberasse dalla fede implicita in leggi scientifiche teoriche cui si suppone che l’uomo sia soggetto: le leggi storiche ed economiche, quella della lotta per vita, eccetera; se soltanto la gente riuscisse a liberarsi da questo terribile accumularsi d’inutile esercizio delle capacità inferiori della nostra mente e della nostra memoria che si chiama “scienza”, da tutte le innumerevoli branche d’ogni sorta di storie, antropologie, prediche morali, batteriologie, giurisprudenze, cosmologie, strategie, il cui nome è legione; se solo la gente si liberasse da questa intossicante e rovinosa zavorra… la semplice, esplicita legge d’amore accessibile a tutti e così naturale all’umanità… diventerebbe naturalmente chiara e impellente».
In altri termini, se l’umanità non fosse quella che è, e non fosse arrivata al punto in cui è arrivata, allora il messaggio tolstoiano sarebbe accolto unanimemente da tutti… Stando le cose come stanno, si potrebbe concludere che è la violenza, e non la legge d’amore, che è «naturale» all’umanità o, per essere più precisi, inerente alla situazione stessa dell’uomo nel mondo, oltre che alla sua «natura»; e che quindi un mutamento radicale -una metanoia- come quello postulato da Tolstoi è impensabile più ancora che impossibile.
Arrivati a una tale conclusione, però, il discorso non può essere chiuso. Se la violenza, infatti, è naturale all’uomo, non meno naturale in lui -o, meglio, in un certo numero di loro- è il disgusto per la violenza bruta, la sopraffazione, la coercizione. Ammesso pure che nessuno dei due impulsi possa esser elevato a legge universale, e con essi nemmeno la cristiana e tolstoiana «legge d’amore», bisogna pur rispondere alla domanda che cosa possano pensare e fare coloro che rifiutano per istinto la violenza come mezzo per rendere più giusta la società in cui vivono.
La conclusione relativamente scettica che si può trarre dal discorso di Tolstoi sulla «non resistenza» è che l’appello all’umanità in genere perché riconosca una volta per sempre la «legge d’amore» e adotti la «non violenza» come mezzo per realizzarla non è sufficientemente giustificato. Dal che consegue che -vigoroso come rimane per la radicalità stessa della tesi- il discorso di Tolstoi diventa però debole nella misura in cui implica l’idea che la «non violenza» sia un mezzo pratico per far fronte alla violenza di cui è capace uno Stato moderno tecnicamente efficiente. La sua autorità rimane, cioè, puramente morale.
Se torniamo al testo su cui Tolstoi fondava esplicitamente la sua tesi, e cioè il Vangelo di Matteo (5, 58-45), notiamo subito che le parole qui attribuite a Cristo non potrebbero essere più chiare su un punto, e cioè che in esse si rifiutano insieme il principio sancito dalla legge ebraica (Levitico, 24, 17-21) «occhio per occhio, dente per dente» e quello greco, non sancito da alcuna legge, ma accettato come naturale anche da Socrate e da Platone, secondo il quale «è giusto fare il massimo bene agli amici e il massimo male ai nemici». «Vi fu detto: ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici… poiché siete figli del Padre vostro che è nei cieli» risponde Cristo.
Che questa sia, in un certo senso almeno, l’essenza del messaggio cristiano non sembra si possa negare. Si noterà solo che nelle parole di Cristo si avverte anche l’eco di quell’universalismo «umanista» -o «cosmopolita»- già da tempo diffusi nella cultura ellenistica. È comunque certo che nel passo di Matteo si trova anche l’essenza di quella che Nietzsche chiamò con sovrano disprezzo «religione dei deboli».
Sorge a questo punto una delle domande cruciali che si sollevano di solito nel discutere di violenza e di non violenza: «Fino a che punto il debole è debole?».
Da una parte, quando a Tolstoi si obiettava che, non resistendo al male, non si otterrebbe altro che di lasciarlo trionfare, e quindi di lasciarsene distruggere, la risposta era che ciò sarebbe stato pur sempre male minore di una resistenza violenta dei deboli oppressi, la quale, mentre avrebbe causato male e distruzione aggiunti a quelli causati dai malvagi, non avrebbe neppure salvato i deboli dalla disfatta finale, dato che il potere organizzato è sempre più forte di quello che possono improvvisare gli oppressi inermi.
D’altra parte, però, oggi sappiamo bene che, quando si riesca con tecniche opportune a formarli in «masse», i «deboli» possono acquistare una forza insospettata e, scatenata da loro, la violenza può avere effetti alquanto devastatori. I deboli non sono deboli che quando sono oppressi e disarmati. E, d’altro lato, la forza dei moderni mastodonti meccanici non è neppur essa tanto forte quanto sembra. Nel fatto stesso dell’oppressione -di esser costretti a opprimere e reprimere- è implicito il timore di una forza latente incalcolabile, e di una violenza che, una volta scatenata, non ci saranno dighe capaci di arginarla.
Questo per sottolineare che l’argomento secondo cui la predicazione della «non resistenza al male» si fonda sulla debolezza dei deboli e sul fatto che essi sono disarmati è molto superficiale. Nella realtà delle situazioni sociali, debolezza e forza sono comunque dei fatti molto relativi; ed è stolto, in tale materia, fidarsi delle apparenze. Deboli erano i milioni di ebrei massacrati da Hitler; ma deboli anzitutto in quanto furono, per dir così, sorpresi nel torpore di un’esistenza pacifica: la rivolta del ghetto di Varsavia mostra che avrebbero anche potuto essere forti, perlomeno fino al punto da causare seri fastidi ai loro organizzatissimi carnefici. Forti, d’altra parte, contro il più forte Stato del mondo, si son dimostrati i guerriglieri vietnamiti. E oggi, la questione se la forza meccanizzata sia forte quanto sembra è diventata una questione molto seria. Uno dei fatti che sono apparsi chiari dalla gara per la strapotenza atomica è, ad esempio, che le forze contrapposte dei mezzi di distruzione moderni possono paralizzarsi (o atterrirsi come giustamente si dice) a vicenda.
Non si tratta dunque di forti e di deboli, ma di ben altro: di un principio da accettare o da rifiutare. Nel testo di Matteo, la «non resistenza al male» è espressa in forma di precetto universale fondato su una legge ugualmente universale: la legge secondo la quale gli uomini sono tutti figli di uno stesso Dio che fa «levare il suo sole sui buoni e sui malvagi, e piovere sopra i giusti e sopra gl’ingiusti».
Ma appunto per questo è d’altra parte chiaro in primo luogo che, parlando come parlava, Cristo non concepiva la non violenza come un metodo d’azione pratica da opporre alla pratica della violenza. Egli parlava evidentemente agli individui uno per uno, e concepiva le sue massime come norme di condotta individuale, da adottare senza considerazione alcuna d’efficacia. Si può dire, come è stato detto in sede di considerazioni storiche, che le sue parole avevano un senso molto preciso, rivolte com’erano a un popolo che aveva vivo il ricordo di rivolte sanguinose ed eroiche e della loro inutilità ai fini dell’abbattimento del potere di Roma.
Ma, in sostanza, ridotto in prosa esplicativa, il significato da attribuire alle parole di Cristo sembra essere questo: c’è l’oppressore armato e c’è l’oppresso disarmato; ci sono il potente, il ricco, il forte, e c’è l’indifeso, il povero, il debole. L’oppressore opprimerà finché ne avrà la forza. Che cosa potrà fare l’oppresso per rimaner fedele a se stesso e al Dio padre di tutti gli uomini nel quale crede? Non resistere al male perché è male in primo luogo, ma anche, al tempo stesso, perché non ne ha la forza. E non resistere non vorrà dire riconoscere il male e l’ingiustizia, ma anzi separarsi visibilmente dall’uno e dall’altra, mostrare negli atti che si è diversi dal malvagio. Il gesto di porger l’altra guancia a chi vi colpisce sarà appunto testimonianza visibile ed esempio di tale separazione e distanza. Ed esso non vorrà dire lasciare il campo libero al male, anzi fermarlo lì, non perpetuarlo opponendogli altro male, altro odio, altra violenza. D’altra parte, con questo il cristiano non pretenderà neppure di compiere un atto efficace, o di mettere in opera un metodo capace di vincere il male. Egli obbedirà alla legge del Dio in cui crede, e basta.
Qui sta forse la differenza fra il senso originario della parola di Cristo e la sua interpretazione da parte di Tolstoi, la quale assumeva la forma di un imperativo categorico non solo, ma anche di un principio efficace che si poteva validamente opporre al principio di violenza giustiziera predicato dai rivoluzionari. Donde i molti equivoci cui ogni movimento d’azione non violenta, da quello di Gandhi a quello di Martin Luther King, ha dato adito, primo fra tutti il tralignamento nella violenza cui è fatalmente soggetto. Ma più grave ancora dei dubbi e delle obiezioni teoriche è il residuo di impersuasione che permane anche dopo che siano state debellate le obiezioni teoriche.
La ragione prima di tale impersuasione è molto semplice: sta nell’impossibilita di fare appello a un gran numero di individui (anzi, in teoria, al genere umano in quanto tale) perché agisca in un dato modo senza in primo luogo fomentare la speranza di effetti immediati o comunque rapidi e, in secondo luogo -derivazione diretta di ciò- andare incontro a conseguenze imprevedibili: prima fra tutte, in questo caso, lo scoppio «naturale» della violenza nei momenti in cui «forti» e «deboli» si trovino faccia a faccia non individualmente, ma in massa. A questo punto, il diritto del debole a difendersi dalla violenza con la violenza rientra fatalmente in campo, come potè facilmente argomentare Martin Buber in risposta all’articolo nel quale, nel novembre 1938, Gandhi aveva consigliato agli ebrei tedeschi di adottare verso i nazisti il metodo della non violenza, anziché impegnarsi nella lotta per conquistarsi una patria in Palestina. Il che, d’altra parte, non significa che gli argomenti di Buber fossero logicamente più forti di quelli di Gandhi: quella che era forte era l’obiezione di fatto, accompagnata dal sentimento della giustizia offesa.
Ma, per tornare al Vangelo, quel che Cristo raccomanda nel Sermone della Montagna non è un metodo efficace, e neppure un comportamento di uomo «semplice» (il quale obbedisca, cioè, a un impulso irriflesso), bensì una condotta di uomo molto consapevole, dotato di una coscienza viva non solo del male che nasce dall’odio e dalla brutalità, ma anche della natura del vincolo sociale e delle condizioni in cui esso può essere mantenuto e ingentilito: un uomo, in altri termini, altamente «civile», o semplicemente «socievole», che è anche più chiaro. L’idea che Cristo si rivolgesse a folle ignare e rozze è certo fittizia: in primo luogo, egli parlava a pochi («Chi ha orecchi per intendere, intenda») e, in secondo luogo, questi pochi appartenevano a una società talmente provata dall’ingiustizia da una parte, e talmente ricca di fermenti spirituali dall’altra, che l’anelito verso una visione redentrice poteva assumervi forme addirittura febbrili.
Ma non è questo il punto cruciale del discorso. La questione che qui si vorrebbe chiarire per quanto possibile è un’altra, e cioè che senso si possa dare al principio cristiano di non resistenza al male in termini di vita morale e di effetto sulle coscienze.
C’è evidentemente, per primo, il rifiuto di agire come il malvagio e l’oppressore, la volontà di separarsi nettamente da lui: tanto nettamente da non tollerare neppure l’ombra del rancore o il pensiero nascosto della vendetta.
Ma in secondo luogo -sempre che non la si tratti come un’idea generale, bensì come un invito rivolto alla coscienza dell’individuo- c’è nella «non resistenza» il desiderio di preservare quel che è possibile preservare sia della vita fisica che della vita morale: una certa «integrità» non solo della persona singola, ma anche della società aggredita dal male; e il male non è soltanto la violenza vera e propria -quella armata- ma anche la prevaricazione smodata della ricchezza, l’arroganza dell’abilità tecnica (con il suo corollario: l’imposizione forzosa del cosiddetto «progresso»), nonché la presunzione della scienza, con il corollario della «culturalizzazione» coatta.
Si noti che queste conseguenze del principio evangelico riguardano tutte la difesa e la preservazione di una certa libertà «naturale», anzi puramente e semplicemente la libertà dell’animo umano: la dipendenza degli uomini dal Padre comune li affranca da ogni altra dipendenza e li incita a rifiutare ogni servitù temporale. Si noti però anche la parte che, nelle parole di Cristo, rimane paradossalmente «inattiva»: è quella contenuta nell’esortazione ad amare i propri nemici, la quale poi è parte integrante dell’universalismo del messaggio cristiano, del fatto, cioè, che esso si rivolge indistintamente a tutti gli uomini.
Non odiare -essere incapaci di odio- è un fatto morale semplice. Antigone sapeva che cosa fosse, quando si diceva «nata per amare, non per odiare». Ma «amare i propri nemici» che senso può avere, nella realtà dell’esperienza? Non si può amare che ciò che è amabile, e il carnefice, l’aguzzino, il prepotente non sono amabili. L’amante non corrisposto può dimostrare la forza del suo amore sacrificandosi per l’amata, distruggersi nel tentativo disperato di strapparle l’amore che essa non prova. Ma l’oppresso, che cosa può fare per vincere la brutalità dell’oppressore e renderlo più umano? Solo non resistergli, appunto, tentare di disarmarlo facendo cadere nel vuoto l’impeto della sua furia, della sua rapacità o della sua barbara sicurezza di essere nel giusto e di star esercitando un giusto potere. Ma questo non è un atto d’amore, né c’è necessità alcuna che lo sia. È un esempio di umanità che toccò raramente gli antichi persecutori e non sembra abbia mai toccato i persecutori moderni, ben altrimenti addestrati alla cecità morale.
L’atto di non resistere al male è, a considerarlo nella sua singolarità, un atto negativo che afferma, senza speranza alcuna di riuscire efficace, la presenza, nell’uomo, di una realtà che trascende ogni evento materiale, compresa la distruzione fisica. Tale atto potrà avere l’effetto inatteso di riuscire a stabilire col «nemico» un rapporto umanamente tollerabile, ma non è a tal fine, comunque, che sarà stato compiuto, bensì, come ogni atto umano autentico, per inevitabile necessità interiore. Il suo valore morale non dipenderà certo dal fatto di far parte di un «metodo d’azione» supposto efficace.
Ma, alla fine, che cos’è dunque realmente quest’atto negativo di non resistenza? È un atto col quale si riconosce il fatto della forza maggiore senza per questo umiliarsi a giustificarla o a guadagnarsi il favore del più forte, ma tuttalpiù per ottenere, in cambio del riconoscimento della strapotenza di quello, la nuda sopravvivenza.
Ora, questa era l’intenzione che ritroviamo all’origine del gesto greco del «supplice»: ikétes. Il supplice non si umiliava: era già umiliato dalla sventura, colpito dagli Dei, sacro. Il suo atto era un primo molto umano tentativo di risollevarsi, un chinarsi per poter alzare di nuovo il capo, e si esprimeva nel gesto di abbracciare le ginocchia del vincitore o del potente. Il gesto era considerato già di per se stesso audace, tanto che Ecuba, in Euripide, si domanda se non sia già troppo osare avanzarsi fino a stringere le ginocchia di Agamennone: il gesto comportava infatti un contatto fisico e, con questo, l’evidenza della comune umanità, rendendo empio di fronte a Zeus chi si fosse rifiutato di far grazia.
Se non la si idealizza facendone un principio universale astratto e un metodo d’azione, la «non resistenza al male» finisce dunque col somigliare alla «non resistenza al Destino» che, per il greco, era non già un principio etico, ma un semplice riconoscimento della realtà di fatto. Giacché, a ben riflettere, Destino e Male, che si tratti di azioni umane o di catastrofi naturali, sono la stessa cosa.
he nell’uomo e nella sua «storia» sia all’opera la stessa necessità che agisce nella natura, e che dunque il male che viene all’uomo dalle azioni dell’uomo stesso sia altrettanto misterioso e inevitabile quanto quello causato dallo scatenarsi delle forze della natura (le quali noi chiamiamo «cieche» unicamente perché non hanno aspetto umano), questa è la verità contro cui recalcitra l’uomo moderno, ostinato com’è nella convinzione insolente che l’uomo è, in ultima analisi, l’autore e l’origine prima delle sue azioni, e quindi anche del suo destino. Ma se si torna a riflettere sul modo di vedere degli antichi greci, secondo cui il fondo delle cose è uno ed eternamente oscuro, e non è neppure possibile dire di che natura sia la necessità che governa ogni moto, allora quello che noi chiamiamo «male» e che consideriamo errore o colpa fatale, sì, ma in teoria pur sempre eliminabile per via d’astuzia, d’abilità tecnica o di opportuna violenza, ci apparirà della stessa natura del Destino; e l’ordine umano, allora, non ci parrà ultimamente meno arcano di quello dell’Universo; e quindi, da ultimo, neppure più docile di esso alla nostra volontà demiurgica. La lezione appresa per questa via sarà una lezione di misura, non di inerzia.
Ma l’uomo contemporaneo rimane, almeno nelle sue dichiarazioni e azioni pubbliche, convinto che la forza dei meccanismi, delle armi e del potere organizzato lo rende ormai capace di opporsi efficacemente sia al Male che al Destino, riducendone progressivamente gli effetti fino ad annullarli del tutto, o almeno a ridurli e contenerli a tal punto da poter dire di averli praticamente eliminati.
L’idea di mobilitare la Forza per abolire il Male sulla terra (e specialmente nella società) è la grande idea moderna. Essa continua a far strage da quasi due secoli, e da cinquant’anni a questa parte a un ritmo pazzamente accelerato. Giacché, facendosi signore della Forza, l’uomo si fa anche signore e arbitro del Male, avanzando di fatto la pretesa di onnipotenza, o almeno di rappresentare lui l’unica potenza efficace, in quanto dotata d’intelligenza. Così egli rischia di far tornare ogni cosa al caos primigenio attraverso lo scatenamento della violenza, dell’ingiustizia e del Male allo scopo finale di far regnare il Bene assoluto.
È di fronte a questa arroganza assoluta che il principio di non violenza, proprio mentre si mostra inefficace come metodo d’azione, viene ad assumere il significato semplicissimo di affermazione di un modo di concepire la vita e di viverla tutt’altro da quello contemporaneo: un modo che non si esprime né in messaggi evangelici né in catechismi né in manifesti politici, ma consiste per cominciare nella fiducia che solo ciò che nasce, cresce e si forma secondo il suo proprio ritmo e la legge inscrutabile che opera in ogni cosa è vera e vale, mentre i mutamenti sono tanto più illusori quanto più repentini, violenti e totalitari. Ciò non significa rifiutarsi di partecipare alle vicende della vita associata, ma solo dare alla politica la sua parte e negarle ciò che non le spetta.
Questo si può esprimere anche nelle parole di Lao Tse: «Chi agisce con violenza può ottenere il suo scopo, ma solo ciò che rimane fermo al suo posto dura».
Nicola Chiaromonte
Stato e minoranze rivoluzionarie
Tratto da «Tempo presente», marzo-aprile 1968
Ci è giunto, con questo titolo, un comunicato che porta l’indicazione «Faro – Agenzia stampa», con sede a Vigevano, e della quale è direttore responsabile Gian Franco Invernizzi. Non conoscevamo l’agenzia Faro, né conosciamo il suo direttore, ignoranza di cui ci scusiamo. L’articolo che porta il suddetto titolo, ed è da lui siglato, ci è parso comunque interessante, in quanto, nella non poca confusione di motivi che accompagna la sommossa degli studenti, c’è qualcuno che ha voluto mettere i punti su qualche i e cercare di distinguere ciò che va distinto, anche se poi le distinzioni si prestano secondo noi a critiche sostanziali. Lo pubblichiamo perciò qui di seguito per intero, facendolo seguire da alcune osservazioni.
Le recenti manifestazioni studentesche che si sono sviluppate in Europa e in America sui temi della “contestazione globale” ad opera di minoranze insofferenti alla organizzazione della società quale si è venuta configurando in Occidente, rappresentano un fenomeno politico di tipo nuovo nel sistema occidentale. Nonostante le apparenze, è sbagliato vedere analogie fra il movimento politico studentesco in Occidente e la “rivoluzione culturale” in Cina. Anche nei Paesi occidentali il moto autonomo e spontaneo dei gruppi studenteschi si è manifestato contro la burocrazia politica. Ma, mentre la “rivoluzione culturale” cinese non contesta il sistema vigente, limitandosi a prenderne di mira alcuni aspetti, alcune frange riformiste e autoritarie, in Occidente il movimento studentesco mette in discussione l’organizzazione della società, il “sistema”. Il movimento studentesco in Cina vuole perfezionare il sistema, purificandolo di alcune “tare” autoritarie, in Occidente il movimento studentesco rifiuta il sistema in quanto basato, a suo dire, sulla logica autoritaria e sulla logica dell’alienazione. L’uno infine è un fatto di massa, l’altro un fatto di élite, di avanguardia. È altrettanto sbagliato vedere analogie fra le manifestazioni studentesche in Occidente e quelle dei Paesi dell’Est europeo, Polonia e Cecoslovacchia in particolare. L’ispirazione politica dei movimenti studenteschi occidentali contesta un tipo di sistema che ha raggiunto una avanzata fase “consumista” nel quadro della società industrializzata. L’ispirazione politica dei movimenti studenteschi dell’Est europeo, contesta un sistema sclerotico, burocratizzato, lento e inefficace sul piano delle riforme economiche e nel promuovere il benessere del Paese, e chiede, insieme alla formale creazione di istituti che in Occidente cominciano a non nascondere l’usura e l’inadeguatezza, la libertà, tout court. Il movimento politico studentesco in Occidente si presenta in realtà più “avanzato” nei suoi contenuti di tutta una fase storica rispetto ai movimenti politici studenteschi dell’Est europeo. In questa differenza di “qualità” e di “quantità” nei fenomeni politici giovanili delle aree comuniste, moscovita e cinese e dell’area occidentale, c’è spazio per un discorso franco e obbiettivo. La violenza delle manifestazioni di alcuni gruppi politici in Occidente sembra direttamente proporzionale al grado di “integrazione” delle varie classi sociali nel sistema. Più il sistema “integra”, più sembra radicalizzarsi nei Paesi industrializzati dell’Occidente l’azione di alcune minoranze, fino all’uso della violenza, da parte di alcuni gruppi più ristretti, come strumento di protesta e di lotta politica. Non serve il richiamo riformista, poiché da parte di queste minoranze il rifiuto del sistema è totale. Si perviene quindi, ed è bene parlarne, ad uno dei temi più delicati e cruciali, quello cioè del rapporto fra lo Stato e l’azione di alcuni gruppi quando questa sfocia nella violenza. Nelle moderne società industrializzate, l’apparato produttivo raggiunge un alto grado di efficienza e sempre più complessa diviene l’organizzazione civile. L’azione irresponsabile di gruppi violenti, che potrebbe arrecare all’una e all’altro danni gravi, non può essere tollerata. Vi è pertanto un problema di prevenzione, di “democratizzazione” e un problema di repressione. Vi è la necessità di dotare gli apparati e i servizi di sicurezza dello Stato di dispositivi idonei ed efficienti di controllo e di intervento, pur nella garanzia della più assoluta libertà di espressione. Occorre prevenire e reprimere le azioni di violenza, lasciando la più ampia libertà di espressione a tutti. Purtroppo, a considerare da come ci si è mossi nei Paesi europei occidentali nei confronti delle manifestazioni studentesche, v’è da temere che da parte delle vecchie classi politiche che si trovano a gestire (male) il “sistema”, si assumano atteggiamenti radicalmente sbagliati. Reprimendo cioè libere e lecite manifestazioni di cittadini e mostrandosi deboli, incerti, persino paurosi e codardi nei confronti delle azioni di violenza di alcuni gruppi politici minoritari. In America ogni gruppo politico gode della più piena libertà di espressione, certamente molto maggiore di quanto non se ne goda in qualsiasi altra parte del mondo (è meglio ogni tanto ricordarlo), ma i pubblici poteri intervengono con prontezza e decisione a stroncare ogni atto di violenza.
È bene che, per cominciare, il direttore dell’agenzia Faro abbia tenuto a dire chiaramente che «è sbagliato vedere analogie fra il movimento politico studentesco in Occidente e la “rivoluzione culturale” in Cina». Quando però egli aggiunge che «il movimento studentesco in Cina vuole perfezionare il sistema, purificandolo di alcune “tare” autoritarie», mentre «in Occidente il movimento studentesco rifiuta il sistema in quanto basato, a suo dire, sulla logica autoritaria e sulla logica dell’alienazione», è difficile non rilevare che, per quanto se ne sa, e quali che siano peraltro stati i suoi effetti e meriti eventuali, la «rivoluzione culturale» cinese ha avuto in ogni caso il carattere di un movimento scatenato dall’alto, sostenuto dal meccanismo statale non poco autoritario che regge attualmente la Cina e in particolare dal formidabile centro di potere costituito dal dittatore Mao Tse Tung e dai suoi fedeli.
Tale movimento è d’altra parte tornato nell’alveo prestabilito non appena detto centro di potere -e più particolarmente il potere militare- ha ritenuto che le cose fossero andate abbastanza avanti, gli scopi prefissi più o meno raggiunti, e i pericoli del preordinato straripamento più grandi ormai dei possibili vantaggi che esso poteva offrire, al fine di sgominare la resistenza di certi quadri del partito e del regime al potere del dittatore Mao Tse Tung. Chiudere le scuole, scatenare quaranta milioni di ragazzi sulle strade e nelle città della Cina, mettendo a loro disposizione le ferrovie e gli altri mezzi pubblici di trasporto e procurando che venissero nutriti e alloggiati a spese dello Stato, sono misure forse politicamente geniali, ma che non sembrano caratteristiche di un movimento spontaneo destinato a «purificare» un regime delle sue «tare autoritarie». Si direbbe piuttosto che un tal movimento è tipico di un moderno e assai astutamente concepito regime di massa. E regime di massa è sinonimo, ci sembra, di regime non solo autoritario, ma totalitario. Ciò non soltanto, nella fattispecie, per la mostruosa fanatizzazione condotta in base al famoso libretto dei pensieri di Mao, ma semplicemente perché manovrare le masse (e in particolare le masse giovanili) per mezzo di meccanismi ideologico-burocratici, anche e soprattutto quando le si scatenano contro obbiettivi prestabiliti, è il segno non equivoco dei regimi totalitari moderni, passati, presenti e (probabilmente) futuri.
Ribellarsi contro un «sistema» -quello occidentale- definito «autoritario» e «alienante» basandosi su tali esempi e su tali definizioni sembra parecchio contraddittorio. A meno, naturalmente, che la «rivoluzione» auspicata non sia di specie massiccia e totalitaria: un’ideocrazia sostenuta da una burocrazia, diretta (come sembra suggerire la nota di Gian Franco Invernizzi) a sgominare ogni bieco «riformismo ».
Ma in qual modo d’altra parte conciliare un simile ideale (se di esso si tratta), o quanto meno un simile giudizio e la logica in esso implicita, con l’affermazione che, contrariamente a quello cinese, il movimento studentesco occidentale è un «fatto di élite, di avanguardia»? Sarà esso per caso qualcosa di analogo all’«avanguardia del proletariato» secondo Lenin (diciamo «secondo Lenin» e non «secondo Marx» perché la concezione che aveva Marx dell’avanguardia rivoluzionaria era alquanto più complessa di quella nettamente minoritaria e autoritaria, propria di Lenin)? Ma, in tal caso, sarebbe pur sempre a un regime di massa che si aspirerebbe, a quella dittatura del proletariato della quale già prima del 1914 Charles Peguy diceva che gli sarebbe piaciuto sapere chi -quale individuo particolare- l’avrebbe impersonata e esercitata.
Una dittatura, quale che sia il motto sulla sua bandiera, ha, fra le altre conseguenze, quella di «alienare» duramente non solo tutti coloro che non l’applaudono e non se ne lasciano irreggimentare, ma anche (e forse soprattutto) quelli che la applaudono e la seguono entusiasti: basta il fatto di vestire un’uniforme, di agitare un libretto, di sfilare in parata, di alzare il braccio nell’una o l’altra forma di saluto al «capo geniale» per essere alienati e asserviti in quanto individui autonomi e possibilmente pensanti. Sarebbe interessante conoscere l’opinione del direttore responsabile dell’agenzia Faro su questo punto, con aggiunta la dimostrazione della superiorità dell’alienazione proletaria, socialista, comunista, o comunque denominata, su quella attribuita al neocapitalismo «consumista».
D’altra parte, con generoso impulso, il direttore responsabile dell’agenzia Faro prende partito in favore dell’attuale rivolta della gioventù e degli intellettuali in Cecoslovacchia e in Polonia (e insomma anche in Russia) contro i rispettivi regimi totalitari, affermando che «l’ispirazione politica dei movimenti studenteschi dell’Est europeo contesta un sistema sclerotico, burocratizzato, lento e inefficace sul piano delle riforme economiche e nel promuovere il benessere del Paese, e chiede, insieme alla formale creazione di istituti che in Occidente cominciano a non nascondere l’usura e l’inadeguatezza, la libertà tout court». Il quale fatto sembra peraltro, all’autore di questa nota, indicare che il movimento occidentale è «più avanzato, nei suoi contenuti, di tutta una fase rispetto ai movimenti politici studenteschi dell’Est europeo».
Strana argomentazione. La «formale creazione di istituti» di cui si tratta in Cecoslovacchia e in Polonia è, in sostanza, esigenza di democrazia effettiva nella gestione degli affari pubblici e di «libertà tout court» quanto al diritto di comunicare con i propri simili sia per mezzo della parola parlata che della stampa e degli altri mezzi d’espressione. In che senso in Occidente tali diritti e istituti «cominciano a non nascondere l’usura e l’inadeguatezza»? In che senso, poi, tale usura e inadeguatezza sarebbero prove del carattere più avanzato dei movimenti studenteschi occidentali? Sarebbe per caso ormai, in Occidente, la «libertà tout court» «un cadavere putrefatto», secondo la celebre asserzione fatta nel 1922 da un notevole manovratore di masse di nazionalità italiana, del quale certo il direttore responsabile dell’agenzia Faro non ha bisogno che gli si ricordi il nome? E sarebbe d’altra parte per caso l’«alienazione» di cui tanto si parla altro che asservimento e mancanza di libertà? Non potrebbe per avventura darsi che ogni rivendicazione politica, quale che ne sia l’impulso ispiratore, fosse sempre una rivendicazione di «libertà tout court», di libertà senza aggettivi, e che un tal fatto andasse riconosciuto una volta per tutte da tutti coloro che si dicono «rivoluzionari», e i quali invece oggi indulgono in una distinzione fra «vera libertà» e «falsa libertà», «libertà concreta» e «libertà astratta» che non può non confondere le idee e far dimenticare il senso della cosa di cui si tratta? La quale è proprio la libertà tout court, anzi la libertà formale, la libertà come forma del vivere civile, eguale per tutti e a disposizione effettiva di tutti: la libertà che Rosa Luxembourg rivendicava fieramente di fronte a Lenin nell’ora del trionfo della dittatura del proletariato, e cioè di quella «libertà concreta» rappresentata, secondo il medesimo Lenin, dal «fucile sulla spalla dell’operaio».
Ma, se non sembra avere idee molto chiare quanto alla libertà e alla democrazia, il direttore responsabile dell’agenzia Faro, bisogna riconoscerlo, si rende conto della china pericolosa su cui si può scivolare seguendo il richiamo del mito rivoluzionario. Questa china è secondo lui, quella della violenza, la quale apparirebbe tanto più attraente, come strumento di lotta politica, quanto più forte diventa «il grado d’integrazione del sistema». E di fronte a questa attrattiva sempre più grande della violenza, «non serve il richiamo riformista, poiché da parte di queste minoranze il rifiuto del sistema è totale».
La conclusione di Gian Franco Invernizzi è che esiste, nelle nostre società, «un problema di prevenzione, di democratizzazione e un problema di repressione», quindi «la necessità di dotare gli apparati e i servizi di sicurezza dello Stato di dispositivi idonei e efficienti di controllo e di intervento, pur nella garanzia della più assoluta libertà di espressione». Ad esempio di buona soluzione di un tal problema, il direttore dell’agenzia Faro non esita a proporre quello dell’America, «dove ogni gruppo politico gode della più piena libertà di espressione, certamente molto maggiore di quanto non se ne goda in qualsiasi altra parte del mondo (è meglio ogni tanto ricordarlo), ma i pubblici poteri intervengono con prontezza e decisione a stroncare ogni atto di violenza».
Conclusione altrettanto sensata quanto inattesa. E tuttavia poco convincente. Non solo perché ci sarebbe pur qualcosa da dire sui metodi usati dalla polizia americana quando si trova dinanzi a scoppi di violenza di massa, ma soprattutto per l’ovvio non sequitur del ragionamento. Il quale non sequitur si riduce a questo: se il «richiamo riformista» è inutile, e quel che le minoranze rivoluzionarie studentesche vogliono è il mutamento totale del «sistema», la violenza è il mezzo non solo logico ma inevitabile a cui esse devono ricorrere, correndo al tempo stesso il rischio -è evidente- della violenza contraria dell’apparato repressivo statale. Non si può volere tutto, e volerlo nel futuro immediato, senza perciò stesso volere la violenza: la violenza è già nell’idea, e dall’idea al fatto il passo è più che breve.
Ma se poi «rifiuto del sistema» e «contestazione globale» sono dei modi di dire massimalisti (come in fin dei conti sembra il caso nella sommossa degli studenti), e si tratta invece in sostanza di «richiamo riformista», e di «lasciare a tutti la più ampia libertà d’espressione», allora non siamo forse nell’«ambito del sistema» (il quale, in Italia come in altri luoghi d’Occidente, è a dir poco alquanto ambiguo sia quanto a energia riformista che quanto a libertà di espressione), ma siamo certo fuori dal rivoluzionarismo senza oggetto di cui tanto abuso s’è fatto, e per tanti anni, assai prima che dai giovani, dai loro pessimi maestri e falsi pastori intellettuali.
Chiaromonte, l’America e “l’etica del limite” nell’età dell’estremismo
Sono onorato di essere qui oggi a condividere alcune riflessioni su Nicola Chiaromonte, eroica figura antifascista della “Generazione della Resistenza”, la vita e l’opera del quale, saranno presto, così spero, celebrate e studiate con maggiore ampiezza sia in Italia, suo paese natale, che in altri paesi. Nello specifico, vorrei parlarvi dell’impatto che Chiaromonte ebbe su un gruppo influente di americani mentre si trovava in esilio a New York negli anni ’40. Il suo umanesimo, che lasciò una traccia così profonda, fu il frutto di una dura esperienza di vita durante l’era di Hitler e Mussolini e delle ideologie che giustificarono il genocidio durante la seconda guerra mondiale; rappresentò la speranza che potesse esistere un’alternativa, che la giustizia, il dialogo e l’idea di comunità fossero ancora praticabili pur nell’ombra dell’Olocausto e di Hiroshima. Io sono convinto che le idee di Chiaromonte, fondate sul principio etico classico del “limite”, siano più attuali che mai oggi, a trent’anni dalla sua morte, non solo per gli americani, ma per molti altri che fanno parte della comunità globale, specie in quest’epoca caratterizzata dall’estremismo e dagli abusi di potere.
- Ho scoperto Nicola Chiaromonte una decina di anni fa, mentre facevo ricerche per la mia dissertazione di dottorato: uno studio sulla figura del dissidente newyorkese Dwight Macdonald, giornalista e critico. Macdonald era un membro del gruppo della “Partisan Review” che nel 1930 si occupava di marxismo -prima che le purghe di Stalin lo inducessero a rifiutarne le pretese utopistiche. Macdonald mi interessava in quanto il più vivace, iconoclasta -e quindi meno datato- degli intellettuali newyorkesi di quel periodo. Chiaromonte una volta lo descrisse affettuosamente come un’”intelligenza libera”, “un americano vecchio stile, un individualista esuberante e ricco di immaginazione”, come da miglior tradizione del paese che, per carattere e convinzioni, risultava incapace di ortodossia ideologica (questo andava con l’idea di Chiaromonte che “nessuna ideologia preconfezionata poteva avere presa sulla realtà americana”). Altri furono meno indulgenti sulle eccessive esuberanze di Macdonald. Un esasperato Leon Trotsky, alla fine degli anni ’30, mentre rifiutava con rabbia le domande sugli esordi sanguinosi della Rivoluzione bolscevica, commentava il suo atteggiamento con queste parole rimaste famose: “ognuno ha diritto alla propria stupidità ma il compagno Macdonald abusa di questo privilegio”. All’interno dell’atmosfera di conformismo patriottico e di autocensura che caratterizzò l’entrata degli Stati Uniti nella seconda guerra mondiale, Macdonald fu uno dei pochi che rifiutò di mettere a tacere le sue facoltà critiche. Nel 1944 aveva lasciato la “Partisan Rewiew” per mettere in piedi un proprio giornale di opinione, chiamato semplicemente “Politics”, che doveva servire come forum di discussione sulle politiche degli stati alleati, per dar voce ai rifugiati europei e ai veterani della Resistenza e per incoraggiare il dialogo fra le alternative democratiche alle potenze militarizzate che, come giustamente aveva predetto, si sarebbero trovate l’una di fronte all’altra dopo la fine della guerra.
Fu durante questo periodo di sperimentazione che Macdonald incontrò e divenne amico di Nicola Chiaromonte, nuovo ingresso nella crescente comunità di esuli a New York. L’influenza fu immediata e così totale da far dire in seguito a Macdonald che la rivista “Politics” era “una coproduzione italo-americana”. Anche la scrittrice Mary McCarthy entrò a far parte di questo gruppo di amici. Per lei “parlare con Chiaromonte fu un’esperienza nuova e così stimolante che non si esaurì mai”. McCarthy ricordava con particolare tenerezza le discussioni dell’estate ’45 su Shakespeare, Tolstoj e la misteriosa scrittrice contemporanea Simone Weil, durante una vacanza a Cape Cod la cui tranquillità fu distrutta dalla notizia della bomba atomica. Chiaromonte ammirava l’apertura e l’entusiasmo dei suoi amici americani che, a loro volta, erano affascinati dalla calma saggezza, dalla profondità e dalla “serietà” di “questo bell’uomo, scuro di pelle, che sembrava un monaco”.
Come altri esuli del gruppo Macdonald-McCarthy, legati alla rivista “Politics” (importante era la presenza di Hannah Arendt), Chiaromonte aveva portato con sé il peso di anni di lotta al fascismo e alle sue orribili conseguenze. La maggior parte di voi conosce la sua storia. Nato nel 1905 nel sud, nella cittadina di Rampolla, Chiaromonte non perse mai l’amore per la forza, la dignità e l’innato anarchismo dell’ambiente contadino che l’aveva circondato nei suoi primi anni. Durante gli studi a Roma, presso i gesuiti, preferì l’umanesimo classico alle astrazioni teologiche in voga allora, sia cattoliche sia marxiste. Seguì l’esilio da Mussolini a Parigi, sotto la tutela di Andrea Caffi e del gruppo “Giustizia e Libertà”, e la pericolosa partecipazione alla guerra di Spagna con André Malraux. Il saggio di Chiaromonte che rendeva omaggio all’idealismo dei repubblicani a fianco dei quali aveva combattuto apparve nel 1939 negli Stati Uniti sulla rivista “Atlantic Monthly”.
“Stando insieme a queste persone talvolta uno ha l’impressione di essere in mezzo a tanti Patrick Henrys (eroe della rivoluzione americana del 1776, Ndr) -scriveva Chiaromonte- ‘Libertà o morte’ sembra essere il motto generale. Essi hanno in comune l’urgenza di liberare il mondo intero dalla minaccia fascista e questo spesso si esprime col darsi delle arie e assumere degli atteggiamenti. Ma c’è anche la fede, una fede fanatica fondata su un concetto semplicissimo: un paese libero e una società fatta di persone oneste, che non debbano patire la fame né vestire di stracci. Esiste qualcosa di più semplice di tutto questo?”.
Poi venne quella che Chiaromonte definì “l’ora zero dell’umanità”, ovvero le prime sconvolgenti vittorie della guerra-lampo nazista. Con la caduta di Parigi nella tragica primavera del 1940 Chiaromonte fu costretto a scappare di nuovo, perdendo la sua prima moglie durante il difficile viaggio verso sud, ma traendo un po’ di conforto dalla generosità e dalla resistenza degli amici rifugiati in quelle comunità improvvisate.
“A Toulouse c’erano degli amici, c’erano compaesani che parlavano il proprio dialetto, c’erano gli amici degli amici; un uomo poteva trovare un letto e qualcosa da mangiare. Arrivavano da ogni luogo: dalle loro case, da reggimenti stranieri, da gruppi di lavoro forzato, da campi di concentramento, dalla Lorena, dall’Alsazia e anche dai sobborghi di Parigi, dal Belgio e finanche dall’Inghilterra, via Dunkerque… Ci stringevamo tutti intorno ad un tavolo in uno scantinato distrutto e non c’era mai posto a sufficienza né al tavolo né a sedere. Dal più abissale sconforto risorgevano gli spaghetti e si organizzava la mensa. Sulla più elementare delle basi comuni -ovvero la necessità di mangiare- nasceva una piccola comunità o piuttosto si formava una famiglia alquanto composita”.
La sua destinazione successiva fu il Nordafrica, dove nel 1941 incontrò Albert Camus, con cui avrebbe condiviso molte affinità artistiche e politiche. Chiaromonte ricordò l’intensità dell’incontro con Camus e con la sua “famiglia” di compatrioti algerini: “Hitler aveva appena occupato la Grecia e la svastica sventolava sull’Acropoli -scriveva-. Soffrivo di una nausea continua per questi avvenimenti. Ma solo e sradicato com’ero, in quel momento ero l’ospite di questi giovani. Per conoscere veramente il valore dell’ospitalità uno deve essersi trovato solo e senza casa”.
- Chiaromonte portò tutte queste esperienze con sé quando finalmente arrivò alla salvezza in America, dando inizio ben presto al sodalizio con l’instancabile Dwight Macdonald. Ebbe una grandissima influenza sulla rivista “Politics” di Macdonald proprio nel modo di affrontare la violenza delle ultime fasi della guerra e, più tardi, cercando di articolare una “terza via” di opposizione post-marxista nella prima fase della Guerra fredda. Condannò l’ideologia della “responsabilità dei popoli”, la nozione disumana della colpa collettiva, del “noi contro loro”, che faceva sì che i civili diventassero obiettivi legittimi di armamenti da giudizio universale (che già allora includevano le opzioni nucleari). Introdusse i lettori della rivista al pensiero di Simone Weil, la cui riscoperta della concezione greca del “limite” sembrava arrivare al momento giusto per essere applicata al rinnovato estremismo ideologico. La Weil, come anche Chiaromonte, rifiutava ogni schematismo -specialmente il determinismo marxista e la fede dell’Occidente nel “progresso” materiale- che trasformava gli individui in unità disponibili per un grande calcolo storico, a giustificazione dell’uso cieco del potere. Chiaromonte capì molto bene come la Weil avesse colto l’aspetto malato della modernità, l’”hubris” di quella che lei chiamava la nostra “era tecnologica che si autocelebra”. “I concetti del limite, della misura, dell’equilibrio che dovrebbero determinare la condotta della nostra vita -scriveva con parole che sono valide oggi come allora- nell’Occidente sono relegati ad una funzione servile nel vocabolario della tecnica”.
Chiaromonte, inoltre, presentò le idee di Albert Camus a Macdonald e ai lettori americani della rivista. Quando Camus arrivò a New York per una lunga visita nella primavera del 1946, Chiaromonte lo accolse al suo arrivo al molo. Si trovarono d’accordo sull’impegno a non diventare “né vittime né carnefici” in tempi di violenta polarizzazione e Chiaromonte registrò con approvazione il monito di Camus alla Columbia University: “il veleno di cui era impregnato Hitler (rimane) presente in ciascuno di noi”.
Le parole di Camus continuano a risuonare ancor oggi: “Viviamo nel terrore perché la persuasione non è più possibile, perché non riusciamo più a tirar fuori quella parte di noi che recuperiamo contemplando la bellezza della natura e dei volti umani, perché viviamo in un mondo di astrazioni, scrivanie e macchine, di idee assolute e di rozzo messianesimo. Soffochiamo in mezzo a questa gente che pensa di avere assolutamente ragione sia rispetto alle loro macchine che alle loro idee. E per tutti coloro che riescono a vivere solo in un’atmosfera di dialogo e socialità fra gli uomini, questo silenzio è la fine del mondo”.
Chiaromonte lavorò con Camus alla fine degli anni ’40 per costruire una cultura cosmopolita del “dialogo e della socialità” che operasse “al di fuori” delle istituzioni ufficiali, governo e partito, fuori dalla politica convenzionale, attraversando le frontiere indurite delle nazioni e delle ideologie nei primi giorni della Guerra fredda. Queste idee descritte da Gino Bianco come “il pensare al di fuori della politica” dovevano molto al mentore di Chiaromonte, Andrea Caffi, che aveva parlato di creare “una società nella società”. E’ un approccio ricorrente nella nostra storia: per esempio in Polonia, dove Chiaromonte veniva letto ed ammirato durante le repressioni degli anni ’70 e ’80, e il dissidente Gÿorgy Konrad lanciò un appello molto simile alla solidarietà internazionale spontanea, dichiarando che “coloro che pensano violano le frontiere”.
Con l’aiuto di Macdonald, Mary McCarthy e altri intellettuali newyorkesi alla ricerca di una “terza via”, fuori dalla minaccia di una terza guerra mondiale, Chiaromonte co-produsse “Europe-America Groups”, un progetto che prevedeva l’invio di aiuti materiali e incoraggiava la creazione di reti di comunicazione e solidarietà oltre l’Atlantico (cosa che allora, senza gli aerei, i satelliti e internet costituiva un problema per la grande distanza).
Chiaromonte ritornò in Europa nel 1947, insieme alla moglie americana Miriam, e lavorò come punto di collegamento di questo progetto che ancora oggi, nonostante sia stato definitivamente chiuso, è un modello per i movimenti transnazionali impegnati per la pace e la democrazia. Al momento della partenza da New York, Macdonald (che aveva dato ad uno dei suoi figli il nome di Chiaromonte) riassunse così l’impatto che l’italiano aveva avuto su di lui: “Ho imparato molto da te, Nick, e tu hai cambiato interamente le mie idee (tu e la bomba atomica)”.
- Nei successivi venticinque anni Chiaromonte, Macdonald e Mary McCarthy mantennero i legami d’amicizia, scambiandosi visite e corrispondendo su tutto, dalle cose personali alle controversie politico-letterarie del momento. Ho avuto il piacere voyeuristico di leggere gran parte di questa documentazione dattiloscritta, che viene conservata nei “Macdonald Papers” all’università di Yale e all’archivio McCarthy presso il Vassar College, e il calore e l’intimità del loro rapporto brilla oltre il tempo e la distanza. Chiaromonte apprezzava molte cose dell’America, ma confessava di sentirsi meglio a casa dopo tanti anni all’estero. “L’Europa si trova in uno stato disastroso -scriveva a Macdonald nel 1947- ed intellettualmente non è molto interessante, pur tuttavia l’Europa è una società, strade alberate, cose strane e belle, mentre per me New York vuol dire qualche amico qua e là, molto cemento ed un’incredibile… mancanza di qualità in tutto”.
Per un breve periodo Chiaromonte visse in Francia, lavorando presso la sede dell’Unesco di Parigi, ma trovò piuttosto demoralizzante quella routine “vuota ed assurda” della vita burocratica. “Così mi trovo qui -scriveva in un’altra lettera a Macdonald lamentandosi- a fare poco o niente ma… legato agli orari d’ufficio, ai discorsi idioti da camicia inamidata, con la sensazione di perdere giorno dopo giorno il controllo sulla mia vita e sul mio cervello…”.
Finalmente, nel 1953, i Chiaromonte arrivarono a Roma, dove Nicola trovò lavoro come critico per il settimanale “Il Mondo” diventando, a metà degli anni ’50, coeditore con Ignazio Silone del giornale “Tempo presente”.
Nicola, Dwight e Mary mantennero ostinatamente la propria autonomia critica anche nei giorni più “frigidi” della Guerra fredda. Condannarono i crimini dello Stato sovietico, ma contemporaneamente misero in evidenza i limiti dei sistemi occidentali. Ben presto, per esempio, si resero conto dell’assoluta follia della guerra americana in Vietnam. “C’è qualcosa di particolarmente nauseante nella brutalità americana -scriveva Chiaromonte a Macdonald nel 1965- non solo perché si accompagna ad un discorso ipocrita sulla democrazia, sulla libertà e sulla pace ma anche perché è così scoperta, cruda, così fine a se stessa, un gioco, una questione tecnica”.
A proposito degli architetti della guerra osservava: “Potere, potere, potere. Non gli viene neppure il sospetto che il potere possa essere speso molto più velocemente e male dei soldi?”.
Richiamando la Simone Weil dei due decenni precedenti, Chiaromonte metteva in guardia sulla possibilità che l’impresa avesse un esito disastroso per gli Stati Uniti poiché andava incontro a quel tipo di “punizione meritata” causata “dalla corruzione, dalla brutalità e dalla volgarità che si manifestano nello stesso momento in cui il potere viene usato come fine a se stesso”. Nello stesso tempo, tuttavia, lamentava che gli europei, così come altri paesi, guardassero allo stile tecnocratico americano con invidia e paura al contempo. In discussione c’era la definizione della vera identità americana e il suo ruolo nel mondo. In una lettera del 1965, Chiaromonte concludeva: “C’è una questione che ha a che fare con la guerra del Vietnam ed è stabilire che tipo di America si vuole. Se si vuole un’America superpotente, super ricca, supermeccanizzata, completamente tecnologicizzata e programmata elettronicamente e che corrisponde a quello che alcuni vorrebbero, … allora (il Presidente) Johnson ha ragione… ma se uno pensa che il potere dell’America debba avere un significato e uno scopo completamente diversi e che l’imperialismo sia del tutto estraneo alla sua natura, perché si fonda su un processo di ‘espansione naturale’ e non di forza militare, allora si deve essere fermamente decisi e contrari a qualsiasi discorso di ‘prestigio nazionale’ o di ‘salvare la faccia’ o di propria convenienza”.
Nel 1966 Chiaromonte fece una serie di conferenze all’Università di Princeton conservate nel volume The Paradox of History (trad. it. Credere e non credere) in cui riassumeva la sua critica all’assolutismo ideologico e all’abuso di potere che ne derivava. Chiaromonte ancora una volta rifiutava le scuole di pensiero -marxista, liberale o conservatrice- che sacrificavano il popolo per realizzare i grandiosi schemi del “Progresso”, salvo poi inondarli con la sanguinosa “rappresentazione spettacolare” della guerra. In scrittori come Stendhal e Tolstoj, come pure nella poesia epica greca, Chiaromonte trovava una conferma di come l’impulso a imporre razionalità, leggi consolidate, storie di eroi o un senso di “unità finale” sulla “molteplicità inesauribile” dell’esperienza umana si rivelasse una delusione irrispettosa, condannata al fallimento e a periodiche catastrofi, come dimostrato dagli sconvolgimenti del XX secolo. Il potere e la forza devono essere usati con limitazione, riconoscendo i limiti della conoscenza umana. In realtà, dal suo punto di vista, queste limitazioni costituiscono la base della nostra autonomia.
Chiaromonte scriveva: “Se riuscissimo a conoscere tutte le conseguenze delle nostre azioni, la storia non sarebbe nient’altro che un intreccio armonico ed idilliaco di volontà libere o lo svolgersi infallibile di un disegno razionale. Così non faremmo altro che agire sempre razionalmente ovvero non agiremmo proprio dal momento che non faremmo altro che seguire uno schema sterile e prestabilito. In questo modo però non saremmo liberi. Ma noi siamo liberi, e questo significa letteralmente che non sappiamo quello che stiamo facendo”.
E’ importante notare che Chiaromonte riscontrava questa “hubris”, questa pericolosa “volontà di potere”, non solo all’interno di ideologie politiche rigide, ma anche nella fede dell’Occidente in un inevitabile progresso materiale, con relativo consumismo e feticismo tecnologico, e nel “culto dell’auto, della televisione e della prosperità derivata dalle macchine”. Questo modo di vivere si fonda su una visione molto impoverita dell’individuo come “animale completamente dedito alla soddisfazione dei propri appetiti e ad una illimitata autoesaltazione”. In un mondo di tal fatta, la cultura diventa “parte di una ricerca mortifera e automatica della novità”, con le persone che si muovono superficialmente “da una vanagloria all’altra, da sazietà a sazietà, di noia in noia”. Chiaromonte illustra l’alienazione con un esempio della vita di tutti i giorni: “L’immagine che più colpisce in questa inflazione egomaniacale dell’individuo prodotta dall’estensione indiscriminata del potere fisico nella società moderna è il volto di un uomo al volante. Tutto teso nello sforzo di sostenere il peso ed il prestigio del potere a sua disposizione, procede con arroganza a tutta velocità, prepotente e sprezzante di qualsiasi cosa lenta o ferma: ha tutto l’aspetto di un essere… soprannaturale”.
(Ci si può solo immaginare cosa direbbe oggi Chiaromonte delle nostre autostrade americane e dell’”inflazione egomaniacale” di automobilisti che sfrecciano aggressivi in Suv dopate “dominati” da cellulari e da stereo a tutto volume). Per contrastare questo clima di paura e di egoismo, Chiaromonte proponeva una cultura dell’umiltà, della proporzione, della limitazione, del “limite”, basata sul dialogo e sul rispetto reciproco. Altrimenti “diventiamo stranieri nella nostra società, niente più che unità numeriche all’interno di un calcolo trascendentale”.
- Nei suoi ultimi anni Chiaromonte si trovò in disaccordo, talvolta anche aspro, con i suoi amici americani, Macdonald e McCarthy, ma l’amore e l’amicizia fra loro non venne mai meno. Per esempio, criticò severamente Dwight Macdonald per quello che giudicò un appoggio insensato ai manifestanti della Nuova Sinistra alla Columbia University nel 1968. Mentre capiva la protesta contro un “Establishment” corrotto ed autocratico, Chiaromonte trovò le ribellioni studentesche di quell’anno “sterili” ed inconcludenti, troppo spesso caratterizzate da slogan insignificanti e gratificazioni immediate e che riproducevano il nichilismo delle istituzioni contro cui erano dirette. Ancora una volta si trattava di una questione di proporzioni, misura, limite. Chiaromonte paragonava il fermento nell’Europa dell’Est, che ammirava, ai sussulti messianici dell’Occidente. “La libertà che stanno chiedendo gli studenti polacchi è una sfida chiara e precisa ad un regime chiaramente oppressivo, mentre lo ‘scontro generale’ di cui parlano gli studenti italiani e tedeschi è una formula tanto generica quanto violenta”. Il “rifiuto totale” teorizzato da molti manifestanti costituiva per Chiaromonte una strada senza sbocco, “una ribellione contro tutto e contro nulla”.
Scrivendo a Mary McCarthy in questo periodo, Macdonald si preoccupava del crescente pessimismo del suo amico italiano; gli rimase comunque sempre fedele cadendo in una grande crisi personale quando, nel 1972, giunse notizia della sua morte improvvisa.
McCarthy giudicò significativo che da molti paesi, come da tutta la stampa italiana, giungessero tributi alla figura di Chiaromonte e che tutti sembrassero sinceri e spontanei, “solo qualcuno aveva un tono ufficiale e convenzionale”. Più tardi avrebbe concluso che le idee di Chiaromonte “non rientravano in alcuna categoria: non erano di destra né di sinistra. Non significava per questo che fosse di centro: era semplicemente se stesso”. E’ forse per una tragica ironia che proprio questo suo “essere se stesso”, questo rifiuto di seguire la massa, questa difficoltà ad “incanalare” il suo pensiero spiegano perché oggi ci sia una conoscenza così limitata della figura di Chiaromonte.
- Nicola Chiaromonte era un moralista e i suoi umanissimi istinti, il suo rifiuto delle ideologie assolute a favore di un’etica del “limite”, la sua voce dall’”ora zero” del trionfo fascista e della guerra mondiale ci possono parlare ancora oggi, in questo nuovo secolo di tecnologie pericolose, fedi messianiche (sacre e secolari) e di altri possibili “ground zero” ancora più devastanti di quello sperimentato dal mio Paese lo scorso settembre. Le sue idee sono particolarmente importanti per gli americani. Infatti, quali cittadini della superpotenza mondiale, dobbiamo agire con misura, proporzione e intelligenza anche di fronte al terrore. Dobbiamo evitare di rimanere intossicati dal nostro potere e di reagire incuranti delle nostre azioni. Dobbiamo rifiutarci, come disse Camus decenni fa, di essere o “vittime” o ” carnefici” e così diventare simili ai mostri contro cui combattiamo.
Chiaromonte, nonostante i tanti difetti, mantenne la sua fiducia nella “promessa” dell’America, suo rifugio in tempo di guerra, e le sue critiche, talvolta severe, vollero essere un contributo costruttivo alla lotta del paese per la propria identità, un tentativo di aiutare la sua gente a vivere per i propri ideali migliori, vera alternativa alla neo-imperialista pax americana. Come scrisse in una recensione di scritti di Macdonald per “L’Espresso”, nel 1970. “In termini politici si tratta di porre le basi di una nuova democrazia. Cosa che non sarà possibile se non si riuscirà a dare al gigantismo americano… una dimensione umanamente accessibile e controllabile”.
Il messaggio di Chiaromonte è senza tempo e noi lo ignoriamo a nostro rischio e pericolo.
Testo di Sumner Gregory tradotto da Enrica Casanova – 2006
Da: http://www.unacitta.it/newsite/altritesti
[1] Stokely Carmichael (1941-1998), originario di Trinidad, ma emigrato negli Stati Uniti giovanissimo, uno dei leader del Student Nonviolent Coordinating Comittee (Sncc), organizzazione impegnata nella promozione dei diritti civili degli afroamericani, inizialmente su posizioni integrazioniste, spostatosi via via su posizioni più radicali, espulso nel 1967 dallo stesso Sncc, assunse una notevole celebrità divenendo il portavoce del Black Panter Parthy, che, influenzato dal marxismo, oppose al principio della non violenza, proprio dell’azione di Martin Luther King, quello della autodifesa come strumento di lotta, teorizzando per i neri non già l’integrazione nella società bianca, ma il suo rifiuto e la conquista violenta del potere. (Nota del curatore)





























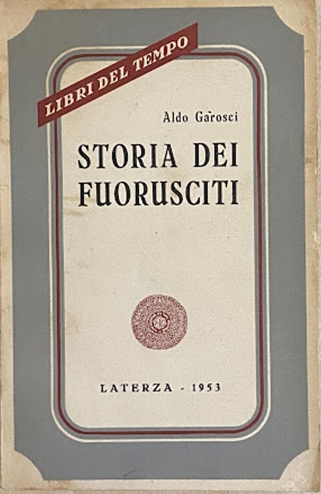





 Arrivava all’improvviso,
Arrivava all’improvviso,



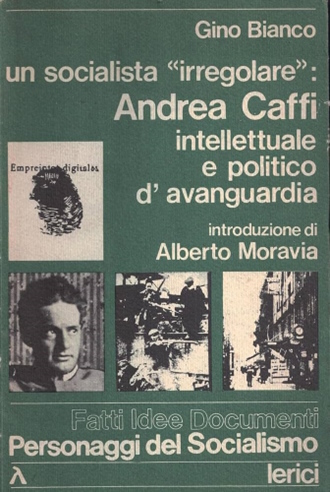



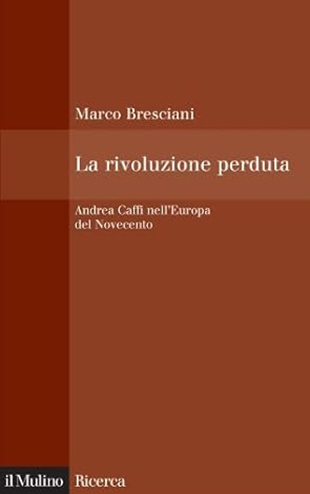






 Ordinare è un lemma dai molteplici significati, tutti assimilabili, tutti connessi alla stessa radice, sia pure a diversi gradi di parentela
Ordinare è un lemma dai molteplici significati, tutti assimilabili, tutti connessi alla stessa radice, sia pure a diversi gradi di parentela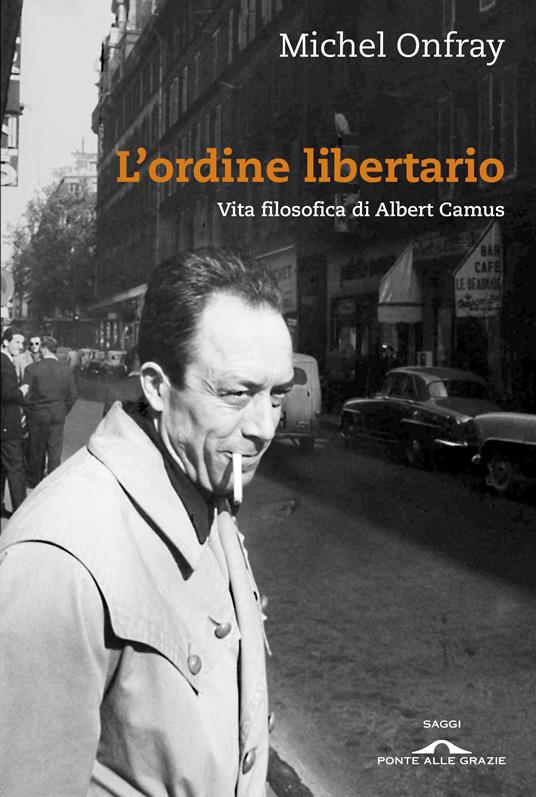 L’apparente chiasmo racchiuso in L’ordine libertario sintetizza, come dicevo, la mia concezione del mondo, degli uomini e dei loro rapporti coi loro simili e col mondo stesso. Quella ideale, naturalmente, di come questi rapporti dovrebbero essere, che non si oppone però alla consapevolezza di come le cose funzionino nella realtà. Non sono ancora così psichicamente turbato da credere in una reale possibilità di riordino del mondo, e da volerla. Ma penso sia importante, ai fini delle nostre scelte e del nostro agire, avere all’orizzonte un traguardo al quale le nostre azioni si ispirino, una direzione nella quale muovere. Sapendo tuttavia che l’orizzonte si sposta in avanti ad ogni passo che fai, e soprattutto che è importante, mentre cammini, tenere sott’occhio il paesaggio circostante e la terra su cui posi i piedi.
L’apparente chiasmo racchiuso in L’ordine libertario sintetizza, come dicevo, la mia concezione del mondo, degli uomini e dei loro rapporti coi loro simili e col mondo stesso. Quella ideale, naturalmente, di come questi rapporti dovrebbero essere, che non si oppone però alla consapevolezza di come le cose funzionino nella realtà. Non sono ancora così psichicamente turbato da credere in una reale possibilità di riordino del mondo, e da volerla. Ma penso sia importante, ai fini delle nostre scelte e del nostro agire, avere all’orizzonte un traguardo al quale le nostre azioni si ispirino, una direzione nella quale muovere. Sapendo tuttavia che l’orizzonte si sposta in avanti ad ogni passo che fai, e soprattutto che è importante, mentre cammini, tenere sott’occhio il paesaggio circostante e la terra su cui posi i piedi.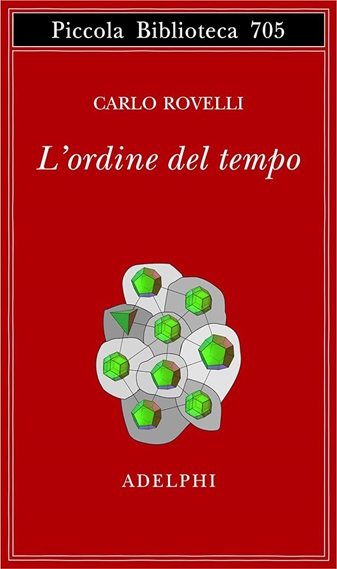 Questo sta accadendo. Rispetto a ciò, se fossi un rivoluzionario, cercherei di cambiare non solo l’ordine e la disposizione dei volumi, ma muterei radicalmente l’approccio coi libri, buttandomi sul supporto digitale. In questo modo guadagnerei, forse, in efficacia e in efficienza, ma perderei tutto quel valore aggiunto che il possesso e il rapporto fisico con il libro cartaceo mi garantisce. Sacrificherei alla praticità uno dei maggiori piaceri che la vita, nella dimensione dell’ordine culturale, può offrire.
Questo sta accadendo. Rispetto a ciò, se fossi un rivoluzionario, cercherei di cambiare non solo l’ordine e la disposizione dei volumi, ma muterei radicalmente l’approccio coi libri, buttandomi sul supporto digitale. In questo modo guadagnerei, forse, in efficacia e in efficienza, ma perderei tutto quel valore aggiunto che il possesso e il rapporto fisico con il libro cartaceo mi garantisce. Sacrificherei alla praticità uno dei maggiori piaceri che la vita, nella dimensione dell’ordine culturale, può offrire. Ma tutto questo, poi, all’atto pratico, in cosa si traduce? Per quanto mi concerne sono convinto che la mia vera attitudine fosse quella del correttore di bozze, o dell’editor, come si usa oggi (sto dicendo sul serio). Alla maniera di Sebastiano Timpanaro. Non “scrivere una storia” (o “la” storia)”, ma aiutarla a scorrere senza troppe frizioni. Sono però anche consapevole che difficilmente avrei potuto svolgere quella mansione, perché tendo ad allargarmi troppo: non mi sarei limitato a emendare i testi, ma avrei anche discusso della loro pertinenza nello specifico, o della loro opportunità in assoluto. Ho trasferito allora la mia coazione a correggere sulle sovrascritture che ciascuno di noi lascia, come traccia del suo passaggio, su quel testo indecifrabile che s’intitola “vita”.
Ma tutto questo, poi, all’atto pratico, in cosa si traduce? Per quanto mi concerne sono convinto che la mia vera attitudine fosse quella del correttore di bozze, o dell’editor, come si usa oggi (sto dicendo sul serio). Alla maniera di Sebastiano Timpanaro. Non “scrivere una storia” (o “la” storia)”, ma aiutarla a scorrere senza troppe frizioni. Sono però anche consapevole che difficilmente avrei potuto svolgere quella mansione, perché tendo ad allargarmi troppo: non mi sarei limitato a emendare i testi, ma avrei anche discusso della loro pertinenza nello specifico, o della loro opportunità in assoluto. Ho trasferito allora la mia coazione a correggere sulle sovrascritture che ciascuno di noi lascia, come traccia del suo passaggio, su quel testo indecifrabile che s’intitola “vita”. Un quasi gemello di Camus, Jean Paul Sartre, prima sodale del nostro e poi rancoroso rivale, ha scritto: “L’Uomo è condannato ad essere libero: condannato perché non si è creato da se stesso, e pur tuttavia libero, perché, una volta gettato nel mondo, è responsabile di tutto ciò che fa”.
Un quasi gemello di Camus, Jean Paul Sartre, prima sodale del nostro e poi rancoroso rivale, ha scritto: “L’Uomo è condannato ad essere libero: condannato perché non si è creato da se stesso, e pur tuttavia libero, perché, una volta gettato nel mondo, è responsabile di tutto ciò che fa”.

 Si trattava di una liturgia di approssimazione al Natale e durava appunto nove giorni, dal sedici dicembre alla vigilia: giorni nei quali si ripeteva puntuale al cessare dei rintocchi dell’Ave Maria, quindi mezz’ora dopo il tramonto. Tecnicamente non era che un’edizione speciale del rosario (mi sembra di ricordare si parlasse di “misteri gaudiosi”), che tuttavia, già solo per la crescente atmosfera di attesa – in fondo era un conto alla rovescia –, sembrava meno noiosa di quella normale: ma la celebrazione era poi resa spettacolare dal corollario dei canti natalizi e delle salmodie, e dalla scenografia. Una delle cappelle del transetto era occupata da un grande presepe, popolato di vecchie statuine che sembravano uscite dalla notte dei tempi e di casette tutte sbrecciate, e proprio per questo ancor più cariche di fascino: inoltre tutti e tre gli altari erano addobbati e la chiesa veniva illuminata quasi a giorno con un rinforzo di luci volanti. Per l’occasione don Bobbio non lesinava sulle spese, anche perché si rifaceva abbondantemente con una pioggia di elemosine. Lerma contava all’epoca, almeno fino a metà degli anni sessanta, più di mille abitanti, e alla Novena, complice anche la forzata sospensione dei lavori agricoli, partecipavano quasi tutti (nel coro, dietro l’altare, sedevano anche i vecchi socialisti come mio zio Micotto, col suo tabarro nero, e appoggiato al muro, subito fuori di uno degli ingressi secondari, vidi una volta persino Modesto, il mio dirimpettaio anarchico). Era un momento di eccezionale socialità, consentiva di rincontrarsi a persone che arrivavano dalle frazioni e magari non si vedevano da mesi. L’illuminazione inconsueta dava poi all’evento anche un carattere “mondano”, con le signore che si presentavano in spolvero invernale (quelle che potevano permettersi uno straccio di cappotto, ma si vedeva persino qualche pelliccia) e con gli sguardi comparativi che viaggiavano come raggi laser e si incrociavano da una parte all’altra della navata.
Si trattava di una liturgia di approssimazione al Natale e durava appunto nove giorni, dal sedici dicembre alla vigilia: giorni nei quali si ripeteva puntuale al cessare dei rintocchi dell’Ave Maria, quindi mezz’ora dopo il tramonto. Tecnicamente non era che un’edizione speciale del rosario (mi sembra di ricordare si parlasse di “misteri gaudiosi”), che tuttavia, già solo per la crescente atmosfera di attesa – in fondo era un conto alla rovescia –, sembrava meno noiosa di quella normale: ma la celebrazione era poi resa spettacolare dal corollario dei canti natalizi e delle salmodie, e dalla scenografia. Una delle cappelle del transetto era occupata da un grande presepe, popolato di vecchie statuine che sembravano uscite dalla notte dei tempi e di casette tutte sbrecciate, e proprio per questo ancor più cariche di fascino: inoltre tutti e tre gli altari erano addobbati e la chiesa veniva illuminata quasi a giorno con un rinforzo di luci volanti. Per l’occasione don Bobbio non lesinava sulle spese, anche perché si rifaceva abbondantemente con una pioggia di elemosine. Lerma contava all’epoca, almeno fino a metà degli anni sessanta, più di mille abitanti, e alla Novena, complice anche la forzata sospensione dei lavori agricoli, partecipavano quasi tutti (nel coro, dietro l’altare, sedevano anche i vecchi socialisti come mio zio Micotto, col suo tabarro nero, e appoggiato al muro, subito fuori di uno degli ingressi secondari, vidi una volta persino Modesto, il mio dirimpettaio anarchico). Era un momento di eccezionale socialità, consentiva di rincontrarsi a persone che arrivavano dalle frazioni e magari non si vedevano da mesi. L’illuminazione inconsueta dava poi all’evento anche un carattere “mondano”, con le signore che si presentavano in spolvero invernale (quelle che potevano permettersi uno straccio di cappotto, ma si vedeva persino qualche pelliccia) e con gli sguardi comparativi che viaggiavano come raggi laser e si incrociavano da una parte all’altra della navata. Lo erano anche, per le orecchie, i canti che partivano alle nostre spalle e i responsoriali che ci arrivavano da oltre la balaustra. Il fascino della novena era legato tutto a questi momenti corali. Per indisciplinati che fossero i coristi e le coriste lermesi (mia madre, che ambiva a voce guida, si lamentava immancabilmente delle sue concorrenti che tutte le sante sere partivano in anticipo, rovinandole l’effetto d’ingresso), i cantici natalizi che salivano assieme al fiato verso la volta a botte mi affascinavano: da quella scarsa disciplina addirittura ci guadagnavano, perché riuscivano genuini e spontanei (o forse li ha resi tali nel ricordo il confronto con la loro successiva degradazione a jingle pubblicitari).
Lo erano anche, per le orecchie, i canti che partivano alle nostre spalle e i responsoriali che ci arrivavano da oltre la balaustra. Il fascino della novena era legato tutto a questi momenti corali. Per indisciplinati che fossero i coristi e le coriste lermesi (mia madre, che ambiva a voce guida, si lamentava immancabilmente delle sue concorrenti che tutte le sante sere partivano in anticipo, rovinandole l’effetto d’ingresso), i cantici natalizi che salivano assieme al fiato verso la volta a botte mi affascinavano: da quella scarsa disciplina addirittura ci guadagnavano, perché riuscivano genuini e spontanei (o forse li ha resi tali nel ricordo il confronto con la loro successiva degradazione a jingle pubblicitari). È andata così. Ormai più che ventenne, rientrando da Genova, dove lavoravo e ogni tanto studiavo anche, vengo informato da mio padre che Pedru è in crisi nera. Il priore della confraternita era, come molti altri, un frequentatore assiduo del nostro negozio di ciabattino, segnatamente nei mesi invernali, e mio padre era un po’ il confidente di mezzo paese. Le prime sere della novena sono andate quasi deserte, persino nel coro un sacco di seggi sono rimasti vuoti. Non solo: il nuovo parroco gli ha anche imposto di dare un taglio ai salmi e di cantare solo quelli tradotti in italiano, liquidando quindi l’Omnes. Ho la conferma da mia madre: anche lei è avvilita, pur se rassegnata all’obbedienza (l’unica volta che io ricordi). Ci rimango male. Ho chiuso da un pezzo con la chiesa, e poi anche con la militanza gruppettara, ma sono sempre in cerca di buone cause per le quali battermi. Ne parlo con gli amici, che dapprima la mettono in ridere, poi, quando capiscono che faccio sul serio, si lasciano convincere: parteciperemo in gruppo alla novena, riempiremo i vuoti del coro e daremo una mano a Pedru a far nascere Gesù anche quest’anno. Ma non basta, mi spingo oltre: vado a patteggiare col parroco la nostra presenza contro la concessione di cantare anche in latino, almeno per le ultime serate, i due salmi.
È andata così. Ormai più che ventenne, rientrando da Genova, dove lavoravo e ogni tanto studiavo anche, vengo informato da mio padre che Pedru è in crisi nera. Il priore della confraternita era, come molti altri, un frequentatore assiduo del nostro negozio di ciabattino, segnatamente nei mesi invernali, e mio padre era un po’ il confidente di mezzo paese. Le prime sere della novena sono andate quasi deserte, persino nel coro un sacco di seggi sono rimasti vuoti. Non solo: il nuovo parroco gli ha anche imposto di dare un taglio ai salmi e di cantare solo quelli tradotti in italiano, liquidando quindi l’Omnes. Ho la conferma da mia madre: anche lei è avvilita, pur se rassegnata all’obbedienza (l’unica volta che io ricordi). Ci rimango male. Ho chiuso da un pezzo con la chiesa, e poi anche con la militanza gruppettara, ma sono sempre in cerca di buone cause per le quali battermi. Ne parlo con gli amici, che dapprima la mettono in ridere, poi, quando capiscono che faccio sul serio, si lasciano convincere: parteciperemo in gruppo alla novena, riempiremo i vuoti del coro e daremo una mano a Pedru a far nascere Gesù anche quest’anno. Ma non basta, mi spingo oltre: vado a patteggiare col parroco la nostra presenza contro la concessione di cantare anche in latino, almeno per le ultime serate, i due salmi.
 Il tema ormai ricorre costantemente in ciò che scrivo, e riguarda il mondo che abbiamo perduto. Riguarda cioè la domanda se davvero abbiamo perduto qualcosa di speciale, se la nostra, intendo di quelli della mia età, è una “delusione ottica” dettata dai personali rimpianti, o se la perdita è stata invece oggettiva. La domanda è meno stupida di quanto appare, perché se è vero che da Adamo in avanti ogni generazione ha lamentato i cambiamenti che la mettevano fuori gioco, è altrettanto vero che nessuna prima della nostra ha assistito a trasformazioni tanto rapide e tanto radicali. Neppure le generazioni che si sono trovate a vivere rivoluzioni, riforme religiose, cadute di imperi, hanno mai visto così scombussolate nel profondo le modalità quotidiane dell’esistere e dei rapporti, le dimensioni degli orizzonti, le aspettative, le sicurezze e le paure. Se il nonno di Romolo Augustolo o quello di Robespierre fossero tornati in vita dopo mezzo secolo avrebbero trovato un mondo cambiato, e probabilmente non sarebbero stati d’accordo su quasi nulla: ma sarebbero stati comunque in grado di capirlo, questo nulla, di vederlo nella sua negatività. Mio nonno, tornasse in vita oggi, non saprebbe da che parte girarsi, non potrebbe nemmeno essere in disaccordo perché non saprebbe con chi e per cosa esserlo.
Il tema ormai ricorre costantemente in ciò che scrivo, e riguarda il mondo che abbiamo perduto. Riguarda cioè la domanda se davvero abbiamo perduto qualcosa di speciale, se la nostra, intendo di quelli della mia età, è una “delusione ottica” dettata dai personali rimpianti, o se la perdita è stata invece oggettiva. La domanda è meno stupida di quanto appare, perché se è vero che da Adamo in avanti ogni generazione ha lamentato i cambiamenti che la mettevano fuori gioco, è altrettanto vero che nessuna prima della nostra ha assistito a trasformazioni tanto rapide e tanto radicali. Neppure le generazioni che si sono trovate a vivere rivoluzioni, riforme religiose, cadute di imperi, hanno mai visto così scombussolate nel profondo le modalità quotidiane dell’esistere e dei rapporti, le dimensioni degli orizzonti, le aspettative, le sicurezze e le paure. Se il nonno di Romolo Augustolo o quello di Robespierre fossero tornati in vita dopo mezzo secolo avrebbero trovato un mondo cambiato, e probabilmente non sarebbero stati d’accordo su quasi nulla: ma sarebbero stati comunque in grado di capirlo, questo nulla, di vederlo nella sua negatività. Mio nonno, tornasse in vita oggi, non saprebbe da che parte girarsi, non potrebbe nemmeno essere in disaccordo perché non saprebbe con chi e per cosa esserlo.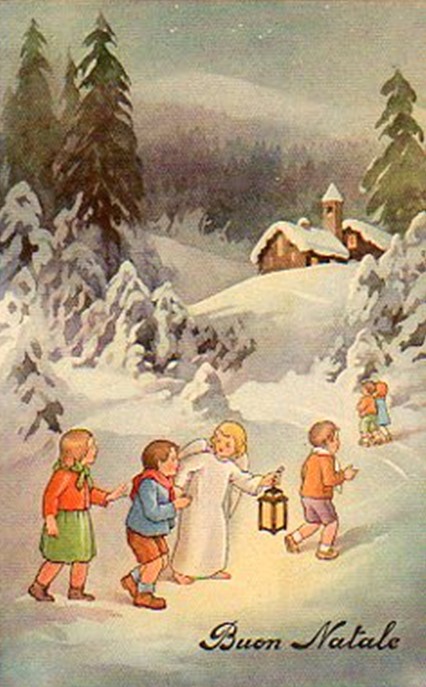 Questo, con un po’ di buona volontà, lo si può ancora fare. E in qualche misura dobbiamo farlo noi, che la “possibilità” di una scuola diversa l’abbiamo conosciuta, e che a quella scuola diversa dobbiamo in fondo l’essere qui oggi a parlarne. Ma non lo dobbiamo solo a quella scuola: lo dobbiamo anche a quelle Novene, o almeno, allo spirito col quale le abbiamo frequentate.
Questo, con un po’ di buona volontà, lo si può ancora fare. E in qualche misura dobbiamo farlo noi, che la “possibilità” di una scuola diversa l’abbiamo conosciuta, e che a quella scuola diversa dobbiamo in fondo l’essere qui oggi a parlarne. Ma non lo dobbiamo solo a quella scuola: lo dobbiamo anche a quelle Novene, o almeno, allo spirito col quale le abbiamo frequentate.


