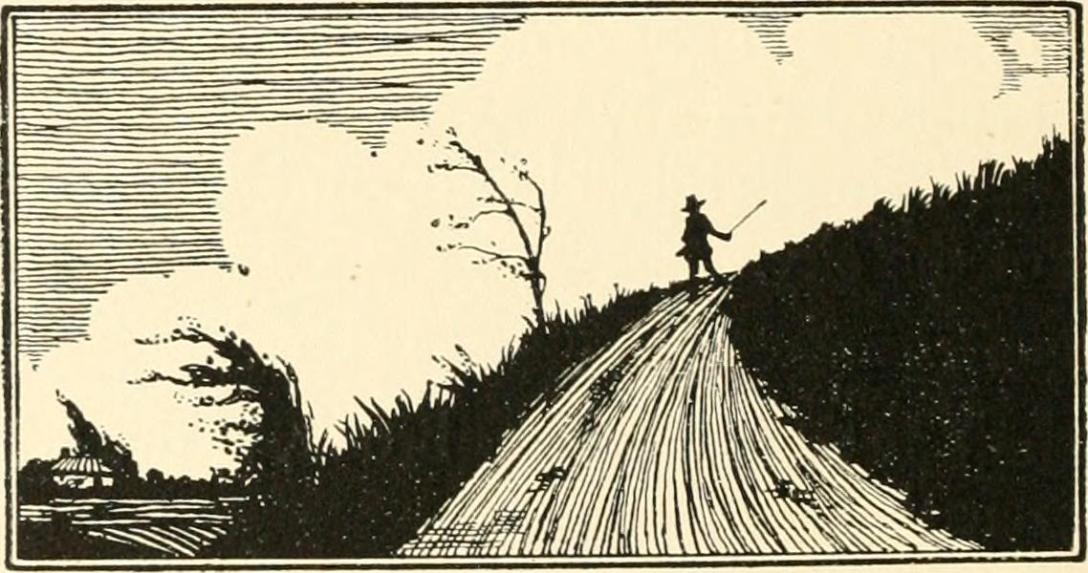Un’introduzione alla storia dell’alpinismo
di Paolo Repetto,28 febbraio 2012
A Franco, capocordata da sempre
Ad Augusta, a Stefano e a Giorgio,
portatori sani del virus della montagna
Quella che segue non è una storia dell’alpinismo. È un abbozzo di storia del rapporto fisico e spirituale intrattenuto dall’uomo con le montagne, con particolare riferimento al XIX secolo. Come tale è ben lungi dal pretendere di essere esaustivo: anzi, l’intento era quello incuriosire, di offrire degli “assist” per approfondimenti che poi ciascuno porterà avanti come vuole. Spero di esserci almeno in parte riuscito, e soprattutto di non annoiare gli amici che vorrebbero raccoglierli.

E vanno gli uomini
Ri-scoperta e riappropriazione
L’assalto alla montagna
Finalmente in vetta
La montagna romantica
La montagna dipinta
La montagna illustrata
La montagna colonizzata
Mondi e monti lontani
Penne e piccozze
La guerra nell’Alpe
La guerra con l’Alpe
La morte dell’impossibile
Scendere a valle
Salire. Bibliografia essenziale per una letteratura dell’alpinismo
STORIA DELL’ALPINISMO
STORIA E ANTROPOLOGIA DELLA MONTAGNA
MONOGRAFIE SULLE PRINCIPALI VETTE
FILOSOFIA ED ETICA DELL’ALPINISMO
LETTERATURA ED ESTETICA DELL’ALPINISMO
BIOGRAFIE DI ALPINISTI
CLASSICI DELLA LETTERATURA ALPINISTICA
LETTERATURA ALPINISTICA MODERNA
NARRATIVA

E vanno gli uomini …
Amo di folle amore i monti fieri e sublimi!
[…] Non producono niente, sono inutili:
son solo belli, e la bellezza è un nulla
Ma io li amo più dei campi grassi e fertili
Ma lontani dal cielo – dove Dio non si vede.
Th. Gautier
Non si può chiudere questo racconto di viaggi, scoperte ed esplorazioni senza accennare a un risvolto solo apparentemente marginale: la conquista delle vette alpine[1]. È una vicenda particolare, rappresentativa di una estremizzazione, individuale o collettiva, dello spirito errabondo e conquistatore dal quale abbiamo preso l’avvio: ma esemplifica e testimonia anche la subordinazione progressiva della curiosità originaria a logiche economiche, strategiche e politiche che ne snaturano l’“innocenza”.
Mi soffermo su questa vicenda – anche se altrettanto significative, sia pure con ricadute diverse, potrebbero essere considerate l’esplorazione degli abissi marini, la corsa ai poli e la gara per lo spazio – intanto perché è maggiormente legata al periodo trattato nella mia narrazione, e poi perché quelli montani sono rimasti gli unici spazi abbordabili da tutti, nei quali il confronto con la natura ha conservato molte caratteristiche invariate; nei quali cioè quello spirito della sfida, ma anche della scoperta e della conquista, dal quale siamo partiti, ha ancora modo in qualche misura di esprimersi.
Questo a dispetto del fatto che l’interesse per la montagna e per la sua esplorazione non sia un carattere biologicamente radicato, e nemmeno si possa dire sia stato “storicamente” acquisito molto presto[2]; è piuttosto un portato della modernità, anche se non mancano le testimonianze di ascensioni impegnative affrontate in età medioevale o prima ancora in quella classica[3]. Vale il solito discorso: si possono retro-datare all’infinito i sintomi o gli indizi di una rivoluzione negli atteggiamenti mentali, ma in tal modo si forza il significato di avvenimenti occasionali e si perde di vista la novità prodotta dalla trasformazione.
In effetti, nella prima lunga fase di nomadismo che ha portato la specie umana a popolare tutti i continenti, e che in sostanza si è protratta sino al basso medioevo, le catene montuose non sono mai state considerate come mete: erano piuttosto degli ostacoli. Non si cercava la vetta, ma il valico. Gli storici antichi, da Erodoto a Strabone, ci raccontano drammatiche traversate di passi impervi piuttosto che epiche scalate. Lo scopo di eserciti, carovane commerciali, popoli migranti, pellegrini o viaggiatori solitari non era salire le montagne, ma lasciarsele alle spalle, compiendo rituali propiziatori prima di affrontarle e ringraziando per lo scampato pericolo dopo averle superate. Tutti i popoli dell’antichità, in qualsiasi parte del globo, hanno da sempre consacrato le vette a dimora della divinità (l’Olimpo, il Sinai, il Fuji, il Kailash, ecc.), per motivi facilmente intuibili, che vanno dalla maestà del paesaggio al mistero dell’ignoto, dal timore nei confronti di ciò che appare immensamente grande al fascino di cime che si nascondono tra le nubi e sembrano attingere, nel senso proprio di toccare, ad un’altra dimensione: e comunque ne vietavano la frequentazione agli umani. L’ostilità degli elementi, il pericolo costante e la difficoltà di sopravvivere alle alte quote costituivano già di per sé un notevole deterrente[4]: fino a tutto il XVI secolo i resoconti atterriti dei viaggiatori che valicano i passi alpini, da Benvenuto Cellini a Montaigne, da Francesco di Sales a John Evelyn, ci parlano solo dello spavento indotto dalle valanghe e dai crepacci. Ma la deterrenza veniva rafforzata e in qualche modo resa accettabile dalla superstizione. In tal senso, anche quando nel passaggio occidentale dall’età classica al medioevo il rapporto con la montagna ha cambiato nettamente segno, e le vette e tutto l’ambiente montano si sono popolati di presenze demoniache e le interdizioni si sono moltiplicate, si è rimasti nell’ambito del sacro: le divinità erano in fondo le stesse, anche se rilette in negativo dal monoteismo cristiano.
La salita in vetta costituiva comunque una “profanazione”, un gesto presuntuoso e sacrilego, sia in Oriente o nell’Occidente classico, dove si esigeva una devota reverenza per la dimora della divinità, sia nell’Occidente cristiano, che scorgeva in ogni dirupo e anfratto un ricettacolo di demoni e di mostri. Questo sacro timore finiva per investire, rovesciandosi in disprezzo, anche coloro che le montagne le abitavano, con le rare eccezioni riservate agli asceti o agli eremiti. I montanari sono stati bollati in tutte le epoche e nelle diverse aree come rozzi e primitivi, in qualche caso come subumani[5]: e le leggende relative all’uomo selvatico, universalmente presenti dalle Alpi alle Ande all’Himalaya, documentano la diffusione e la persistenza della considerazione negativa. Proprio tra queste genti, tra l’altro, che pure con la montagna e le sue insidie e i suoi misteri avevano maggiore dimestichezza, le superstizioni erano particolarmente diffuse: lungo tutto l’arco alpino sono centinaia i toponimi che rimandano alla presenza di giganti, di streghe, di draghi o di enormi serpenti, quando non addirittura del Diavolo in persona, magari esiliato nelle “ghiacciaie” per liberare i valichi (come accade ad esempio nel caso di San Bernardo e del passo omonimo), e tutto il massiccio del Monte Bianco era conosciuto fino al Settecento dai valligiani come “Montagnes Maudites”.
Ciò non toglie che vadano immaginati tra questi anche i primi salitori delle vette, trascinati dai lunghi inseguimenti di caccia o dalla ricerca di cristalli, o magari da rituali pagani sopravvissuti sotto le specie del folklore e del gioco.
Oltre alle interdizioni religiose, nel medioevo hanno senz’altro contribuito ad una particolare disaffezione nei confronti della montagna anche i cambiamenti climatici: l’irrigidimento del clima verificatosi tra il IX e il XIV secolo ha esteso i ghiacciai e resa decisamente più dura la vita oltre una certa altitudine[6]. In quest’epoca quindi, più che mai, e in Europa a differenza di quanto accade nelle altre parti del mondo[7], alle montagne vengono associati il male, il mistero e l’orrore, e la frequentazione delle zone che si trovano al di sopra dei limiti naturali della caccia o del legnatico viene letta non solo come un atto di sfida inutile e fine a se stesso, ma anche come un segnale di inclinazioni malefiche.
Se l’età medioevale sostituisce il demoniaco al divino, la vera e propria “desacralizzazione”, ovvero la sottrazione della montagna alla sfera religiosa, positiva o negativa che sia, e l’instaurazione di un rapporto se non laico, perché quello con la montagna non è mai tale, almeno disincantato, sono invece molto più tardi: occorre attendere l’età moderna[8].
Il primo alpinista moderno, sia pure solo in ispirito, è tuttavia un uomo medioevale. È Francesco Petrarca. L’aretino non compie una grande impresa: il Mont Ventoux, sul quale sale nel 1336, è in realtà un panettone dalla cima spelacchiata; l’ascesa è solo una lunga camminata, disturbata in prossimità dalla vetta da uno sferzante mistral. Ma è lo spirito quello che conta. Petrarca sale per il piacere di salire, di arrivare in vetta e di guardarsi attorno da lassù: “oggi, spinto solo dal desiderio di vedere un luogo celebre per la sua altezza […]”[9]. Non ha la presunzione di “vincere” la montagna, perché si rende conto benissimo che la scalata è alla portata di tutti. Semmai vuole vincere la propria pigrizia, quella disposizione melanconica e inibente che chiama “accidia”, e che si nutre, a proprio alibi, anche dei tabù. Un pastore che lo incontra alle prime pendici del monte gli racconta di essere salito da giovane in vetta, e cerca di dissuaderlo: “ma cosa ci vai a fare? In cima non c’è niente”. E invece il Petrarca sulla cima trova se stesso, trova un significato proprio nello sforzo che si è imposto per violare un tacito divieto interiore. Nella lettera-relazione a Dionigi da Borgo San Sepolcro si affretta poi a rinnegare questo impulso, a deprecare la vanità delle aspirazioni umane: cita il celebre passo di Agostino ([…] e vanno gli uomini a contemplare le cime dei monti, i vasti flutti del mare, […] e trascurano se stessi) e cerca una giustificazione nel desiderio di approssimarsi di qualche metro a Dio. Ma la realtà è un’altra. Petrarca sa di aver compiuto un gesto di ribellione, di autonomia: ne ha un po’ paura, ma è arrivato comunque in vetta, e soprattutto lo racconta, lasciandoci il primo resoconto alpinistico della storia, inaugurando un genere e, con largo anticipo, una tendenza.
Dopo Petrarca, gli episodi di ascensioni testimoniate, alcune anche di difficoltà tecniche non indifferenti, si infittiscono, già a partire dall’ultima parte del medioevo. Le motivazioni sono le più disparate: può trattarsi di una pratica mistica o penitenziale (la salita nel 1368 di Bonifacio Rotario, che porta sulla vetta del Rocciamelone un trittico di bronzo), di un espediente militare (la traversata invernale del Kimmler Tauern compiuta da Rodolfo IV d’Austria nel 1363), di una curiosità estetico-scientifica (l’ascesa di Leonardo da Vinci al monte Bo), o di un gesto politico (la volontà di affermare un possesso integrale, fisico, e non solo teorico, del territorio sul quale si ha giurisdizione: la scalata del Mont Anguille, nel Delfinato, ordinata da Carlo VIII ad Antoine de Ville, nel 1492). Ma lo spirito dell’esplorazione fine a se stessa, quello per intenderci anticipato da Petrarca, è più tardo: si affermerà solo col Romanticismo. Per intanto la dissacrazione passa invece per un’altra via, quella della “riscoperta” scientifica della terra.
Ri-scoperta e riappropriazione
Nel 1555 Conrad Gessner, un naturalista svizzero, intraprende come gesto esplicito di sfida l’ascensione al monte Pilatus, vicino a Lucerna: va a gettare pietre in un lago che si riteneva abitato da draghi e da spiriti maligni[10]. Gessner è indubbiamente mosso dallo spirito antisuperstizioso della Riforma, ma è anche uno che scrive: “asserisco che è nemico della natura colui che non reputa le alte montagne degne di studio”. E, soprattutto, che quando aggiunge: “Le regioni più alte delle più elevate vette sembrano essere al di sopra delle leggi che regolano il mondo sottostante, quasi appartenessero ad una sfera diversa[11]” intende dire che le leggi fisiche operano in maniera diversa: la neve che sfida i raggi del sole, l’aria che è più limpida e rarefatta, i colori, la temperatura, ecc… Si apre un campo nuovo all’indagine, e non c’è posto per i draghi. Un amico di Gessner, Benedikt Marti, nella sua Courte description du Stockhorn et du Niesen (1557), oltre a ribadire la bellezza del paesaggio, la religiosità del silenzio, la salubrità dell’aria e dello stile di vita, arriva a proclamare la superiorità “civica” dell’uomo di montagna. Concetti analoghi sono rintracciabili in un poema del francese Jacques Peletier, La Savoye, del 1572. La montagna è innanzitutto il luogo della libertà, nel quale lo spirito può distendersi e spaziare: “Luoghi isolati, altezze vertiginose / gelidi paesaggi e sentieri gibbosi / Là dove, quanto più lo sguardo si trova prigioniero / più trova spazio e trova libertà”[12].
Lo stesso spirito anima pochi anni dopo (1574) il “De Alpibus commentarius” di Josias Simler, altro svizzero, professore di esegesi neotestamentaria a Zurigo, che fornisce una descrizione storico-geografica di tutta la catena alpina. Simler dedica molta attenzione anche alle tecniche e ai problemi degli spostamenti in montagna, dando l’avvio ad una ricognizione, e quindi ad una secolarizzazione sistematica, del territorio, sia pure nei limiti di una conoscenza che è agli esordi: paradossalmente, infatti, in tutta la sua opera non viene mai citato il monte Bianco. È caduto un tabù, e se anche nel Seicento l’attenzione per il mondo alpino rallenta, perché una nuova repentina glaciazione prodottasi verso la fine del XVI secolo[13] si somma alle condizioni generali di insicurezza politica create dalla guerra dei Trent’anni e rende meno facili e frequenti gli spostamenti, la strada è ormai aperta. Sotto l’azione combinata della Riforma e della Controriforma, che mirano a sradicare ogni residuo di paganesimo superstizioso, delle scienze naturali che cercano di dare spiegazione dei fenomeni di cui parlava Gessner, e in particolare della nascente geologia, che proprio dallo studio delle rocce trae gli elementi per dilatare la profondità temporale del mondo, viene rimossa la patina protettiva di sacralità e si avvia la domesticazione delle cime.
La geologia come autonoma scienza della terra, svincolata da idee precostituite e da principi primi costitutivi dell’universo e dotata di metodi d’indagine propri, basati sull’esperienza in campo aperto e di ricerca sul terreno, nasce da un viaggio, da una fascinazione e da uno scarto[14]. Il viaggiatore è Thomas Burnet, un ecclesiastico inglese che compie nel 1671 il suo Grand Tour continentale, rimane affascinato dalle Alpi ed elabora sulla scorta di quell’esperienza una singolare teoria orogenetica, che viene enunciata nella Telluris theoria sacra del 1681. Secondo Burnet la terra era in origine perfettamente liscia e pianeggiante, e gli attuali rilievi e cicatrici, monti e fiumi, baratri e precipizi sono il risultato di una immane inondazione provocata dalla rottura della crosta terrestre. La terra non è dunque che un rozzo ammasso di rovine, un mondo in pezzi: ma proprio questo sfacelo è testimonianza della potenza divina.
Al di là della scontata conclusione, la teoria di Burnet contiene degli elementi di rivoluzionaria novità, soprattutto se confrontata con i Principia di Newton, apparso sei anni dopo, e con i cartesiani Principia Philosophiae di quarant’anni prima. Rispetto a entrambi, che trattavano il “problema montagne” (in sostanza: come si concilia il loro disordine con un cosmo perfettamente regolato da leggi eterne e immutabili? perché ci sono, a dispetto di un ordine universale che non le prevede?) da un punto di vista teorico-matematico, come variabili da far rientrare nel quadro ordinato di una lettura meccanicistica del mondo, e lo liquidavano o riconducendo la singolarità, l’irregolarità e la diversità dei fenomeni ad astratti modelli teorici, o attribuendole sbrigativamente ad atti divini non necessitanti di spiegazione, il vescovo inglese introduce il fattore “disordine”. Le montagne scompigliano il quadro, e non possono essere considerate solo un elemento di disturbo nella teoria, ma ne costituiscono addirittura la chiave. La rottura d’equilibrio postulata da Burnet all’origine della loro formazione, pur fissando la terra al momento in cui si era svolto l’evento catastrofico, ha il merito rispetto alla concezione di Newton di immettere comunque un cambiamento: è in qualche modo, molto timidamente, una storicizzazione. Le montagne sono riscoperte “nel tempo” e quel tempo non è ciclico, non è costituito dal ripetersi di eventi simili, ma lineare, profondo, irreversibile. Ciò che da Bacone in poi valeva per la storia umana, vale ora anche per quella naturale.
Ma c’è dell’altro: una concezione simile non può essere finalistica. Il mondo è un ammasso di rovine, non un’armoniosa costruzione. La potenza divina non opera necessariamente “al servizio” del mondo, finalizzata alla sua stabilità e al suo ordine: anzi, al contrario nel tempo la terra attraversa successive metamorfosi e alterazioni, ma il prodotto finale di ogni fase sono appunto solo rovine. Per capire tutto questo (Burnet non lo dice, ma lo pensa) le montagne bisogna vederle, conoscerle da vicino. Bisogna provare quello strano, contradditorio sentimento insieme di entusiastica attrazione e di fantastico terrore che fa dimenticare ogni estetica delle simmetrie per spingerti verso quella delle rovine.
Il nuovo concetto di “tempo della natura”, inconsapevolmente introdotto da Burnet nel momento in cui lo sgancia da quello umano, è comunque già maturo al momento della comparsa della Theory. Una dozzina di anni prima il danese Nicola Stenone ha fatto scandalo proponendo nei Prodomi[15] una lettura dell’origine dei fossili che prende spunto proprio dallo studio delle montagne. Ciò che si rinviene negli strati calcarei messi a nudo dalle frane o dall’erosione non sono giochini artistici cui si è abbandonato Dio, ma testimonianze di forme di vita antichissime, molte delle quali definitivamente scomparse, depositatesi nell’arco di tempi lunghissimi nei fondali marini e sollevate poi dai movimenti tellurici. Stenone è immediatamente costretto dalla reazione della chiesa danese a ritrattare le sue idee, ma queste vengono riproposte quasi contemporaneamente dall’inglese Hooke, e con diverso successo. Anche se ufficialmente, almeno sino ai primi dell’ottocento, la datazione dell’antichità del mondo rimarrà quella stabilita nel 1650 dal vescovo Ussher (per l’esattezza, il mondo è stato creato 4004 anni prima della nascita di Cristo)[16], di fatto gli studiosi, soprattutto quelli che come Burnet hanno l’occasione di un approccio diretto con le formazioni montuose più giovani, cominciano a pensare in termini di tempi ben più profondi. Nel 1695 Woodward pubblica il Saggio sopra la storia naturale della terra[17], col quale intende confutare l’ipotesi “catastrofista” di Burnet: ma nel farlo finisce a sua volta per mettere implicitamente in discussione il computo basato sulla interpretazione letterale della Bibbia.
Queste intuizioni sfoceranno, alla fine del secolo successivo, in due teorie orogenetiche contrapposte, il nettunismo di Werner e il plutonismo di Hutton. In questo dibattito lo studio delle montagne farà la parte del leone e fornirà la chiave interpretativa di tutta la storia della terra[18]: per il momento però importa cogliere un altro nuovo portato dell’approccio di Burnet. Lo scienziato deve andare alla montagna, se vuole comprendere davvero il senso profondo. Deve quindi farsi esploratore, e l’esplorazione, oltreché geografica, si fa storica. Nasce una nuova figura, quella del naturalista-viaggiatore, che si applica ad una indagine non più solo orizzontale, di superficie, ma verticale, di profondità e di altitudine, e quindi storica. Lo stesso Woodward pubblica nel 1696 un manualetto contenente Brevi istruzioni per fare osservazioni in ogni parte del mondo[19], nel quale si spiega cosa osservare, come e con quali strumenti. Ci aveva già pensato più di un secolo prima Bacone, e lo faranno cinquant’anni dopo anche Linneo, con l’Instructio peregrinatoris[20], e in Italia Lazzaro Spallanzani. Nel 1849 verrà pubblicato in Inghilterra addirittura un volume collettaneo di istruzioni, affidato per le diverse discipline ai più eminenti protagonisti degli studi scientifici, da John Herschel per l’astronomia a Hooker per la botanica, a Richard Owen per la zoologia. Lo stesso Darwin redige la parte relativa alla geologia. In tutte queste opere uno spazio sempre più considerevole, mano a mano che i protocolli delle diverse scienze si definiscono, è riservato alla vulcanologia e all’orogenetica.
L’assalto alla montagna
Il vero e proprio assalto alle vette scatta nel Settecento, ed è preceduto nella prima parte del secolo da un totale ribaltamento nella percezione del paesaggio montano: da luoghi del maleficio e del proibito le montagne si avviano a diventare gli scenari ideali di un più genuino rapporto con la natura, e conseguentemente, tra gli uomini. I fattori che concorrono al mutamento radicale di prospettiva sono svariati e complessi, e hanno incidenza diversa rispetto alle diverse culture. Alcuni sono di ordine squisitamente pratico, legati ad esempio all’opera di rilevazione cartografica del territorio avviata dai sovrani, in particolare da Luigi XIV e dal suo ministro Colbert, a fini amministrativi, strategici e fiscali. A cavallo tra il Sei e il settecento l’area alpina sud-occidentale è aspramente contesa tra la Francia e il Ducato di Savoia, con gli Svizzeri partecipi e preoccupati spettatori: risale a questo periodo la costruzione dei più importanti sistemi di fortificazione dei valichi e delle cime (da Fenestrelle a Exilles). La conoscenza del territorio si rivela in tal senso determinante: nella battaglia dell’Assietta i francesi perdono 6.000 uomini perché non hanno idea della conformazione del terreno dello scontro. Pur non comportando di per sé alcun coinvolgimento emozionale, la ricognizione “strategica” delle montagne contribuisce fortemente a laicizzarne l’immagine e ad abbattere i residui tabù psicologici e fisici (ad esempio, quello della impossibilità di sopravvivenza per lunghi periodi alle alte quote).
C’è poi il crescente successo della Svizzera (soprattutto di Ginevra) nella considerazione da parte dell’opinione pubblica (prima inglese e poi francese e germanica), che con effetto alone si allarga successivamente a tutta la zona alpina. I monti che fanno corona ai laghi e alle piccole e virtuose comunità calviniste sembrano preservare queste ultime dagli influssi negativi del resto del continente, appaiono come un baluardo della purezza religiosa e della libertà politica. E conseguentemente, con il diffondersi della moda del Grand Tour, che sguinzaglia in giro per l’Europa e porta a contatto con le Alpi i giovani irrequieti rampolli delle classi dominanti inglesi, le montagne vere, il regno delle nevi eterne, sono visti con uno sguardo nuovo, curioso e disincantato.
I viaggiatori d’oltremanica colgono dell’ambiente montano l’aspetto pittoresco, attraverso una percezione sentimentale che è stata educata lungo il XVII secolo dalla disposizione “libertina” nei confronti del nuovo e del diverso: quella che fa scrivere ad Addison, che inaugura idealmente nel 1701 l’elenco dei nuovi pellegrini settecenteschi, che le Alpi “sono interrotte da così tanti salti e precipizi da riempire la mente di una gradita forma di orrore e costituire uno degli scenari più irregolari e disarmonici della terra”[21]. Si fa strada il sottile e ambiguo piacere dell’orrido. Addison stesso fa riferimento peraltro alle impressioni di un “gradevole stupore della mente” riportate dai viaggiatori che lo avevano preceduto negli ultimi anni del ‘600, come il vescovo Burnet o il letterato John Dennis (“Ho la sensazione di essere transitato, in senso letterale, sull’orlo della distruzione. La percezione di ciò produsse in me […] un delizioso orrore, una terribile gioia, e godendone immensamente, al tempo stesso tremavo”). Ma è lui a fissare lo stereotipo che informerà per tutto il secolo le lettere e i resoconti di viaggio dei “touristes” britannici, a prescindere dalla direzione che daranno alle loro impressioni. Thomas Gray riconcilierà il paesaggio alpestre con la presenza divina, alla maniera di Burnet (“ci sono scenari che indurrebbero un ateo a credere senza bisogno di altri argomenti”), mentre a Lady Montague “l’aspetto prodigioso delle montagne coperte di nubi eterne, le nubi sospese sotto i piedi […]”, tutto ciò sembrerà “solenne e dilettevole”. Il tutto mitigato appena da un realistico appunto, molto femminile: “se avessi sofferto meno per il freddo”.
La contemplazione meravigliata non tarda però a lasciare il posto all’azione esplorativa. Quattro decenni dopo Addison una bizzarra pattuglia di giovani scavezzacollo britannici, guidati da un aristocratico cultore della boxe, William Windham, e da un ricco borghese giramondo, Richard Pococke, spediti sul continente dalle rispettive famiglie per tenerli lontani dai guai, invece di limitarsi ad ammirare le Alpi dalle sponde del Lemano sale a calpestare le “nevi eterne”. Sfidando lo scetticismo dei valligiani guadagnano la Mer de Glace, scendono sul ghiacciaio e a dispetto dello spirito da bravata che li anima aprono la strada all’esplorazione vera e propria. Già l’anno successivo infatti la loro spedizione è ripetuta da uno studioso ginevrino decisamente più serio, Pierre Martel, che sale con lo scopo preciso di studiare la struttura del ghiacciaio e di fornirne una descrizione scientifica. Martel incarna un’ulteriore motivazione, quella fornita dal crescente interesse per la glaciologia, sia in rapporto alle controversie scientifiche di cui faremo cenno sia in ragione di un fenomeno, quello dell’avanzata dei ghiacciai, che aveva assunto una tangibile e preoccupante rilevanza pratica, dopo che nel 1712 un intero villaggio era stato inghiottito, con i suoi abitanti, da un improvviso sommovimento ed altri erano stati frettolosamente abbandonati.
Queste due ascensioni, delle quali lo stesso Martel pubblica più tardi a Londra una relazione congiunta (1742)[22], sono significative del duplice percorso lungo il quale si svilupperà d’ora innanzi l’approccio con la montagna. Quello britannico, “umanistico” e curioso prima, sportivo e avventuroso poi; e quello continentale, o franco-svizzero, scientifico e filosofico. Windham e Pococke salgono armati di pistole, pugnali e bottiglie di buon vino, e una volta sul ghiacciaio si divertono a saltare i crepacci; Martel è accompagnato da un pittore e da un biologo, si porta dietro un barometro, col quale calcola l’altitudine e i dislivelli, compie osservazioni naturalistiche, esegue rilievi topografici e abbozza una classificazione geografica delle cime circostanti il mare di ghiaccio, oltre a darne una prima rappresentazione iconografica.
La “seriosità” dell’approccio continentale si riscontra anche nei suoi esiti letterari e filosofici. Le montagne esordiscono da protagoniste nella letteratura dell’Europa continentale (mentre in Inghilterra rimangono a margine, a fare da sfondo o confinate nel genere “letteratura di viaggio”) nel 1732 con il poema Die Alpen, di Albert von Haller; vengono poi consacrate da Rousseau nella Nouvelle Héloïse del 1761 e trovano un appassionato cantore e propagandista nel pittore, naturalista, storico ed etnografo Marc-Theodore Bourrit. Haller ripropone tutti gli stilemi descrittivi del paesaggio montano già fatti circolare dagli inglesi, compreso il fascino esercitato dal “terrificante”: ma ci aggiunge lo stereotipo del montanaro povero e virtuoso, in contrapposizione al cittadino corrotto (laddove Windham, dieci anni dopo, descrive gli abitanti di Chamonix come imbroglioni, ostili e poco amanti della fatica)[23]. E sarà questo stereotipo a caratterizzare, soprattutto nella versione di Rousseau (che in verità amava assai poco la montagna e i montanari, ma aveva letto Haller) l’immagine letteraria del secondo settecento. (“Sulle alte montagne dove l’aria è pura e sottile, la respirazione è più agevole, il corpo più agile, lo spirito più sereno, i piaceri meno ardenti, le passioni più moderate. Le meditazioni assumono lassù non so che carattere grande e sublime, proporzionato agli oggetti che ci colpiscono, una non so che voluttà tranquilla che non ha niente di acre e di sensuale. Si direbbe che, alzandosi al di sopra del soggiorno degli uomini, ci si lascino tutti i sentimenti bassi e terrestri, e che a mano a mano che ci si avvicina alle regioni eteree, l’anima sia toccata in parte dalla loro inalterabile purezza”[24]). A monte (è il caso di dirlo) c’è l’illuminismo, con l’interesse nuovo per la diversità dei costumi, delle leggi, delle credenze, e con l’uso polemico della contrapposizione.
È comunque l’approccio scientifico ad informare i primi veri tentativi di ascensione. Gli studi geografici e naturalistici, soprattutto quelli dedicati all’inesplorata dimensione dei ghiacciai, si moltiplicano nella seconda metà del secolo, e vanno ad inserirsi nella fioritura di interesse per la ricerca geologica e orogenetica. Nell’ottica di una scientificità finalizzata agli aspetti pratici, l’Enciclopedie riserva alla natura dei ghiacciai e alle cause della loro formazione uno spazio prevalente all’interno della trattazione delle montagne[25]: e anche la Royal Society, autorevolissimo indicatore degli interessi e delle sensibilità prevalenti nella ricerca, ospita numerose comunicazioni relative alle Alpi, incentrate però in particolare sul problema della misurazioni delle altitudini. Nel complesso la montagna viene letta come depositaria della storia geologica, una storia molto profonda, che rimanda ad ere incredibilmente lontane: ed essendo nel frattempo comparse opere che mettono in discussione l’interpretazione biblica dei tempi e dei modi della formazione della terra, il supporto “documentario” offerto dalla morfologia alpina diventa determinante. Nel 1741 Anton Lazaro Moro pubblica a Venezia De’ crostacei e degli altri marini corpi che si truovano sui monti, che conosce larga diffusione anche fuori d’Italia e può essere considerato l’atto battesimale della moderna paleontologia[26].
Con le acquisite credenziali di luoghi per eccellenza deputati allo studio dell’antichità della terra le montagne conoscono, soprattutto nella seconda metà del Settecento, un nuovo tipo di frequentazione. Ogni scienziato che si rispetti, quale che sia il campo di interesse specifico, dalla fisica alla biologia, alla mineralogia, deve pagare un qualche tributo alle cime.
In questo periodo due studiosi si distinguono per la continuità e la sistematicità dell’interesse dedicato all’orografia, alla geologia e in definitiva a tutte le peculiarità naturalistiche dell’ambiente alpino: Horace Benèdict de Saussure nelle Alpi Occidentali e Déodat de Dolomieux in quelle Orientali. Il primo soprattutto diventa, assieme a Bourrit, ma con intenti più scientificamente fondati, il promotore di un vero e proprio assedio al Monte Bianco, e ispirerà direttamente (anche mettendo in palio un premio) l’assalto finale. Il secondo incarna nella sua più compiuta fenomenologia la nuova figura dello scienziato-viaggiatore: nel corso di un quarto di secolo percorrerà le Alpi palmo a palmo, in una serie di escursioni condotte spesso in solitaria, animate da una determinazione ferrea e sorrette da un fisico instancabile.
Finalmente in vetta
Nel 1786 arriva la capitolazione di quella che è diventata la montagna simbolo e l’ossessione di De Saussure. I primi due salitori, Jacques Balmat e Michel Paccard, dovrebbero puntare secondo il mandato di De Saussure alla misurazione della pressione barometrica in vetta e alla conseguente determinazione dell’altitudine, piuttosto che alla conquista. In realtà non sono mossi dagli stessi intenti. Paccard, medico e naturalista dilettante, ha già effettuato diverse ascensioni significative mirate a verifiche sperimentali, e ha dato prova in più occasioni di una rara onestà intellettuale e di una motivazione scientifica genuina. Balmat, cercatore di cristalli, ha in mente solo il primato e la ricompensa. È inevitabile che ne nasca una diatriba sulla paternità della conquista, relativa in particolar modo all’individuazione della via. La prima salita del Monte Bianco è quindi all’origine anche della prima polemica, e inaugura un costume di antagonismi che accompagnerà poi sempre l’alpinismo.
L’anno successivo alla prima, De Saussure ripete l’ascensione portandosi dietro uno stuolo di studiosi e una strumentazione adeguata. Ma se l’ufficialità scientifica è stavolta pienamente rispettata (“Nel momento in cui raggiunsi il punto più alto della neve che sovrasta quella vetta la calpestai più con collera che con un sentimento di piacere. Del resto, il mio scopo non era soltanto quello di raggiungere il punto più alto; dovevo soprattutto compiere le osservazioni e gli esperimenti che, soli, davano un senso a quel viaggio”)[27], la conquista della cima è diventata in realtà da subito una gara sportiva. De Saussure stesso, e come lui Bourrit, al di là dei trionfali proclami rilasciati in nome della scienza all’indomani della salita di Paccard e Balmat, nei quali non mancano di sottolineare i loro rispettivi ruoli di ispiratori e di organizzatori, sono in realtà alquanto dispiaciuti di non essere stati della partita (e questo spiega il credito ingiustamente dato alla versione dei fatti di Balmat, che in effetti, non essendo uno scienziato, dava loro meno ombra). Pochi anni dopo lo stesso Alexander von Humboldt, prototipo dello scienziato puro, mosso solo dalla volontà di toccare con mano, di sperimentare sulla propria pelle, non riesce a celare, dietro il suo aplomb razionalistico, l’orgoglio di essere salito sul Chimborazo ad una altitudine mai toccata prima da altri uomini (e che non sarà superata per oltre mezzo secolo).
Questo spostamento di obiettivo è d’altro canto naturale: eseguite una volta le misurazioni, al massimo replicate una seconda per la conferma, la salita a scopo scientifico ha esaurito la sua significatività. E infatti la terza ascensione al Bianco è compiuta da un gentiluomo inglese, che il barometro non ce l’ha, ma vuole semplicemente provare a farcela. Quelle successive non fanno che confermare il prevalere di nuovi moventi alle scalate: il fascino romantico dell’avventura e l’imperativo della moda. Nel 1808 sale in vetta la prima donna, Marie Paradis, una valligiana amica di Balmat, e trent’anni dopo la prima nobildonna, Henriette d’Angeville, una regina dei salotti parigini[28]. In mezzo ci sono decine di altre salite, e nel 1820 anche la prima tragedia, con tre alpinisti sepolti da una valanga; ciò che invece di dissuadere dai tentativi di ascensione sembra aumentarne il richiamo, aggiungendo il fascino ambiguo del rischio. Nascono naturalmente anche le polemiche nei confronti di una moda che a molti appare assolutamente insensata: nelle riviste dedicate ai viaggi, che verso la metà del secolo si contano già a decine, e sulla stampa quotidiana, si comincia a giocare sugli effetti sensazionalistici. Quando gli incidenti e le tragedie si infittiranno la stessa regina Vittoria chiederà a Gladstone di intervenire in qualche modo per scoraggiare i cittadini inglesi dal mettersi a repentaglio per un assurdo capriccio: solo per sentirsi rispondere che sono liberi di giocarsi la pelle come vogliono, e che tutto sommato le Alpi sono una buona palestra per gente destinata a costruire degli imperi. Resta comunque ferma la dominanza inglese: trentasette delle prime cinquanta ascensioni, tra il 1786 e il 1854, sono di viaggiatori britannici: e tra il Monte Bianco e il Cervino, ma in pratica lungo tutta la fascia alpina occidentale, per le guide e per i valligiani chiunque ami scalare le montagne è “un inglese”.
L’Ottocento vede però anche nascere una nuova generazione di scienziati-alpinisti, per lo più franco-svizzeri, esemplarmente rappresentati da Louis Agassiz. Accompagnato da una pattuglia di studiosi giovanissimi Agassiz dimora per diverse estati successive sul ghiacciaio svizzero di Unteraar, in un pittoresco rifugio ricavato sotto una sporgenza rocciosa e destinato a diventare famoso come Hotel des Neuchatelais, per compiere studi sulla composizione e stratificazione del ghiaccio e soprattutto sui suoi movimenti, e a tempo perso scala vette come la Jungfrau e il Wetterhorn. Per certi aspetti la sua motivazione è più simile a quella di Wyndham che a quella di De Saussure: la vetta è un corollario, la vittoria è proprio la sopravvivenza al di sopra della quota delle nevi eterne. Con uno spirito analogo si muove James D. Forbes, vero e proprio esploratore, fisicamente poco adatto alla pratica alpinistica vera e propria, ma determinato a percorrere alla maniera di Dolomieu la fascia alpina occidentale dal Delfinato e dalla Savoia al massiccio del Bianco e al gruppo del Rosa, identificando e percorrendo tutti i valichi possibili. Come Agassiz, presso il cui hotel soggiorna anche per un breve periodo ma del quale non condivide le teorie sull’origine glaciale delle vallate alpine, Forbes vive la fase eroica, genuina e spensierata della nuova passione per la montagna, ancora indenne dai guasti della moda e dall’esasperazione competitiva. La prima parte del secolo offre un florilegio aneddotico e una galleria di personaggi incredibili, per l’incosciente entusiasmo col quale affrontano una natura tutt’altro che facile e per la strabiliante fortuna che li assiste in imprese che, stanti le condizioni, le conoscenze e l’equipaggiamento dell’epoca appaiono oggi eccezionali.
Nel corso delle sue peregrinazioni sui ghiacciai della Brenva e del Miage[29], Forbes conosce e frequenta anche alcuni dei pionieri dell’alpinismo italiano. Si tratta di personaggi come l’alagnino Giovanni Gnifetti, primo a raggiungere la cima del Rosa che oggi porta il suo nome, e il valdostano Georges Carrel, salitore dell’Emilius (quest’ultimo è in contatto anche con molti altri alpinisti inglesi, da Tyndall a Tuckett, a Coolidge, e con lo stesso Agassiz). In comune essi hanno, oltre alla passione per la montagna, il fatto di essere dei sacerdoti.
Il ruolo dei curati di montagna, dei canonici, degli abati, nella scoperta e nella “domesticazione” delle montagne è fondamentale[30], sia sotto il profilo dell’azione alpinistica vera e propria, sia per il ruolo svolto nella promozione dell’immagine dell’ambiente alpino. Il parroco svizzero Elie Bertrand, in una serie di Saggi sull’utilità delle montagne[31] pubblicati quasi un decennio prima de La Nouvelle Heloïse, sostiene che “i monti sono la testimonianza dell’armonia del mondo”: è il ribaltamento della teoria di Burnet e delle spiegazioni dei catastrofisti, oltre che di quelle di Voltaire. Ma è soprattutto il segno di un atteggiamento positivo verso la montagna che caratterizza tutto il mondo ecclesiastico delle vallate alpestri. Questo atteggiamento ha diverse spiegazioni: in primo luogo è legato ad una più ampia azione della Chiesa, di matrice controriformistica, volta a liquidare le sacche di credenze popolari paganeggianti o le forme di religiosità deviata che resistono in particolare proprio nelle vallate alpine, in ragione del lungo isolamento in cui queste ultime hanno vissuto e del fatto che in esse hanno trovato rifugio durante il medioevo alcuni tra i più importanti movimenti ereticali, dai valdesi ai dolciniani. Le autorità ecclesiastiche sono determinate a riprendere (o a prendere per la prima volta) il controllo di queste aree, e agiscono col tramite di un clero locale ben diverso da quello del seicento, formato attraverso percorsi culturali più severi e legato alla propria parrocchia da vincoli di origine e da obblighi di ufficio più stretti.
Mentre altrove il processo di secolarizzazione avviato dai sovrani illuminati estromette gradualmente il clero dai ruoli civili, in queste zone, e persino nell’area orientale delle Alpi, quella di pertinenza asburgica, avviene il contrario. Il clero rurale svolge mansioni di registrazione anagrafica, di prima conciliazione, di tramite con le autorità e la burocrazia di valle, oltre a curare la memoria storica e a vigilare sulla pubblica moralità. Queste nuove figure di sacerdoti, dotate di una cultura superiore ed impegnate anche nell’alfabetizzazione dei fedeli, finiscono per essere quasi necessariamente sensibili al nuovo spirito illuministico-scientifico, per cui spesso coltivano interessi naturalistici a buon livello, e trovano in essi lo stimolo all’esplorazione di montagne e ghiacciai.
C’è infine una terza ragione, legata allo spirito campanilistico. I curati si fondono in un tutt’uno con le popolazioni dei villaggi loro affidati, e ne sposano, o a volte addirittura ne stimolano, rivalità, ambizioni, retaggi. In più di una situazione li troviamo ad organizzare ascensioni, o a condurle in proprio, per conquistare le vette circostanti prima degli abitanti (e dei curati) dei villaggi vicini. È un movente tutt’altro che trascurabile, che ad un certo punto, quando si afferma l’alpinismo turistico e sportivo, assumerà anche significati economici. Il futuro di un paese o di una valle, la sua appetibilità turistica e quindi il suo sviluppo, sono legati anche alla fama delle sue guide e ai diritti di prelazione sulle vette che queste si sono conquistati.
Oltre ai curati, un ruolo fondamentale lo svolgono naturalmente i monaci, i canonici e gli abati dei diversi ospizi posti al culmine dei valichi alpini. I più attivi, e i più famosi, non fosse altro che per l’aura particolare costruita attorno a loro dalla letteratura romantica, sono naturalmente quelli dell’Ospizio del San Bernardo, che quotidianamente vivono a contatto con un ambiente selvaggio e al cospetto di scenari suggestivi, e finiscono inevitabilmente per subirne il richiamo[32]; ma lo stesso vale per quasi tutti i religiosi che vivono negli avamposti sparsi ai piedi o nel cuore delle montagne, che sono naturalmente portati ad esplorarle e a conquistarsi dalle vette uno sguardo d’assieme.
Sul piano della pratica “alpinistica”, poi, gli esempi di religiosi impegnati nell’ascensione alle vette sono innumerevoli, e riguardano l’intero arco della catena. Nella zona del Bianco abbiamo già incontrato nel 1779 l’abate Murith sulla vetta del Velan (3734 m): nel vallese opera Jean-Maurice Clément, salitore nel 1788 della Dent du Midi (3260 m), possessore di un’enorme biblioteca specializzata nei resoconti di viaggio e di esplorazione ed amico personale di De Saussure (che a casa di Clement quasi ci lascia la pelle, per essere stato colpito in testa proprio da uno dei tomi dei suoi Voyages dans les Alpes); nel salisburghese e poi nella valle dell’Isonzo si esercita l’alpinismo preromantico di Valentin Stanig, facente parte del gruppo dei primi salitori del Grossglokner, ma autore anche di numerosissime prime ascensioni in proprio. Nei Grigioni troviamo a partire dal 1792 Placidus Spescha, un monaco benedettino che segna decine di prime ascensioni oltre i tremila metri, tra le quali lo Stocgron (3418 m), quasi sempre in solitaria perché non trova nessuno che voglia accompagnarlo; che viene deportato in Tirolo per ragioni politiche (simpatizza per la rivoluzione) e ne approfitta per scalare le montagne di quella zona, trascinandosi dietro altri preti; che a settanta e passa anni compie l’ennesimo tentativo (ci aveva già provato altre sei volte) di vincere il Tödi (3614 m), arriva sotto la vetta e spinge a salirla i due cacciatori che lo avevano accompagnato; che scrive infine una Guida per intraprendere viaggi tra i monti piena di ottimi consigli, anche perché legati ad una incredibile serie di esperienze, e di incidenti, dal fulmine alle slavine, vissuti sulla propria pelle.
Potrei citare altre decine di esempi. Ma quel che importa è sottolineare come questi sacerdoti da un lato rappresentino e guidino la reazione locale alla nascita dell’alpinismo, fungendo da mediatori tra i touristes e la popolazione locale, offrendo informazioni, procurando le guide, spesso accompagnando loro stessi gli stranieri. E come siano anche i primi a cogliere il risvolto economico che l’alpinismo può indurre, i benefici che possono derivare alla popolazione delle comunità alpine[33]. Dall’altro, come testimonino quel particolare interesse per le montagne che caratterizza la politica della Chiesa, espresso inizialmente nelle iniziative di singoli mossi da un misto di interesse scientifico, di competitività e di spirito religioso, e che in seguito si definisce più ufficialmente, per il potenziale educativo e morale, e quindi di controllo, che la frequentazione organizzata della montagna può offrire. Se ne riparlerà a proposito dell’associazionismo.
La montagna romantica
Il successo della corsa al Monte Bianco si riverbera comunque ben presto, in termini tanto di promozione “alpinistica” che di ingresso nell’immaginario collettivo, sull’intera catena alpina. Prima del 1860 sono state ormai scalate tutte le principali vette oltre i quattromila, eccezion fatta per il Cervino[34]. Il resto lo fanno la pittura e la letteratura romantica, che scoprono la morbosa attrazione del pericolo e della fatica: la montagna torna mistero, ma mistero da violare e da svelare.
Sono i romantici a fare della montagna un autentico topos letterario, sia nell’ambito di una più generalizzata sensibilità per tutti gli aspetti della natura, sia per le valenze fortemente simboliche che la montagna e l’ambiente montano possono rivestire[35]. Col Romanticismo giunge a compimento quella rivalutazione che era iniziata alla fine del Seicento con Burnet e con i catastrofisti, e che porta a rileggere “in positivo” ciò che prima era visto come negativo, il disordine e la complessità della natura selvaggia e irregolare. Questi aspetti non vengono negati o minimizzati: vengono anzi enfatizzati. “Lontano in alto, trafiggendo il cielo infinito / il Monte Bianco appare – calmo, innevato e nitido – / i monti suoi vassalli ammassano attorno / le loro forme non terrene, ghiaccio e roccia … in che congerie orrenda / sono ammassate le sue forme! Ruvide, nude e alte, / spettrali, deturpate e infrante” scrive Shelley[36]. Ma l’enfasi sulla “congerie orrenda”, su caratteristiche come la solitudine tetra, i siderali silenzi, la verticalità densa di minacce, e sui contrastanti sentimenti che esse inducono è congeniale a quell’estetica del sublime che travalica ogni canone e si nutre non di statiche armonie e di regolarità geometriche, ma del dinamismo scomposto e dell’irregolarità[37].
Per i romantici questo tipo di percezione è riservato a pochi, solo agli animi capaci di un più alto sentire, che proprio per questo vivono a disagio nella quotidianità meschina e ripetitiva e trovano invece conforto negli spazi misteriosi e solitari, depositari di arcani e incanti, o anche semplicemente adatti ad una liberazione e ad una ripartenza per un’esistenza nuova, autentica. Shelley infatti aggiunge: “Questo deserto ha una sua lingua misteriosa / che insegna un dubbio terribile, o una fede così dolce, / così solenne e serena, che solo grazie ad essa / l’uomo può essere riconciliato alla natura; superbo monte, la tua voce può abrogare / vaste leggi di frode e di dolore; non tutti la comprendono / ma i saggi e i grandi e i buoni / l’interpretano, o la fanno sentire, o la sentono profondamente”. L’ambiente inquietante, irregolare, misterioso, diventa simbolo della perfezione originaria, primordiale, non contaminata dall’opera di “valorizzazione” dell’uomo: oppure specchio dell’animo irrequieto, testimone e partecipe del conflitto spirituale che lo spinge a fuggire la vista degli umani[38]. “Alfine eccomi in pace! – Che pace? Stanchezza, sopore di sepoltura. Ho vagato per queste montagne. Non v’è albero, non tugurio, non erba. Tutto è tronchi¸ aspri e lividi macigni¸ e qua e là molte croci che segnano il sito de’ viandanti assassinati” fa dire Foscolo a Jacopo Ortis. “[…] La natura siede qui solitaria e minacciosa, e caccia da questo regno tutti i viventi”: o almeno tutti coloro che non hanno l’animo predisposto a coglierne, nella solitudine e persino nella desolazione, la superiore grandezza.
Lo scenario montano, quello svizzero per la precisione, fa da sfondo all’opera più significativa di questo modo di sentire, il Frankenstein dell’altra Shelley, Mary. “Al tramonto scorgemmo catene immense e dirupate che ci dominavano da ogni parte, e udimmo il rumore del torrente che scorreva tra le rocce e si frangeva in mille cascate … mano a mano che ci portavamo più in alto la valle assumeva un aspetto meraviglioso”. Ma non è solo un fondale: per il protagonista è una sorta di grembo originario cui tornare: “Il peso che gravava sulla mia anima si alleggeriva mano a mano che mi addentravo nella gola dell’Arve. Le montagne e i vertiginosi strapiombi che mi circondavano da ogni parte, il rumore del torrente che infuriava tra le rocce e lo scroscio delle cascate intorno mi parlavano di una forza immensa come l’Onnipotente […] Persino i venti sussurravano con accenti sommessi e la natura materna mi invitava a non piangere più”. Per la sua creatura è un luogo d’elezione, il regno della desolazione dove trovano rifugio i reietti, i banditi dalla società. Entrambe le facce del “doppio” umano (tematica che sarà sviluppata poi da Stevenson e da Wilde), quella avida di conoscenza e quella oscura della trasgressione disumanizzante, sono chiaramente simboleggiate nell’ambivalenza dell’ambiente montano.
Non tutti, naturalmente, sono così entusiasti. Chateaubriand dice che “ai paesaggi di montagna si attribuisce un carattere sublime, che deriva probabilmente dalla grandezza delle cose. Ma … perché possiamo godere della loro bellezza, devono trovarsi nella giusta prospettiva; altrimenti tutto, forme, colori, proporzioni, svanisce. In mezzo alle montagne, poiché siamo vicini all’oggetto, e poiché il campo ottico è troppo ristretto, le dimensioni, necessariamente, si riducono […] La tanto decantata grandezza delle montagne è reale solo per la fatica che vi costa”[39]. Da buon bretone preferisce evidentemente il mare: ma il suo stizzito disincanto, che si allarga anche agli abitanti, coglie nel segno quando mette in rapporto il piacere procurato dalla montagna con il suo costo in fatica e con la sensazione e l’orgoglio di esserselo pienamente guadagnato[40].
Nemmeno Hegel, prima di lui, si era fatto commuovere dalla “monotona rappresentazione” di “massi eternamente morti”[41]. Forse pesano sul suo giudizio le aspettative create dai resoconti dei viaggiatori tedeschi che lo avevano preceduto: ma è anche vero che nell’economia del suo viaggio alle radici dello Spirito le montagne non rappresentano assolutamente nulla, non rivestono alcun significato simbolico o concettuale. Per Hegel la vita è essenzialmente attività, e l’attività ha da essere produttiva, e non c’è nulla di meno “produttivo” della scalata di un monte (ma anche della sua contemplazione).
Al tramonto della stagione romantica la montagna è comunque ancora protagonista in un delizioso racconto di Adalbert Stifter, Cristallo di Rocca (1845)[42]. Lo spunto è offerto da un’escursione compiuta dall’autore in compagnia di Friederich Simony, un geografo e geologo amante delle scalate e dei ghiacciai, un emulo di Agassiz. Simony gli parla di una meravigliosa grotta di ghiaccio che ha scoperto nelle sue peregrinazioni invernali sul ghiacciaio, e Stifter ne fa il luogo centrale di una vicenda piena di pathos e di incanto, nella quale la natura alpestre è rappresentata senza forzature o idealizzazioni, dura e pericolosa, ma non matrigna.
Qui la bellezza della montagna non è data dalla grandiosità, ma al contrario, da una quotidianità armoniosa e ripetitiva, che proprio per questo dà sicurezza. “Tutto l’anno, d’estate e d’inverno, s’affaccia sulla valle con le sue rocce sporgenti e le sue distese bianche”: se ne ha quindi una percezione ben diversa da quella del viaggiatore alpinista che la incontra all’improvviso e viene per violarla. Stifter descrive così la piccola comunità del villaggio: “tutti gli abitanti formano un mondo a sé. Si conoscono tutti per nome e sanno le storie di tutti dai tempi del nonno e del bisnonno, si affliggono tutti se uno muore, sanno come si chiama se uno nasce, parlano un linguaggio che differisce da quello del piano, hanno le loro liti, che appianano da sé, si aiutano tra loro e si riuniscono tutti quando avviene qualcosa di straordinario”. È, né più né meno, la comunità ideale cui facevano riferimento gli anarchici del Giura, che a quanto pare tanto utopisti non erano: non volevano cambiare il mondo, volevano semmai che non cambiasse.
In alcuni passaggi il racconto sembra ambientato in una boccetta di vetro natalizia, di quelle che capovolte creano l’effetto di caduta della neve: “possono comodamente guardare attraverso le finestre il paesaggio invernale, dove cadono lentamente i fiocchi di neve o un velo di nebbia fascia le montagne o scende all’orizzonte il freddo sole color sangue”. Ma altrove si ritorna alla prosa: “La montagna, oltre ad essere la meraviglia del paese, dà anche un utile reale agli abitanti, ché quando arriva una comitiva di alpinisti per darne la scalata partendo da quella valle, gli abitanti fanno da guida, ed essere stato una volta guida, aver sperimentato questo e quello, conoscere questo e quel punto, è un segno di distinzione che ognuno è fiero di mettere in mostra”.
Il romanticismo dei monti aspri, minacciosi e solitari ha fatto il suo tempo, e Stifter paradossalmente, mentre descrive un ambiente e un paesaggio che saranno quelli ripresi e diffusi per tutto il secolo a seguire da cartoline e calendari illustrati, ne decreta anche la fine, cominciando ad intravvedere le potenzialità turistiche ed economiche che alla montagna e ai suoi abitanti si schiudono (o volendo, che su di essi incombono).
All’evoluzione dell’immagine letteraria si accompagna quella della colonna sonora che viene associata all’ambiente alpestre. Luogo del silenzio per eccellenza, la montagna ha, per chi si rende disponibile ad ascoltarla, una sua voce, che non può essere trasmessa altrimenti che con la musica. Il romanticismo offre in questo senso la formula perfetta: assomma la disposizione ad interpretare ogni aspetto della natura secondo una superiore consonanza spirituale ad una acutissima sensibilità musicale.
Il primo approccio con la musica della montagna passa naturalmente attraverso il recupero di quegli strumenti, di quei suoni e di quelle melodie che caratterizzano la cultura delle popolazioni alpine, e che fino a tutto il settecento sono stati considerati troppo rozzi per poter essere associati alla grande musica, o vi sono entrati come curiosità e concessione bizzarra ad un gusto barbaro. Solo dopo Rousseau i canti di montagna, le composizioni tipiche (la ranz des vaches), gli strumenti musicali della tradizione vengono recuperati e integrati in un disegno molto più ampio di “riabilitazione” dell’ambiente naturale, antropologico e culturale montano. Nel 1805 vengono addirittura istituiti a Berna dei corsi di corno di montagna, che diventa anche il simbolo della confederazione elvetica.
Questi suoni, queste melodie sono dunque fatti propri e riproposti, in genere attraverso un’opportuna rielaborazione, ma spesso anche nella loro semplicità originaria, dalla musica “colta” romantica. Al di là dell’interesse per l’aspetto folklorico, che è connesso al recupero della cultura popolare, e quindi anche alla costruzione o ricostruzione di una identità nazionale, agisce nei romantici l’attenzione alla maestosità degli scenari e alle suggestioni sonore che dall’ambiente montano possono venire, tanto se inteso come territorio ostile, infido e pericoloso (il rumore della valanga) quanto nella sua accezione bucolica (la voce del ruscello affidata al pianoforte nei lieder di Die Schöne Mullerin, di Franz Schubert). L’approdo della montagna alla grande musica passa quindi per un doppio canale. Da un lato attraverso l’ambientazione: l’ambiente alpestre ritorna con regolarità, nelle forme musicali più diverse, dalla sinfonia alla sonata (la Pastorale di Beethoven, Die Berge di Schubert), al melodramma (il Guglielmo Tell di Rossini, il Manfred musicato da Schumann, l’Aroldo di Berlioz), al poema sinfonico (Una notte sul monte Calvo di Musorgskij, la Sinfonia delle Alpi di Richard Strauss), alla romanza (Le chant du Berger di Meyerbeer); dall’altro, strettamente correlato al primo, attraverso l’utilizzo delle sonorità vocali e strumentali e delle tipicità melodiche. Haydn (e dopo lui moltissimi altri) introduce il corno di montagna, Mahler arriva a utilizzare i campanacci delle mucche nell’organico orchestrale.
La montagna ha inoltre spesso un ruolo fondamentale per l’ispirazione creativa: Richard Strauss e Mahler, per esempio, sono compositori che alla montagna non devono soltanto singole suggestioni, ma della sue atmosfere hanno bisogno per vivere e per pensare. Accade per i musicisti quel che vedremo accadere per i pittori: una volta viste le Alpi non riescono più a togliersele dal cuore. Quanto a farle entrare in quelli altrui, oltre ad ottenere un risultato “promozionale” la musica ha il valore di una consacrazione del ribaltamento di immagine: diventando metafora del sublime le montagne entrano a pieno diritto in quella dimensione spirituale alta e ristretta alla quale per sua natura la musica attinge.
La montagna dipinta
A partire dalla metà dell’‘800 (potremmo anche stabilire una data esatta, il 1853, che è per inciso proprio quella della pubblicazione di Cristallo di rocca), la montagna cessa di essere uno spazio di riferimento per eccentrici ed entra davvero nell’immaginario (e nel desiderio) collettivo. Il Monte Bianco comincia a godere di un’improvvisa popolarità anche tra le fasce sociali escluse dal Grand Tour, e tutto questo è dovuto all’intraprendenza di un giornalista, naturalmente inglese, Albert Smith, che consacra la propria esistenza al sogno di scalare la montagna e che una volta toccata la vetta se ne erge a profeta. Tornato in patria Smith affitta una sala e per nove anni, con duemila repliche, propone ai suoi concittadini uno spettacolo “panoramico” che ha per tema proprio la salita, con proiezioni di lanterna magica, camosci e cani vivi o imbalsamati, rifugi alpini di cartone e tutti gli ammennicoli che servono a creare un’atmosfera pseudo-alpina. Il successo è enorme, e gli emuli si moltiplicano. Solo due anni dopo arrivano in vetta le prime macchine fotografiche, e partono le prime mostre itineranti.
Qui occorre però aprire una parentesi e fare un passo indietro. Smith ha pubblicizzato il Monte Bianco presso il grande pubblico, ma non ne ha certo inventata l’iconografia. Allo stesso modo, la scoperta del paesaggio alpestre nella pittura non è prerogativa della sensibilità romantica. Anche in questo caso si possono trovare gli indizi di un mutamento nei modi della percezione già a partire dal medioevo, dallo stesso Giotto, anche se i paesaggi assumono una verosimile fisionomia alpina solo nel Rinascimento[43]. Ciò accade principalmente perché la fioritura italiana richiama dal Nord una quantità di artisti che per raggiungere la penisola, da qualunque paese provengano, devono valicare le Alpi. E si tratta di un’esperienza che lascia tracce profonde.
Lo constatiamo già con Albrecht Dürer, che mette sullo sfondo del suo autoritratto o di alcuni dipinti religiosi cime innevate e ghiacciai. Per Leonardo poi il paesaggio montano diventa un vero e proprio campo di ricerca, tanto da indurlo, come abbiamo già visto, a salire in vetta al monte Bo (che non si sa bene quale sia, perché con questo nome era indicato genericamente all’epoca tutto il massiccio del Rosa). Le sue montagne, quelle famosissime della Vergine delle Rocce ma soprattutto quelle che sono oggetto di studi specifici, realizzati con matite rosse, manifestano un’idea di intima potenza e contemporaneamente di equilibrio. Leonardo intuisce le forze che sommuovono dall’interno la terra, calcola quelle che la levigano dall’esterno e ne riproduce l’equilibrio, in una concezione armonica. Al contrario, la violenza delle forze naturali appare ancora incontrollabile nelle tele e nelle pale di Lucas Cranach e di Albrecht Altdorfer: l’atteggiamento protestante nei confronti di Dio si manifesta nel misto di stupefazione e di terrore di fronte alla potenza distruttiva che egli può scatenare. In compenso si avverte benissimo che quelle rappresentate sono montagne “culturali”, lette nella Bibbia piuttosto che conosciute.
In chi l’ha vissuta da vicino, in Brueghel il Vecchio ad esempio, la montagna diventa incantesimo (si veda Cacciatori sulla neve). Il passaggio delle Alpi lo ha impressionato al punto da indurlo, sulla via del ritorno, ad un soggiorno prolungato, per catturare in una corposa serie di studi e schizzi le immagini montane che riverserà nei fondali delle sue tele più suggestive.
Il gusto secentesco del paesaggio fa invece nuovamente sparire la montagna dietro le quinte: c’è piuttosto la ricerca di ambientazioni storiche ben definite, o ricreate e inventate, con una focalizzazione sui personaggi, sul primo piano. Soltanto i fiamminghi prestano attenzione allo sfondo: ma sono i panorami delle Fiandre o della Zelanda. Nel passaggio al Settecento lo sguardo degli artisti si apre nuovamente su prospettive spaziali più ampie, ma vengono predilette ambientazioni armoniche, equilibrate, idealizzate: il modello è quello dell’idillio campestre di Poussin. Le eccezioni, costituite da Salvator Rosa o da Vermeer, guardano più ad una natura marina di falesie e scogli che ad un ambiente montano. È tuttavia proprio il primo, che conosce in Inghilterra un grande successo postumo, a diffondere il gusto per paesaggi in cui rocce e rovine si confondono, quasi un corrispettivo visivo delle teorie catastrofiste di Burnet. Ne Il sogno di Giacobbe, ad esempio, le rocce hanno una funzione teatrale, scenografica, e non riflettono affatto il sentimento della natura: quello che viene evocato è piuttosto il senso di solitudine del protagonista.
In compenso, la scoperta dei ghiacciai avviene prima sulla tela che nei testi scientifici. Le immagini dei fronti dei ghiacciai corrispondono perfettamente a quell’ideale artistico di grandezza e semplicità che Winckelmann predicava invitando all’imitazione dei classici. A raffigurarli sono naturalmente pittori svizzeri come Felix Meyer o Ludwig Abuli, o il già citato Marc-Théodore Bourrit: ma a dare loro dignità di vero e proprio topos estetico è soprattutto Caspar Wolf. A dispetto di una concezione “spettrale” della montagna, e dei ghiacciai in particolare, Wolf tiene a bada il sentimentalismo e non scade nel gioco dell’orrore: i suoi paesaggi montani sono luminosi, aperti, immersi in una sorta di siderale silenzio. La sua pittura prelude a quella sorta di “riconsacrazione”, questa volta artistica, che delle montagne farà Caspar David Friedrich.
Il primo grande paesaggista alpino è comunque Jean-Antoine Link, che raffigura esclusivamente la catena del Bianco, da ogni possibile punto di vista. Link supera le rappresentazioni imprecise e fantasiose dei suoi predecessori, per fissare invece in innumerevoli acquarelli e tempere la realtà “geologica” delle montagne, i seracchi, le pareti, i nevai, le morene, i crepacci: lo fa con uno sguardo sobrio e libero da ogni costrizione canonica o stereotipo preromantico. La precisione e la definizione dei particolari sono frutto di lunghe e solitarie sedute di contemplazione e di trasposizione in schizzi della natura nella sua nudità. Linck non vuole esprimere alcuna particolare filosofia paesaggistica, alcuna simbologia; nelle sue rappresentazioni il senso è già intrinseco alla natura rappresentata. L’esatto opposto di quanto fa Friedrich.
Friedrich non è mai stato sulle Alpi, e lo si capisce subito: anche le sue vedute da Chamonix sul monte Bianco sono riprese da stampe dell’epoca. Eppure quell’idea “platonica” di montagna che cerca espressione (e tutto sommato la trova) nelle sue tele, e che non è mutuata da nessuna precedente modalità di rappresentazione, ma le riassume tutte, è entrata nell’immaginario collettivo a rappresentare non una forma, ma una essenza. Nella sua immaginazione le montagne coperte di ghiaccio bluastro si trasformano in una metafora del lontano, dell’inaccessibile: coglie leopardianamente della natura una certa frigidità, la tristezza e il vuoto, cose che nessun pittore che disegni dal vero coglierà mai. È il rapporto di attrazione-repulsione che abbiamo visto adombrato anche nella letteratura dell’epoca, in tutti i generi, che vanno dal romanzo gotico alla Shelley sino alle fiabe e alle leggende su misteriose (e malvagie) regine delle nevi.
William Turner invece le Alpi le ha attraversate, e come Brueghel ne ha tratto un’impressione indelebile. Nell’estate del 1802, a ventisette anni, quando già è considerato il miglior paesaggista inglese, lascia per la prima volta la Gran Bretagna per raggiungere il continente, e in particolare l’Italia. L’anno precedente ha scoperto i paesaggi montuosi della Scozia e del Galles, e le montagne lo hanno letteralmente affascinato. Ora, di fronte allo spettacolo grandioso e sempre diverso che giorno dopo giorno le Alpi gli offrono, non sa più da che parte guardare: riversa le sue emozioni in schizzi rapidissimi, in carboncini, in guazze e in acquerelli, che saranno poi in parte tradotti sulle tele, ma che meglio ancora trasmettono nella loro immediatezza il senso di gioia e di stupore che non lo abbandona per tutto il viaggio. Turner non può neppure immaginare quale successo avranno queste immagini; una volta tornato in patria dovrà dipingerne una miriade di copie per soddisfare le continue richieste dei clienti, e il suo sguardo entusiasta e nostalgico contribuirà in maniera determinante ad influenzare l’immaginario collettivo. E nemmeno immagina quanto la lezione cromatica e formale delle Alpi segnerà per sempre la sua tecnica.
Nessun pittore prima di lui, e nessuno dopo di lui, è in effetti riuscito a trasmettere in maniera così autentica ed immediata le sensazioni dettate dalla grandezza delle montagne, dalla loro anche brutale bellezza, dalla solitudine. Turner esplora nel dettaglio tutta la regione, e la sequenza dei suoi scorci diventa una sorta di diario fotografico di viaggio. Ma ciascuna immagine ha forza propria; ci parla ora della calma serena dei laghi di Thun, Brienz e Ginevra, ora dell’asprezza del Monte Bianco, della tortuosità delle gole, dei valichi innevati, dei massi erratici e dei pascoli. Il risultato complessivo è quello di una sommessa ma stupefacente epopea della natura alpestre. Le Alpi rimarranno per lui un ricordo così forte che trentaquattro anni dopo, ormai anziano, vorrà tornare nei luoghi che tanto lo avevano impressionato, con l’obiettivo di portare a compimento l’esplorazione dell’area del Monte Bianco e della Valle d’Aosta.
L’esecutore testamentario di Turner (non solo ideale, perché riceve questo mandato, per quanto concerne l’immensa collezione di schizzi e abbozzi e acquerelli ricavati dai viaggi sulle Alpi, direttamente dall’artista) è John Ruskin. Ruskin ha maturato proprio sulle tele di Turner un vero culto estetico per il paesaggio e per il mondo alpestre, prima ancora di incontrarli in Italia. Nel 1833, a 14 anni, soggiorna per la prima volta a Chamonix, e da questo momento le Alpi diventano per lui un appuntamento fisso e l’oggetto primo della sua celebrazione della bellezza. Non ha né il fisico né il carattere dell’alpinista, e non salirà mai oltre i tremila metri: ma non manca di percorrere in lungo e in largo tutta la catena occidentale, attraversando valichi e ghiacciai e interessandosi, oltre che alla natura, agli abitanti, alle tipologie abitative, alle tradizioni e ai mestieri artigianali. Guarda alle montagne come un artista e a chi le abita come un antropologo, ma anche come un riformatore politico, sociale e morale che elegge a modello proprio i ritmi e i modi della vita alpigiana. L’unica cosa che non lo interessa, e che anzi lo esaspera, sono le imprese degli scalatori: “Considerate le Alpi stesse, che così appassionatamente i vostri poeti hanno amato, come alberi da cuccagna, sui quali vi ritenete in dovere di salire per poi discenderne lanciando urla di gioia. Quando non potete neppure più urlare […] riempite il silenzio delle valli con il vostro fracasso e tornate a casa, rossi per l’orgoglio, e così felici da singhiozzare convulsamente per la vanità soddisfatta”.
Le pagine migliori dedicate da Ruskin all’estetica delle montagne si trovano nel quarto libro dei Modern Painters (1856) e nel Sesame and Lilies (1865). Ecco un frammento della descrizione del Cervino, che a ragione egli considerava il capolavoro delle Alpi: “Il luogo è così immutabile, così silenzioso, così al di là non solo della presenza dell’uomo ma anche di quella dei suoi pensieri, così sprovvisto di ogni vita di albero o di erba, e così incommensurabile nella sua raggiante solitudine di una morte maestosa, che sembra un mondo dal quale si sia ritirata ogni presenza umana e anche spirituale, e dove gli ultimi arcangeli, innalzando quei monti a monumenti funerari, si siano sdraiati nella luce del sole per un eterno riposo, ognuno avvolto in un drappo bianco […] Le pareti del Cervino […] non sono avanzi di guglie frastagliate che cedono, lastra per lastra, strato per strato, ad un’usura continua. Sono al contrario un monumento inalterabile, apparentemente scolpito da lunghissimo tempo, e di cui tuttavia le immense muraglie conservano la forma del primitivo aspetto. Si innalzano come un tempio egizio dal delicato frontone, dalle tinte sfumate, su cui da epoche remote si levano e tramontano i soli che proiettano sempre, da est a ovest, la stessa linea d’ombra […]”.
È l’occhio di un architetto, di un esteta e di uno storico dell’arte quello che si esercita sulla natura alpina. Soprattutto è l’occhio di chi le montagne le ha amate prima ancora di conoscerle davvero, attraverso le suggestioni letterarie o iconografiche; come tale non può fare a meno di leggerle col filtro costante della citazione, di caricarle del rimando ad altro. Ma questo, come abbiamo già visto, è appunto il destino della montagna, in ogni epoca: ciascuno vi trova esattamente ciò che vi porta[44].
Anche in quelle più remote. Il nuovo sguardo col quale si coglie la montagna non rimane infatti confinato alle Alpi. L’orizzonte cui volgerlo si dilata immediatamente. Agli inizi dell’Ottocento due intrepidi viaggiatori, Alexander von Humboldt e Aimée Bompland, rientrano in Europa reduci da un viaggio “alle regioni equinoziali” (vale a dire nell’America Latina) durato cinque anni. Hanno risalito fiumi, attraversato deserti, convissuto con giaguari, mosquitos e caimani, ma soprattutto hanno percorso in lungo e in largo la parte settentrionale della catena andina. Hanno anche stabilito un record di altitudine, scalando il Chimboranzo sino a 5.900 metri e arrestandosi solo a poche centinaia di metri dalla vetta. Tornano portando con sé decine e decine di “vedute” panoramiche, che andranno a formare l’Atlas pictoresque annesso agli studi compiuti da von Humboldt su ogni aspetto naturalistico, antropologico, geografico e politico delle aree visitate.
Humboldt ha idee particolari sull’uso della veduta. Il paesaggio deve trasformarsi per lui da idea estetica in concezione scientifica: in un indistinto nel quale gli oggetti convivono come avvolti in una leggera nebbia, che fa da collante per suggerire una organica armonia. E sono soprattutto le montagne, a partire dal Pico de Teide, a Tenerife, 3.700 metri scalati quasi di corsa, fino al Chimborazo e agli innumerevoli vulcani saliti sulle Ande e in Messico, a fornirgli il materiale più interessante per lo studio, ad esempio, della distribuzione della vegetazione alle diverse altitudini, o per quello delle stratificazioni rocciose. L’Atlas Pictorésque è redatto con queste finalità, ma acquisisce una sua autonomia estetica e diventa un classico dell’iconografia montana; assieme alla relazione di viaggio costituirà per i viaggiatori della prima metà del secolo una sorta di Bibbia. Non ce n’è uno (Darwin per primo) che non lo citi tra i suoi libri ispiratori.
L’esempio di Humboldt è contagioso. Tutta una schiera di studiosi e di pittori formatisi sui suoi testi si riversa in America latina. Sono in gran parte tedeschi, da Johann Moriz Rugendas a Carl Gustav Carus: ma sono anche statunitensi, primo tra tutti Frederic Edwin Church, che dai suoi viaggi sulle Ande trae tele di enormi dimensioni, come Nel cuore delle Ande e Monti dell’Ecuador, e le espone poi al grande pubblico in mostre-evento che riscuotono un grande successo (Smith ha fatto scuola molto rapidamente). Attraverso Humboldt, ma anche nella prospettiva di un buon ritorno economico, gli americani imparano a guardare con occhi nuovi la natura e il paesaggio che li circonda.
Anche la parte settentrionale del continente ha infatti le sue montagne, per molti versi più spettacolari delle Ande. Non hanno ancora conosciuto la popolarità delle Alpi perché per tutta la prima metà dell’800 continuano a costituire una barriera, e sono battute da personaggi ben diversi dagli aristocratici perdigiorno inglesi. A renderle famose e ad ammantarle di mito ci pensa però dopo la metà del secolo un gruppo di artisti che accompagna e a volte precede lo spostamento ad occidente della frontiera: i pittori della Hudson River School.
Il più prolifico e quotato è Albert Bierstadt, originario della Prussia ma trasferitosi presto in America, e di lì poi tornato a studiare pittura in Germania per qualche anno. Bierstadt è quindi cresciuto tanto alla scuola di Friedrick quanto a quella dei pittori dello Hudson: nei confronti di questi ultimi ha il vantaggio di una tecnica molto più raffinata, oltre che di uno sguardo “storicamente” educato. Il resto ce lo mette lui: si accoda ad una spedizione militare che attraversa il continente, poi gira per conto proprio a fotografare e a realizzare schizzi delle meraviglie naturali che incontra. Racconta gli spazi immensi della Sierra Nevada e della Yosemite Valley[45], dove tutto, dagli alberi alle pareti a picco è malato di gigantismo: e lo fa con uso sapiente, anche se un tantino esagerato, della luce. Il risultato è davvero spettacolare, e talmente emozionante che in seguito al successo riscosso dalle vedute della Yosemite tutta l’area sarà dichiarata parco nazionale[46]. Quella che riversa nelle sue numerosissime tele (più di quattrocento) è l’idea di una natura immane ma benevola, nell’ambito della quale le montagne non costituiscono un ostacolo ma una corona, una barriera protettiva posta a guardia di piccoli angoli di paradiso terrestre: ma ciò che a noi più importa, è che Bierstadt già a partire dal 1860 queste vedute le fa girare, le porta in tour per tutti gli States e poi in Europa, raggruppandole a costituire un fantastico diorama che incontra un notevole successo. Dopo l’operazione di Smith rispetto al Monte Bianco, questa è la consacrazione definitiva dell’uso spettacolare, e per ricaduta turistico, della veduta montana. Prelude immediatamente all’uso promozionale e pubblicitario.
La montagna illustrata
Infatti. Una volta violate le altitudini proibite, calpestate le cime vergini, dissacrata la montagna liberandola dei suoi sortilegi e dei suoi demoni e recuperandola ad una consuetudine non più timorosa e penitenziale, la si va ora a riempire di significati economici, culturali ed anche politici nuovi. L’ingresso della veduta montana nelle alte sfere dell’arte ha un suo corrispettivo a livello “popolare”, tra la metà del XVIII e quella del XIX secolo, nella proliferazione di immagini-souvenir, inizialmente piccole stampe ad acquaforte e bulino, destinate ai “signori escursionisti” che vogliono portarsi a casa un ricordo di quanto hanno visto, ma più ancora una sorta di certificazione del viaggio che hanno compiuto (quello che un tempo era il sigillo del pellegrino. Per i più arditi ci sono dei veri e propri “certificati di ascensione”, almeno relativi al Monte Bianco). Queste vedute, che privilegiano gli aspetti canonici del paesaggio alpino (le cascate, gli orridi, le cime, i panorami, gli alpeggi) si standardizzano velocemente e sono le immediate precorritrici della cartolina e della foto-ricordo. In fondo, gli acquarelli di Turner ne erano soltanto una versione di livello artistico superiore.
Quando la colonizzazione turistica e commerciale delle montagne si consolida, dopo la metà dell’800, le immagini passano ad assolvere anche ad un altro ruolo, quello della pubblicizzazione dei prodotti immediatamente legati al turismo di montagna (gli alberghi) o alle tradizioni alimentari (liquori, formaggi, ma anche profumi ed essenze). E ciò consente un’istruttiva lettura di come il nuovo mito positivo della montagna si intersechi con i sistemi di valori socio-culturali che scandiscono le tappe successive dell’avanzata del moderno.
In una prima fase l’immagine pubblicitaria punta essenzialmente a trasmettere un messaggio bucolico, caratterizzato da alcuni elementi fissi (vette e ghiacciai sullo sfondo, castelli arroccati o deliziosi masi in campo medio, pastorelli o animali, o il prodotto pubblicizzato, in primo piano) e comunque dall’assoluto protagonismo della natura. I nomi stessi dei prodotti suggeriscono la provenienza da luoghi di per sé garanti di purezza e genuinità, spacciano l’appartenenza ad una tradizione connaturata e strizzano l’occhio ad una idea di vita sana e morigerata, di virilità e salute degli abitanti che ne sono gli originari consumatori e produttori. Non solo: quel che viene venduto, proprio per la relazione con un ambiente comunque difficile, isolato rispetto alle normali vie di traffico, in qualche modo esotico, è anche un concetto di rarità. Quindi l’immagine risulta completamente ribaltata rispetto agli inizi del settecento: ciò che viene dalle montagne è genuino, è bello, è raro ed è quindi prezioso.
Con la nascita delle prime catene alberghiere e l’estensione delle reti ferroviarie parte verso la fine del secolo il reclutamento dei turisti. Il veicolo è in questo caso soprattutto il manifesto pubblicitario, che ha tra le caratteristiche peculiari quella di portare in primo piano proprio il luogo da pubblicizzarsi: la montagna non fa più da sfondo, ma diventa essa stessa protagonista dell’immagine. Si passa dalla pubblicizzazione dei derivati del mondo alpestre a quella dell’Alpe stessa: e ciò paradossalmente induce una ulteriore standardizzazione. Per esercitare un immediato richiamo l’immagine deve accordarsi il più possibile con lo stereotipo iconico della montagna ormai invalso: quello della piramide di roccia e ghiaccio. È Friedrich, piuttosto che Turner, a fornire il modello ideale: quello reale è offerto dal Cervino.
Quest’ultima immagine mitica della montagna è però giocata dalla pubblicità anche su un altro versante. Se all’assalto della montagna c’è l’uomo, e se è lui, nella veste eroica dell’alpinista e dell’esploratore, il protagonista, l’associazione simbolica si fa più sottile e si sovrappone alla rappresentazione naturalistica. Ad essere pubblicizzati non sono più luoghi o sapori, ma valori: anzi, uno specifico valore, quello della virilità. La moderna frequentazione della montagna è stata connotata da subito in senso molto “maschio”, ma questa virilità viene accentuata proprio nel periodo che stiamo considerando, di pari passo con la focalizzazione dell’interesse da parte del mondo alpinistico sulle difficoltà, sulle performances sportive, sulle tecniche, e con l’abbandono di ogni motivazione o pretesto naturalistico, scientifico o antropologico. Le immagini commerciali di liquori, ad esempio, o di energetici come il cioccolato, puntano sul doppio nesso virilità uguale ardimento e ardimento uguale rischio; il nesso ulteriore è quello col prodotto, che aiuta a superare il pericolo, o consente di celebrarlo degnamente una volta scampato.
In questa direzione l’immagine della montagna che viene proposta non è più quella idilliaca di un grembo accogliente, ma quella maschia di una palestra di ardimento, superba e bellissima, ma nemica. In fondo non è che la traduzione per il grande pubblico della filosofia di Lammer, di Rey, di Welzembach e di tutti i protagonisti dell’“alpinismo eroico” che andremo a conoscere, banalizzata quanto si vuole, ma efficace nel creare l’assuefazione ad un linguaggio icastico e nell’educare a valori perentori. E questa è la direzione che verrà percorsa, come vedremo, da un altro tipo di propaganda, quella politica, e soprattutto da quei sistemi totalitari che la propaganda impareranno ad utilizzare in maniera massiccia. La retorica del sacrificio, del coraggio e della conquista trovano nella montagna un repertorio sterminato: il gesto eroicamente virile dell’impresa sportiva è anche funzionale ad un addestramento militare.
Una parziale mediazione tra le due immagini pubblicitarie della montagna, quella eroico-sportiva e quella idillico-pastorale, che corrispondono poi all’immaginario diffuso e contribuiscono a loro volta a corroborarlo, verrà imposta a partire dagli anni trenta dalla comparsa del turismo sciistico. Lo sci è una pratica sportiva, e la sua immagine necessita di rimandi all’azione, alla velocità: ma, a differenza dell’alpinismo, non può far leva su una forte connotazione virile. Anzi. Lo sci di massa, quello turisticamente più significativo, promette le facili emozioni della discesa, non la dura conquista della salita: è aperto a tutti, non seleziona élites fisicamente e spiritualmente “superiori”: e deve quindi diversificare il messaggio, pubblicizzare la sua universalità inserendo nell’immagine presenze femminili e alludendo ad una possibile fruizione familiare. Anche gli sfondi debbono suggerire una libertà condizionata, quella di cui si gode sulle piste, e comunque una natura addomesticata, pendii rasati anziché dirupi o pareti. Da questa mediazione nasce una nozione completamente diversa dell’andare in montagna, agli antipodi di quella coltivata, ad esempio, in quegli anni da Julius Evola[47]. “L’alta montagna è luogo propizio al manifestarsi dell’impersonalità attiva, in quanto ci abitua ad un’azione che fa a meno degli spettatori, e di un eroismo che rifugge dalla retorica e dal gesto”.
Nell’iconografia della stampa periodica prevale invece decisamente la versione “tragico-spettacolare” dell’immagine della montagna. In tutta l’Europa sono diffuse già a partire dalla metà dell’Ottocento riviste “specializzate” come la Revue des Deux Mondes o il Giornale illustrato dei viaggi, o semplicemente popolari come Le Petit Journal e Le Petit Parisien in Francia, o La Tribuna illustrata e più tardi La Domenica del Corriere in Italia, che giocano sugli effetti di richiamo emozionale delle immagini di copertina: e la montagna, soprattutto i drammi che vi si consumano, si presta benissimo sotto questo profilo a suscitare forti sensazioni e ad alimentare altrettanto forti polemiche. I periodici illustrati dell’epoca ci vanno a nozze, proponendo tutte le possibili varianti della tragedia, corde spezzate, valanghe, assideramenti, ecc…, senza trascurare i pericoli legati alla fauna selvatica, assalti di lupi, aquile che rapiscono bambini, orsi, persino stambecchi impazziti. Riesce difficile oggi, a palati assuefatti a vivere in diretta gli eventi più drammatici e spettacolari, valutare il peso enorme che questa iconografia ha nella creazione di una sensibilità “borghese” o popolare per la montagna, quella che dopo la metà dell’ottocento rimpiazza l’aristocratico understatement dei touristes inglesi. Anche se qualche volta, molto più raramente, vengono celebrate le imprese alpinistiche, con bandiere nazionali sempre in bella vista, e durante i conflitti vengono raccontate le audaci imprese degli alpini, dei Chasseurs des Alpes o dei Kaiserjager, la reiterazione dell’immagine drammatica contribuisce a creare una distanza tra quel mondo di pazzi e di incoscienti che vanno a rischiare la pelle e il mondo normale; anziché avvicinare le masse alla fruizione alpinistica della montagna, le allontana. E nello stesso tempo, quando agisce in positivo, quando cioè crea interesse e curiosità, lo fa soprattutto negli animi più irrequieti, e prepara la strada ad una concezione “eroica” che tornerà a rappresentarsi la montagna come nemica.
Esemplare è la vicenda del Cervino. La tragedia della cordata di Whymper viene enfatizzata tanto dalla stampa inglese, che come abbiamo visto si fa portavoce della preoccupazioni per l’insana passione dei giovani britannici, sia da quella continentale, per motivi meno nobili: gli italiani per sottolineare che la vera vittoria è quella di chi è salito e ridisceso indenne, i francesi, gli svizzeri e i germanofoni per stigmatizzare come le richieste dei clienti britannici siano sempre più esasperate e la loro incoscienza di fronte al pericolo metta a repentaglio le vite delle povere guide. Gustave Doré dipinge un paio d’anni dopo la Sciagura sul Cervino, un dittico nel quale al momento della gloria e della superbia fa drammaticamente da contraltare quello della tragedia, rappresentata quasi come una punizione inflitta dalla potenza della montagna ai piccoli esseri umani che l’hanno profanata. È una sorta di prototipo al quale faranno riferimento tutti gli illustratori successivi, che tradurranno in un linguaggio iconico semplice e stereotipato la percezione romantica del mistero e del rischio. Lo faranno come portavoce di un perbenismo borghese che rifiuta l’idea del pericolo corso gratuitamente, ma nell’accondiscendere alla fame di spettacolarità dei lettori contribuiranno a costruire attorno alla montagna e ai suoi sfidanti un’aura in cui si mescolano pazzia, coraggio e sprezzo del pericolo, e della quale in fondo l’ambiente alpinistico si compiace. Tanto che ad un certo punto, da Lammer in poi, la farà volutamente propria.
La montagna colonizzata
Nel corso dell’800 le Alpi diventano il “terreno di gioco dell’Europa”, secondo la definizione di Leslie Stephen[48]: in realtà sono per tutta la prima metà del secolo, e quasi sino alla fine della seconda, il terreno di gioco dei rampolli dell’aristocrazia e della borghesia d’oltremanica a caccia delle emozioni offerte dal nuovo “turismo di montagna”. Ma a partire dagli anni sessanta comincia a cambiare il significato che al gioco viene dato: il “turismo di montagna” lascia il posto all’alpinismo. Nello stesso anno in cui Whymper vince il Cervino una cordata britannica scala il versante italiano della Brenva, e poco dopo è la volta della parete est del Rosa. Non si cercano più le cime, ma le vie più ardite alle cime; non ci si accontenta più di salire le normali al semplice scopo di raggiungere la vetta e gustare il panorama, ma ci si rivolge ai versanti ed alle pareti vergini, e ciò, assieme ad una professionalizzazione di sempre maggior livello delle guide, e successivamente anche alla rinuncia alle guide stesse, sancisce il passaggio dall’esplorazione allo sport. Il livello delle difficoltà affrontate sale dal terzo al quarto grado superiore, e l’attenzione si sposta sulle grandi pareti glaciali nelle Alpi Occidentali e su quelle di roccia delle Dolomiti. L’approccio sportivo ha ragione anche di quelle cime che per la loro difficoltà non erano state salite nel periodo precedente (il Dru, il Grépon, la Torre Winkler, ecc…).
I nomi associati a questi prime sono quasi tutti inglesi: ma Whymper, Mummery e gli altri britannici che una dopo l’altra cancellano l’inviolabilità delle vette alpine non si muovono in un’ottica “nazionale”. Sono battitori liberi, fieri senza dubbio di essere inglesi, convinti che solo gli inglesi possano riuscire in certe imprese: ma rappresentano se stessi. Anche in questo senso però le cose stanno cambiando, e lo si vede proprio in occasione dell’assalto all’ultima grande vetta. Nella gara per il Cervino, infatti, vinta da Whymper sulla guida valdostana Jean-Antoine Carrel per poche ore, la competizione si è spostata dal piano individuale a quello nazionale. I due nuovi stati formatisi tra il ‘60 e il ‘70, l’Italia e la Germania, devono inventarsi un’identità e sono determinati a riconsacrare in senso nazionalistico il “patrio suolo”, calpestandone in prima esclusiva ogni zolla. Mentre dietro Whymper non c’è nessuno, e al suo fianco ci sono spesso dei dilettanti incoscienti (anche se tra le vittime della caduta durante la discesa dal Cervino figurano una guida particolarmente esperta e uno degli alpinisti più forti dell’epoca, il reverendo Hudson), dietro Carrel c’è un futuro ministro delle finanze, che oltre a praticare l’alpinismo in proprio (è tra i primi salitori del Monviso) vede nel tricolore issato sulle poche vette ancora inviolate una via alla costruzione di un’identità italiana “forte”. Sarà proprio Quintino Sella a volere la fondazione del Club Alpino italiano, e a conferirgli i crismi di una istituzione che rappresenta un intero popolo e soprattutto una nuova “nazione”.
La vittoria di Whymper è per gli italiani un vero schiaffo: avevano preparato con ogni cura il tentativo alla montagna-simbolo dell’alpinismo, arrivando anche a soffiare all’inglese la migliore guida in circolazione. Ora debbono accontentarsi di “andare a issare lassù la nostra bandiera – come scrive Felice Giordano a Quintino Sella – altrimenti saremo non solo battuti, ma anche beffati”. L’abate Amé Gorret, uno dei partecipanti al tentativo dal versante italiano che viene ripetuto a tre soli giorni dalla prima scalata, dice: “Andavamo volontari per riscattare l’onore del nostro paese, era una spedizione di vendetta nazionale”.
Questo atteggiamento esasperato finisce per stravolgere tutte le regole che fino ad ora avevano governato la “competizione” alpina. La necessità di far risultato ad ogni costo diventa tale che qualche anno dopo, nel 1882, il Dente del Gigante verrà conquistato da una cordata italiana (tra l’altro, tutti membri della famiglia Sella) dopo che un gruppo di guide ha attrezzato per giorni il percorso: tanto che alpinisti come Mummery, che avevano tentato invano in precedenza la salita, parlano chiaramente di “un imbroglio”, e stigmatizzano il ricorso tipicamente italiano alle furberie.
Al di là della vicenda Cervino, che il clima sia cambiato lo dimostra proprio il passaggio a metà secolo dalla fase totalmente dilettantistica dell’alpinismo a quella organizzata. È questo infatti il periodo in cui nascono i vari club alpini nazionali: il primo è naturalmente quello inglese (1857), seguito nel volgere di poco più di un decennio da quelli svizzero, italiano, austriaco e tedesco. Ma mentre nel caso degli inglesi, che per le Alpi possono nutrire solo un interesse sportivo, lo spirito rimane quello ludico, di un consesso di aristocratici e dandy disponibile ad accogliere chiunque se lo sia meritato (e ne abbia i mezzi, perché la quota di iscrizione è piuttosto salata), indipendentemente dalla nazionalità, per gli altri entrano in ballo i motivi legati alla recente unificazione (per italiani e tedeschi), ad una sorta di diritto di prelazione (svizzeri) o addirittura all’urgenza di un riscatto di fronte a gravi rovesci internazionali (francesi e austriaci). Gli eccentrici dilettanti inglesi lasciano quindi gradualmente il posto ad una nuova generazione alpinistica, soprattutto germanica e italiana, tecnicamente e spiritualmente agguerrita, che dalla lotta con l’Alpe di Guido Rey passerà rapidamente alla lotta per l’Alpe. Le Alpi diventano lo scenario di una gara i cui protagonisti, a dispetto delle forti personalità individuali, devono portarsi in vetta il ruolo e le responsabilità di simboli nazionali, nei quali interi popoli si identificano; ma soprattutto di una competizione che ad un certo punto non avrà più come obiettivo una presa di possesso ideale, ma una rivendicazione fisica e politica.
La propaganda dei club alpini rivela da subito il nuovo “intento civile”. A quasi vent’anni dalla fondazione del club alpino italiano Quintino Sella scrive: “La nostra gioventù dell’Alta Italia mi pare da qualche anno più robusta, più ardita, più virile: all’ozio della città, nella state, sostituisce ormai l’aria pura dei monti, le ascensioni difficili, ove ci s’impara a indurare nelle fatiche ed a sentirci solidali”. La “politica alpina” mira a creare una classe dirigente dinamica e coraggiosa, dei lavoratori robusti, dei cittadini e dei soldati animati da amor di patria e cameratismo: e in tal senso sarà rivolta, a partire da fine secolo e limitatamente alle aree del primo sviluppo industriale, anche alle classi inferiori e al proletariato, con l’ulteriore intento di combattere l’alcoolismo diffuso e di promuovere abitudini di vita più compatibili con le esigenze del nuovo modo di produzione.
Anche il Club francese, che nasce immediatamente dopo la disfatta del 1870, manifesta nella sua carta d’intenti il proposito esplicito di “strappare i giovani all’ozio snervante delle città, condurli in montagna ed educarli mediante sane emozioni al culto della bellezza e della libertà, all’amore del sacro, della terra natale e delle sue meraviglie”. In questo senso tra le iniziative più caldeggiate c’è proprio quella della organizzazione di “carovane scolastiche”, gite o soggiorni in montagna che portino gli studenti a contatto diretto con la natura, con la fatica, con il senso del dovere e della disciplina. Il successo di queste iniziative sarà però scarso, e in Francia l’alpinismo organizzato rimarrà a lungo una pratica per pochi iniziati, reclutati, come in Inghilterra, attraverso una selezione in funzione delle ascensioni effettuate, sia pure su una base sociale più larga. Alla vigilia del primo conflitto mondiale il numero degli iscritti al sodalizio non supererà i settemila, contro gli oltre centomila dell’omologo tedesco.
Il risultato è che, nato in un contesto politico difficile e da uno scatto d’orgoglio patriottico, il club alpino francese si avvia a vivacchiare per mezzo secolo come un’istituzione di seconda serie, riflettendo in ciò lo scarso interesse che i francesi mostrano per il turismo alpinistico delle loro valli, almeno sino all’avvento dello sci. Il ritratto dell’alpinista che i francesi hanno presente è piuttosto quello disegnato da Alfonse Daudet in Tartarino sulle Alpi[49] che non quello dell’eroe conquistatore: “Sdirenato, la testa vuota come una zucca, le gambe ciondoloni, cadeva da tutte le parti, e le guide dovevano prenderselo una da un lato una dall’altro, e sostenerlo portandolo a braccia fino alla fine del muraglione di ghiaccio”. Dove in realtà il sarcasmo è rivolto, oltre e più che alla spacconeria dei connazionali, a quei gentlemen inglesi che inanellano cime una dietro l’altra per il solo gusto di spuntarne i nomi dalla loro lista: “Il pensiero di essere ammirato su quella vetta da tutti gli alpinisti di laggiù, le misses, il riso e le susine illustri coi loro occhialini occhialoni e cannocchiali puntati su di lui, richiamarono d’un colpo Tartarino alla coscienza e alla grandezza della propria missione. Saltò in piedi, e strappata dalle mani della guida la bandiera di Tarascona, la fece sventolare una due tre quattro cinque volte; ficcò quindi la piccozza dentro la neve, ci si mise a sedere sopra colla bandiera spiegata nel pugno e la faccia superba e calma: marmorea. Era sul tetto del mondo”.
Lo stesso Daudet ci aiuta però a comprendere l’atteggiamento “rilassato” dei francesi nei confronti della montagna: “Se mai avete trascorso una notte sotto le stelle sapete che, quando si dorme, un misterioso mondo si desta dalla solitudine e dal silenzio. Tutti gli spiriti della montagna vagano liberamente, e vi sono nell’aria fruscii, impercettibili rumori, quasi si udissero i rami crescere, l’erba spuntare. Di giorno sono gli esseri a vivere, di notte vivono le cose. Quando non si è abituati, si ha paura”. Tradotto in musica, questo è Debussy: è una concezione armonica, leggera, malinconica della vita, quella di un popolo che dopo Luigi XIV e Napoleone non ha più da dimostrare nulla, e soprattutto non ha più voglia di farlo. Confrontiamolo con questo brano di Lammer: “Che bel ritmo già in questa suddivisione di salita, riposo in vetta e discesa, la quale ultima può essere altrettanto ricca di tensione e di esperienza quanto la salita! L’epica serena si dilata nella drammatica tempestosa, indi la dolce e solenne lirica della cima, poi ancora lotta drammatica che si attenua in un finale epico-lirico […] Non si tratta di un’armonia a buon mercato: i pinnacoli più bizzarri, gli abissi più terrificanti, l’ululato della tempesta più violenta, le valanghe annientatrici si compongono in un’unità perfetta col più dolce raggio di sole, col velo più tenero di nebbia […]” Questo è Wagner: una visione conflittuale, eroica e tragica; quella di chi invece sente di dover dimostrare molto, a se stesso e al mondo.
I francesi hanno quindi nella seconda metà dell’800 una concezione “debussiana” della montagna, e sostanzialmente l’hanno mantenuta tale sino ad oggi. Ciò non toglie che la frase pronunciata da Pierre Gaspard al compimento della conquista della Meije (1877), unica impresa di rilievo a firma d’oltralpe in tutto l’ottocento: “Non saranno delle guide straniere ad arrivare per prime!”, sia la stessa che avrebbe voluto poter incidere Carrel sulle rocce sommitali del Cervino.
Nell’area germanica, al contrario, in entrambi gli atti di fondazione dei due diversi club (quello di Vienna e quello di Monaco, che di lì a poco saranno riunificati in un organismo unico, il DÖAV (Deutscher und Österreicher Alpenverein), si insiste su una presa di distanza dalle motivazioni politiche: il movimento alpinistico più forte è in effetti inizialmente quello austriaco, ispirato ad una concezione dell’alpinismo molto intellettualistica e ristretto ad una frequentazione altoborghese, che non trova grossi stimoli nazionalistici nella difesa dello status quo praticata dall’impero asburgico. Ma anche la “scuola di Monaco”, che ha una connotazione decisamente più “sportiva” e tende a facilitare e a propagandare l’avvicinamento alla montagna (impegnandosi ad esempio nella costruzione di rifugi), propugna un cameratismo che nasca sulla parete, e non negli uffici dell’anagrafe.
In realtà poi le implicazioni politiche sbucano fuori da ogni parte, prima tra tutte la rivendicazione dell’appartenenza storica delle Alpi orientali all’area germanica, opposta al nascente irredentismo italiano. Dopo la fusione tra i due sodalizi il club alpino diventa per forza di cose veicolo di un pangermanesimo declinato inizialmente solo nell’accezione “culturale”, ma destinato a tradursi in breve tempo in una istanza politica. In Austria inoltre è da subito forte la componente ideologica razzista, che riflette il sentimento della superiorità tedesca diffuso nell’impero delle undici etnie, e che si manifesta naturalmente nell’antisemitismo. Nello statuto del club vengono introdotti già ai primi del novecento, in largo anticipo rispetto alle leggi razziali naziste, dei “paragrafi ariani” che impediscono l’iscrizione agli ebrei. Il tentativo di creare una sezione staccata ebraica, che raccoglie migliaia di adesioni, viene liquidato con l’espulsione di tutti i “non ariani” dal club.
Il club alpino tedesco diventa in sostanza, a dispetto dell’apoliticità professata, la prima palestra delle ideologie razziali che vanno maturando nella Germania wagneriana ma più ancora nella Vienna di Karl Lueger, e che si sostanziano attraverso una lettura assolutamente forzata e impropria della filosofia di Nietzche. La montagna offre il pretesto per un arroccamento in “sfere non inquinate dall’impurità del moderno[50], dalla piatta uniformità della massa”; salire è approssimarsi al regno della divinità, marcare le distanze soprattutto nei confronti di coloro che sono ritenuti i subdoli portatori della disgregazione dei valori: “Mentre la nostra civiltà priva di cultura disintegra e isola ogni cosa, nella grande natura alpina che respira in Dio ogni singolo essere si fonde in un cosmo”[51].
Mentre i diversi club alpini conducono per conto dei contrapposti nazionalismi una sorta di guerra a bassa intensità, il loro monopolio, se non sulle vette almeno sul terreno montano, subisce la concorrenza di altre organizzazioni, religiose e laiche, socialiste o conservatrici. In palio c’è il controllo di un numero sempre più significativo di persone, soprattutto di giovanissimi, che attraverso la scolarizzazione, il servizio militare, il recupero di tempo libero consentito dalle nuove professioni, la velocizzazione e la maggior facilità negli spostamenti, possono essere opportunamente guidate a scoprire il fascino della montagna, sottraendo l’alpinismo alla sia pur recente tradizione aristocratica ed elitaria. La soddisfazione espressa da Sella ricalca quasi parola per parola i propositi enunciati dall’Abbé Gorret, quello che abbiamo incontrato nella seconda salita al Cervino, che sostiene che l’andare per monti deve “sottrarre i giovani ai piaceri, ai divertimenti e alle gozzoviglie snervanti delle città”. Nascono, come abbiamo già visto, a margine del crescente movimento socialista e in opposizione all’alpinismo istituzionalizzato del club, associazioni sportive ed escursionistiche operaie: ma quelle che conoscono un maggiore successo e avranno per il futuro un peso importantissimo sono le associazioni giovanili.
Il movimento associazionistico giovanile più rilevante e più precoce è quello tedesco. Nel risorto Reich è lo stato stesso a creare direttamente o a ispirare attraverso la scuola e l’esercito la nascita di associazioni che cementino il cameratismo, inculchino e pratichino l’amor di patria e trasmettano una mentalità e un’educazione di tipo militare. Ma si sviluppa anche, già nei primissimi anni del novecento, una forma di associazionismo spontaneo, la Jugendbewegung, che recluta i suoi associati tra gli studenti delle superiori e che almeno nella fase iniziale riesce a mantenere una reale autonomia, scegliendosi i capi tra i giovani stessi. Una delle attività preminenti dell’associazione è quella escursionistica, da praticarsi appena possibile nella zona alpina e intesa come forma di autoeducazione alla natura, ma soprattutto come fuga dalle città e dalle famiglie. La spontaneità di questi sodalizi ha vita breve: la prima guerra mondiale chiama la gioventù a ben altre esperienze, e consente alle istituzioni di assumerne il controllo; dopo l’avvento del regime nazista finiranno fagocitate nel programma di addestramento e indottrinamento della gioventù hitleriana, o saranno soppresse.
La risposta inglese alla Jugendbewegung è lo scoutismo. A differenza di quella tedesca l’associazione creata da Baden-Powell non lascia nulla allo spontaneismo, ha anzi un ordinamento gerarchico e paramilitare. Inoltre non contempla, per ovvie ragioni, attività negli scenari alpini. Ma combinando l’educazione al contatto con la natura e allo spirito avventuroso con lo spirito di gruppo prepara, oltre che i dominatori coloniali, i futuri partecipanti alle grandi spedizioni himalayane. Il corpo degli scout, costituito a partire dal 1907, dopo soli due anni dopo accoglie anche le ragazze. L’apertura al mondo femminile è una caratteristica che sul continente rimarrà riservata alle associazioni di ispirazione confessionale o a quelle socialiste, mentre l’associazionismo laico rimane più maschilista.
In Italia la politica del CAI, almeno per quanto concerne la frequentazione sportiva della montagna, è pur sempre quella dell’associazione elitaria, anche se non manca la promozione dell’escursionismo popolare. Un’altra istituzione detiene nella penisola il controllo del mondo giovanile, ed è la Chiesa. La Chiesa, come abbiamo già sottolineato raccontando dei moltissimi abati e preti che partecipano alla prima fase dell’esplorazione delle vallate e dei ghiacciai alpini, manifesta un precoce interesse per il fenomeno di disincantamento e rivalorizzazione secolare delle montagne, paradossalmente riempiendone di croci e madonnine le cime. Questo interesse rimane vivo e induce diversi religiosi alla pratica alpinistica anche nella fase successiva, nella seconda metà dell’Ottocento e nel nuovo secolo: è sufficiente ricordare, tra moltissimi altri, oltre all’Abbé Gorret, l’Abbé Henry, alpinista formidabile[52], il prete-geologo-alpinista Antonio Stoppani e lo stesso don Eugenio Ratti, il futuro Pio IX, che compie diverse nuove ascensioni e che cercherà anche in tutti i modi di farsi accogliere nella spedizione polare del duca d’Aosta. Negli anni venti del novecento una delle figure più limpide del cattolicesimo laico e dell’antifascismo militante, Piergiorgio Frassati, sarà un alpinista appassionato. Questa frequentazione, come quella dei primordi dell’alpinismo, non rimane legata ad una passione individuale ma si sostanzia di una specifica finalizzazione educativa.
In questo senso la chiesa parte da una posizione di vantaggio: dispone di tutta una serie di punti d’appoggio, monasteri, abbazie, conventi, eremi, ospizi, oratori e canoniche sparsi alle pendici o spesso nella parte più alta delle vallate alpine, che supportano l’educazione e il convogliamento ad una pratica escursionistico-alpinistica molto allargata, ospitando gruppi parrocchiali provenienti anche dalle città della pianura. La maggior parte dei giovani che si accostano alla montagna sino a tutta la metà del ‘900, anche nel periodo fascista, lo fa attraverso questo tramite.
La concezione di base di tutte queste forme associazionistiche è la stessa che si era andata affermando già dal Settecento, a partire da Haller e da Rousseau: quella di una montagna risanatrice, spiritualmente e fisicamente, che educa al culto della bellezza, dell’ardimento, della lealtà e dell’amicizia. Cambiano invece le finalità rispetto alle quali viene declinata. La cultura cattolica dà naturalmente un’interpretazione molto più soft del rapporto con la montagna: mentre l’alpinismo classico si carica di valenze nazionaliste e si nutre di ideologie superomistiche, l’alpinismo cattolico si caratterizza come un alpinismo spirituale, pacifico; non propugna la lotta contro la montagna, ma la lotta che l’alpinista ingaggia quasi con il suo corpo, con il peso delle sue debolezze che lo tira verso il basso. A fronte della ricerca del rischio assoluto e dello sprezzo del pericolo, esaltati dalla scuola austro-tedesca, o del gioco temerario e un po’ incosciente dell’interpretazione anglosassone, l’alpinismo cattolico si caratterizza come un alpinismo della prudenza: “L’alpinismo vero non è già cosa da scavezzacolli, ma al contrario tutto e solo questione di prudenza, e di un po’ di coraggio, di forza e di costanza, di sentimento della natura e delle sue più riposte bellezze” scrive il futuro papa Pio XI.
Anche l’alpinismo inglese, che mantiene un profilo distaccato e superiore fino a che si tratta di Alpi, non tarda ad assumere una connotazione e una valenza “politica” quando il “gioco” si trasferisce dall’Europa all’Asia. Ai confini dell’impero coloniale l’assalto alle montagne entra a far parte tacitamente della strategia britannica di difesa “attiva”, basata sulla costante dilatazione delle zone di rispetto attorno alle aree direttamente governate. L’Himalaya diventa quindi “affare inglese”, e i suoi esploratori sono tutti quanti, più o meno consapevolmente, agenti di quello che viene appunto definito il “grande gioco”.
La diversione rispetto alle Alpi è peraltro già iniziata sin dagli anni ‘60, con l’avvio della esplorazione sistematica delle montagne del Caucaso[53]. Anche in questo caso, trattandosi di un’area di confine dell’impero russo, che sino alla prima guerra mondiale è appunto il rivale del dominio britannico nel “grande gioco” sullo scacchiere asiatico, l’interesse alpinistico si porta appresso dell’altro. Lo stesso vale per i primi approcci alle montagne africane, ai Monti della luna (la catena del Ruwenzori) raggiunti da J. H. Speke già negli anni cinquanta e visitati poi da Stanley alla fine degli ottanta. Dietro la ricerca delle sorgenti del Nilo c’è la corsa a “segnare” la maggior parte possibile del territorio, e la conquista delle vette lascia un segno particolarmente visibile, marca un diritto di prelazione su tutto ciò che di lassù lo sguardo può abbracciare. Al di là di questo, comunque, è lo spirito stesso dell’alpinismo a mutare: se Mummery era ancora un solitario e romantico vagabondo delle cime, Mallory, Irvine e tutti gli altri dopo di loro si muoveranno nel contesto di grandi spedizioni volute, organizzate e finanziate direttamente dai governi o da istituzioni culturali che a questi ultimi fanno capo.
Mondi e monti lontani
Fino alla prima metà del Settecento della regione himalayana si sapeva poco o nulla: l’area era resa praticamente inaccessibile, oltre che dalla conformazione del territorio, da impedimenti religiosi e politici, ed era rimasta quindi sempre esclusa dagli itinerari commerciali del medioevo. Le prime notizie attendibili si hanno a partire dagli inizi del settecento, quando la catena viene attraversata dal padre gesuita Ippolito Desideri, probabilmente il primo italiano ed europeo a mettere piede nel Tibet in tempi moderni, e comunque senz’altro il primo a lasciarne traccia. Il padre è inviato dalla Compagnia al di là dell’Himalaya per verificare le antiche notizie relative all’esistenza di una comunità cristiana in quelle zone. Naturalmente non trova alcun riscontro di una precedente evangelizzazione, ma da buon gesuita impara il tibetano, visita e studia a fondo le regioni del Kashmir e del Tibet e ne produce una descrizione che per i tempi è molto precisa.
Per una conoscenza più approfondita occorre però attendere la metà dell’800[54], quando il Servizio Geologico dell’India avvia un imponente lavoro di rilevazione a fini strategici di tutta la zona confinaria settentrionale della colonia indiana (con una decisa tendenza a sconfinare), che porterà a una determinazione abbastanza esatta dei lineamenti geografici della regione. È in questa occasione che viene data per la prima volta notizia dell’Everest (1856), mentre viene compiuta nel Karakorum la rilevazione del K2 ed ha luogo (nel 1861) la prima vera e propria spedizione sul ghiacciaio del Baltoro.
A precedere o a completare il lavoro del servizio geologico ci sono naturalmente le iniziative di esploratori e avventurieri, private o commissionate dal governo coloniale. Tra i primi i fratelli tedeschi Hermann, Adolf e Robert Schlagintweit, discepoli di Humboldt, che dopo essersi fatti le ossa nelle Alpi scalando il Monte Rosa ricevono dalla Compagnia delle Indie l’incarico di una prospezione generale dei sistemi montuosi che chiudono a nord il Deccan. Durante l’esplorazione dell’Himalaya, nel 1854, Adolf e Robert raggiungono sul monte Kamet la ragguardevole quota di 6770 metri. Adolf prosegue poi da solo e viene ucciso nel Turkestan, mentre gli altri due fratelli fanno ritorno in patria e scrivono una relazione dei loro viaggi che suscita nel mondo germanico una curiosità, non solo sportiva.
Le esplorazioni a carattere dichiaratamente alpinistico hanno inizio più tardi, verso la fine del secolo. Con la conquista nel 1882 della prima vetta nel Karakorum, il Pioneer Peak (6890 m) da parte di William Conway, ha inizio una vera e propria gara a battere i record di altitudine. L’anno successivo la spedizione Graham al Nanda Devi ha ancora un carattere misto scientifico-alpinistico, ma non manca di corteggiare una delle vette più alte e delle montagne più belle della catena himalayana. Ormai si punta decisamente agli ottomila. Nel 1895 è lo stesso Mummery a guidare una spedizione al Nanga Parbat; raggiunge e supera quota settemila, ma muore poi con due sherpa nel tentativo di passare sull’altro versante. Con questa tragedia il Nanga Parbat inaugura la sua sinistra fama: prima di essere conquistato, nel 1953, ha già fatto trentun vittime. Al volgere del secolo è ancora un alpinista inglese, Douglas Freshfield, ad effettuare il primo periplo documentato del Kangchenjunga: con lui c’è, come fotografo ufficiale, l’italiano Vittorio Sella.
Un’altra montagna tanto appetita quanto maledetta è il K2. È stata raccontata nella sua bellezza solo alla fine degli anni ottanta, dal colonnello Younghusband, il primo a forzare il passo Mustang nella sua marcia su Lhasa, e conosce già un tentativo di ascensione nel 1902, da parte di Aleister Crowley e di Oscar Eckenstein; la spedizione arriva ad una quota di circa seimilaseicento metri, ma è costretta a ritirarsi per il maltempo[55]. Nel 1909 una spedizione italiana guidata dal duca degli Abruzzi, ed accompagnata dall’immancabile Vittorio Sella, scopre una via di salita lungo lo sperone est della montagna, ancora oggi noto come “Sperone degli Abruzzi”. Ripiega poi sul Chogolisa, senza raggiungere la vetta ma arrivando a settemilacinquecento metri, primato di altitudine dell’epoca. Il Karakorum diventa la catena degli italiani, presenti ancora negli anni immediatamente successivi con spedizioni esplorative dirette da Mario Piacenza e da Filippo de Filippi.
Non c’è però solo l’Himalaya. La fine del secolo vede una corsa affannosa a porre il sigillo su tutte le vette di un qualche rilievo sparse per il mondo. Nell’America settentrionale la prima ascesa del Mc Kinley viene effettuata (spedizione Hudson Stuck) nel 1913[56], mentre nel 1897 una spedizione del Duca degli Abruzzi ha salito con condizioni climatiche proibitive il Monte Saint Elias (la prima ripetizione si avrà solo cinquant’anni dopo).
In quella meridionale la vetta dell’Aconcagua, dopo essere stata tentata già nel 1883 da una spedizione tedesca (del geologo ed esploratore Paul Gussfeld, che arriva a 6.500 m), è raggiunta per la prima volta dalla guida svizzera Matthias Zurbriggen, membro di una spedizione britannica (Briton Edward Fitzgerald).
In Africa il primo europeo ad esplorare a fondo il massiccio del Ruwenzori è Henry Morton Stanley, nel 1889, ma la cima è raggiunta solo nel 1906 dall’ennesima spedizione del Duca degli Abruzzi. Il picco Uburu del Chilimangiaro è salito invece già nel 1889 dai tedeschi Meyer e Purtscheller, subito dopo la creazione della colonia del Tanganika. La prima ascensione al monte Kenia è del 1899.
Il plateau sommitale dello Kinabalu, il monte più alto del sud-est asiatico, era stato raggiunto fin dal 1851 da un funzionario della amministrazione coloniale inglese, ma la vetta è toccata solo nel 1888.
Allo scoppio della prima guerra mondiale rimangono inviolate in pratica solo le vette himalayane superiori ai settemilacinquecento metri. Il limite non è nemmeno più psicologico, ma puramente fisico.
La guerra interrompe solo momentaneamente la corsa. Nel frattempo l’Himalaya ha inaugurato un modello di alpinismo che si è portato appresso motivazioni nuove: ma né l’uno né le altre, fino a secolo inoltrato, vengono accettati nell’ambiente alpinistico ortodosso. Quando nel 1920 si comincia a parlare di una spedizione “pesante” all’Everest, con una organizzazione quasi militare, nell’Alpine Club si grida allo scandalo. Si avverte che una cosa del genere chiuderà per sempre l’epoca dell’alpinismo classico, al quale, essendone stata quasi unica protagonista, l’associazione inglese è profondamente legata. In effetti è così, anche se i segni del cambiamento erano già avvertibili in quanto stava accadendo sulle Dolomiti.
Tentativi come quello di Mummery e quello di Crowley sono in fondo ancora la trasposizione dello spirito alpino in un ambiente diverso; ma quello del Duca degli Abruzzi appartiene già ad una dimensione e a uno spirito totalmente nuovi. Il teatro himalayano non presenta soltanto problemi tecnici, ma anche e soprattutto problemi logistici: le distanze, le altitudini, i tempi sono dilatati su una scala enorme, le possibilità di rifornimento sono remote, occorre soggiornare a lungo in quota, tanto per l’avvicinamento che per l’acclimatazione. C’è inoltre il problema della mancanza di ossigeno, e dei suoi devastanti effetti fisici e psicologici, e ci sono condizioni climatiche estreme, da sopportarsi per periodi lunghissimi. Si impone la necessità di una organizzazione per trattare con le autorità locali, per coordinare le linee di rifornimento, per organizzare i campi in quota e spingere sherpa e portatori sempre più in alto.
L’utilizzo di questi ultimi è qualcosa che cozza completamente con il contemporaneo rifiuto dell’uso delle guide sulle Alpi. E l’interazione con le popolazioni locali, insieme alla violazione di tabù, alla dissacrazione dei luoghi, porta ad un rivoluzionamento dei costumi e delle economie, alla rottura di equilibri, alla disgregazione culturale di mondi rimasti a lungo immobili, che proprio per le particolari condizioni ambientali sono spesso molto fragili e delicati. Infine, in queste imprese la prestazione del singolo individuo o della singola possibile cordata non hanno più senso: è la squadra a vincere, nel caso, è la disponibilità di attrezzature e materiali sempre migliori. È il trionfo dell’organizzazione e della tecnica. Hanno ragione di scandalizzarsi, gli aristocratici e conservatori membri dell’Alpine club: in effetti si tratta di qualcosa di completamente diverso da ciò che essi cercano e vedono nell’alpinismo.
Cambia anche l’immagine della montagna. L’Himalaya non viene conosciuto dagli occidentali con la preventiva mediazione della pittura, come le Ande e le Montagne Rocciose, ma direttamente attraverso la fotografia. E la fotografia, soprattutto quella in bianco e nero, la lastra al nitrato d’argento, rispetto all’immagine dipinta crea un’atmosfera decisamente più fredda. Nella pittura c’è rumore, nella fotografia c’è silenzio. Il dipinto parla, la fotografia mostra. Alle altitudini himalayane poi, anche quando la fotografia è in movimento, nelle prime immagini cinematografiche, si respira un’atmosfera diversa, in senso sia letterale che metaforico. I movimenti sono più lenti, ogni cosa appare ovattata: Mallory e Irvine che partono dall’ultimo campo, prima di sparire sull’Everest, sembrano muoversi sulla luna. Gli spazi, le dimensioni, sono enormi; al confronto quelli alpini, che tanto entusiasmavano nell’Ottocento, sono fazzoletti. E c’è la distanza: le Alpi in fondo per gli occidentali sono lì, alla portata di tutti. Come vedremo è sufficiente possedere una bicicletta per raggiungerle: le montagne asiatiche rimangono invece, almeno sino alla seconda metà del Novecento, un sogno proibito per quasi tutti. Sono tanto remote da poter ospitare mondi perduti, la favolosa Shangri-la o le dimore sotterranee dei mitici arii: ma appartengono alla dimensione del sogno, appunto, sono altro dalla quotidianità possibile dell’escursione o della scalata nel calcare o nel ghiacciaio.
Appena chiusa la parentesi bellica, in un periodo nel quale le altre potenze, vincitrici e vinte, si leccano le ferite, gli inglesi tornano dunque all’attacco. Dalla loro base indiana indirizzano verso l’Everest tre successive spedizioni, nel 1921, nel 1922 e nel 1924. Ma i tempi non sono maturi. Non è ancora previsto il ricorso all’ossigeno. Nel corso di un tentativo alla vetta lungo la parete Nord George Mallory ed Andrew Irvine, i due alpinisti più forti, scompaiono dopo aver superata la quota di ottomila e cinquecento metri. Il mistero della loro fine, e più ancora il dubbio su un loro possibile arrivo in vetta, alimenterà la letteratura alpinistica per tutto il secolo successivo. Ci sono anche polemiche, inevitabilmente: ma ormai, dopo il carnaio della guerra, le tragedie della montagna hanno un impatto ridimensionato. Si polemizza semmai sull’organizzazione, sulla logistica, sul mancato risultato: e le figure degli alpinisti diventano oggetto di una mitizzazione mediatica che gioca volentieri con le scomparse premature. In più, non ci si può tirare indietro proprio quando gli altri incombono. Alla fine degli anni venti tornano infatti nel Karakorum gli italiani, sia pure con missioni geografico-esplorative, quella di Aimone di Savoia Aosta nel 1929 e quella di Giotto Dainelli nel 1930. Nel 1934 una spedizione internazionale diretta dal geologo Dyrenfurth tocca le prime vette oltre i 7200 m, conquistando il Sia Kangri (7422 m). Ma, soprattutto, si muove la macchina da guerra alpinistica tedesca, in parallelo con quanto accade nel frattempo sulle Alpi.
Si comincia nel 1929 dal Kangchenjunga, che viene preso d’assalto per tre anni consecutivi, con il solo risultato di diverse vittime e di ritirate dovute a maltempo, malesseri o defezioni. Si cambia poi obiettivo: dal 1932 è la volta del Nanga Parbat. La prima spedizione non sale molto, ma torna casa integra. Due anni dopo, invece, nel 1934, il tentativo si conclude in tragedia, con la morte per assideramento di tre alpinisti, tra i quali Willo Welzembach, e di sei sherpa. I tedeschi ci riprovano nel 1937, con un enorme spiegamento di mezzi, che comprende anche l’uso dell’aviazione, ma l’esito è ancora una volta tragico: una valanga uccide sette alpinisti e nove sherpa. Si ripete nel 1938, e stavolta il nemico è il maltempo. Infine nel 1939 un’ennesima spedizione guidata da Heinrich Harrer, reduce dalla salita della nord dell’Eiger, è bloccata dallo scoppio della seconda guerra mondiale. Harrer stesso finisce in un campo di prigionia in India, dal quale evaderà per rifugiarsi in Tibet.
Alla fine degli anni trenta entrano in scena anche le spedizioni statunitensi. L’obiettivo è il K2. Nel 1938 raggiungono la quota di 7800 m, l’anno successivo toccano gli 8200 m, ma registrano anche la prima di una serie di vittime che faranno di questa montagna la più pericolosa del mondo. Poi è nuovamente guerra vera.
Sullo spostamento di interesse verso le montagne asiatiche, e in particolare verso la catena himalayana, non influiscono solo la ricerca di vette e terreni nuovi d’alpinismo (come potrebbe essere per il caso di Mummery) o la voglia di cimentarsi con altezze quasi doppie rispetto a quelle delle Alpi, o ancora gli interessi politici inglesi: agisce anche un clima spirituale e ideologico particolare, che caratterizza gli ultimi anni del ottocento e la prima parte del secolo successivo. Del nazionalismo abbiamo già parlato, e ci si tornerà ancora per quelli che saranno i suoi funesti sviluppi. Allo stesso modo si è fatto cenno a componenti ideologiche come il razzismo, anch’esse gravide di esiti drammatici. Ma accanto, e spesso a monte di queste, c’è una temperie più vaga e indeterminata, diffusa senza distinzioni nei diversi strati o ambienti sociali, quasi un presentimento del declino che incombe sull’Occidente. Nell’ambito artistico-letterario questa atmosfera prende il nome di Decadentismo, e il termine può essere esteso ad ogni aspetto del sociale: implica una pressante ricerca di senso, legata allo smarrimento di fronte ai primi cedimenti della certezza scientifica e ai primi conflitti sociali moderni. Comporta soprattutto un ostentato rifiuto della razionalità, e la ricerca di spiegazioni e di emozioni nelle pieghe oscure dell’occultismo, nella teosofia, nelle “corrispondenze” segrete e magiche. Tutto questo viene a combinarsi perfettamente con la necessità di costruirsi un’epica da parte dei popoli recentemente unificati, di giustificare la loro lunga assenza dal palcoscenico della storia, di riscattare o inventare una tradizione. Trova il terreno più fertile, naturalmente, in Germania: ma l’alone copre tutta l’Europa.
Nella seconda metà dell’800 si diffondono in tutto l’Occidente società esoteriche che fanno riferimento, nella simbologia e nella pratica, alla montagna. Una rete intricatissima di rimandi fa discendere dagli studi di indoeuropeistica coltivati da Schlegel, da Shopenhauer e da Max Muller l’elaborazione di una mitologia “ariana” e l’anelito a ricostruire l’unità perduta delle genti “arie”, la cui culla è identificata nelle montagne inaccessibili che stanno al centro dell’Asia[57]. Questo indurrà, a partire dai primi del novecento, molti europei (uno di questi è senza dubbio Crowley) a guardare alla zona himalaiana con un interesse che va ben oltre quello alpinistico. Soprattutto in Germania miti come quello del popolo della “terra cava” verranno fatti propri prima da società iniziatiche e poi addirittura dal regime nazista. Le spedizioni himalayane degli anni Trenta sono dettate principalmente dalla ossessiva volontà di Hitler di trovare una “fonte perenne di sangue ariano”, che contrasti la crescente ibridazione del popolo tedesco. È addirittura fondata la Deutsches Ahnenerbe (Eredità tedesca degli antenati), una società di studi che organizza in cinque anni più di cento spedizioni scientifiche, non solo in Asia, per effettuare ricerche storiche e archeologiche e studiare i costumi di gruppi etnici eredi presunti di antiche culture[58]. L’ultima di queste spedizioni è proprio quella che vede coinvolto Harrer.
Penne e piccozze
Dobbiamo ora fare nuovamente un passo indietro. Se agli inizi dell’800 si afferma una vera e propria “pittura di montagna”, che fiorisce nell’area del romanticismo nordeuropeo (inglese, tedesco e scandinavo) e viene rinverdita verso fine secolo dalle opere dei divisionisti italiani (Segantini in primis), a cavallo del secolo successivo nasce anche una “letteratura di montagna”. Anche se rimane confinata nel genere diaristico, adattato alla nuova formula del “récit d’ascension”, questa letteratura esercita un influsso notevole soprattutto sulle giovanissime generazioni, ed è destinata ad avere un impatto che prescinde dal reale valore artistico. Consente tra l’altro di leggere attraverso le diverse concezioni dell’alpinismo, e più in generale del rapporto con la montagna, ciò che va maturando nelle contrapposte culture europee. In questo senso due opere sono particolarmente significative, per il successo che hanno conosciuto, e quindi per l’influenza che hanno esercitato, e per la differente impostazione del rapporto.
La prima è Le mie scalate nelle Alpi e nel Caucaso (1895), di Albert Frederick Mummery, destinata ad essere il filtro di lettura dell’alpinismo per le giovani generazioni anglosassoni[59]. È un libro che più anglosassone non si può, pieno di humor e di autoironia, ma al tempo stesso capace di trasmettere una concezione “dilettantistica” nel senso più alto e più letterale del termine, quello di un puro piacere estetico e spirituale e di un rapporto insieme confidenziale, leale e riverente con l’ambiente. Mummery non ingaggia epiche battaglie, non ci pensa nemmeno a sfidare o ad attaccare la montagna: la studia e cerca “dolcemente” di salirla, anche quando, come nel caso del Grépon, di dolce la montagna non ha proprio nulla (ma Mummery la ripaga con la sua ironia, sintetizzandone così le successive immagini: una montagna inaccessibile; la più difficile scalata delle Alpi; una facile ascensione per signore!). Vuole divertirsi, rimanendo in armonia con un ambiente che gli piace, provando gusto nell’arrampicata e lasciando a valle ogni condizionamento o finalità ideologici. E ha della montagna una visione cosmopolita, che lo porterà infatti a cercare altre emozioni nel Caucaso prima e in Himalaya dopo (e a lasciarci la pelle). Non scala le montagne perché “deve”, per un imperativo categorico, ma perché sono lì, come avrebbe detto il suo discepolo Mallory: sono belle, promettono emozioni e allora tanto vale provarci. L’alpinismo come puro gioco, ma non per questo eticamente meno solido (o forse proprio per questo; la bellezza del gioco sta proprio e solo nel vincere rispettando le regole).
Mummery sarà anche uno dei primi a scalare senza guide, ma fino a quando lo fa col suo fidato e inseparabile Alexander Burgener non ha alcun ritegno ad attribuirgli la maggior parte del merito, anche se di fatto è in genere lui a guidare la cordata. Il tenore del racconto di Mummery, e verosimilmente il suo modo di vivere le situazioni, è questo: “La mia posizione stava diventando molto seria. È cosa nota (attestata da tutte le autorità ecclesiastiche delle valli di Susa, Zermatt e Anzasca) che chiunque ha scorto uno Spirito muore certamente entro le ventiquattro ore! Dissi a Burgener che, stando così le cose, non c’era alcun vantaggio a fare ritorno; infatti o si trattava veramente di Spiriti, ed allora fatalmente saremmo morti, o non si trattava di Spiriti, e allora potevamo benissimo proseguire il nostro cammino. Le guide accettarono il dilemma, ma espressero l’opinione che, anche nel caso peggiore, scalare una montagna con la prospettiva di essere buttati giù da uno Spirito malevolo non era precisamente un’allegria”[60].
Quello di Mummery è forse il momento più equilibrato e limpido della “conquista” delle montagne. La sua moderazione è senz’altro anche voluta; può tranquillamente minimizzare le imprese, ben sapendo che chi legge avrà poi modo di verificare direttamente la realtà e il livello delle difficoltà affrontate. Ma senza dubbio esprime e riassume al meglio lo spirito col quale per oltre un secolo i suoi connazionali, da Windham in poi, avevano percorso in lungo e in largo le valli alpine. “Sebbene forse l’alpinismo non sia più pericoloso di altri sport, suscita sicuramente un senso più vivo del pericolo, in verità del tutto sproporzionato rispetto al rischio reale”. Il suo understatement verrà attaccato violentemente dagli alpinisti di nuovo stampo sfornati dai club alpini tedeschi, quasi rappresentasse una forma di irrisione sprezzante per quelle vette e per quelle sfide mortali che stanno invece diventando per loro lo strumento di dimostrazione di una superiorità razziale. Con Mummery, che pure sotto molti aspetti è un innovatore e un precursore, possiamo davvero dire che si chiude l’alpinismo classico di conquista, quello la cui finalità era ancora raggiungere la vetta per la via più logica.
Ben diversa è infatti la concezione della montagna che troviamo in Fontana di giovinezza (1922)[61] di Guido Lammer, comparso un quarto di secolo dopo il libro di Mummery e intriso di forti tensioni ideali, di gusto estetizzante, di esaltazione virile. Intanto, prima ancora che come resoconto di imprese alpine il libro si propone come un saggio spirituale e filosofico. La montagna offre lo sfondo ideale a chi vuole confrontarsi col rischio, con la morte, con la solitudine, ma soprattutto con se stesso, con le proprie paure e con il proprio anelito al trascendente. “Per me il risultato supremo è il modo dell’attività sportiva, l’essere senza guida, il giocare la vita”. E rispetto a questo assunto la montagna è lo sfondo, appunto, un pretesto, un fichtiano non io cui contrapporsi per spremere da sé il meglio, per costruire la propria vita come un’opera d’arte. “Quasi ogni ascensione è un’opera d’arte vissuta, è come una materia già artisticamente formata: questo vale specialmente per le ascensioni grandiose, turgide di pericoli e d’avventura e soprattutto per i viaggi d’esplorazione”. Lammer non racconta la montagna: la interpreta. La montagna è il luogo non contaminato dall’azione uniformante dell’uomo e lontana dalle meschinità del mondo, lo scenario perfetto per compiere gesta eroiche, la palestra per la costruzione di una personalità superiore, che emerga dalla mediocrità della massa. “Non conosco altra attività umana la quale, come il cimento con le difficoltà della montagna, prosciughi spesso sino agli estremi residui e tenda variamente in mille nuove complicazioni tutte le energie del corpo e molte dell’intelletto e dell’anima. Difficilmente in altre circostanze i nostri sentimenti vengono così sconvolti, la nostra volontà così duramente forgiata come in questo duello col monte”. Tanto più è tale, quindi, quanto più è difficile, pericolosa, repulsiva. Non esiste una bellezza della montagna, quanto piuttosto la bellezza “artistica” del gesto compiuto in montagna. Questa tentazione di pensarsi come diversi rispetto ai comuni mortali, nel senso almeno di dotati di un coraggio, di uno sprezzo del pericolo, di una forza, di una resistenza superiore, ma anche di una sensibilità, di una purezza testimoniata dalla gratuità del gesto, dello sforzo e del rischio affrontato, appartiene in realtà a tutti coloro che praticano l’alpinismo, ma è di norma tenuta nascosta; qui viene invece proclamata come il senso ultimo dell’alpinismo. “Per una lunga vita, giovane e adulto, io ho venerato solo l’individualità, ho lavorato a scalpellare la mia personalità”.
Si van ben oltre la concezione sportiva, qui si parla di sfida esistenziale: «Ogni qual volta attraverso lo sforzo e il terrore riuscii a conquistarmi una prima ascensione oppure una nuova via, vidi splendere davanti a miei occhi queste parole di fiamma: “ora io sono diventato più forte dell’onnipotenza divina”». È evidente che Nietzsche ispira ogni singola parola del libro, e si potrebbe leggere Fontana di giovinezza come una sorta di compendio divulgativo del credo nietzschiano, in una interpretazione distorta, esasperata ed esaltata. La montagna è essenzialmente “nemica”, nella concezione di Lammer: e non nemica fredda e inerte, ma personificata: «nel centro dell’azione compaiono “eroi” veramente drammatici, uomini che lottano, soffrono, gioiscono […] ed avversari realmente drammatici, esseri demoniaci come nelle fiabe: la strega dei crepacci in agguato, il lanciatore di blocchi gigantesco, la fata malvagia delle valanghe, il mostro delle tormente, il mago della vertigine che stordisce i sensi, l’aquila delle folgori di Giove, i neri corvi delle nebbie di Wodan».
C’è anche una terza via, quella che trova forse la migliore espressione nell’austriaco Julius Kugy. Non a caso Kugy arriva alla montagna animato non dalla volontà di lotta ma dallo spirito scientifico, dall’amore per la botanica, né più né meno di quanto De Saussure o Dolomieu lo fossero da quello per la geologia: anche fisicamente non incarna l’immagine ascetica ed atletica propagandata da Lammer (è un omone massiccio e tozzo). Il titolo del suo ultimo libro, “Dal tempo passato”[62], riassume perfettamente la sua nostalgia per un’epoca, e non solo per una montagna, che appare nel ricordo ricca di certezze e densa di sentimenti genuini. La montagna non viene da Kugy né sfidata né dominata: è percorsa e vissuta con delicatezza e serenità, goduta e ringraziata per le gioie che offre, affrontata con il rispetto che merita, sempre in compagnia delle guide. La conquista della cima non è mai un’ossessione, non diventa un imperativo morale, anche perché Kugy ha altre passioni, la musica e la botanica in primis, che equilibrano ed armonizzano il suo sentimento.
Eppure quest’uomo ha salito, partendo dalle Alpi Giulie, nel corso di una serie innumerevole di campagne, tutte le vette più importanti della catena alpina. Il suo alpinismo, a dire il vero, non sembra tanto appartenere ad un altro tempo, quanto essere fuori dal tempo: è romantico, ma è anche positivo, è disincantato e talvolta distaccato, come quello inglese, ma è anche caldo, eticamente ispirato, portatore di valori come quello italiano o tedesco; solo molto più equilibrato. In opposizione a Lammer, che ringraziava l’alpinismo di avergli fatto “sorseggiare il più dolce dei godimenti che la vita possa offrire: aver bagnato le labbra alla coppa della morte”, egli scrive: “I monti non devono essere i nostri nemici. La base dell’alpinismo deve essere sempre il puro amore della natura e dei monti, un’intima penetrazione nella loro vita, nella loro essenza, nella loro anima. Certe arrampicate disperate che oggi si usano sono contrarie al mio modo di sentire. Io amo l’equilibrio, la salute, in una parola il bene della vita”[63]. Kugy rifiuta il concetto stesso di “sport alpino”, la ricerca delle difficoltà fini a se stesse, la conquista della vetta come affermazione personale e superomistica, per valorizzare invece la bellezza del camminare, del contemplare, del muoversi con lentezza sulla roccia e sul ghiaccio, per godere davvero di tutto ciò che un’ascensione può offrire. Per questo, al contrario di Lammer, che tra le due guerre risulta con Fontana di giovinezza l’autore più letto in Germania dopo Dio e Hitler, e dello stesso Mummery, che ai primi del Novecento è un autore di culto per gli alpinisti di tutto il mondo, anglosassone e non, Kugy rimane un autore “per pochi”: così come di pochissimi è rimasto il suo modo di rapportarsi alla montagna.
La guerra nell’Alpe
L’atmosfera che si respira in montagna ai primi del Novecento è dunque ben diversa da quella di un secolo prima. La rincorsa tedesca al recupero militare e industriale nei confronti dell’Inghilterra ha i suoi risvolti anche nell’alpinismo. La “corsa agli armamenti” si traduce nell’ingresso della tecnica nella pratica alpinistica. Il chiodo, il moschettone, la corda doppia, i ramponi, l’abbigliamento specialistico rivoluzionano le modalità dell’approccio e aprono ad una ulteriore ricerca delle difficoltà. A questo si aggiunge l’allenamento specifico e sistematico praticato soprattutto a partire dalla “scuola di Monaco”. L’età dell’oro dell’alpinismo classico di stampo inglese, che rifuggiva da ogni mezzo artificiale, si chiude per lasciare il posto all’età del ferro e della tecnica. Non senza polemiche, naturalmente: sulla liceità dell’uso del chiodo c’è un dibattito aspro, che vede da un lato i “puritani” come Paul Preuss, capace di scalare in libera assoluta il Campanile Basso, dall’altro chi è disposto a compromessi in nome della sicurezza o del “divertimento”. Naturalmente sarà quest’ultima posizione a trionfare, e da un timido uso delle corde e dei chiodi si passerà ben presto all’elaborazione di una vera e propria tecnica di arrampicata artificiale. Ma le polemiche sono anche legate alle sempre più accentuate rivalità nazionalistiche, che arriveranno all’esplosione con la prima guerra mondiale.
Ci sono due figure di alpinisti, entrambi marcatamente “italiani” che riassumono molto bene la coesistenza tra le diverse concezioni, le loro differenze e insieme il filo che le lega. E tanto più si prestano in quanto spesso e volentieri si ritrovano a scalare assieme.
L’alpinismo conservatore, rigorosamente praticato con le guide, concepito come pratica elitaria, è rappresentato da Guido Rey. Rey non può essere collocato tra i grandi alpinisti: o almeno, non è tra quelli che aprono vie e prospettive nuove. Arrampica con le guide (anche se quello di confessare la propria assoluta dipendenza dalle stesse appare un po’ un vezzo, perché in realtà compie alcune ascensioni non facili in solitaria) e mantiene un suo distaccato aplomb nei confronti della novità e della “trasgressione”, anche quando non disdegna il ricorso alle tecniche di arrampicata più recenti. È un pronipote dei Sella, “ricco e romantico”, come viene definito in una recente enciclopedia dell’alpinismo, che conosce prima e dopo il conflitto mondiale una grandissima fama, anche internazionale, tale da procurargli la qualifica di socio onorario dell’Alpine Club e la Legion d’Onore francese. La sua celebrità è legata senz’altro più ai suoi “récits d’ascension” che alle imprese in parete: opere come Alpinismo acrobatico (1914) sono per tutta una generazione alpinistica italiana l’equivalente di quel che rappresenta Fontana di Giovinezza per i tedeschi. Eppure, a rileggerle oggi, grondano retorica e lirismo declamatorio da ogni pagina, e non basta la giustificazione di un amore immenso per la montagna a riscattarle letterariamente.
Rey ha una concezione ottocentesca, aristocratica, dell’alpinismo. La montagna diventa nella sua rappresentazione un avversario mitico e proteiforme da sottomettere e l’alpinista un san Giorgio votato alla lotta e al sacrificio: la frase conclusiva della dedica di Alpinismo acrobatico: “Io credetti e credo nella lotta con l’Alpi utile come il lavoro, nobile come un’arte, bella come una fede” (che tra l’altro è stata il motto del CAI fino alla fine del secolo scorso) riassume perfettamente i valori che Rey si porta appresso nello zaino e che, praticati necessariamente al livello più alto nel confronto con la montagna, segnano lo spartiacque tra l’eroe semidivino e l’uomo comune: “Montanvert è il vestibolo di uno dei templi più grandi e più venerati dell’Alpi: il punto di contatto, la frontiera tra una piccola oligarchia di alpinisti e una grande repubblica di non alpinisti […] lì si incontrano quelli che scendono dalle pericolose cime con quelli che salgono dalla valle senza alcun desiderio di arrivare più in alto”.
Ad incarnare il nuovo atteggiamento, ribelle, polemico e dissacratorio nei confronti di ogni tabù, nessuno invece meglio di Tita Piaz, una delle più famose, forse la più famosa in assoluto, tra le guide italiane delle Alpi orientali. Intanto Tita è una guida molto particolare: sceglie lui i clienti, invece di essere scelto, fa solo le ascensioni che gli piacciono e chiarisce da subito che il protagonista sarà lui[64]. Poi non esita di fronte a nulla, per arrivare a quello che gli preme. Dopo aver realizzato una traversata volante tra la torre di Misurina e la Guglia De Amicis, quest’ultima mai violata, aggrappato come una scimmia ad una corda sospesa, così commenta: “Non ho mai preteso di negare per lo meno la comicità di un tale sistema di scalare le montagne; non ho mai chiesto che esso venisse preso sul serio, ho riconosciuto il più ampio diritto di critica a tutti: ma per l’amor del cielo, non lapidatemi se una volta ho dimostrato praticamente come Darwin non avesse avuto torto a spendere la sua vita per costruire l’albero genealogico della specie umana, cominciando dai gorilla”. Col che si fa una risata di tutte le polemiche, ma dice anche che ormai il fine giustifica qualsiasi mezzo[65].
Piaz testimonia però anche l’uscita della rivalità italo-tedesca dai limiti di una competizione sportiva: un po’ perché da buon valligiano di Fassa sente fortissima la contrapposizione di confine tra le due culture (e tra i due nazionalismi); un po’ perché è proprio la sua indole a ribellarsi al “perbenismo” e alla mistica che la concezione germanica dell’alpinismo va propugnando. Sempre a proposito della guglia De Amicis scrive: “I filistei mi gridarono addosso il loro piccino livore di omuncoli. I puritani dell’alpinismo videro nella pazzesca scalata un pericoloso pervertimento sportivo. I rocciatori seri fecero dell’ironia, dichiarando l’impresa funambolismo da palestra, indegna di un rocciatore come Piaz, ma i più ameni furono i nostri pangermanisti purosangue, i maschi vestali dell’intero progresso umano, che vi scorsero un’inequivocabile manifestazione di irredentismo, e proposero alla Sezione Centrale dell’Alpenverein delle sanzioni esemplari contro un simile ribaldo […]”.
La “guerra” sul fronte alpino (e alpinistico) comincia quindi ben prima del 1915, non conosce interruzione durante le operazioni militari vere e proprie e prosegue poi, è il caso di dire “con altri mezzi” e a dispetto di tutte le alleanze e simpatie politiche, nel ventennio che intercorre tra i due conflitti. In un primo momento, e limitatamente alle Alpi Orientali, l’iniziativa rimane nelle mani degli alpinisti di lingua tedesca, che come abbiamo visto privilegiano l’arrampicata tecnica, su roccia, veloce e verticale, rispetto alle lunghe ascensioni su ghiacciaio. Sino alla guerra personaggi come Preuss e Dülfer saranno in questo settore i dominatori assoluti, rinunciando, secondo i dettami della “scuola di Monaco”, a servirsi delle guide dolomitiche, superando il quinto grado e realizzando imprese che rapportate all’epoca appaiono incredibili, il primo senza alcun ausilio artificiale, il secondo facendone un uso “eticamente” tollerabile. Ad essi rispondono sul fronte italiano Piaz e Angelo Dibona, che al di là della qualifica conservano ben poco della figura della guida, e sono invece ormai alpinisti professionisti. Per questo breve periodo il vecchio e il nuovo convivono ancora, come accade per molti altri aspetti della società e della cultura.
La guerra rallenta naturalmente l’attività alpinistica, ma non rappresenta solo una parentesi di sospensione: crea infatti le condizioni per un diverso rapporto delle masse con l’ambiente montano. Dispiegandosi il fronte italo-austriaco essenzialmente nell’area alpina orientale[66], centinaia di migliaia di uomini che non avevano mai visto prima una montagna vera da vicino vengono a contatto loro malgrado con le Alpi e scoprono luoghi di una bellezza incomparabile. L’esperienza e l’occasione non sono di quelle che invoglino, ma qualcosa del fascino delle Alpi si trasmette: maledette o rimpiante, entrano comunque di prepotenza nell’immaginario popolare. Inoltre, la rilevanza strategica di valli e montagne fino a quel momento quasi irraggiungibili produce una moltiplicazione dei collegamenti, la costruzione di strade carrozzabili, ponti, gallerie che renderanno successivamente queste zone accessibili allo sport e al turismo. Allo stesso modo, la necessità di facilitare l’accesso delle truppe a posizioni dominanti porta ad attrezzare numerosissime vie ferrate, aprendo ad un tipo di fruizione che dieci anni prima sarebbe sembrata disonorevole e scandalosa.
Nell’immaginario patriottico entrano certamente, sotto l’impulso della propaganda bellica, le truppe di montagna, che per preparazione, addestramento e spirito di corpo costituiscono l’élite delle forze armate dell’uno e dell’altro schieramento. Nel corso delle ripetute offensive vengono compiute da ambe le parti imprese alpinistiche notevoli, che al pari di quelle aviatorie si prestano in modo eccellente all’uso propagandistico: i protagonisti sono individui eccezionali che operano in contesti speciali, lontani dal carnaio degli assalti frontali e dal fango e dalla rassegnata disperazione delle trincee. L’eroe più celebrato nell’epopea austriaca del dopoguerra, assieme al Barone Rosso, è Sepp Innerchofler, un alpinista di prim’ordine che viene ucciso al termine di una scalata quasi impossibile compiuta per sorprendere alle spalle gli italiani. E al quale, peraltro, i nemici stessi che lo hanno abbattuto, i nostri alpini, tributano l’onore delle armi andando a recuperarne il corpo, e rischiando a loro volta la pelle, per poterlo seppellire sul monte Paterno, teatro della sua performance. È un residuo di cavalleria che fa della “guerra bianca” una guerra speciale, reso possibile dal fatto che a fronteggiarsi sono uomini che molto spesso si conoscono, se non di persona almeno di fama, e si stimano, perché amano in fondo le stesse cose. L’ambiente in cui operano si presta poi all’azione individuale o di piccoli gruppi, e impone lunghe pause tra un’azione e l’altra, o soste invernali di mesi e mesi. In esso si muovono alpinisti del calibro di Andreoletti, Giuseppe Gaspard, Gunther Langes e Antonio Berti, e le azioni militari diventano spesso delle vere e proprie performances di arrampicata[67]. Questi personaggi, queste imprese, lasciano una traccia indelebile nell’ambiente alpinistico del dopoguerra, soprattutto in quello germanico, fornendo dei modelli di riferimento nei quali il valore sportivo e la determinazione individuale si coniugano opportunamente con il senso della disciplina e con quello dell’appartenenza nazionale[68].
Le elevate quote altimetriche toccate dalla linea del fronte comportano di combattere in condizioni fisiche, ambientali e meteorologiche estreme, alle quali in precedenza era ritenuto impossibile sopravvivere. In inverno i combattimenti cessano quasi del tutto e la lotta contro il maltempo e gli assideramenti è assai più importante della lotta stessa contro il nemico. I combattenti incappano anche, per colmo di sfortuna, in due inverni tra i più freddi e nevosi del secolo, e sono impegnati a difendersi dalla neve, a guardarsi dalle valanghe e a mantenere i collegamenti con il fondovalle per non lasciar venir meno i rifornimenti di cibo e di legna. Si organizzano con la costruzione di baracche, di ricoveri, di caverne nella roccia e di teleferiche per i rifornimenti, o addirittura, come fanno gli austriaci, costruendo sotto il ghiacciaio della Marmolada chilometri di gallerie e ricoveri per uomini, viveri e munizioni, nei quali la temperatura si mantiene attorno allo zero anche quando all’esterno ci sono venti gradi di meno.
Le esigenze militari inducono inoltre a lasciar cadere ogni pregiudiziale antitecnicistica e ad adottare una mentalità performativa: in guerra ciò che importa è il risultato, e a tal fine viene fortemente incrementata la ricerca di soluzioni tecniche. Sotto il profilo militare, questo significa che alla natura non viene risparmiato proprio nulla, e le montagne sono sfregiate in ogni modo, bucherellate da gallerie e camminamenti, tagliate da trincee, incatenate da reti di teleferiche, devastate da bombardamenti e scoppi di mine che in alcuni casi cambiano per sempre il volto del paesaggio. Applicato all’alpinismo si traduce da un lato in innovazioni o miglioramenti nell’equipaggiamento, attraverso lo studio dei materiali (corde, chiodi, ramponi, piccozze, abbigliamento, sistemi di assicurazione, alimentazione), dall’altro in nuovi sistemi di rilevazione e nell’aggiornamento della cartografia.
Ma non è tutto: l’esperienza bellica produce conseguenze anche sul piano psicologico. Per chi ha vissuto per anni esposto ad un livello di rischio altissimo e continuativo la percezione delle soglie cambia drasticamente: quello che era ritenuto insensato ed inaccettabile fino a dieci anni prima viene ora affrontato senza remore, anzi, con una sorta di euforia.
Infine, tramonta completamente un costume, quello del ricorso alle guide. Il conflitto segna infatti la fine della loro epoca d’oro: la crisi economica del dopoguerra dirada quella clientela facoltosa e insieme capace e motivata che aveva animato sin dagli esordi l’alpinismo, e lo aveva anzi reso possibile. Per l’economia alpina legata al turismo di ascensione è un bruttissimo periodo, che verrà superato solo nella seconda metà degli anni trenta, quando farà la sua comparsa un nuovo modello di fruizione della montagna, quello dello sci e del turismo di massa.
La guerra con l’Alpe
Ciò che accade dopo il primo conflitto mondiale ha qualcosa al tempo stesso di epico, di tragico e di sconcertante. Si parla di “alpinismo eroico”, ma si pensa ad una forma di esaltazione talvolta prossima all’invasamento. Il modello vittoriano dell’alpinismo colto e aristocratico, per il quale “andare in montagna è uno sport, come la pesca e la caccia, come il cricket o il canottaggio” (Leslie Stephen), è definitivamente accantonato a favore della sfida all’impossibile e della ricerca della “bella morte” lanciate dalla scuola di Monaco. Gli inventori del rapporto sportivo con la montagna, gli inglesi, si ritraggono da una competizione che stravolge ogni precedente assunto etico. Continuano a frequentare le Alpi come terreno di allenamento, anche ad alto livello: ma il loro interesse e le loro ambizioni si sono già spostati altrove. Per motivazioni analoghe, rafforzate dalle resistenze “corporative” opposte dalle guide locali, appaiono defilati anche i francesi e gli svizzeri, che non accettano di buon grado il trasferimento del modello dolomitico nei santuari storici dell’alpinismo, le guglie e le pareti nord del gruppo del Bianco e dell’Oberland.
Sul “terreno di gioco” rimangono dunque i germanofoni e gli italiani. L’attività da parte degli alpinisti austriaci e tedeschi diventa frenetica, quasi a cercare una sorta di rivincita rispetto alla perdita di una vasta area alpina e a riaffermare, soprattutto a se stessi e a dispetto di una sconfitta ritenuta sleale (la pugnalata alle spalle), il convincimento di una superiorità razziale, nazionale e culturale. Sono loro, cresciuti alla scuola del “mordi e fuggi”, dell’arrampicata pura, tecnica, veloce e marcatamente competitiva, a interpretare un nuovo tipo di rapporto con la montagna e a dettarne le regole.
L’esasperazione nazionalistica contagia anche l’alpinismo italiano, che non avrebbe in realtà nulla da riscattare, ma si impegna in una competizione a tratti persino rabbiosa con quello germanico. Sotto il profilo sportivo i risultati di questa rivalità sono indubbiamente eccezionali, con un numero impressionante di vie nuove di estrema difficoltà collezionate da un gruppo di fuoriclasse dell’arrampicata[69]: ma sul piano della cultura alpinistica il discorso cambia. Il Club Alpino Italiano è uno dei primissimi sodalizi ad essere fagocitati nell’orbita della politica del regime fascista. Pur senza arrivare ai deliri mistico-eroici dell’omologo tedesco, l’alpinismo ufficiale italiano fa proprie le istanze nazionalistiche del regime, la vena di rivalsa legata alla “vittoria mutilata”, la chiamata della gioventù all’ardimento e al sacrificio: e nemmeno si astiene dalle notazioni razziste. C’è persino un’elaborazione autoctona delle teorie razziali e superomistiche, quella incarnata da Julius Evola, che affonda le radici in un esoterismo più raffinato rispetto a quello tedesco, ed attinge pertanto anche nei confronti dell’alpinismo ad esiti meno devastanti: ma è un modello che tanto per scelta quanto per necessità rimane confinato a pochi “iniziati”[70].
Per quanto concerne il DÖAV, abbiamo già visto come non solo i suoi indirizzi siano in linea con le finalità del regime nazista, ma addirittura le abbiano anticipate e in qualche modo anche create. In un articolo comparso agli inizi degli anni venti sul suo organo ufficiale si legge: “L’alpinismo fu una scuola dura e seria in preparazione della guerra. La piccozza e lo scarpone sul campo di battaglia furono altrettanto importanti del fucile e della baionetta”. È una sintesi perfetta di quello che il nazismo chiederà.
L’avvento dei regimi totalitari favorisce e stimola dunque, dall’una e dall’altra parte, l’uso strumentale dell’alpinismo a sostegno delle ideologie razziali e imperialistiche sulle quali gli stessi si fondano. Ma c’è un terzo fattore che entra in gioco nella costruzione del modello della nuova società totalitaria, e che coinvolge di sponda l’ambiente alpinistico: è la crescente “sensibilità ambientale”, destata degli sconquassi ormai evidenti della rivoluzione industriale, che nasce nei paesi anglosassoni ma in Germania ha una sua particolare declinazione. Non è un caso che sia un tedesco, e che sia proprio Ernst Haeckel, considerato uno dei teorici fondatori del razzismo germanico[71], ad introdurre il termine “ecologia”[72].
Nel sostrato ideologico comune ai due fascismi (con tutte le distinzioni e le differenze qualitative e quantitative del caso), al mito del sangue (Blut) si sposa infatti quello del suolo (Boden), inteso quest’ultimo sia come imperativo del ripristino dei “sacri confini” della patria (e qui i due regimi vengono a confliggere, perché esistono aree territoriali per le quali le rivendicazioni si sovrappongono) sia come impegno alla valorizzazione del territorio e incentivo al radicamento dei suoi abitanti. Nel caso italiano il fascismo persegue una “valorizzazione” più prosaica, finalizzata a recuperare alla produttività vaste zone incolte o sottoutilizzate (la politica delle bonifiche, il mito dell’autarchia); in quello tedesco c’è un’accezione più “arcadica”, legata appunto alla diffusione di una mentalità proto-ecologista, ad un vincolo più tradizionalmente radicato con la terra d’origine, che comporta un’attenzione particolare all’ambiente.
È significativa in questo senso la presenza ai vertici del Reich di un ministro dell’agricoltura come Walther Darré, che nel testo “La nuova nobiltà di sangue e suolo” del 1930 (Neuadel aus Blut und Boden), teorizza un rinnovamento spirituale e razziale tramite una riconversione all’economia agraria, il distacco dall’industria e il ritorno ad un rapporto più diretto con la natura[73]. In pratica Darré vagheggia il ripristino delle condizioni economiche e ambientali precedenti la rivoluzione industriale, che è esattamente il contrario di quanto vorrebbe Mussolini. La sua posizione alla fine risulta sconfitta, perché anche il Terzo Reich punta decisamente a riconquistare la supremazia industriale: ma per intanto la politica “ruralista” di Darré si concretizza nella destinazione di una notevole fetta del territorio tedesco ad area naturalistica protetta (viene rimboschita, ad esempio, e in buona parte completamente reinventata la Selva Nera, attraversata da una miriade di percorsi escursionistici) e in una speciale attenzione verso le zone per eccellenza incontaminate, quelle montane. Ne consegue naturalmente che su queste zone vada rivendicato un diritto: e il diritto si acquisisce non solo conquistando le vette, ma vincendone ogni resistenza, ogni spigolo e ogni parete.
Mentre l’attenzione per l’alpinismo in Germania è motivata dalla combinazione di tutti questi fattori (educazione alla virilità, componente razziale, preparazione militare, superomismo e diritto al dominio, sensibilità ambientale), e quindi rispecchia un sentire in qualche modo diffuso, in Italia, per la natura comunque elitaria dell’associazionismo alpinistico e per la situazione di ritardo economico, gli elementi di base per una sensibilizzazione popolare nei confronti della montagna (e della natura in genere) mancano totalmente[74]. Al di là di qualche isolata iniziativa per allargare alla massa la pratica alpinistica[75], la politica del regime si risolve principalmente nell’uso cerimoniale delle vittorie (le medaglie d’oro) e in quello propagandistico dei personaggi. L’attenzione mediatica riservata agli alpinisti è tra le due guerre pari a quella per i ciclisti, per i calciatori e per i giganti del ring.
Il fatto è che sulla percezione della montagna continua a pesare in Italia una radicata ambiguità. In un paese che vanta quasi ottomila chilometri di coste, e nel quale la distanza dalla spiaggia più vicina è raramente superiore ai duecento chilometri, è naturale che il divertimento e la vacanza si identifichino col mare. L’Italia è però anche un paese innervato da oltre duemila e cinquecento chilometri di massicci e di catene montuose, che occupano il 35% del territorio: eppure l’associazione della montagna con l’idea del divertimento è solo recente, ed è legata quasi esclusivamente agli sport invernali. La montagna non sciistica, estiva, quella che consente a tutti di praticare di un minimo di alpinismo, rappresenta nella prima parte del Novecento un tipo di vacanza ancora elitario, riservato a ceti benestanti e colti. E fino alla metà del secolo l’immagine della montagna rimane addirittura associata a necessità di salute (diffusione di sanatori o di stabilimenti di cure termali) e quella dei suoi abitanti a carenze psichiche o a deformità congenite.
L’alpinismo eroico italiano degli anni trenta è quindi in buona misura un’operazione d’immagine. A differenza di quanto accade in Germania, dove la strumentalizzazione è forse ancor più marcata, ma gioca su una forma di partecipazione diffusa, di consonanza già acquisita, l’icona dello scalatore indomito e temerario, incurante del rischio, votato alla vittoria o alla morte, non rispecchia il sentire e tantomeno l’essere degli italiani. Più che indurre all’emulazione, funge come altre immagini sportive da motivo di consolatorio orgoglio: anche un popolo di piagnoni trova sempre un Bartali o un Carnera che lo riscatta. La “lotta con l’Alpe”, che già era bandita da Guido Rey in una versione molto meno esasperata rispetto a quella teutonica, viene poi interpretata con sfumature diverse dai più forti alpinisti italiani degli anni trenta, o almeno dai più famosi: Comici, Boccalatte e Gervasutti.
Emilio Comici non è un “vitalista” faustiano dello stampo di Lammer, anche se molte frasi del suo “Alpinismo eroico” parrebbero scritte dal tedesco: “È bello, immensamente bello arrampicare tutto libero, su una parete che strapiomba, vedere fra mezzo alle tue gambe il vuoto, e sentirsi di poterlo dominare con le tue solo forze. Io quando arrampico da solo guardo sempre in giù per inebriarmi del vuoto, e canto dalla gioia. Se non ho fiato per cantare, perché il passaggio difficile me lo stronca, allora il canto continua muto nel mio interno”[76]. È piuttosto un esteta. Ama la plasticità del gesto, e nelle foto che lo ritraggono in azione si coglie una ricerca plateale di teatralità: “Io intendo l’alpinismo soprattutto come arte… come, per esempio, la danza o, se vuoi, l’arte del violino… Perché se sei padrone assoluto della tecnica dell’arrampicare, puoi facilmente dare espressione ai tuoi sentimenti, proprio come nella musica e nella danza”. La sua vis teatrale, frutto paradossale di introversione e sensibilità, lo rende perfettamente idoneo a incarnare il supereroe da stampa popolare nel quale l’uomo della strada vorrebbe identificarsi, capace di imprese e di uno stile di vita sempre al limite (almeno per i parametri del tempo), che nella versione italiana non esclude anche un contorno di soldi e bella vita. Comici è forse il primo alpinista italiano a monetizzare i suoi successi e l’immagine di “uomo ragno” che gli è stata costruita addosso, collezionando conferenze e sponsorizzazioni: il che lo fa entrare in una dimensione totalmente nuova, quella dell’alpinismo professionistico.
Gabriele Boccalatte parrebbe dei tre quello maggiormente ancorato al modello ottocentesco, mentre in realtà l’assoluta libertà dagli schemi e la naturale leggerezza del gesto ne fanno un precursore degli arrampicatori contemporanei[77]. Non è un asceta dell’alpinismo, e nemmeno un superuomo; ha una vita completa, è un concertista di buon livello e arrampica molto spesso con la sua compagna, Ninì Pietrasanta. Non gli interessano le prime o le ripetizioni difficili per sé, vuole solo che si tratti di salite belle. Il suo è un estetismo interiore, tanto quanto quello di Comici è esteriore[78].
Gervasutti rappresenta invece la potenza, la forza della volontà. “Osa, osa sempre e sarai simile ad un dio”[79]. Arriva dalle Dolomiti e porta nelle Alpi occidentali una tecnica che fa invecchiare immediatamente tutti i vecchi parametri di difficoltà. Ha una personalità difficile, tormentata, irrequieta: al termine di una delle sue imprese più eclatanti scrive: “[…] ci stendiamo al sole. Fa caldo e abbiamo una gran voglia di dormire. Niente fremiti di gioia. Niente ebbrezza della vittoria. La meta raggiunta è già superata. Direi quasi un senso di amarezza per il sogno diventato realtà. Credo che sarebbe molto più bello poter desiderare per tutta la vita qualcosa, lottare continuamente per raggiungerla e non ottenerla mai”. Gervasutti è quello che in maniera più convinta accetta e vive la sfida con i tedeschi, a partire da quella persa sulla Nord delle Grandes Jorasses. Diventa l’alfiere dell’alpinismo italiano anche fuori dai “sacri confini”, andando ad arrampicare e ad aprire nuove vie nelle Alpi francesi e a salire vette inviolate sulle Ande. Lo fa coniugando le proprie motivazioni interiori con quelle politiche e propagandistiche del regime fascista: “Noi viviamo di sensazioni, intese nel senso più nobile della parola. Ognuno ha le proprie, altrimenti la vita sarebbe inutile e vuota. Ma per vivere compiutamente bisogna pure arrischiare qualcosa. Il Duce ha insegnato così”.
Nell’uso propagandistico di queste figure il regime non incontra granché resistenza. In qualche caso approfitta del disinteresse degli alpinisti per la politica, in qualche altro del loro sincero consenso. Non tutti però si lasciano strumentalizzare. Vedremo che c’è chi non nasconde il proprio dissenso, come Riccardo Cassin, chi rifiuta di essere coinvolto nella fiera celebrativa, come Ettore Castiglioni, e chi semplicemente va per la propria strada, come Giovan Battista Vinatzer, rinunciando ad ogni notorietà e conquistandosi, forse proprio per questo, la stima e la simpatia di tutti coloro che arrampicano con lui. Tutto sommato, trattandosi di un ambiente particolare, caratterizzato da un livello culturale molto alto e da un sentire sensibilissimo alla libertà e all’indipendenza personale, la reazione all’allineamento agli scopi del regime potrebbe sembrare sin troppo tiepida: ma non credo si possa parlare, al di là della fascistizzazione del sodalizio ufficiale, di una reale acquiescenza. Per il momento gli alpinisti il loro spazio di libertà se lo ritagliano individualmente sulle montagne: quando verrà il momento, sempre sulle montagne, sapranno anche difenderlo.
La strumentalizzazione politica dell’alpinismo non ne fa in Italia una pratica diffusa a livello popolare, come è da sempre in Austria o è divenuta dai primi del Novecento in Germania, mentre crea senza dubbio uno zoccolo di scalatori di ottimo livello e impone, sotto la pressione del confronto e nell’urgenza di sbandierare risultati, una mentalità alpinistica per certi aspetti sin troppo prosaica e disinvolta. La base dei praticanti si allarga, in termini sia numerici che di coinvolgimento sociale o territoriale, ma la distanza tra un’eccellenza ormai semiprofessionistica e la truppa dei dilettanti risulta ancor più marcata. L’alpinismo italiano non ne esce insomma con una identità forte: ma questo non fa che rispecchiare la natura di un popolo da sempre individualista e anarcoide.
Il bagaglio tecnico maturato da tedeschi e italiani nella zona dolomitica viene dunque trasferito alla fine degli anni ‘20 sulle grandi montagne occidentali e all’arrampicata su ghiaccio. L’antesignano di questo trasferimento è Willo Welzenbach, senza dubbio il più forte alpinista tedesco tra le due guerre, che dopo essersi fatto le ossa sulle vie di misto delle Alpi orientali si volge all’Oberland Bernese e dà inizio ad una straordinaria campagna di superamento delle pareti nord. Al di là delle sue straordinarie capacità alpinistiche, Welzenbach è emblematico del nuovo spirito tedesco, proprio perché tra tutti i protagonisti di questa breve ed intensa stagione appare il più equilibrato, il meno emozionalmente squinternato. Eppure quest’uomo, che ha un regolare lavoro e quattro settimane di ferie l’anno, in quindici anni di attività sale 949 cime e compie 43 nuove ascensioni, queste ultime tutte di eccezionale livello. Significa aver dedicato alla montagna tutti i fine settimana e tutti i giorni di ferie, estate e inverno, con la pioggia o col bel tempo, averne fatto il significato unico dell’esistenza. Significa anche aver minuziosamente programmata la propria attività, aver redatto piani stagionali delle salite, quote di risultati da ottenere, calcoli di dislivelli e di difficoltà. A questo proposito, Welzenbach è anche il primo a proporre una scala delle difficoltà (quella appunto che contempla una progressione sino al sesto grado). Un approccio alla montagna a questo punto lucidamente pianificato, ma al di sotto del quale c’è una concezione non meno forsennata di quella di Lammer. Involontariamente, Welzenbach suggerisce un po’ l’idea di quella che sarà la follia lucidamente perseguita dalla Germania hitleriana (che peraltro si manifesta anche direttamente in campo alpinistico, con le spedizioni al Nanga Parbat).
La progressione in artificiale e l’uso di nuovi materiali (soprattutto i chiodi da ghiaccio) consentono a lui e ai suoi numerosissimi emuli di superare limiti risalenti all’epoca di Mummery e di restringere velocemente il campo a quelli che vengono definiti gli ultimi grandi problemi delle Alpi: le pareti Nord del Cervino, delle Grandes Jorasses e dell’Eiger. Con gli anni Trenta ha inizio pertanto una gara esaltante e dissennata, che rischia di trasformare la passione alpinistica in una folle corsa al suicidio, ma che produce anche performances davvero degne del Walhalla.
Prima a cadere è la Nord del Cervino, che viene salita nel 1931 dai fratelli austriaci Franz e Toni Schmid. Nella loro storia c’è tutto l’alpinismo anni Trenta, tutta la sua distanza dal vecchio “gioco” un po’ snobistico dei viaggiatori inglesi. I due fratelli arrivano da una discreta pratica dolomitica, ma non hanno alle spalle un curriculum particolarmente significativo. Caricano sulle loro biciclette tutta l’attrezzatura, peraltro piuttosto datata, partono da Monaco di Baviera, arrivano dopo tre giorni a Zermatt (sotto la pioggia), salgono per la Nord con un solo bivacco (ancora con condizioni atmosferiche avverse), ridiscendono fradici sino al bivacco (dove dormono per due giorni mentre fuori infuria la tempesta), riguadagnano Zermatt, inforcano nuovamente le biciclette e tre giorni dopo (pedalando sotto la pioggia) sono nuovamente a Monaco. È difficile stabilire se siano stati più bravi o fortunati, dal momento che la via percorsa si sviluppa sotto un’incessante gragnuola di pietre, e che ad un certo punto si sono cacciati in una situazione di non ritorno, dalla quale cui l’unica via d’uscita è la vetta: ma indubbiamente il piglio, la determinazione, la rapidità, il coraggio anche incosciente col quale la salita è effettuata si prestano a creare un modello, tanto nuovo quanto pericoloso. E in effetti, malgrado non siano neppure i primi, la risonanza dell’impresa è enorme, e gli imitatori fioriscono a frotte.
Il prossimo fronte sul quale questi ultimi possono cimentarsi è la Nord delle Grandes Jorasses: a partire dal 1931 la parete è oggetto di innumerevoli attacchi, da parte di cordate francesi, austriache ed italiane. L’assalto è tutt’altro che incruento. Nel 1934 quattro cordate, una italiana con Gervasutti e Chabod, una francese ed una tedesca si trovano contemporaneamente in parete, impegnate a scavalcarsi reciprocamente per toccare per prime la cima. Quando il tempo volge al peggio tre abbandonano, mentre quella tedesca persiste nel tentativo, “fortemente decisa – come scrive Renato Chabod –, a imprimere sulla sconfitta parete la croce uncinata”. Uno degli alpinisti, Rudolf Haringer, viene tramortito da un fulmine e precipita; l’altro, Rudolf Peeters, rimane in parete sei giorni e viene salvato in extremis, ma ci riprova l’anno successivo, e stavolta arriva in vetta con Martin Meier. Il loro successo non viene riconosciuto da tutti, perché la via seguita non conduce direttamente alla cima principale. Ci pensano tre anni dopo gli italiani Cassin, Tizzoni ed Esposito a tracciare l’itinerario diretto lungo lo sperone Walker.
Rimane la terribile parete Nord dell’Eiger, che per gli alpinisti austriaci e tedeschi diventa una vera ossessione, alimentata dalla propaganda del regime nazista, e che esige uno spropositato tributo di sangue. In tre anni ci sono sette morti appesi in parete, e il comitato centrale del club alpino svizzero arriva ad annunciare che le guide non saranno tenute a soccorrere eventuali alpinisti in difficoltà. Nel 1936, dopo che altri tre tentativi si sono conclusi in tragedia, è la volta di due giovanissimi alpinisti bavaresi, Andreas Hinterstoisser e Toni Kurz, che hanno a lungo preparato l’impresa e ci provano durante una licenza. Trovano in parete un’altra coppia, due scalatori austriaci, e decidono di salire di conserva, mentre in tutta la Germania la radio di Goebbels propone in diretta quello che dovrà essere il trionfo dei “ragazzi del Reich”. Si mette male subito, il tempo e la montagna si mostrano inclementi, ma gli scalatori non ripiegano. L’epilogo è tragico per tutti e quattro, con l’ultimo che rimane appeso per giorni, in agonia, a pochi metri dai soccorritori che non riescono a raggiungerlo. Solo due anni dopo la parete è scalata da una cordata mista tedesca ed austriaca, della quale fa parte Heinrich Harrer.
Alla fine degli anni trenta i più importanti ed evidenti “problemi delle Alpi” sono di fatto risolti. L’alpinismo classico è già tramontato da un pezzo: la guerra verrà a porre fine anche a quello “eroico”. I “problemi”, per un bel pezzo, saranno altri.
Mentre l’alpinismo classico è iconograficamente narrato da immagini statiche, pittoriche o fotografiche che siano, in armonia tutto sommato con la plasticità dell’ambiente, a partire dal primo dopoguerra l’immaginario collettivo della montagna è dettato, prima ancora che dai libri di Lammer, sempre più dal cinema. I primi documenti cinematografici relativi a scalate arrivano già assieme al nuovo secolo. Dai brevissimi spezzoni girati nel 1901 sul versante svizzero del Cervino si passa in dieci anni a veri e propri documentari, realizzati portando sin sulla vetta della montagna una ingombrantissima attrezzatura del peso di oltre trenta chili[80]. Nel frattempo Vittorio Sella racconta con la cinepresa la spedizione del Duca degli Abruzzi al K2 (1909). Si tratta inizialmente di documenti destinati ad una utenza molto ristretta: nelle produzioni mirate al consumo popolare il materiale girato negli ambienti montani si riduce a poco più che cartoline turistiche, nelle quali le montagne fungono solo da pretesto e da sfondo: ma per intanto, il solo ingresso del cinema nel regno dei ghiacciai e della roccia calcarea ne cambia la percezione.
Una divulgazione più ampia di immagini cinematografiche alpine è indotta durante il conflitto dalla propaganda bellica: la documentazione cinematografica militare privilegia il realismo di sentieri, salite, cordate, ecc., e forma una nuova generazione di fotografi e cineasti che imparano a lavorare in alta quota. Non a caso, dopo la guerra ci sarà soprattutto in area tedesca una notevole fioritura della filmografia di montagna.
A partire dagli anni Venti, infatti, registi come Arnold Fanck, con Il monte del destino del 1924, e La montagna sacra del 1926, e soprattutto Luis Trenker (che esordisce come attore nei film di Fanck e interpreterà anche tutti quelli realizzati come regista), a partire da Montagne in fiamme, del 1931 fino a Il grande ribelle, del 1933 – che tra parentesi piace molto a Goebbels e allo stesso Hitler – e poi a La grande conquista del 1938 e a Il ribelle della montagna del 1939, sviluppano accanto ai temi mielosi del “repertorio” montano quello della mistica dell’eroismo alpino, che si incontra con quella dell’eroismo militare. Le immagini di alpinisti indomiti, che affrontano la furia degli elementi e il rischio estremo per far trionfare su terrificanti pareti di ghiaccio e di roccia la propria volontà di conquista, sono perfettamente congeniali all’ideologia e alla propaganda naziste. Ma si va anche oltre. In un film di Trenker rievocativo della conquista del Cervino, La sfida, si avalla la versione secondo la quale Whymper avrebbe tagliato la corda che reggeva i suoi quattro compagni. In un colpo solo si scredita tutto l’alpinismo britannico dell’età dell’oro.
Il cinema è giustamente considerato da Goebbels l’arma propagandistica più efficace, e questo induce il regime a patrocinare direttamente i bergfilm e a mettere a disposizione risorse finanziarie, pubblicitarie e umane straordinarie. Trenker e Leni Riefensthal, ottima alpinista e protagonista fissa dei film di montagna, prima di diventare lei stessa regista, sono forse gli attori più popolari del cinema tedesco tra le due guerre. Dal punto di vista spettacolare si tratta di opere di sicuro effetto, con immagini girate direttamente in parete e con l’utilizzo di mezzi tecnici d’avanguardia per l’epoca. Ma i costi non sono soltanto finanziari, perché durante la lavorazione la percentuale degli incidenti, spesso mortali, è altissima.
Nella promozione della versione eroica della montagna non troviamo, a differenza che nella prima metà dell’Ottocento, la pittura. Le ragioni sono evidenti: l’immaginario visivo è ormai determinato da altre fonti, quelle che abbiamo sopra descritte, l’illustrazione, la stampa, i calendari, ma soprattutto, verso la fine del secolo, la fotografia. Ciò non toglie che nella seconda metà dell’800, e fino almeno alla prima guerra mondiale, ci sia una vera e propria esplosione di pittura di montagna, eguagliata per quantità forse solo dalle marine. La veduta montana, l’ambientazione alpestre rispondono ai gusti estetici della società borghese, oltre ad offrire anche ai pittori amatoriali un’infinità di soggetti di facile effetto. Si diffonde quindi quella produzione di maniera che riempirà i salotti buoni delle famiglie benestanti, allo stesso modo in cui le stampe o le illustrazioni dei calendari riempiranno le case delle classi meno abbienti. Anche il manierismo riesce comunque ad esprimere autori ed opere di notevole livello, sia quando interpreta col filtro di Ruskin la sacralità estetica della montagna (la produzione anglosassone, e soprattutto Elija Walton) sia quando accetta la sfida del realismo fotografico esaltando le luci e i colori, come nel caso della paesaggistica elvetica e del vedutismo di Alexandre Calame.
Al di là di questo, però, si opera una trasformazione nella pittura di montagna, ed è l’alpinismo stesso ad indurla. Una volta violate e conquistate, o rese facilmente accessibili dai nuovi mezzi di trasporto, le vette non sono più le stesse, non trasmettono gli stessi sentimenti. Non c’è più spazio per il titanismo romantico, che in fondo si crogiola nella sconfitta, mentre adesso sono le vette a cadere. Viene meno anche il gusto dell’esotico e del pittoresco, perché le montagne sono ormai uno spettacolo alla portata di tutti. Per quanto concerne il realismo documentario c’è la concorrenza della fotografia, che anche nei limiti imposti dal bianco e nero fornisce una documentazione incomparabilmente più ampia e più puntuale nel dettaglio. Viene intrapresa quindi la via di una ricerca cromatica o di forme che prescinde da finalità di rappresentazione informativa o emozionale, e al limite anche dal soggetto stesso rappresentato. Lo si vede soprattutto in Arnold Böcklin. Le montagne tornano a caricarsi di simbologie, come in Friedrich, ma in questo caso sono simbologie oscure e inquietanti.
Più solare è invece, al di qua delle Alpi, Giovanni Segantini, che utilizzando i colori puri del divisionismo restituisce l’atmosfera dell’alta montagna, le tonalità nitide e chiare di cieli e nevai. Sotto una superficie distesa e composta la sua pittura è però densa di malinconia: nel famoso trittico “Nascere, vivere, morire” la primavera, l’estate e l’inverno della vita sono rappresentati attraverso i mutamenti stagionali dello scenario e delle semplici e primitive occupazioni dei contadini, ma la cornice montana rimane silenziosa spettatrice sullo sfondo, estranea al tempo che scorre in primo piano: un simbolismo giocato proprio sul racconto fatalisticamente oggettivo della quotidianità.
Il passaggio finale si ha con Ferdinand Hodler: anche a lui preme raccontare il destino degli uomini, ma lo fa o stagliandoli contro una luce naturale quasi magica, o addirittura progressivamente escludendoli dall’immagine e cogliendo l’insieme della montagna in un’unica linea, attraverso la caratteristica ricorrente del ripetersi di forma e colore, secondo un suo personale “principio del parallelismo”: il che ci riporta alle origini, a Giotto, e chiude il cerchio[81].
Dopo, infatti, c’è l’astrattismo, che con le montagne non ha più nulla a che vedere. O meglio: non ha a che vedere con quello di cui abbiamo parlato sinora, mentre potrebbe rappresentare benissimo ciò che oggi è diventata la montagna, e lo sguardo col quale la si coglie.
Il processo che aveva avuto inizio centosessant’anni fa all’Egyptian Hall di Londra, dove Albert Smith esponeva il suo diorama dell’Ascensione al monte Bianco, è arrivato a compimento oggi con la possibilità di attraversare tutto il massiccio del Bianco senza fare un passo. La funivia più alta del mondo consente di arrivare con un’ora di viaggio dall’aeroporto di Caselle alla stazione di partenza, e di essere un’ora dopo ad oltre quattromila metri, su una terrazza panoramica con vista sulla vetta. La montagna che ci viene incontro mentre stiamo seduti nella cabina è non solo addomesticata, ma piena di cicatrici, segnata da impianti di risalita, ristoranti, rifugi, alberghi, parcheggi di fondovalle, bivacchi d’appoggio, strade di servizio. La sua fisionomia è stravolta, i suoi scenari si stanno velocemente standardizzando, come tutto il resto del nostro mondo e delle nostre vite. Si può scendere sulla vetta del Cervino da un elicottero, anziché salirci lungo la Cresta del Leone. L’idea di montagna sulla quale si fondava l’alpinismo, che al netto di tutte le intenzioni delle quali la si caricava aveva un fondamento quanto mai concreto, solido e immutabile, è diventata un’astrazione. Certo, esistono anche luoghi quasi incontaminati, ma proprio per questo sono meta sempre più frequente di chi ancora si illude di sfuggire all’omologazione, e nel farlo se la porta appresso e ne diventa lo strumento. Si ripete su scala di massa quel che è avvenuto nell’ottocento per piccole élites. L’alpinismo non è certo il maggior responsabile di questo scempio: ne è anzi inorridito, e per quanto possibile cerca di frenarlo. Ma è altrettanto vero che ne è stato, per oltre un secolo, l’avanguardia.
Questo, e tutto il resto, ciò che accade dopo l’Eiger attorno e sopra le montagne, non rientra più nostro racconto. La mia introduzione alla storia dell’alpinismo potrebbe tranquillamente chiudersi qui, con il confronto tra due scuole di pensiero (e soprattutto d’azione) che a lungo si fronteggiano e cedono poi entrambe il passo al nuovo. Il nuovo sono le sponsorizzazioni, la performance fine a se stessa, gli ottomila con l’ossigeno prima, senza ossigeno dopo, le concatenazioni a raffica di vie, le salite di corsa al Cervino e le discese con gli sci dall’Everest, fino all’arrampicata libera sulle facciate dei palazzi. Non è di questo che volevo parlare.
Aggiungerò quindi, per dovere di completezza, una breve appendice sul ruolo della montagna nella seconda guerra mondiale e sugli ultimi sessant’anni di alpinismo, ma sarà pura cronaca. In effetti, soprattutto quest’ultima parte non mi interessa molto. La mia concezione dell’alpinismo è rimasta ferma a un secolo fa, a quella di Mummery; il mio modello umano di alpinista è Kugy: l’alpinismo è anche una pratica sportiva, ma è soprattutto un piacere, e per essere tale non deve cercare il pericolo eccessivo, deve calcolare le difficoltà, e utilizzare più che la forza l’intelligenza e la forza di volontà. Se praticato in questo modo, non ha bisogno di cercare motivazioni e di darsi un’etica: le porta già con sé.
La morte dell’impossibile
Per un paio d’anni, verso la fine del secondo conflitto mondiale, “salire in montagna” assume un significato ben diverso da quello sportivo o turistico. La montagna, e le Alpi soprattutto, diventa la zona operativa delle formazioni partigiane, un rifugio per renitenti e sbandati, una via verso la salvezza per ebrei e oppositori del regime che cercano scampo in Svizzera.
A differenza che nel primo conflitto le Alpi sono solo per un brevissimo periodo scenario di una guerra regolare, e questo a dispetto della intensa preparazione che a partire dal 1935 il regime fascista da un lato e il governo francese dall’altro avevano avviato. La lezione della grande guerra, nella quale le formazioni alpine altamente specializzate avevano svolto un ruolo cruciale, ha indotto infatti gli stati maggiori a ripensare le strategie difensive. Tutta la zona di confine è stata attrezzata sui due versanti con opere di fortificazione e sono state rese accessibili anche le postazioni più impervie. Sul piano dell’addestramento specifico delle truppe, nel 1935 è stata aperta la scuola militare di alpinismo di Aosta, mentre in Francia già funzionava dal 1932, a Chamonix, l’École de Haute Montagne (EHM).
La militarizzazione anche simbolica e propagandistica della montagna segue a ruota. Nel giugno del 1935 gli allievi della scuola militare di Aosta prestano il giuramento di fedeltà alla patria sulla vetta del Monte Bianco, e due anni dopo si svolge sempre sul Bianco una imponente esercitazione dimostrativa. I francesi replicano nel 1938, con una manovra di massa di tutte le loro truppe d’alta montagna e un “grand rassemblement” sulla cima del Bianco.
Tutta questa preparazione alla resa dei conti si rivela inutile. La guerra alpina dura due settimane, nel giugno del 1940, e vede gli italiani impegnare per il tentativo di occupazione della Savoia una forza tre volte superiore rispetto a quella francese, ma ottenere alla fine una penetrazione di pochissimi chilometri, a prezzo di un alto numero di caduti. I problemi più grossi sono dati dalla temperatura e dal maltempo, che mettono a nudo la scarsa preparazione e l’inadeguato equipaggiamento dei soldati italiani.
La montagna torna invece protagonista, questa volta non per due settimane ma per due anni, dopo l’armistizio dell’8 settembre. In realtà sul versante francese delle Alpi Marittime e del massiccio del Bianco il maquis aveva già cominciato ad organizzarsi nella primavera del 1943. Nell’autunno anche quello italiano comincia a popolarsi dei primi gruppi armati, e dopo una iniziale diffidenza i due movimenti finiscono per cooperare. Sono soprattutto i partigiani italiani, dopo i rastrellamenti della primavera e dell’estate del ‘44, a trovare rifugio in terra di Francia, in una zona che a dispetto di massicce e cruente azioni di “bonifica” da parte tedesca rimane sostanzialmente terra di nessuno. La conoscenza del territorio e l’abitudine alla pratica alpinistica di molti capi si rivela fondamentale per la sopravvivenza delle formazioni partigiane. Quelle che riescono a sfuggire ai rastrellamenti sono guidate da personaggi come Nuto Revelli, che ha una formazione militare alpina, o Livio Bianco, che ha trascorsi di alpinismo di buon livello.
Il massiccio del Bianco, e più in generale l’Alta Savoia, sono anche teatro di alcuni episodi di guerra ad altissima quota. Una vera e propria battaglia si svolge attorno al Rifugio Torino, e in un’altra occasione le truppe tedesche sono costrette ad abbandonare Chamonix. Ma la norma degli scontri è quella della guerra per bande, e l’azione dei resistenti ha essenzialmente lo scopo di disturbare le linee di comunicazione tedesche e di rappresentare, anche simbolicamente, una presenza minacciosa nelle retrovie, oltre che di dare di assistenza ai profughi e ai renitenti. Quest’ultimo ruolo viene svolto con efficacia da alcuni dei nomi più prestigiosi dell’alpinismo italiano degli anni trenta. Ettore Castiglioni facendo base in una baita in Valpelline, sopra Aosta, guida verso la Svizzera attraverso le montagne centinaia di profughi, oppositori del regime, tra i quali la futura “regina di Maggio” e Luigi Einaudi, ed ebrei[82]. Lo stesso fanno Riccardo Cassin e Vittorio Ratti[83] nelle Alpi Centrali, e ad essi si uniscono Gino Soldà e l’ormai anziano Tita Piaz. Leopoldo Gasparotto[84] diventa il comandante delle formazioni di Giustizia e Libertà per la Lombardia, viene catturato e torturato dai tedeschi, finisce nel campo di Fossoli, dove organizza fughe di detenuti e dove alla fine viene ucciso. Attilio Tissi opera nel Bellunese, dove ha l’incarico di distribuire ai partigiani le armi lanciate dagli alleati: anche lui viene catturato e torturato per un mese, ma alla fine riesce a scamparla[85]. L’elenco potrebbe allungarsi parecchio, ma credo che questi nomi bastino a far intendere non solo quale parte attiva abbiano svolto gli alpinisti nell’unico episodio non infamante della nostra storia recente, ma soprattutto come la lotta per libertà sia in fondo congenita in chi ama questo mondo.
Come ogni dopoguerra anche l’ultimo è caratterizzato da importanti novità tecniche: si comincia bene, con l’utilizzo delle nuove suole in gomma Vibram, che in effetti rivoluzionano l’approccio ad ogni tipo di percorso, limando mezzi gradi nella scala delle difficoltà e aprendo le vie meno difficili ad una frequentazione molto più allargata, per arrivare poi invece all’introduzione dei chiodi a pressione, e in qualche caso addirittura all’uso del compressore, che consentono di violare in artificiale ciò che la natura da sempre aveva vietato. Il resto lo fanno i nuovi materiali plastici, le corde in sintetico, sempre più leggere, i tessuti impermeabili e termici.
Queste novità hanno una ricaduta importante sull’alpinismo di punta, favorendo prima gli exploit oltre gli ottomila e consentendo da ultimo il ritorno a perfomances di altissimo livello con equipaggiamento leggero; ma rivoluzionano anche quello di massa, consentendo a un numero crescente di appassionati di affrontare in sicurezza livelli di difficoltà superiori.
L’avvicinamento alla montagna passa anche, letteralmente, per le possibilità di accesso. In questo senso lo sviluppo delle reti ferroviarie e stradali di comunicazione (e per quanto concerne l’alpinismo extraeuropeo quello delle linee aeree) consente a chiunque di frequentare, anche per periodi brevissimi, rifugi e vette. L’aumento del tempo libero, con l’introduzione della settimana corta e delle ferie pagate, fa il resto.
Una serie di vicende tragiche risveglia l’attenzione dei vecchi e dei nuovi media, che alla maniera di quelli ottocenteschi cercano soprattutto la polemica. D’altro canto proprio l’aumentata frequentazione e l’eccesso di confidenza creato dalla fiducia nelle attrezzature moltiplica la possibilità di incidenti. Ma ormai l’idea di un tributo annuale di vite da versarsi alla montagna, così come alle autostrade, è universalmente accettata: per gli eroi della verticale, poi, essendo nel frattempo diventato l’alpinismo uno sport professionistico, sembra quasi che la morte in parete sia inserita a contratto. Fa molto più notizia la sopravvivenza di alpinisti estremi come Cassin o Bonatti che la scomparsa della gran parte dei loro colleghi.
Sul piano di quella che è ancora negli anni cinquanta pura competizione nazionale il dominio tedesco per cause di forza maggiore si allenta (anche se la vecchia scuola austriaca esprime ancora alcune individualità di caratura altissima), e salgono alla ribalta soprattutto gli alpinisti francesi. La scuola francese era rimasta nell’ombra negli anni trenta, ma aveva allevato una generazione di rocciatori fortissimi, con una grande propensione alla verticalità e alle imprese invernali, ma soprattutto al lavoro in cordata. Ora si risveglia dal letargo: uomini come Rebuffat, Lachenal, Terray, Desmaison, Couzy, Livanos portano l’alpinismo francese ai vertici su ogni terreno, d’estate e d’inverno, in Europa e fuori. A favorirli sono appunto le caratteristiche di gruppo, la capacità di conciliare e valorizzare al massimo, ai fini della complementarità, le differenze di attitudine e le diverse propensioni.
Anche la scuola italiana continua ad esprimere personalità eccezionali, del livello di un Bonatti o di un Mauri, capaci di exploit indifferentemente sul calcare o sul ghiaccio, in Alpe o in Himalaya: ma è sempre caratterizzata dalle polemiche e dalle rivalità interne, che guastano persino risultati importanti come quello del K2.
Nelle spedizioni extraeuropee tornano infine in gioco gli inglesi, i quali tuttavia, una volta conseguito sulla vetta più alta quel successo che la morte di Mallory aveva reso obbligato, mantengono un certo distacco e tornano al vecchio terreno di gioco alpino. Nei limiti consentiti dall’evolvere della tecnica e dell’attrezzatura cercano di conservare intatto lo spirito di Mummery o di Geoffrey Winthrop Young.
Potremmo definire quella iniziata nel primo dopoguerra la fase coloniale o imperialistica dell’alpinismo: la corsa a piantare la bandiera per primi su qualsiasi altura significativa in ogni parte del globo, a stabilire o a sancire una sorta di primato occidentale sul mondo e di superiorità etnica o nazionale all’interno dell’occidente. Questa corsa conosce un’accelerazione esasperata che legittima l’utilizzo di qualsiasi tecnica artificiale, e termina solo negli anni cinquanta, quando in rapida successione vengono conquistate tutte le vette superiori agli ottomila metri, Si comincia con l’Annapurna, nel 1950, salito appunto dai francesi Herzog e Lachenal; si prosegue nel 1953 con il più alto, l’Everest, scalato da Hillary e Tenzing, e con il più crudele, il Nanga Parbat, quello cui i tedeschi avevano pagato negli anni trenta un tributo di ventotto vittime, che viene vinto con un’incredibile ultima tratta di diciotto ore in solitaria dal formidabile austriaco Hermann Buhl. Nel 1954 cadono quello considerato più difficile, il K2, salito da Compagnoni e Lacedelli, e il Cho Oyu vinto dagli austriaci Tichy e Jochler, insieme allo sherpa Pasang Dawa Lama.
Il Kanchenjunga, terza vetta più alta, viene salito nel 1955 dagli inglesi George Band e Joe Brown, che hanno alle spalle trecentodieci portatori e trenta sherpa d’alta quota. Nello stesso anno i francesi Lionel Terray e Jean Couzy, seguiti da altri sei compagni un giorno dopo, salgono il Makalu. La cima del Lhotse è raggiunta da Ernst Reiss e Fritz Luchsinger, alpinisti di punta della forte spedizione svizzera diretta da Albert Eggler, nel maggio 1956. Nello stesso anno c’è il primo exploit di una spedizione non europea: dopo due tentativi falliti i giapponesi raggiungono la vetta del Manaslu con Toshio Imanishi e lo sherpa Gyaltsen Norbu. A seguire, in rapida successione: nel 1956 gli austriaci Moravec, Larch e Willenpart salgono la vetta del Gasherbrum II; nel 1957 altri austriaci, tra cui Kurt Diemberger ed Hermann Buhl, sono sulla vetta del Booad Peak, con una spedizione molto leggera, senza portatori nel tratto finale; nel 1958 arrivano anche gli americani, primi sul Gasherbrum I; nel 1960 ancora sei alpinisti austriaci, tra i quali Diemberger, sul Dhaulagiri, questa volta con abbondanza di mezzi, compreso un piccolo aereo per i rifornimenti in alta quota (che peraltro si schianta). Rimane solo il Shisha Pangma, che i cinesi hanno riservato per sé e che scalano nel 1964, in piena rivoluzione culturale, portando in vetta dieci alpinisti, e impiegandone centoventicinque.
Malgrado siano ancora occupati nella ricostruzione postbellica, i governi europei si buttano nella corsa organizzando vere e proprie spedizioni di stampo militare, che impegnano centinaia di portatori, richiedono un grande sforzo logistico, prevedono l’uso sistematico dell’ossigeno, la preparazione delle vie con corde fisse e una serie di campi avanzati da piazzarsi progressivamente. Sfruttano in fondo le esperienze organizzative maturate durante il conflitto, si avvalgono di uomini rotti ormai ad ogni disagio e a vivere le situazioni più rischiose, utilizzano i materiali testati per sei anni sotto il fuoco. Ne nascono indubbiamente delle grandi imprese, anche sotto il profilo umano, ma la parentela con l’alpinismo classico è piuttosto laterale. L’impressione è che in questa corsa ci sia l’affanno a conquistarsi un pezzo di gloria e a liberarsi finalmente di un problema, e che dell’elemento ludico, del piacere di cui parlavano Kugy e Rey, ma anche Comici, e della passione pur ambigua di Lammer non sia rimasta nemmeno l’ombra.
La “decolonizzazione” parte negli anni sessanta. Ormai non rimane più nulla da conquistare: l’alpinismo può conservare un significato solo se scopre o si inventa una nuova dimensione etica. Questa dimensione viene individuata nel “rispetto” per la montagna, nella sua riconsacrazione attraverso un approccio più naturale, meno invasivo. È quello che viene definito, da uno storico dell’alpinismo, un “Nuovo Mattino”. Contribuisce a indurre questo ripensamento l’entrata in scena degli americani, non in virtù di una loro particolare sensibilità ecologica (anche se Thoreau, Emerson e Muir sono indubbiamente su questa direzione dei precursori) ma perché non hanno alle spalle alcuna tradizione alpinistica, e non si preoccupano quindi né di rispettarla né di dissacrarla. Sono portatori di un individualismo anarchico, in una connotazione però assai diversa da quella degli italiani: la loro irriverenza non è mai astiosa o polemica; semplicemente, se ne infischiano. E assieme a loro arriva sulle montagne anche l’eco dello spirito del sessantotto, delle lotte di liberazione, del terzomondismo, da ultimo della new age. È il compimento di un ciclo, e il ciclo è lo stesso che abbiamo già visto svolgersi nel racconto delle esplorazioni e della colonizzazione.
Il modello dominante torna dunque ad essere dopo gli anni cinquanta quello dell’alpinismo anglosassone, ma in due versioni diverse. Gli inglesi, che hanno riscoperto le Alpi con personaggi come Chris Bonington e Dough Scott, praticano un’etica molto severa quanto a protezioni, e quindi accettano una componente di rischio elevatissima. Non è cosa da tutti, perché include anche tutte le altre componenti tradizionali dell’alpinismo: freddo, fatica e paura. E infatti, rimane circoscritta ad una élite di puristi.
Gli americani portano invece, con Gary Hemmings e con la sua brigata di hippies cresciuta nella Yosemite Valley, una ventata innovativa, alle cui spalle c’è una trasformazione radicale di mentalità. Intanto rifiutano l’arrampicata artificiale come mezzo sleale, in nome di performance condotte in perfetta armonia con la natura, cosa che può attuarsi solo attraverso l’arrampicata libera. Di conseguenza bandiscono il chiodo ad espansione e riducono anche all’essenziale l’uso dei chiodi tradizionali, a favore delle moderne protezioni veloci (stopper, eccentrici, poi friends, etc.). La parete deve essere lasciata come la si è trovata. Infine rivalutano l’arrampicata a bassa quota, innalzandola da pratica complementare di allenamento ad attività fine a se stessa. Sono tuttavia americani, e si portano appresso, anche quando cercano la wilderness, un connaturato tecnicismo (micronut, cliff, etc), che aggira “quantitativamente” il nodo dell’artificiale, nel senso che è molto meno invasivo, ma “qualitativamente” non sposta granché il discorso. E questo aspetto in Europa viene colto, e malignamente rinfacciato dai puristi. Tutto sommato comunque il modello yosemitico, meno spartano, animato più dalla voglia di divertimento immediato che dall’etica del sacrificio, si sposa meglio col nuovo spirito dei tempi e incontra un successo ben maggiore di quello inglese. Col risultato, però, di creare in molti casi dei puri fenomeni di moda, o di inaugurare pratiche che con l’alpinismo hanno in comune solo la verticalità.
Quando questo modello viene invece adottato (ma per taluni aspetti si potrebbe anche dire anticipato) con senso critico e indipendenza nelle scelte, come modo di pensiero ed abito etico piuttosto che come canone tecnico e stilistico, i risultati sono eccezionali (sto pensando a Messner, alla determinazione e alla velocità delle sue realizzazioni alpine e himalayane). I gradi della scala Welzenbach saltano come birilli, a dispetto di resistenze e polemiche. Non è tanto il progresso tecnologico, a questo punto, a fare la differenza, quanto quello atletico e soprattutto quello psicofisico. L’allenamento in arrampicata, e anche quello alla scalata su ghiaccio, una volta coniugato ad una buona acclimatazione mentale e fisica alle quote più alte rende percorribili in velocità vie che erano considerate vent’anni prima di difficoltà estrema ed erano rimaste prerogativa di pochi eletti, spostando sempre più lontano la linea d’orizzonte dell’impossibile. Proprio questo balzo in avanti, però, che si traduce prima in ripetizioni invernali o in solitaria di itinerari proibitivi, poi nella corsa agli ottomila senza ossigeno e infine nelle concatenazioni e combinazioni più peregrine e massacranti (due o tre ottomila in successione, con trasbordo in elicottero, salite classiche e discese con gli sci o col parapendio, maratone ai limiti della troposfera, ecc.) distrugge il confine tra l’alpinismo e lo spettacolo circense o l’esibizione ginnica.
Anche la nuova etica dell’alpinismo, d’altra parte, vive davvero solo lo spazio di un mattino. Le istanze sincere di cambiamento si riducono rapidamente ad atteggiamenti vuoti e modaioli, e hanno una ricaduta commerciale piuttosto che comportamentale. L’esplosione dell’arrampicata sportiva in falesia induce al contrario il ritorno al chiodo ad espansione e all’attrezzatura sistematica del percorso, in nome di una visione puramente estetica e sportiva che necessita di arrampicare con protezioni sicure. Questo crea l’abitudine mentale a considerare “palestra” ogni parete, e tale abitudine non tarda ad essere trasferita in montagna, soprattutto nelle Alpi occidentali (nelle Dolomiti incontra molta più resistenza).
Ci troviamo pertanto di fronte oggi a quello che potrebbe essere definito l’ennesimo “ultimo problema delle Alpi”, e che rischia stavolta di esserlo sul serio. La parola d’ordine che circola ormai in maniera sempre più insistente e inquietante è “risanamento”: che significa mettere in sicurezza, riattrezzandole a spit, le grandi vie classiche, per consentire un “consumo” rapido e sicuro delle pareti e garantire il divertimento a tutti. È un progetto assurdo, che parrebbe aver nulla a che vedere con l’alpinismo, ma che nasce comunque da un’esasperazione e da uno stravolgimento della performance che serpeggiano nell’ambiente alpinistico. Il virus è diffuso in alto, ma qualche linea di febbre l’abbiano un po’ tutti. Non sarebbe male, ogni tanto, magari al momento in cui scendiamo dall’auto o lasciamo il rifugio per affrontare una salita, fermarci a riflettere su come siamo bardati e sullo spirito con quale ci stiamo muovendo. Qualora ci scoprissimo disposti a prenotare o a pagare il biglietto per salire in giornata il Petit Dru, sarebbe ora di tornare a casa.
Scendere a valle
Non sono un alpinista, neppure mediocre, se per poter essere considerato tale occorre vantare un ricco palmares di quattromila. Sarò salito si e no cinque o sei volte oltre quella quota. In compenso amo la montagna, e se vedo una cima voglio arrivarci, se incrocio una roccia che tira in verticale mi piace salirla, ho esperienza di corde e di rifugi, e più ancora di letteratura alpinistica: ma tutto si ferma lì. Le mie credenziali per tirare le somme della vicenda che ho raccontato sono davvero scarse, se si esclude il coraggio di averci provato. Ma forse, al contrario, è davvero questa la miglior condizione per farlo: uno sguardo “laico” su un’attività che troppo spesso, da ludica che dovrebbe essere, è diventata e continua ad essere vissuta come religiosa.
Non c’è dubbio che dal punto di vista naturalistico, che è quello della specie, l’alpinismo rappresenti uno spreco insensato: di tempo, di energie, di uomini e di mezzi. Non è nemmeno uno strumento di selezione positiva, anzi: paradossalmente ad essere scartati dalla selezione sono in questo caso quasi sempre i più arditi e i più forti. Meno che mai è un’attività che arreca un qualche beneficio collettivo: quando va bene non metti a repentaglio la vita di altri, compagni, soccorritori, ecc. e ti porti a casa una scaglia di roccia come souvenir. A voler essere generosi si può pensare che si scarichino su pareti e ghiacciai energie e tensioni che a valle potrebbero essere perniciose: e questo forse, sempre dal punto di vista della specie, un qualche vantaggio lo porta. C’è comunque da chiedersi se quella che ho sommariamente descritta non sia la storia di una insana passione, indotta da un progressivo aumento del benessere e della sicurezza di vita. Quando la percentuale di precarietà e di rischio nella vita quotidiana scende sotto una certa soglia i più sensibili, quindi i più irrequieti, ne patiscono l’assenza, e sono indotti a ricrearne in qualche modo le condizioni. Gli alpinisti sarebbero quelli che lo fanno nella maniera socialmente meno dannosa, perché in fondo mettono in gioco e a rischio solo se stessi.
In realtà non penso che si tratti solo di questo. Ci deve essere molto di più per spingere qualcuno non tanto a rischiare (questo lo fanno anche gli idioti che si gettano in piscina dalla finestra, o che si sdraiano sui binari: e comunque, quanto al rischio, c’è in ogni attività, dal guidare un’auto o una bicicletta al buttarsi in mare) quanto a faticare, a patire il freddo, a esporsi al congelamento, ecc.
Su questo tema si sono già sbizzarriti milioni di appassionati, ciascuno portando la sua brava motivazione, e devo dire che quelle che ho letto mi sono sembrate tutte altrettanto convincenti. Ma si trattava comunque di motivazioni individuali. Ciò che a me interessa, e che in queste pagine ho cercato di indagare, è invece il secondo livello, quello nel quale le singole motivazioni si sommano e danno origine ad un fenomeno sociale e culturale. L’assunto era questo: l’alpinismo non scaturisce da una naturale spinta biologica. Questa spinta non esiste in natura perché non risponde ad alcuna strategia di sopravvivenza o riproduttiva. Nessuno stambecco ha mai sentito il bisogno di salire in vetta al Gran Paradiso, pur vivendo appena mille metri più in basso. Il desiderio di scalare una montagna appartiene solo all’uomo: può essere giustificato, a seconda delle epoche, in maniere diverse, con motivazioni politiche, religiose, scientifiche, nazionalistiche, superomistiche, sportive, economiche o legate al successo: ma è comunque frutto di una elaborazione culturale. In due sensi: nel primo perché l’assenza di fini concreti in un’azione che richiede sacrificio, impegno, dispendio energetico, e al limite anche assunzione di rischio, è misura della distanza di questa azione dai dettami dell’istinto. Nel secondo perché penso che l’affermazione vada presa anche alla lettera; non è un caso se la gran parte degli alpinisti ha un livello di cultura superiore, e se un tempo la cosa poteva dipendere dalla diversa disponibilità di tempo e di denaro nelle differenti classi sociali, oggi questo discrimine non esiste più.
L’alpinismo è dunque una forma di cultura, per un verso soggetta al variare dei climi culturali, storicizzata, per l’altro legata ad un modo d’essere “naturalizzato” degli umani, effetto reversivo dell’evoluzione. I modi della variazione li abbiamo visti: provo ora ad enucleare sinteticamente quelle che proprio nello scrivere queste pagine mi sono parse essere le matrici costanti, indipendenti dai tempi.
- a) L’irrequietezza. Non ci piove. È un bisogno connaturato (questo sì) all’uomo quello di andare un po’ più in là. È un problema di spazio, già a livello primitivo. Come ogni animale l’uomo ha bisogno di spazio per sopravvivere: ma a differenza di ogni altro animale, e in ragione del suo eccezionale successo evolutivo, ne ha necessità poi anche per vivere. In un pianeta che si avvia a diventare sovraffollato gli spazi orizzontali sono praticamente ormai tutti occupati. Rimangono solo, almeno in parte, quelli verticali. Siamo animali sociali, ma non gregari: almeno, alcuni di noi non lo sono. Hanno bisogno del contatto, ma ne hanno altrettanto di uscire dal gruppo. Lammer centrava il problema quando diceva che la solitudine era la condizione e la molla dell’alpinismo. Solo, avrebbe dovuto usare gli articoli indeterminativi.
- b) Il confronto con se stessi, la necessità di conoscersi. Siamo talmente condizionati dal ruolo, dall’ambiente, dalla famiglia, dal lavoro, che non sappiamo quasi nulla di noi stessi. A volte ce ne accorgiamo, e desideriamo metterci alla prova. Soprattutto, vorremmo capire quali sono i nostri limiti. L’alpinismo ti offre condizioni estreme, nelle quali non ti puoi raccontare palle. Vai o non vai. E non è detto che il responso debba essere sempre positivo. Solo, è importante che sia chiaro: questo fa per me, questo no; fin qui ci arrivo, più in là no. Può darsi che ci siano altri modi altrettanto efficaci per conoscersi: ma la situazione nella quale ti mette l’alpinismo è senz’altro la più semplice e la più pulita. Non consente trucchi.
- c) Il rapporto con la natura. La nostra cultura ha steso sulla terra una seconda pelle. Tutto ciò che facciamo è condizionato dall’artificio, o è addirittura virtuale. L’alpinismo (quello vero, naturalmente) non si concede alcun artificio (e non classifico come tali le misure di sicurezza; diverso è il discorso dell’attrezzatura dei percorsi). Ti immerge in una situazione nella quale il manico lo tiene la natura. Il rapporto si ribalta: ti devi affidare ad essa (clima, tenuta del terreno su cui arrampichi), sei nelle sue mani. È un ritorno nel suo grembo.
- d) Ma alla fine, non sarà la competitività la vera molla dell’alpinismo? Se la cultura è sublimazione degli istinti, lo sport è la sublimazione per eccellenza dell’aggressività e della competizione. Massimo Mila, che ha scritto sulla montagna pagine bellissime, dice che è inutile girarci attorno: arrivare per primo su una vetta che non è mai stata toccata da altri, o salire una via che non è mai stata percorsa, è il sogno di ogni alpinista. Il confronto non è solo con se stessi, ma anche con gli altri. In effetti, le vicende che abbiamo incontrato in queste pagine parlano di uomini che hanno cavalcato cime vergini o tracciato itinerari inediti: sono loro che hanno fatto la storia dell’alpinismo. Io la trovo tuttavia una componente non necessaria, e forse neppure sufficiente. Può darsi che segni la differenza tra fare dell’alpinismo o andare in montagna: ma se così fosse, l’alpinismo sarebbe davvero solo uno sport. Penso che ci sia già soddisfazione completa nell’arrivare in vetta, indipendentemente dal fatto che qualcun altro vi sia stato prima (meglio, naturalmente, se non vi ha piantato una croce o costruito un cippo).
E qui, finalmente, mi fermo. Fossi davvero su una vetta, ora proverei quel sentimento che più di ogni altro penso appartenga agli alpinisti. Io lo definirei “struggimento”, i Romantici parlavano di “sehnsucht”: l’angoscia sottile che prende quando si arriva a vedere il mondo da un punto che lo fa apparire fantastico, e si sa di non poter rimanere lì per sempre, o tornarci ogni volta che si vorrà. È la percezione della nostra finitezza spaziale e temporale rispetto all’infinità e all’eternità di quanto ci circonda: un sentimento che ci turba, ma ci fa anche ringraziare la natura per averci, sia pure per un attimo, fatti sentire partecipi di tanta meraviglia.
Quando ricordo però che Gervasutti parla di “amarezza per il sogno diventato realtà”, e non accenna affatto al guardarsi attorno, il dubbio ritorna: forse davvero non sono un alpinista, forse sono solo un sognatore, e ho raccontato fino ad ora un mio sogno. E allora me ne scuso con chi mi ha letto, ma io il sogno me lo tengo.
Salire. Bibliografia essenziale per una letteratura dell’alpinismo
STORIA DELL’ALPINISMO
AA VV – Alpinismo italiano in Karakorum – Museomont. – To 1991
AA VV – Dal Polo al K2 – Museomontagna, To 1984
AA VV – De Saussure e il Monte Bianco – Museomontagna, To 1987
Amy, Bernard – L’alpinismo – Dall’Oglio, Milano
Ardito, Stefano – Le grandi scalate – Newton Compton, 2014
Ballu, Yves – Gli alpinisti – Mursia, Milano 1987
Ballu, Yves – Naufragio sul Monte Bianco – Vivalda, Torino 2000
Buscaini, G. Metzeltin, S.– Patagonia – Corbaccio 1998
Camanni, Enrico – Di roccia e di ghiaccio –Laterza 2003
Camanni, Enrico –Nuovi mattini – Vivalda 1998
De Agostini, A. M. – Ande Patagoniche – Vivalda 1999
De Filippi, Filippo – La spedizione nel Karakoram – Zanichelli 1981
De Filippi, F.–La spedizione del Duca degli Abruzzi al Sant’Elia– Milano 1996
Desio, Ardito – La conquista del K2 – Marsilio, Venezia 1988
Engel, C. E. – Storia dell’alpinismo – Einaudi 1965
Fantin, Mario – Tricolore sulle più alte vette – Tamari, Bologna 1970
Fleming, Fergus – Cime misteriose – Carocci, Roma 2001
Ferrari, Marco A. – Freney 1961 – Vivalda 1998
Ferrari, Marco A.– Le prime albe del mondo – Laterza 2014
Frison-Roche, Roger – Storia dell’alpinismo – Corbaccio, Milano 1993
Franco, J.- Terray, L. – Battaglia per lo Jannu – Tamari, Bologna 1969
Garobbio, A. – Rusconi, G. – L’alpinismo – Sansoni, Firenze
Heckmair, Anderl – I tre ultimi problemi delle Alpi – CDA 2001
Herzog, M. – Le grandi avventure dell’Himalaya – De Agostini, 1983
Herzog, Maurice – Annapurna, I primi ottomila – Corbaccio 1994
Holzel, T., Solkeld, A. – Il mistero della conquista dell’Everest– S&K.1999
Keay, J. – Quando uomini e montagne si incontrarono – Neri Pozza 2005
Kurz, Marcel – Alpinismo invernale – Vivalda, Torino 1994
Joutard, Philippe – L’invenzione del Monte Bianco – Einaudi 1993
Lopez Marugan, A. – Corde ribelli – CDA, 2001
MacFarlane, R. – Come le montagne conquistarono gli uomini – Mondadori 2005
Masciandri, F. – Storia dell’alpinismo europeo – Com. Naz. Sc. Alp. 1989
Motti, Gian Piero – Storia dell’alpinismo – Vivalda, Torino 1997
Monzino, Guido – Spedizioni d’alpinismo in Africa – Mondadori
Monzino, Guido – Spedizioni d’alpinismo in Groenlandia – Mondadori
Monzino, Guido – Italia in Patagonia – Martello 1958
Pesci, Eugenio – La scoperta dei ghiacciai – CDA/Vivalda 2004
Shipton, E. – Quel mondo inesplorato – CDA/Vivalda 2002
Sposito, Livio – Il mondo dall’alto – Sperling & K. 2000
Spreafico, G. – Enigma Cerro Torre – CDA &Vivalda 2006
Tenderini, Mirella – Le nevi dell’Equatore – CDA 2001
Zannini, Andrea – Tonache e piccozze – CDA/Vivalda 2004
STORIA E ANTROPOLOGIA DELLA MONTAGNA
AA VV – La Montagna. Grande Enciclopedia Illustrata – De Agostini, Novara 1987
AA VV – L’uomo e le Alpi – Vivalda, Torino 1993
AA VV – Rapporto sullo stato delle Alpi – CDA, Torino 1998
Bocca, M. – Centini, M.– Le vie della fede attraverso le Alpi –Pr/Verl, 1994
Camanni, Enrico – Storia delle Alpi – Bibl. dell’Immagine, MI 20017
Dainelli, G. – Le alpi. L’ambiente naturale. L’ambiente umano – Utet, 1963
Guichonnet, Paul – Storia e civiltà delle Alpi – Jaka BooK 1984
Mari, A. – Kindl, U. – La montagna e le sue leggende – Mond. 1988
Maraini, Fosco – Segreto Tibet – Bari 1951
Neale, Jonathan – Le tigri delle nevi – CDA & Vivalda 2004
Ries, Julien – Montagna sacra – Jaka Book, 2010
Tenderini, Silvia –Locande, ospizi, alberghi sulle Alpi – CDA/Viv 2002
Tenderini, S. – La montagna per tutti – CDA/Vivalda 2004
Tenderini, S. – Ospitalità sui passi alpini – CDA/Vivalda 2005
MONOGRAFIE SULLE PRINCIPALI VETTE
AA VV – K2 – Museomontagna, Torino 1994
AA VV – Free K2 – Pescara 1991
Ardito, Stefano – Le regine d’Africa – Vivalda, 2003
Bernardi, Alfonso – Il Gran Cervino – Zanichelli, Bologna
Bernardi, A. – Il Monte Bianco. Un secolo di alpinismo – Zanich, 1966
Bernardi, Alfonso – La grande Civetta – Zanichelli, Bologna 1969
De Agostini, Alberto M. – Ande patagoniche – Vivalda, Torino 1999
Fantin, Mario – Cervino 1865-1965 – Tamari, Bologna 1965
Fava, Cesarino – Patagonia. Terra dei sogni infranti – CDA 1999
Ghiglione, Pietro – Monte Bianco – De Agostini, Novara 1978
Gillman, Peter – Everest – Vallardi 1994
Gogna, Alessandro – Grandes Jorasses, sperone Walker – Tamari, 1994
Gugliermina, F. – Il Monte Bianco esplorato – Tamari, 1991
Mazzotti, Giuseppe – Grandi imprese sul Cervino – L’Eroica, MI 1934
Messner, R. – Annapurna. Cinquant’anni di un ottomila – Vivalda 2000
Miotti, Giuseppe – Bernina, questo sconosciuto – Vivalda 1998
Rey, Guido – Il Monte Cervino – Viglongo, Torino 1962
Unswort, Walt. – Everest – Mursia 1991
FILOSOFIA ED ETICA DELL’ALPINISMO
Ardito, Fabrizio – Di pietra e acqua – Vivalda 2000
Berhault, P. – Giani, B. – Il gesto e la pietra – Ivrea 1986
Bernbaum, G. – Le montagne sacre del mondo – Leonardo, Milano 1991
Biancardi, Armando – La voce delle altezze – Cappelli, Bologna
Bianchi, Marco – Montagne con la vetta – Vivalda 1999
Bonatti, Walter – Un modo di essere – Dall’Oglio, Milano 1989
Camanni E – Nuovo mattino. Il singolare sessantotto degli alpinisti– Vivalda 1998
Camanni, Enrico – Sogni scelti per alpinisti classici – Vivalda 1995
Del Zotto, Giancarlo – Alpinismo moderno – Il Castello
Diemberger, Kurt – Gli spiriti dell’aria – Vivalda 1999
Diemberger, Kurt – Cime e segreti – Zanichelli, Bologna 1982
Edlinger, P. – Ferrand, A. – Lemoine, M. – Arrampicare – Zanichelli, 1985
Edlinger, P. – Kosicki, G. – Rock Games – Zanichelli
Evola, Julius – Meditazioni delle vette – Ed, del Tridente, La Spezia 1974
Ferrari, Marco A. – Attraverso il decennio dei cambiamenti – Vivalda, 1994
Forno, Oreste – Il paradiso può aspettare – Mountain Promotion 2001
Forno, Oreste – Sherpa, conquistatori senza gloria – Dall’Oglio 1990
Forno, Oreste – Compagni di cordata – Mountain Promotion 1998
Gherzi, Andrea – La musica delle montagne – CDA 2000
Giglio, Pietro – La montagna dei preti alpinisti – Vivalda, Torino 2000
Gobetti, Andrea – Una frontiera da immaginare – Dall’Oglio, 1976
Gogna, Alessandro – Cento nuovi mattini – Zanichelli 1981
Gogna, Alessandro – La parete – Zanichelli, Bologna 1981
Gogna, Alessandro – Rock story – Il Melograno, Genova 1983
Gogna, Alessandro – Un alpinismo di ricerca – Dall’Oglio, Milano 1975
Kugy, Julius – La montagna che strega – Vivalda, 1998
Livanos, George – Al di là della verticale – Tamari, Bologna 1964
Mazzotti, Giuseppe – Alpinismo e non alpinismo – Treviso 1946
Messner, Reinhold – L’avventura alpinismo – Athesia, 2005
Messner, Reinhold – La montagna è il mio mondo – Corbaccio 2009
Mestre, M. – Le Alpi contese. Alpinismo e nazionalismi – CDA/Viv 2003
Mila, Massimo – Scritti di montagna –Einaudi, Torino 1997
Miotti, Giuseppe – Il ritorno del classico – Vivalda, 2002
Motti, Gian Piero – I falliti – Vivalda, Torino 2000
Prada, Sandro – Alpinismo romantico – Tamari, Bologna, 1974
Rebuffat, Gaston – Gli orizzonti conquistati – Zanichelli, 1988
Reinhard, Karl – Montagna vissuta. Tempo per respirare – Vivalda 2001
Rey, Guido – La fine dell’alpinismo – ed. Montes, Torino 1939
Simpson, Joe – Ombre sul ghiacciaio – CDA, Torino 2004
Stenico, M. – Alpinismo Perché – ed. Ghedina 1981
Zolla, Elèmire – Lo stupore dell’infanzia – Adelphi, Milano 1991
LETTERATURA ED ESTETICA DELL’ALPINISMO
AA VV – Le seduzioni della montagna – Electa 1998
AA VV – Le cattedrali della terra – Electa 2000
AA VV – Le montagne della satira – Museomontagna, Torino 1994
AA VV – Le montagne della pubblicità – Museomontagna, Torino,1989
AA VV – Ritratto di alpinista –Museomontagna, Torino 1992
AA VV – John Ruskin e le Alpi – Museomontagna, Torino 1990
AA VV – Il Monte Bianco nelle immagini e nelle relazioni dell’800 – Torino 1986
AA VV – Alpi gotiche – Museomontagna, Torino 1998
AA VV – Alpi Giapponesi – Museomontagna, Torino 1998
AA VV. – Simbolico e concreto – Museomontagna, Torino 1999
AA VV – Ecuador. Le Alpi dipinte – Museomontagna, Torino 1998
Audisio, A. – Rinaldi, R – Montagne e letteratura – Museomontagna, 1983
Audisio, A. – Rinaldi, R – Letteratura dell’alpinismo – Museomont, 1985
Camanni Enrico – La letteratura dell’alpinismo – Zanichelli, 1975
Christoffel, U– La montagne dans la peinture – CL. ALP. SUISSE, 1963
Dumas, Alexandre – In viaggio sulle Alpi – Vivalda 1998
Festi, R. – Manzati, E. – Le Dolomiti nei manifesti – Ivrea 1990
Garimoldi, G., Jalla, D. – Alpi di sogno – Silvana, Milano 2006
Gherzi, Andrea – La musica delle montagne – CDA/Vivalda 2003
Giardina, Andrea – Le parole della montagna – Baldini & Castoldi 2003
Mazzotti, Giuseppe – La montagna presa in giro – L’Eroica, Varese 1936
Mazzotti, G. – La montagna nel manifesto pubblicitario – Canova, 1959
Pesci, Eugenio – La montagna del cosmo – CDA, Torino 2001
Schama, Simon – Paesaggio e memoria – Mondadori, Milano 1997
BIOGRAFIE DI ALPINISTI
AA VV – Guido Rey. Dall’alpinismo alla letteratura – Museomont, 1986
AA VV – Ai limiti del mondo. Alberto De Agostini– Museomont., 1992
AA VV – Sant’Elia 1897. Il Duca degli Abruzzi – Museomont, 1997
AAVV – L’ultima scalata – Newton Compton 2010
AAVV – Sul tetto del mondo – Newton Compton 2009
Bonington, Chris – Ho scelto di arrampicare – Vivalda, Torino
Borgognoni, A. – Titta Rosa, G. – Scalatori – Hoepli, Milano 1985
Camanni, E. – Ribola, D. – Spirito, P. – La stagione degli eroi – Vivalda. 1994
Camanni, E. – Cieli di pietra. La vera storia di Amé Gorret – Torino 1997
Camanni, E. – Il desiderio di infinito. Vita di Giusto Gervasutti – Laterza, 2017
Casara, Severino – Preuss, l’alpinista leggendario – Milano 1970
Casara, Severino – L’arte di arrampicare di Emilio Comici – Hoepli, 1957
Cassarà, Emanuele – Un alpinismo irripetibile – Dall’Oglio, Milano
Cassin, Riccardo – Capocordata. La mia vita di alpinista – Vivalda 2001
Cassin, Riccardo – Cinquant’anni di alpinismo – Dall’Oglio, Milano 1977
De Amicis, Ugo – Piccoli uomini e grandi montagne – Treves, 1924
Ferrari, Marco A. – Il vuoto dietro le spalle – Vivalda 2000
Ferrari, Marco. A. – La storia di Ettore Castiglioni – TEA 2008
Gervasutti, Giusto – Il fortissimo – Il Melograno, Milano 1985
Hiebeler, Toni – Tra cielo e inferno – Tamari, Bologna
Kugy, Julius – Dalla vita di un alpinista – L’Eroica, Milano 1932
Livanos, George – Cassin. C’era una volta il sesto grado – Dall’Oglio, 1984
Maestri, Cesare – Arrampicare è il mio mestiere – Garzanti, Milano 1961
Mazzarelli, Paola – G. W. Young, l’ultimo alpinista vittoriano – Vivalda
Mazzarelli, Paola – Il setacciatore delle Alpi – Vivalda
Messner, R.- Hofler, H. – Hermann Buhl in alto senza compromessi– Vivalda 1998
Messner, Reihnold – La libertà di andare dove voglio – Garzanti, 1992
Miotti, Giuseppe – Sulle tracce di Piero Ghiglione – Vivalda
Rebuffat, Gaston – La montagna è il mio mondo – Vivalda, Torino, 1997
Roberts, Eric – Willo Welzenbach – Vivalda 1992
Tenderini, M – Gary Hemming, Una storia degli anni sessanta– Vivalda, 1994
Trenker Luis – Eroi della montagna – Dall’Oglio, 1982
CLASSICI DELLA LETTERATURA ALPINISTICA
Boccalatte, G. – Piccole e grandi ore alpine – L’Arciere/Vivalda, 1992
Bonatti, Walter – I giorni grandi – Zanichelli, Bologna 1971
Bonatti, Walter – Montagne di una vita – Baldini e Castoldi, 1995
Bonatti, Walter – Le mie montagne – Rizzoli, Milano, 1983
Bonatti, Walter – Il caso K2 – Baldini e Castoldi, 1996
Bonington, C. – Ho scelto di arrampicare – Vivalda 1997
Buhl, Hermann – È buio sul ghiacciaio – Il Melograno, Milano 1984
Buzzati, Dino – Le montagne di vetro – Vivalda
Buzzati, Dino – Sulle Dolomiti – 2005
Cassin, Riccardo – Mc Kinley – CDA, Torino
Cassin, Riccardo – In Grigna! – Domus 2005
Castiglioni, Ettore – Il giorno delle Mesules – Vivalda 1993
Chabod, R. – La cima di Entrelor – Zanichelli 1969
Comici, Emilio – Alpinismo eroico – Vivalda, 1996
D’Angeville, Henriette – La mia scalata al Monte Bianco 1838 – Vivalda 2000
De Amicis, Edmondo – Nel regno del Cervino – Vivalda, Torino 1998
De Amicis, Ugo – Alpe mistica – Milano 1926
Desmaison, Renèe – La montagna a mani nude – Dall’Oglio, 1972
Desmaison, R – 342 ore sulle Grandes Jorasses – Dall’Oglio, 1973
Diemberger, Kurt – K2. Il nodo infinito – Dall’Oglio, Milano 1988
Diemberger, Kurt – Tra zero e ottomila – CDA, Torino 1995
Dingle, G. – Hillary, P. – La traversata dell’Himalaya – De Agostini 1985
Dumler, Helmut – Le tre cime di Lavaredo – Tamari, Bologna 1972
Frison-Roche, Roger – Primo di cordata – Vivalda, Torino 1994
Gervasutti, Giusto – Scalate nelle Alpi – SEI, Torino 1966
Gervasutti, G. – Scalate nelle Alpi – CDA/Vivalda 2005
Gervasutti, G. – Il Fortissimo – Il Melograno, MI 1985
Harrer, Heinrich – Parete Nord – Mondadori 1999
Hillary, Edmund – Arrischiare per vincere – Dall’Oglio, Milano
Klucker, Christian – Memorie di una guida alpina – Tararà, Verb. 1999
Kugy, Julius – Dal tempo passato – Libreria Adamo, Gorizia 1982
Javelle, Emilio – Ricordi di un alpinista – Canova, Treviso 1947
Lammer, Eugen Guido – Fontana di giovinezza – Vivalda, Torino 1999
Maestri, Cesare – …E se la vita continua – Baldini e Castoldi 1996
Maestri, Cesare – Duemila metri della nostra vita – Garzanti 1972
Maraini, Fosco – Gasherbrum IV – Vivalda, Torino 1996
Marchi, Rolly – Le mani dure – Vivalda 1997
Mauri, Carlo – Quando il rischio è vita – La Sorgente 1975
Muyr, John – La mia prima estate sulla Sierra – Vivalda, 1997
Mummery, A. F. – Le mie scalate nelle Alpi e nel Caucaso – Torino 1965
Piaz, Titta – Mezzo secolo d’alpinismo – Il Melograno, Milano 1986
Rebuffat, Gaston – Tra la terra e il cielo – Bietti, Milano 1965
Rebuffat, Gaston – Stelle e tempeste – Zanichelli, Bologna 1981
Rey, Guido – Alpinismo acrobatico – CDA, Torino 2001
Samivel – Amatore d’abissi – Zanichelli, Bologna 1984
Stephen, Leslie – Il terreno di gioco dell’Europa – Vivalda 1999
Terray, Lionel – I conquistatori dell’inutile – Dall’Oglio, Milano 1977
Tilman, H.W. – Uomini e montagne – CDA, 2001
Tyndall, J – Un gentleman in cima al Weisshorn – Domus 2005
Zurbriggen, Mattia – Dalle Alpi alle Ande – Vivalda, 2001
Wymper, E. – Scalate nelle Alpi La conquista del Cervino –Viglongo, 1963
LETTERATURA ALPINISTICA MODERNA
Ardito, Stefano – Le grandi scalate – Newton Comp. 2014
Ardito, Stefano – Dodici quattromila e mezzo – Vivalda, Torino
Ardito, Stefano – Il primo orso non si scorda mai – Vivalda, Torino
Ardito, Stefano – Ramponi all’ascolana – Vivalda
Bizzarro, Paolo – Vietato volare – CDA Vivalda 2005
Boardman, P. – Montagne sacre – Dall’Oglio, Milano 1983
Boardman, P. – La montagna di luce – Dall’Oglio, Milano 1978
Boivin, Jean Marc – L’uomo dei ghiacci – Dall’Oglio, Milano 1985
Bonicelli, Piero – Pukajirka ‘81 – CEDIS, Bergamo 1983
Bonington, Chris – Annapurna parete sud – Dall’Oglio, Milano 1973
Bonington, Chris – Everest parete sud-ovest – Dall’Oglio, Milano 1975
Brevini, Franco – Rocce – Mondadori 2004
Brevini, Franco – Ghiaccio – Mondadori 2002
Bukreev, A. – Weston, G.– Everest 1996 – CDA & Vivalda 2004
Calcagno, Gianni – Stile Alpino – Vivalda, Torino 2000
Camanni, Enrico – La guerra di Joseph – Vivalda, Torino 1998
Cassin, R. – Nangeroni, G. – Lhotse ‘75 – Zanichelli, Bologna 1977
Cesen, Tomo – Solo – Dall’Oglio, Milano 1991
Cognetti, Paolo – Otto montagne – Einaudi, Milano 1916
Drury, Bob – Una stagione da eroi – Corbaccio, 2001
Ferrari, Marco A. – In viaggio sulle Alpi – Einaudi Milano 2009
Ferrari, Marco A. – Alpi segrete –Laterza 2012
Ferrari, Marco A. – La via del lupo – Laterza 2014
Ferrari, Marco A. – Il sentiero degli eroi – Rizzoli 2016
Giovannini, Franco – Tibet e dintorni – CDA 1999
Gogna, Alessandro – Mezzogiorno di pietra – Zanichelli
Harrer, Heinrich – Sette anni in Tibet – Mondadori 1998
Haston, D. – Verso l’alto – Dall’Oglio, Milano 1978
Hiebeler, Toni – Eiger, parete Nord – Tamari, 1972
Kammerlander, Hans – Malato di montagna – Corbaccio 2000
Kammerlander, Hans – Discesa al successo – Publilux 1991
Krakauer, Jon – Aria sottile – Corbaccio 1998
Jackson M. – Stark E. – Tende tra le nuvole – TEA 2005
Lauwaert, Anna – La via del drago – CDA, Torino 2003
Lightner, Sam – Altitudini sconosciute – Il Saggiatore, 2001
Mazzotti, G. – La grande parete – Nuovi Sentieri, Belluno
Messner, Reinhold – Corsa alla vetta – De Agostini 1986
Messner, Reinhold – Tutte le mie cime – Zanichelli 1995
Messner, Reinhold – Il settimo grado – De Agostini 1992
Messner, Reinhold – Nanga Parbat in solitario – De Agostini, 1979
Messner, Reinhold – Orizzonti di Ghiaccio – De Agostini, Novara 1983
Messner, Reinhold – Due e un ottomila – Dall’Oglio 1977
Messner, Reinh. –Sopravvissuto: i miei 14 ottomila –De Agostini, 1987
Messner, Reinhold – Ritorno ai monti – Athesia, Bolzano 1971
Messner, Reinhold – Il limite della vita – Zanichelli 1989
Moro, Simone – Cometa sull’Annapurna – Corbaccio 2003
Norgai, Tiensin – Lo sherpa – Corbaccio 2006
Perlotto, Franco – Giungla verticale – Vivalda, Torino 1998
Pieropan, Gianni – Due soldi di alpinismo – Tamari, Bologna 1970
Pietrasanta, Ninì – Pellegrina delle Alpi – CAI, MI 2011
Reinhart, Karl – Yosemite – Dall’Oglio, Milano 1986
Ryan, Tom. – Con te in cima al mondo – Sperling&K. 2011
Simpson, Joe – La morte sospesa – Vivalda, Torino 1994
Simpson, J. – Queste storie di fantasmi. Storie vere di un sopravvissuto – Torino 1994
Thurman, R. – Wise, T. – La montagna sacra – Neri Pozza 2000
Unterkircher, Silke – L’ultimo abbraccio della montagna – BUR 2012
Wingall, Sidney – La spia sul tetto del mondo – Pratiche, Milano 2001
Zannini, Gianfranco – Arrampicate di confine – Vivalda, Torino, 1998
NARRATIVA
Bertolotto, G. – Il camoscio bianco –ArabaFenice 2010
Buzzati, Dino – Barnabò delle montagne – Mondadori, Milano 1981
Cagna, A. – Alpinisti ciabattoni – Baldini e Castoldi, Milano 2000
Daudet, Alphonse – Tartarino sulle Alpi – Rizzoli 2002
Daumal, René – Il monte Analogo – Adelphi 1968
Frison–Roche, Roger – Primo di cordata – Garzanti 1960
Haushofer, Marlene – La parete – E/O, Roma 1989
Stifter, Adalbert – Cristallo di rocca – Adelphi 1984

NOTE
[1] Questo saggio è nato come capitolo finale dello studio “In capo al mondo e ritorno”, dedicato ai viaggi di scoperta, alle esplorazioni e alla colonizzazione europea del mondo nell’età moderna. Non ho ritenuto di modificarne l’incipit per l’edizione separata.
[2] È significativo il fatto che l’unico nome latino rimasto per un monte delle Alpi sia quello del Mons Vesulus, il Monviso. Seneca definisce coloro che ammirano le Alpi intelletti incostanti e insensibili. Strabone dice però che anche i Romani, nella loro politica di sottomissione delle popolazioni alpine, cercavano “la gloria delle cime”.
[3] La prima scalata “certificata”, in questo caso da Tito Livio, sembra essere quella di Filippo di Macedonia al monte Emo, in Tessaglia, nel 181 a.C.
[4] Livio e Silio Italico parlano del terrore deli uomini di Annibale, Claudiano di quelli di Stilicone durante le campagne di quest’ultimo nelle Alpi Centrali.
[5] Con qualche eccezione. Strabone, ad esempio, vedeva nella rozzezza dei montanari, se mitigata e combinata con l’intelligenza degli abitanti delle pianure, una virtù.
[6] Le piccole glaciazioni si ripeteranno nel XVII e nel XVIII secolo, spingendo a valle gli insediamenti e facendo scomparire interi villaggi e vaste zone di pascolo. Una leggenda alpina racconta che le zone dei ghiacciai fossero un tempo fertili, abitate e coltivate, e che siano state ricoperte dai ghiacci per punizione divina.
[7] I soggetti prevalenti nella pittura cinese del periodo Sung (corrispondente alla parte centrale del nostro Medioevo) sono i corsi d’acqua e le montagne, perché queste due entità incarnano non solo i due poli della natura, ma anche quelli della sensibilità umana: e sono poli entrambi positivi. Secondo un detto di Confucio “l’uomo di cuore si incanta davanti alla montagna: l’uomo di spirito gode dell’acqua”.
[8] Le Alpi continuano tuttavia ad essere interessate anche durante il Medioevo da un traffico costante. Per l’intero periodo rimangono aperti quasi tutti i passi già frequentati in epoca romana, dal Col di Tenda al Monginevro, al Grande e al Piccolo San Bernardo, al Moncenisio, allo Spluga e al Brennero. A percorrerli sono eserciti che scendono in Italia, papi con il loro seguito che si recano a concili, pellegrini che si muovono a volte in processioni di massa, mercanti che viaggiano con carovane di muli. I disagi che costoro incontrano sono dati dalla scarsa o nulla manutenzione dei percorsi, mentre i pericoli, oltre che dai fenomeni naturali, valanghe, tempe-ste di neve, fulmini, precipizi, arrivano dal diffuso banditismo o dagli animali (soprattutto dai lupi). Ad attenuare questa pericolosità c’è il diffondersi dei castelli, costruiti in genere all’imbocco delle valli, di ospizi, al culmine dei passi, e di abbazie, eremi e monasteri, nelle zone più alte e recondite delle vallate.
[9] Epistulae Familiares, VI, 1
[10] E non è l’unico. Nel suo Itinera per Helvetiae alpinas regiones, pubblicato nel 1723, il naturalista Jacob Scheuchzer fa un censimento di tutti i draghi svizzeri, dandone per scontata l’esistenza e annoverandone diverse decine, classificati per dimensioni e caratteristiche.
[11] C. Gessner, Libellus de lacte et operibus lactariis.Cum epistola ad Jacobum Avenium de montium admiratione, Zurigo 1541
[12] Peletier sottolinea anche la differente disposizione che abitanti e viaggiatori hanno nei confronti dei luoghi: “I savoiardi che l’onesto avvenire / ammonisce quietamente alle fatiche / restando in pace guardano gli stranieri / andare e venire, ciechi ai pericoli / Sono a casa loro, e per restarvi faticano / guardando quelli che, per faticare, restano”. Una rappresentazione icastica di quello che sarà il rapporto tra gli alpigiani e gli alpinisti nel XIX e nel XX secolo.
[13] Il precedente periodo di riscaldamento climatico, tra la metà del XV e la fine del XVI secolo, aveva molto favorito la frequentazione delle Alpi, e di conseguenza il mutamento della loro percezione. Il traffico di viaggiatori era aumentato, imponendo anche il ripristino e la manutenzione di numerose vie di valico, ed erano state riscoperte, ad esempio, località termali già note ai Romani.
[14] In effetti, il vero fondatore della geologia moderna è considerato James Hutton, che pubblica la sua Theory of the Earth nel 1785, ad un secolo dal libro di Burnet. Hutton è fra i primi a comprendere il ruolo fondamentale degli agenti esogeni nel modellamento della superficie terrestre e intuisce il ruolo determinante del fattore tempo in geologia, facendo risalire l’antichità della Terra a molti milioni di anni.
[15] Nicola Stenone, De solido intra solidum naturaliter contento dissertationis prodromus Firenze, 1669. Stenone interpreta correttamente la natura dei fossili come resti di animali vissuti precedentemente, e sulla base dei suoi criteri interpretativi riesce a fornirne anche una scala crono-logica. L’adozione sistematica del principio stratigrafico secondo il quale gli strati geologici sovrapposti rappresentano una successione nel tempo lo porta a conclusioni in grado di rivoluzionare le idee sulla formazione e l’evoluzione della Terra.
[16] Iames Ussher, Annales Veteris Testamenti, a prima mundi origine deducti, 1650
[17] John Woodward, Essai toward a Natural History of the Eart, 1695
[18] I plutonisti, seguaci delle teorie di James Hutton, pensavano che le rocce (basalti e graniti) fossero di origine magmatica, formate cioè da depositi di lava, creati e mescolati da una attività vulcanica e tellurica continuativa. In ciò essi si opponevano ai cosiddetti nettunisti, legati alle teorie di Abraham Gottlob Werner, che ritenevano che le rocce si fossero formate per sedimentazione in un grande oceano che dopo il diluvio aveva ricoperto la terra. Hutton sosteneva che la fuoriuscita del calore terrestre attraverso periodiche eruzioni vulcaniche avesse determinato un innalzamento del suolo; che i successivi processi erosivi avessero ridotto l’altezza dei rilievi e trasportato i detriti in mare; e che per il calore interno della Terra, i sedimenti marini si sarebbero fusi nuovamente e sarebbero stati spinti nuovamente verso l’alto, iniziando in tal modo un nuovo ciclo.
[19] John Woodword, Brief Instructions for making Observations in all Parts of the World, 1696
[20] Carl Nilsson Linneo, Fundamenta botanica et Instructio peregrinatoris, 1736
[21] Joseph Addison, Remarks on several parts of Italy, 1702
[22] Oggi tradotta in: Eugenio Pesci, La scoperta dei ghiacciai, Torino 2001
[23] “Distanti dal vacuo affanno degli affari /e dal fumo delle città, essi vivono in pace / tempra le forze fisiche la loro vita attiva, / ignorano la noia che fa crescere la pancia. / Li desta e ne quieta gli animi il lavoro / che salute e piacere rendono più lieve. / Nelle loro vene scorre sangue sano, non viziato / da veleni ereditari, né viziato dall’ansia …”
[24] J.J. Rousseau, Nouvelle Héloïse, 1761, parte I, lett. XIII
[25] Nella voce “Géographie”, vol. VII
[26] La vera natura dei fossili era già stata intuita addirittura nel VI secolo a.C. dai filosofi naturalisti greci (in particolare da Senofane). Successivamente Eratostene aveva dedotto dalla presenza di fossili marini in luoghi lontani dal mare che le linee costiere dovevano essersi spostate col tempo. Nel Medioevo tuttavia era invalsa la teoria che fossero prodotti da una vis plastica intrinseca alla Terra, quasi degli “scherzi della natura”, o al limite che si trattasse dei resti di animali uccisi dal Diluvio universale. L’antica teoria che si trattasse di resti fossilizzati di animali e piante era stata ripresa in Italia da Leonardo da Vinci alla fine del ‘400 e nel XVI secolo da Girolamo Fracastoro.
[27] Honoré Benedict De Saussure, Voyages sur les Alpes, Neuchâtel 1796
[28] “Quel cielo così straordinario, quel caos di montagne immani, quelle nubi traforate e sormontate da picchi grigiastri, la neve eterna, il silenzio solenne di quel deserto, l’assenza di qualunque rumore, di qualunque essere vivente, di vegetazione […] tutto si unisce per creare l’illusione di un mondo nuovo, di essere trasportati alle ere primigenie. Per un attimo ho creduto di assistere allo spettacolo della creazione che sorge dal grembo del caos”. (Henriette. d’Angeville, Mon excursion au Mont Blanc, 1838)
[29] Narrati in Travels through the Alps of Savoy, 1843
[30] Cfr. Andrea Zannini, Tonache e piccozze, CDA-Vivalda 2004
[31] Elie Bertrand, Essais sur les usages des montagnes, 1754
[32] Da tener presente anche che a partire dal 1817 sul colle e sulle vette più prossime vengono installate apparecchiature di misurazione meteorologica, i cui dati vengono rilevati e pubblicati dai religiosi dell’ospizio.
[33] Gnifetti nelle Nozioni topografiche del Monte Rosa inserisce una descrizione della Val Sesia che ha tutte le caratteristiche di un depliant pubblicitario. Carrel sulla “Feuille d’annonce d’Aoste”, primo giornale valdostano, scrive: “Viaggiatori che cercate nuovi divertimenti, lasciate la monotonia delle pianure e visitate le alte Alpi”.
[34] Tra le principali il Grossblochner nel 1800, la Punta Giordani del Rosa e il Breithorn nel 1801, l’Ortles nel 1804, la Jungfrau nel 1811, il Bernina nel 1829. Ultime a cadere sono il Pelmo nel 1857, il Monviso nel 1861 e le Grandes Jorasses nel 1863.
[35] Con la mediazione, però, di personaggi che assommano nella loro vita e nella loro opera tanto l’illuminismo scientifico che il romanticismo: primo tra tutti Goethe. “Monti enormi mi circondavano, abissi mi stavano davanti, torrenti vorticosi rovinavano a valle; sotto di me scrosciavano i fiumi, il bosco e la montagna echeggiavano, ed io vedevo, operanti insieme e creatrici, nelle profondità della terra, tutte le imperscrutabili energie, ed ecco, di sopra alla terra e di sotto al cielo, il brulicar delle generazioni di diversissimi esseri”. (I dolori del giovane Werther)
[36] Percy.B. Shelly, Il Monte Bianco, 1816
[37] La montagna ben rappresenta ciò che Kant identificava nei due volti del sublime, quello matematico che nasce dalla contemplazione della natura immobile, atemporale, dove l’uomo, non la natura, è parte attiva attraverso la propria ragione e morale, e quello derivato dalla forza della natura, ove l’uomo è drammaticamente succube, concezione quest’ultima che ha ispirato intere generazioni di artisti e poeti romantici. La dimensione spirituale, per Kant, nasce attraverso la contemplazione dello spettacolo naturale dove la mente prende coscienza del proprio limite razionale e riconosce la possibilità di una dimensione sovrasensibile.
[38] Ma già Petrarca scriveva: “Per alti monti e selve aspre trovo / qualche riposo: ogni abitato loco / è nemico mortal de gli occhi miei.” (Canzoniere, Di pensier in pensier, di monte in monte)
[39] René de Chateaubriand, Viaggio sul Monte Bianco, 1806
[40] L’atteggiamento di Chateaubriand riflette un più generalizzato atteggiamento francese, se non di indifferenza, di disincanto o di fredda compostezza nei confronti del fascino della montagna. Lo ritroviamo in Stendhal, in George Sand, in Sainte-Beuve, in Victor Hugo.
[41] G.W.F. Hegel, Diario di viaggio sulle Alpi Bernesi, 1797
[42] Inserito nel 1853 nella raccolta di racconti Bunte Steine (Pietre colorate).
[43] Nell’iconografia medioevale la centralità è riservata evidentemente alla figura umana, anche perché si tratta in genere di santi. Lo sfondo montano, che troviamo appunto da Giotto al Beato Angelico a Benozzo Gozzoli, è sommariamente schematizzato in semplici e confuse geometrie. La prima rappresentazione realistica delle Alpi la troviamo in una pala d’altare di Conrad Witz, La pesca miracolosa (del 1444). Nel Rinascimento sono soprattutto i pittori veneti, da Giorgione a Cima da Conegliano, a inserire nel panorama le cime del Cadore o delle Dolomiti, sia pure interpretandole o reinventandole molto liberamente.
[44] Tra le altre cose che Ruskin si porta appresso c’è una certa conoscenza dell’arte cinese. Anche se nell’800 non sono più di moda, le “cineserie” diffuse dal gusto rococò hanno lasciato una traccia nell’arredo delle dimore aristocratiche o altoborghesi e nella fantasia dei giovani che le abitano. “Uomini di cuore”, i romantici sono colpiti, ma anche un po’ inquietati, da rappresentazioni che quasi escludono la presenza umana e che tolgono peso alla montagna, facendola galleggiare costantemente sopra una coltre di nebbie. Gli stessi acquarelli di Turner sembrano debitori di questa leggerezza.
Allo stesso modo, sembra debitrice delle Centoun vedute del monte Fuji, di Hokusai, la rappresentazione ossessiva nelle tele di Cèzanne della montagna di Saint Victoire, unica presenza montana di rilievo nella pittura impressionista, a dispetto della teorizzazione del plein air. La montagna simbolo del Giappone, che ha da sempre mantenuto la sua importanza sacrale, tanto da aver dato vita ad una vera e propria religione delle montagne (lo Shu gen do) ricorre in pratica nell’opera di tutti gli artisti giapponesi, è imprescindibile.
[45] “In questo momento sono qui, in quello che io chiamo il giardino dell’Eden. Il luogo più splendido in cui io sia mai stato”.
[46] Quello che Bierstadt fa per Yosemite, testimoniarne al grosso pubblico l’esistenza e la bellezza, e quindi nei limiti del possibile preservare quest’ultima, Thomas Moran, suo contemporaneo e concorrente, lo farà in seguito per Yellowstone.
[47] Julius Evola, Meditazioni delle vette, 1972
[48] Leslie Stephen, The Playground of Europe, 1871
[49] Alphonse Daudet, Tartarin sur les Alpes, 1885
[50] “L’alpinismo, così poliedrico, è un elisir magico per salvarci, per ovviare allo storpiamento dovuto alla divisione moderna del lavoro”. (Eugen Guido Lammer, Fontana di giovinezza, 1922)
[51] ibidem
[52] E autore di L’alpinismo e il clero valdostano (1905)
[53] La cima est dell’Elbrus (5.621 m), era già stata scalata per la prima volta nel 1829 da una spedizione russa. I primi alpinisti occidentali a raggiungerla sono gli inglesi A.W. Moore, Charles Comyns Tucker e Douglas Freshfield, nel 1868.
La vetta ovest, la più alta (5642 m),viene scalata per la prima volta nel 1874, da una cordata di quattro inglesi con guida russa.
[54] L’esplorazione dell’Himalaya e del Karakorum ebbe inizio, nel XIX secolo, ad opera di singoli viaggiatori, Tra questi, nella prima metà del secolo possono essere ricordati Thomas Manning (1811-12), i fratelli Alexander, James e Patrick (1812-23), William Moorcroft e George Trebeck (1812-29), J. Baillie Fraser (1814-15), G.Thomas Vigne (1835-38), A. Cunningham (1847) e Richard Strachey (1848).
[55] La vita di Aleister Crowley sarebbe incredibile anche se raccontata in un romanzo. Mago, teosofo, consumatore di droghe in quantità industriali, truffatore, affiliato a società segrete e cacciato per malversazioni, è stato per un certo periodo, una decina d’anni, anche un formidabile arrampicatore. Nel corso della spedizione al K2, quando a 6400 un alpinista viene colpito da edema polmonare Crowley è l’unico a intuire la gravità della situazione e a imporre al resto del-la squadra di ritirarsi e portare il malato a valle. Nel 1905 partecipa ad un’altra spedizione, al Kanchenjunga, che si conclude con la morte di quattro membri, travolti da una valanga. In questa occasione il suo comportamento è opposto, non si muove in soccorso dei colleghi, giustificandosi poi col fatto che sono stati loro a provocare l’incidente, e la sua carriera alpinistica è stroncata con infamia.
[56] In precedenza, nel 1903, Frederick Cook aveva sostenuto di aver scalato per primo il monte, ma si scoprì in seguito che l’affermazione era falsa.
[57] Attraverso la mediazione delle teorie razziali di De Gobineau si arriva al pensiero “ariosofico” di Guido Von List e di Lanz von Liebenfels. Nel 1871 il romanziere britannico Ed¬ward Bul-wer-Lytton, nel suo The Coming Race, descrive una razza superiore (“Vril-ya”) che vive sotto la superficie terrestre e progetta di con¬quistare il mondo con la sua energia psicocinetica (“Vril”). Il francese Louis Jacolliot traduce la fantasia di Lytton in termini pseudo-scientifici nel suo Les Traditions Indo-Européeenes (1876), legando il “Vril” ai popoli della mitica Thule. Un tocco ulteriore viene apportato trent’anni dopo dal nazionalista indiano Tilak, che in The Arctic Home of the Vedas attribuisce ad una migrazione degli abitanti di Thule verso sud la nascita del popolo ariano. L’idea di una razza iperborea superiore finisce per innestarsi in Germania sulla linea del superomismo nietzchiano, creando un cocktail esplosivo di fantasia e pseudoscienza. Molti tedeschi si convincono di essere i discendenti degli Iperborei Ariani, e soprattutto di esse-re destinati a diventare i padroni del mondo. Tra questi il generale Basil Hausofer, futuro sponsor di Hitler, che fonda la sovietà Vril, dedita alla meditazione e alla ricerca delle origini ariane. Da questa scaturisce la Società Thule, fondata con intenti culturali ma presto, nelle mani del barone von Sebottendorf, anti-semita e anti-comunista sfegatato, divenuta organizzazione politica. Da essa ha origine nel 1919 il “Partito dei Lavoratori Tedeschi”, che l’anno successivo avrà alla sua testa Hitler.
[58] Un forte stimolo alle ricerche dell’Ahnenerbe è dato dalle teorie dell’esploratore svedese Sven Hedin, che tra il 1893 e il 1908 compie numerosi viaggi in Tibet, rimanendo affascinato dalla cultura buddista e riscontrando in essa affinità con l’originario spirito germanico.
[59] Prima di quello di Mummery, il libro di alpinismo più famoso fu senza dubbio quello di Edward Whymper, Scalate nelle Alpi (1871), che ebbe una diffusione popolare enorme, aiutata anche dalle numerose conferenze che l’autore tenne nei college e nelle sale pubbliche di tutta l’Inghilterra.
[60] Albert F. Mummery, My climbs in the Alps and Caucasus, 1895
[61] G. Lammer, Jungborn: Bergfahrten und Höhengedanken eines einsamen Pfadsuchers,1922
[62] Julius Kugy, Aus vergangener Zeit, 1943
[63] Julius Kugy, Aus dem Leben eines Bergsteigers (Dalla vita di un alpinista), 1925
[64] Guido Rey lo descrive così: “Piaz non è una guida come le altre: sarei per dire che non è una guida. È l’esponente di una formula nuova di alpinismo, il maestro di tutta questa scuola di arrampicate brevi ma intense che si svolgono sul confine tra il difficile e l’impossibile” (Alpinismo acrobatico).
[65] Così la racconta Guido Rey: “Gli dà ombra una guglia intatta, umanamente inaccessibile? Piaz riesce su una vetta vicina: di lassù, a tradimento, lancia per aria una corda che avvince al collo la superba e, afferrata la corda con piedi e mani, strascinandosi sospeso sulla profonda valle, giunge sulla guglia e le dà un nome. Egli ha compiuto in quel girono una delle più belle follie dell’alpinismo!” (Alpinismo acrobatico)
[66] Il fronte attraversa i gruppi montuosi più elevati delle Alpi orientali, dall’Ortles Cevedale all’Adamello e alla Presanella: scende di quota in val d’Adige,tocca il Pasubio e la zona di Asiago, risale lungo la catena dei Lagorai, distendendosi poi dalla Marmolada sino alle Alpi Carniche.
[67] Come la conquista del passo della Sentinella o gli assalti al monte Cristallo e a Cima Trafoi nel gruppo dell’Ortles, o la presa del Corno di Cavento nell’Adamello, o la conquista, da parte di una pattuglia d’alpini, della Marmolada d’Ombretta (3153 m).
[68] “L’impegno alpinistico e sciistico dei militari in montagna si attesta all’interno di quegli esercizi fisici collettivi che si caratterizzano come forme di una esemplare liturgia nazionale. In tal modo appartenenze nazionali e consapevolezze patriottiche si imprimono sul corpo fisico di quegli ufficiali e di quei soldati che superano difficili passaggi su roccia per eseguire ricognizioni e per individuare posizioni tatticamente rilevanti da conquistare e da presidiare. […]
Lo sport si configura come un elemento che contribuisce a definire e a qualificare l’identità delle élites e delle masse tra il tardo Ottocento e il primo Novecento, passando attraverso la fa-se cruciale dal 1914 al 1918. Questo intreccio di ideologia, cultura e corporeità risalta in modo esplicito negli anni del conflitto aperto ma si riflette – almeno nel caso italiano – negli anni del dopoguerra e del fascismo sia sul piano delle percezioni dell’alpinismo che su quello delle sue acquisizioni tecniche ed operative”. (Alessandro Pastore, Alpinismo e storia d’Italia dall’Unità alla Resistenza, 2001)
[69] Alcune di queste salite (Vinatzer in Marmolada, Carlesso alla Trieste, Andrich alla Punta Civetta, Comici alla Grande, Cassin ancora alla Trieste) rappresentarono dal punto di vista dell’arrampicata libera il livello massimo raggiunto, almeno in Dolomiti, fino agli anni ‘70.
[70] Julius Evola, Meditazioni delle vette. La via interiore alla montagna, 1972
[71] La sua formula secondo la quale “l’ontogenesi segue la filogenesi” fornisce un pretesto scientifico alla teoria sulla superiorità della razza ariana. Infatti le etnie prive di determinati caratteri sarebbero su questa base ad uno stadio evolutivo inferiore. A suo parere le differenze sulle “razze” non sono solo legate a caratteristiche fisiche, ma anche alle potenziali capacità intellettive e «la differenza fra la ragione di un Goethe, di un Kant, di un Lamarck o di un Darwin, e quella del selvaggio più basso… è molto maggiore della differenza di grado esistente fra la ragione di quest’ultimo e quella dei mammiferi “più razionali”, le scimmie antropoidi».
[72] Haeckel utilizza il termine “ecologia” nel 1866, definendola come studio dell’economia della natura e delle relazioni degli animali con l’ambiente organico e inorganico.
[73] Dal 1931 Darré dirige l’“Ufficio per la razza e le colonie”, nell’ambito delle SS.
[74] Negli anni venti, comunque, anche in Italia qualcosa comincia a muoversi, grazie soprattutto all’estensione della pratica sciistica amatoriale. Una sensibilità ambientale e una nuova attenzione alla montagna trovano riscontro nel 1923 nella creazione del primo grande parco italiano, il Parco nazionale d’Abruzzo.
[75] Già a metà degli anni venti nasce ad esempio una speciale sezione del Club Alpino, l’ESCAI, dedicata all’escursionismo scolastico.
[76] “La prima cosa che si deve curare nell’arrampicamento, è lo stile” (in Alpinismo eroico, p. 138).
[77] Anche nel metodo di allenamento sulle palestre di roccia delle valli piemontesi, Boccalatte è un anticipatore.
[78] Gabriele Boccalatte, Piccole e grandi ore alpine, 1939. Lo stile del suo unico libro è come il suo alpinismo: pulito, onesto, concreto.
[79] Giusto Gervasutti, Scalate nelle Alpi, 1945
[80] Cervino. (Ascensione sulla via normale), 1911, realizzato da Mario Pazienza, che gira anche nello stesso anno Ascensione al Dente del Gigante. Nel 1913 viene girato da una troupe inglese un altro “Cervino”, che verrà programmato anche nelle sale pubbliche.
[81] Hodler afferma: “La mia particolarità consiste nel combinare monumentalità e leggerezza”. Nelle sue tele sono rappresentate continuamente le cime dell’Eiger, del Mönch e della Jungfrau, irradiate da una luce che è energia luminosa allo stato puro.
[82] Castiglioni muore nel marzo del 1944, a soli trentacinque anni di età, sulle Alpi svizzere. Dopo una prima detenzione in Svizzera con successiva espulsione, viene catturato nuovamente oltre il confine e rischia l’internamento in un campo di prigionia. Riesce a fuggire nella notte, senza pantaloni e senza scarponi, con i ramponi legati ai piedi scalzi. Verrà ritrovato tre mesi dopo, appena oltre il confine, morto congelato.
[83] Vittorio Ratti viene ucciso in uno degli ultimissimi scontri, il 26 aprile 1945.
[84] Gasparotto aveva partecipato nel 1929 ad una delle prime spedizioni italiane nel Caucaso. L’anno precedente insieme a Castiglioni aveva sfiorato la grande impresa, compiendo un serio tentativo alla parete nord delle Grandes Jorasses, Altrettanto pionieristica la spedizione sulle coste orientali della Groenlandia, nel 1934.
[85] Tissi, come Livio Bianco, morirà in montagna, durante una scalata, pochi anni dopo la fine della guerra.









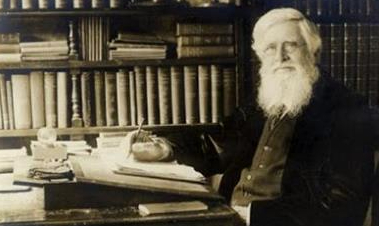
 Il mio interesse per Wallace dura da lunga data, ma era rimasto sino a qualche tempo fa piuttosto epidermico, legato più ad una sua presunta appartenenza al mio album dei “perdenti” che ad una effettiva conoscenza della complessità del personaggio. Devo il cambiamento radicale di attenzione alla bellissima biografia pubblicata da Ferruccio Focher nel 2006, “L’uomo che gettò nel panico Darwin”, alla quale questo scritto vorrebbe essere solo un’introduzione.
Il mio interesse per Wallace dura da lunga data, ma era rimasto sino a qualche tempo fa piuttosto epidermico, legato più ad una sua presunta appartenenza al mio album dei “perdenti” che ad una effettiva conoscenza della complessità del personaggio. Devo il cambiamento radicale di attenzione alla bellissima biografia pubblicata da Ferruccio Focher nel 2006, “L’uomo che gettò nel panico Darwin”, alla quale questo scritto vorrebbe essere solo un’introduzione. Visto che nel frattempo è diventato un giovanottone lungo e magro, non c’è da dubitarne. La sera poi, e le domeniche e qualsiasi altro momento libero, sono dedicati allo studio appassionato di materie che davvero lo interessano, a letture che lo entusiasmano. Con i primi soldi guadagnati si procura testi naturalistici d’ogni genere, tra i quali gli Elementi di Botanica di Lindley, e in pratica li manda a memoria, applicando ogni nuova conoscenza alle osservazioni sul campo. È in effetti il fratello ad occuparsi delle questioni pratiche e dei rapporti con i committenti, e Alfred si trova a godere della libertà di un lavoro che svolge come un gioco e che gli consente di coltivare e approfondire ciò che più gli interessa. Anche quando dovrà interromperlo, per un calo delle richieste, e adattarsi senza molto entusiasmo a fare per un paio d’anni il maestro di scuola a Leicester, continua a scoprire e a leggere i naturalisti. Divora con passione i Viaggi alle regioni equinoziali di Humboldt e il Diario della “Beagle” di Darwin, ma conosce anche Vestigia della storia naturale della creazione
Visto che nel frattempo è diventato un giovanottone lungo e magro, non c’è da dubitarne. La sera poi, e le domeniche e qualsiasi altro momento libero, sono dedicati allo studio appassionato di materie che davvero lo interessano, a letture che lo entusiasmano. Con i primi soldi guadagnati si procura testi naturalistici d’ogni genere, tra i quali gli Elementi di Botanica di Lindley, e in pratica li manda a memoria, applicando ogni nuova conoscenza alle osservazioni sul campo. È in effetti il fratello ad occuparsi delle questioni pratiche e dei rapporti con i committenti, e Alfred si trova a godere della libertà di un lavoro che svolge come un gioco e che gli consente di coltivare e approfondire ciò che più gli interessa. Anche quando dovrà interromperlo, per un calo delle richieste, e adattarsi senza molto entusiasmo a fare per un paio d’anni il maestro di scuola a Leicester, continua a scoprire e a leggere i naturalisti. Divora con passione i Viaggi alle regioni equinoziali di Humboldt e il Diario della “Beagle” di Darwin, ma conosce anche Vestigia della storia naturale della creazione




 Questo breve omaggio non si ripropone di riscattarne la memoria: ci vorrebbe ben altro. È solo un ingenuo tentativo di evocazione, visto che volentieri avrei fatto un pezzo di strada in sua compagnia. Sarà come trascorrere insieme una mezz’ora, invitando a conoscerlo anche qualche amico.
Questo breve omaggio non si ripropone di riscattarne la memoria: ci vorrebbe ben altro. È solo un ingenuo tentativo di evocazione, visto che volentieri avrei fatto un pezzo di strada in sua compagnia. Sarà come trascorrere insieme una mezz’ora, invitando a conoscerlo anche qualche amico.