di Paolo Repetto, 29 ottobre 2025
Un anatema ebraico, pochissimo conosciuto, recita: “Possa il mio nemico pubblicare un libro”. Non è un augurio, anche se lo sembra, né una professione di tolleranza: è una maledizione. Ora, io non so quanto questo detto sia antico o solo vecchio, e ignorando la lingua ebraica non posso che affidarmi alla fedeltà della traduzione nella quale lo conosco: ma so che poter determinare l’epoca in cui è stato coniato sarebbe tutt’altro che indifferente. Nel caso fosse molto antico infatti quel “pubblicare” andrebbe inteso come “scrivere”, piuttosto che diffondere tramite amanuensi in più copie, e per un popolo che è stato definito “il popolo del libro” mi pare un po’ fuori luogo. Anche se è poi vero che il sospetto nei confronti della scrittura era presente pure nella cultura greca (vedi Platone), e che per gli ebrei poteva essere tanto più giustificato, almeno nei confronti della scrittura “profana”, dall’esistenza di un testo sacro dettato da Dio stesso, da considerarsi quindi rispondente a ogni domanda, esauriente ogni dubbio, definitivo (salvo poi darne infinite interpretazioni).
Propendo dunque piuttosto per la seconda ipotesi, che quantomeno rende il concetto più funzionale a ciò di cui intendo parlare. Il problema a mio giudizio non sta infatti nello scrivere, ma proprio nel “pubblicare” (operazione che assume ben altro significato dopo l’introduzione della stampa), ovvero nel divulgare quanto si è scritto. Sono due cose diverse, mi pare ovvio, perché la seconda presuppone la prima – per ora, in attesa degli sviluppi dell’AI – mentre non vale il contrario: e tuttavia quasi sempre nel linguaggio corrente i due verbi vengono usati come sinonimi, mentre tali non sono. La differenza sta innanzi tutto nell’intenzione che muove alla scrittura, e poi nei contenuti e nella destinazione, che comportano scelte particolari nei modi e nei mezzi in cui sarà diffusa.
Voglio dire che, certo, chi scrive lo fa di norma per relazionarsi col presente e per lasciare traccia nel futuro, ma la scrittura può essere utilizzata anche in forma privata, per memorizzare, per chiarirsi le idee e metterle in ordine, per tenere un diario, per accompagnare un gesto o un regalo, oppure per fare arrivare la propria voce ad amici o confidenti, quando magari si diano poche possibilità di frequentazione. Ad esempio: l’uso che ne faccio io in questo momento, sfruttando una tecnologia che mi permette di dialogare facilmente con uno sparuto gruppo di persone che condivide i miei interessi, ovvero le mie domande e i miei dubbi, rappresenta il limite estremo dell’utilizzo “privato”.
Se si va oltre si accede invece ad un’altra dimensione, quella appunto del “pubblicare”, che come il termine suggerisce significa rendere intenzionalmente pubblico il proprio pensiero. E qui entrano in gioco finalità e ambizioni diverse. Io vorrei occuparmi nello specifico del caso di cui l’intenzione è di orientare o influenzare il pensiero altrui, offrendo al maggior numero possibile di sconosciuti delle “risposte”, delle interpretazioni del mondo e della storia che non possono essere controbattute direttamente, come avverrebbe in un colloquio. Nel formato stampa queste risposte assumono un’autorevolezza che è suggerita già visivamente dall’ordine, dalla nitidezza, dall’irreggimentazione delle righe e dei periodi sulla superficie della pagina. Insomma, la parola stampata incute rispetto, e questo consente di esercitare in qualche modo un potere. E anche se i mass media e le nuove tecnologie e modalità comunicative stanno rendendo obsoleta la stampa, credo che per il momento, e almeno per la mia generazione e per quella immediatamente successiva, l’autorevolezza del pensiero sia ancora legata alla divulgazione cartacea.
Naturalmente ci sono anche, e oserei dire soprattutto, altre finalità: quella pura e semplice di ottenere una qualche visibilità, ad esempio, o di trovare un modo per sbarcare il lunario: oppure, un po’ più ambiziosamente, di combinare il tutto e di proporre, alla maniera di Balzac, sia pure attraverso la finzione, un ampio quadro della reale condizione umana. Sarà il tempo poi a decidere della rilevanza e della sopravvivenza di qualsiasi testo, a farne o no “un classico”, o almeno un riferimento che vada oltre il presente.

Ma mi sto perdendo nelle ovvietà. Ciò che intendevo dire è che attualmente tanto la narrativa, più o meno “impegnata”, quanto la saggistica, rientrano allo stesso modo nei circuiti di un “mercato culturale” che ha acquisito una enorme rilevanza sia finanziaria che politica, e rispondono alle sue leggi, in primis a quelle della “spettacolarizzazione” (un mercato culturale in realtà è sempre esistito, ma senz’altro non aveva come caratteristica dominante quella della spettacolarità). Basti pensare ai tour promozionali cui senza alcun ritegno gli autori si sottopongono, compresi gli scienziati e i filosofi, andando a far marchette nei programmi televisivi, intervenendo ai festival o agli altri innumerevoli “eventi” imbanditi per platee di consumatori totalmente passivi e acriticamente fidelizzati, creando quelli che oggi si chiamano podcast, ecc….
Io ritengo esista però anche una terra di nessuno, quella che ospita i libri scritti non per fornire risposte preconfezionate, ma per suscitare domande, alle quali poi il lettore cercherà di rispondere con un percorso tutto suo. Questi sono per me i soli libri meritevoli di essere “pubblicati”, e non è qui il caso di dettagliare i criteri sui quali baso la distinzione. Emergeranno da soli nel prosieguo del discorso.
Vorrei però fosse chiaro che non auspico alcun tipo di censura preventiva o di esclusione o di protezionismo. Quello culturale è l’unico ambito nel quale sposo il libero mercato. D’altro canto ritengo che leggere e scrivere siano, almeno in linea di principio, le attività meno pericolose per sé e nocive per gli altri, e tra le più piacevoli, che un essere umano può svolgere. L’importante per il “consumatore” è avere sempre ben presente che di un “mercato” appunto si tratta, nel quale i banchi e gli scaffali traboccano di prodotti tra i quali può scegliere. Per come la vedo io, però, per poterlo fare è necessario auto-educarsi a un “consumo culturale” consapevole, e farlo per prove ed errori, prendendo le distanze da tutte le azioni “promozionali” di incentivazione alla lettura. Chi deve essere spinto o incentivato, per non dire precettato, a farsi un’idea, non sarà mai capace di scelte proprie.
Esistono dunque i normali prodotti da supermercato, quelli perennemente in offerta, di per sé abbastanza innocui, perché in fondo nessuno ci obbliga ad acquistarli e a leggerli. Ce ne sono invece altri che sempre all’interno di questo mercato si arrogano un ruolo di orientamento del gusto, si propongono come “bio”, garanti della nostra salute spirituale, e ci gratificano vellicando la nostra ambizione a sentirci al passo coi tempi, o anche un pochino avanti: questi, a dispetto della loro più o meno esplicita ambizione a diffondere sempre nuove e definitive “verità”, andrebbero comunque almeno conosciuti, se non altro per prenderne consapevolmente le distanze. E infine ne esistono altri ancora, che negli scaffali vengono confusi con tutto il resto, ma che bisogna imparare a riconoscere come genuini alimenti per la nostra crescita.
In questa ultima tipologia rientrano senz’altro le opere di George Steiner. Steiner è, assieme a Isaiah Berlin, l’ultimo dei veri “maestri” del ‘900. Uno che scrive: “Quello che mi sentirei di sostenere con fervore è questo: la fede (qualsiasi fede, n,d,r), o l’assenza di essa è, o dovrebbe essere, la parte costitutiva più privata, più gelosamente custodita di un essere umano […]. Pubblicizzare svilisce e falsifica irrimediabilmente il proprio credo”.

Proprio da un suo libro, significativamente titolato I libri che non ho scritto (come gli invidio questo titolo, lo avevo in mente da decenni!), arrivano l’anatema di cui sopra e lo stimolo che mi spinge ora a parlarne.
Nel compendio di uno dei saggi mai scritti, ma fatti assaporare al lettore almeno in forma di spuntino, Steiner sintetizza l’opera e il pensiero di Joseph Needham, eccentrico erudito novecentesco, grande sinologo, che mezzo secolo fa viaggiava ancora sulla cresta dell’onda. Io stesso ho sempre riservato all’unico volume che possiedo del suo Scienza e civiltà in Cina (edizione inglese 1954, italiana Einaudi 1981; primo di tre tomi, s’intitola Linee introduttive e costava un patrimonio) una collocazione di prestigio nella mia biblioteca, sezione storia della scienza. Di Needham però, della sua vita, del suo impegno politico, conoscevo quasi nulla.
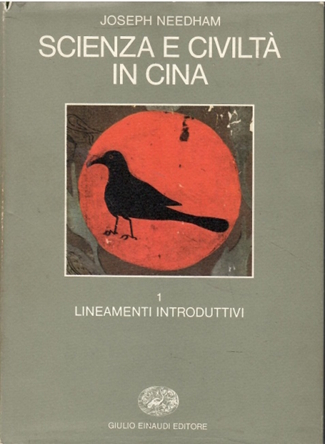
Steiner invece lo conobbe personalmente, ebbe diverse occasioni di confronto, e pur riconoscendone la sterminata cultura e tributandogli tutti i dovuti meriti non ne traccia un ritratto positivo. A motivare questo giudizio (che a suo tempo ha indotto Steiner a non redigere una biografia dello scienziato britannico per la quale aveva ricevuto dalla sua università un incarico) sono le posizioni pregiudiziali a partire dalle quali Needham affronta qualsiasi argomento. Il suo approccio è infatti sempre rigidamente vincolato all’ortodossia marxista, una ortodossia peraltro non fedele direttamente a Marx, ma alla lettura che di Marx era stata data, e imposta, dal leninismo. Steiner non mette in discussione le competenze scientifiche di Needham, che era in primo luogo un biologo, né la sua capacità di lavorare su un piano multidisciplinare: ma è il dogmatismo di fondo a respingerlo. Non può fare a meno di mettere in rilievo come tanto le competenze scientifiche quanto quelle umanistiche vengano sempre piegate non ad aprire nuove possibilità interpretative dei fatti, ma ad avvalorare una ipotesi iniziale precostituita. E sottolinea come le incursioni in ambiti specialistici sostanzialmente estranei ai suoi abbiano indotto Needham a prendere per oro colato ogni minimo e discutibilissimo indizio, biologico, antropologico, linguistico, architettonico, che sembrasse portare mattoni alla sua ricostruzione della Storia. Ricostruzione che seguiva le linee di un progetto dettato dal clima ideologico postbellico, dal compiersi della decolonizzazione, dagli entusiasmi del terzomondismo.

In pratica Steiner avverte, dietro il meritevole intento di Needham di portare l’occidente a conoscere e apprezzare l’origine extraeuropea di buona parte dei saperi scientifici e delle tecnologie che ne sono discese, il caparbio proposito di forzare l’entità del debito scientifico occidentale nei confronti di un’area che ai suoi tempi era ancora percepita come sottosviluppata, e sullo sfondo quello di capovolgere (non di equilibrare) le posizioni nel rapporto tra le diverse civiltà. La stessa operazione che trent’anni dopo avrebbe ripetuto Martin Bernal con Atena nera, per provare come la cultura greca classica sia assolutamente debitrice di quella africana e mediorientale (cosa di cui peraltro erano ben consapevoli già Pitagora, Erodoto e Platone).
Insomma, il problema di Needham non sta nell’attribuzione di questi contatti e rapporti e finanche di talune priorità, ma nel darne una interpretazione che nemmeno troppo larvatamente colpevolizza l’occidente: nel voler cioè convintamente affermare che in fondo l’occidente non può vantarsi di aver inventato nulla, e che si è limitato a depredare i patrimoni culturali di altre civiltà (come se il valore intrinseco di una conoscenza fosse nella priorità, e non negli sviluppi e nelle applicazioni che ne discendono). E peggio ancora, nel farlo producendo prove documentarie, linguistiche e archeologiche molto abborracciate e in parecchi casi del tutto irrilevanti, quando addirittura non false.
Ora, tutto ciò, per senza nulla togliere al fascino che i lavori di Needham e di Bernal senz’altro emanano, e al rilievo delle ipotesi interpretative che hanno introdotto, dovrebbe però guidare a una giustificata prudenza nell’accettarne il messaggio di fondo. L’assunzione di un altro punto di vista, o del punto di vista altrui, può scuotere e incrinare una lettura della storia consolidatasi sulla narrazione auto-apologetica dei vincitori, ma non necessariamente ne produce una nuova più veritiera. Semmai dovrebbe indurne una più interlocutoria, più possibilista, e non altrettanto assiomatica.
Questo mi porta a una considerazione solo apparentemente marginale, che concerne la differenza tra gli autori “enciclopedici” del Sette/Ottocento e i “tuttologi” imperanti ai giorni nostri. Enciclopedici, per intenderci, erano gli eruditi eclettici come Diderot, Goethe o Alexander von Humbolt, che ambivano a raccogliere in grandi sintesi lo stato delle conoscenze alla loro epoca. Erano curiosi di tutto, e questo li induceva a non dare nulla per scontato, a considerare i saperi di cui erano depositari come punti di partenza. A dispetto dell’ampiezza e della poliedricità delle loro opere, lo scopo che ad esse attribuivano era di indicare possibili percorsi per la ricerca futura, e anche quando fornivano spiegazioni lo facevano nella consapevolezza di produrre delle congetture. Chi avesse la pazienza di leggere oggi il Cosmos di Humboldt, che nel titolo sembra adombrare un’ambizione sterminata, si accorgerebbe che ogni affermazione viene sempre presentata come provvisoria, e che la frase più ricorrente è “Chissà cosa ci riserverà nel futuro la ricerca in questo campo”. E lo stesso scienziato-esploratore non si limitava ad auspicare, ma incoraggiava i giovani naturalisti a ripercorrere i suoi passi, per verificare e al limite contraddire le sue scoperte e le sue intuizioni, e a tale scopo donava loro anche le sue strumentazioni. Ma non è tutto: si accollò personalmente la pubblicazione dell’opera, e dati i costi enormi finì praticamente sul lastrico.
Tra gli enciclopedici e i tuttologi si collocano proprio Needham e Bernal, che esplorano ambiti nuovi, che producono nuove conoscenze relative ai rapporti e agli interscambi tra le civiltà extraeuropee e la nostra, ma non si limitano ad avanzare delle ipotesi, affermano delle tesi. Sono ancora enciclopedici nel senso che sostanziano le loro opere con l’apporto di saperi diversi, anche se padroneggiati con eccessiva disinvoltura, e spesso con molta approssimazione. Sono già tuttologi perché presumono di dare un significato diverso alla storia, affermandone categoricamente non possibilità interpretative inedite ma linee di sviluppo certe e inconfutabili. Non sono tali però a pieno titolo, almeno nel senso che do io al termine, perché ancora non si avvalgono delle più recenti tecnologie e modalità che portano dalla “pubblicazione” alla “pubblicizzazione” di massa. E alla spettacolarizzazione.
Con ciò vengo finalmente al dunque, prendendo tre nomi a caso (in realtà non proprio a caso) tra i più conosciuti oggi dal grande pubblico italiano: Pier Giorgio Odifreddi, Luciano Canfora e Alessandro Barbero. Già il fatto che possa citarli come largamente conosciuti, come “popolari”, la dice lunga: segna la differenza rispetto agli enciclopedici genuini alla Humboldt, conosciuti soltanto da chi li leggeva (ma questo valeva ancora per Needham e Bernal).
Nessuno può negare le competenze matematiche di Odifreddi, meno che mai chi come me nelle scienze matematiche è un asino; ma quando mi ritrovo in mano testi suoi che sconfinano nell’etica o nella politica mi si rizzano i capelli, perché sono trattazioni che non si propongono all’insegna dell’“io la vedo così”, ma a quella del “è così, e ve lo dimostro”. Odifreddi ha nel mirino soprattutto il cristianesimo, e prima ancora l’intera tradizione biblica, che a suo parere ha impresso alla civiltà occidentale, in tutte le sue componenti, il marchio di una distruttiva pulsione al dominio e alla negazione di ogni alterità: ma spinge costantemente la sua critica sino al limite dell’invettiva, e spesso anche oltre, facendo un solo fascio di tradizioni, istituzioni politiche e giuridiche, indirizzi economici, ecc … Col risultato di scorgervi dietro, a tirare le fila, sempre la lunga mano e il modus operandi del capitalismo, nelle sue svariate versioni pre-moderne e poi coloniali, imperialistiche, liberistiche, liberalistiche e pseudo-democratiche. Quello che denuncia, senza arretrare neppure di fronte ad evidenti anacronistiche forzature, è in fondo un progetto di dominio pluto-giudaico che ha informato tutta la storia occidentale, e che sembra ormai ossessionare più le varie sinistre sedicenti rivoluzionarie che le vecchie destre reazionarie.

Discorso appena leggermente diverso si può fare per Canfora e per Barbero, che quanto meno rimangono nell’ambito della loro disciplina: ma la specializzazione disciplinare si è spinta oggi talmente oltre che è difficile concepire una competenza storica estesa dai Neanderthal alla guerra fredda o ai conflitti attualmente in corso.
L’impressione che ho ricavato dalle sempre più frequenti apparizioni di costoro nei salotti televisivi o come conduttori di programmi disegnati a loro immagine, impressione che si riverbera retrospettivamente su tutta la loro opera, è che la storia venga trattata non come terreno di costante esplorazione, ma come pezza d’appoggio per avvallare dogmatiche certezze. Che riguardano, come per Needham e per Bernal, e per Odifreddi, la nefandezza della cultura e della civiltà occidentale e la denuncia di come è andata sviluppandosi. È evidente che qui non siamo a livello dei vari Galimberti o dei nipotini post-moderni di Foucault e di Vattimo: l’operazione che i nostri conducono è assai più sottile e sofisticata, ma il punto d’arrivo è lo stesso.

Si vedano ad esempio il saggio di Barbero sull’impero ottomano e le conferenze che ne ha tratto. È uno stillicidio di confronti che oppongono la tolleranza, la giustizia, l’uguaglianza, la meritocrazia praticate dalla cultura ottomana all’intolleranza, alle diseguaglianze, alla farraginosità giuridica e ai privilegi correnti nella coeva cultura occidentale. Ora, sarà anche vero che ebrei e cristiani erano molto più tollerati nelle terre del Sultano di quanto lo fossero nell’Europa rinascimentale, e che a Costantinopoli non esisteva una aristocrazia del privilegio ereditario, e che le classe dirigente era reclutata senza badare al censo; ma tanto per cominciare il tutto era arbitrariamente gestito da un despota assoluto, che in alcuni casi poteva essere illuminato e in molti altri no, e il cui potere non conosceva limiti o contrappesi, né religiosi, né politici, né giuridici. C’è poi il fatto che le relazioni dei viaggiatori che per cinque secoli hanno attraversato quelle terre (non moltissimi, perché viaggiare lì era estremamente difficile e pericoloso) concordano tutte nella descrizione di un clima di povertà, di sopruso e di violenza, narrano di massacri continui e spoliazioni, nei confronti ad esempio dei Curdi, degli Yazidi, dei Mandei, dei Copti, o delle popolazioni balcaniche o di quelle elleniche. Checché ne dicessero gli ambasciatori veneziani, che vivevano peraltro nel perimetro della corte, ai quali Barbero attinge tutte le testimonianze, la tolleranza era molto più proclamata che praticata. Vigeva invece senz’altro l’uguaglianza, ma nel senso che la violenza arbitraria davvero non faceva sconti a nessuno.
Per capirci meglio. Richiesto nel corso di una intervista che circola sul web di spiegare cosa significa essere di sinistra, Barbero ha risposto che per lui significa vedere una bandiera rossa o una falce e martello e non averne paura, anzi, provare piacere. “Io se vedo un corteo in piazza con le bandiere rosse che protesta mi piace, e quando vedo che la polizia li picchia non mi piace, mentre a tanti borghesi la cosa fa paura o da fastidio, e pensano che la polizia faccia bene a picchiarli. Basta questo, di base, per essere di sinistra”. Il che, pur essendo una semplificazione provocatoriamente voluta, spiega comunque tante cose. Spero almeno non gli dia gioia anche veder bruciare i cassonetti, simbolo del consumismo borghese, o le bandiere, con l’eccezione naturalmente di quella rossa (o di quelle che vanno al momento per la maggiore): oppure le occupazioni delle università e dei licei, dove si fa resistenza antifascista impedendo a chi non è schierato “dalla parte giusta” di prendere la parola. Stiamo parlando di docenti universitari. Se questo è per loro lo stare a sinistra, stiamo freschi. E soprattutto, io dove sono stato fino ad oggi?

Lo stesso vale per il modo in cui Canfora parla della democrazia occidentale, sottintendendo che le sue storture erano già presenti sin dall’origine e si sono semmai amplificate nella versione moderna, contrariamente a quanto la storia ufficiale vorrebbe raccontarci. Tanto da fargli preferire un sistema come quello spartano, non a caso vagamente “comunista” e livellatore (salvo reggersi, né più né meno come quella da lui definita la pseudo-democrazia ateniese, sulla schiavitù), e da indurlo a mostrare un’evidente simpatia per l’odierno modello putiniano, nonché naturalmente un sincero rimpianto per quello staliniano: “Uno statista può essere valutato per quello che ha fatto per il suo Paese. L’opera di Stalin è stata positiva, anche se aspra, per la Russia al contrario di quella di Gorbaciov”.
Siamo insomma di fronte ad un “odio di sé occidentale” che non trova corrispettivo in altre culture. Tutte le altre civiltà hanno mantenuto bene o male nel corso del tempo un’alta considerazione di sé (gran parte dei popoli si attribuiscono in esclusiva lo status di “uomini”, già a partire dai termini con cui si autodenominano, o considerano la loro terra come il centro del mondo): e attribuiscono le cause della loro decadenza, dei loro ritardi (ammesso che li considerino tali), del loro eventuale asservimento, alla protervia dei competitori, a sfortunate congiunture climatiche o al volere di divinità irritate. La negatività occidentale affonda invece le sue radici in un’attitudine autocritica nata già agli albori della modernità (ma volendo se ne potrebbero trovare tracce anche prima: basti pensare a Erodoto, o alla Germania di Tacito): solo che nel XVI secolo con Montaigne questa attitudine si esprimeva in un equilibrato ripensamento delle modalità di confronto con “gli altri”, e successivamente con Montesquieu nella critica delle istituzioni domestiche, tutte cose che rimanevano nell’ambito di ciò che va perfezionato, rivisto, recuperato. È in fondo questo che ha fatto la differenza, permettendo all’Occidente di spezzare i vincoli della tradizione immobilista, di innovare o cancellare istituzioni sclerotizzate, di sperimentare modelli produttivi e rapporti sociali di convivenza del tutto inediti. Con quali risultati non sta a me qui discutere (in realtà su questo sito se ne è già discusso ampiamente): le scorie dell’idea di “progresso” che sino a ieri l’Occidente ha abbracciato sono tante e tali da non consentirmi di esprimere giudizi e proporre scale dei valori. Oltretutto, se mi guardo un po’ attorno e vedo solo opposti fanatismi e l’idiozia al potere quasi ovunque, qualche dubbio sulle nostre scelte non può non sorgermi. Di certo so però che in pochissime altre culture una discussione come questa sarebbe consentita, e vorrei tenermi stretta questa possibilità.
Già in epoca romantica, però, nel mito esotico del buon selvaggio, il saldo del confronto con altri possibili modelli di civiltà diventava negativo, e nel secolo scorso questo confronto si è tradotto in un vero e proprio rifiuto della civiltà e della cultura occidentali, a partire dai suoi presupposti. Un rifiuto tutto “di sinistra”, perché non fa appello alla tradizione, non chiede un ritorno nostalgico ad altri tempi, ma fa tabula rasa del sistema valoriale sul quale l’occidente si è fondato sin dai primordi della storia. Col risultato di approdare a quello che Nietzsche chiamava nichilismo.
Tanto Odifreddi quanto Canfora e Barbero, che a questo rifiuto si associano, non possono però essere propriamente definiti dei nichilisti: portano avanti convintamente le loro teorie sulla deriva occidentale, che fanno risalire di volta in volta a Euclide, a Pericle o a una non meglio definita “borghesia”. Di certo non vanno annoverati tra gli orfani dell’occidente, e non sono tra quelli che ne vaticinano o ne piangono il tramonto: semmai anzi lo auspicano. Ne vogliono disvelare il “marcio”, e pensano che il frutto sia da buttare e che l’albero non sia da potare, ma da capitozzare radicalmente.
Sta di fatto che interpretano il loro radicalismo anti-occidentale come una missione, e questo li spinge ad essere costantemente presenti, sui teleschermi, sui monitor o in libreria. Ho contato in una bibliografia di Canfora, aggiornata al 2024, centotredici volumi pubblicati, una volta e mezza quelli di Simenon su Maigret. In quella di Odifreddi siamo a soli trentasette, su temi che spaziano da Le menzogne di Ulisse a Caro papa ti scrivo, sino a La democrazia non esiste, ma accanto a un profluvio di audiovisivi e di interviste, più di quattrocento partecipazioni a programmi radio e trecento a trasmissioni televisive. Barbero si attesta per ora a quarantotto volumi (ma è giovane e può dare ancora molto), che a questo punto si può dire abbiano un ruolo secondario rispetto all’intensissima attività da star mediatica. Vorranno dire qualcosa questa grafomania e questo delirio di onnipresenza? Questa fame insaziabile di pubblicazioni e di comparsate? Che ci sia dietro la maledizione talmudica?

Cosa c’è dietro non lo so. Sospetto che ad un certo punto le lusinghe del mercato e della popolarità spettacolare mandino in tilt anche menti di indubbio livello, accendendo ambizioni egoistiche che scadono nella piaggeria (si può essere ruffiani in due modi: salendo sulla carrozza dei potenti o assecondando le rabbie più fumose degli “insorgenti”. Non mi risulta che alcuna lezione universitaria o conferenza dei tre sia mai stata contestata o impedita) Ma credo soprattutto che questo “odio di sé” (rivolto però a un “sé” rappresentato da tutti gli altri condomini che abitano la casa occidentale) nasca da una duplice presunzione: quella di aver individuato cosa c’è di marcio in Occidente (a seconda dei casi: un pensiero tutto fondato sulla “ragione calcolante”, una finzione democratica messa in piedi dalle classi dominanti, una narrazione della storia asservita agli interessi imperialistici): e quella di averlo fatto chiamandosi fuori dalla parte guasta del frutto.
Continuo a chiedermi comunque cosa può indurre persone tanto intelligenti a costringersi in una visione e in un uso del loro sapere così preconcetti. Ammettiamo che possano agire la temperie culturale del momento, le esperienze politiche, le ambizioni di cui sopra, tutto ciò che si vuole: ma il conoscere non dovrebbe indurre semmai a staccarsi progressivamente da ogni certezza, a ingolosirsi di ciò che di nuovo può arrivare, a non chiudersi a riccio dietro le interpretazioni dogmatiche. Come si conciliano le due cose?
Azzardo la spiegazione che mi pare più plausibile. Credo che tutto questo nasca dalla paura. Intendo la paura del vuoto che ci si spalanca davanti se appena apriamo gli occhi e usciamo dal recinto di significati che ci siamo costruiti attorno. La paura di affrontare l’assurdità della condizione umana come raccontata ad esempio da Camus, e prima ancora da Leopardi, e su su fino a Lucrezio, di guardarla negli occhi. Non sono molti quelli che reagiscono a questa consapevolezza rassegnandosi non passivamente all’assenza di uno scopo ultimo, e creandosene uno più modestamente temporaneo attraverso l’autodeterminazione etica. Nei più la paura del vuoto e dell’insignificanza induce l’urgenza di “esserci”, o almeno di apparire, e la necessità di aggrapparsi ad una bandiera (possibilmente a quelle prêt-à-porter, e non a quelle che vengono bruciate). Se poi la bandiera la si sventola o la si “indossa” in testa al gruppo, è più facile finire sui teleschermi e reclutare seguaci.
Infatti. Le arringhe dei guru dell’anti-occidentalismo sono subdolamente conformiste e confortanti, perché scodellano ad un pubblico pigro, smarrito e rancoroso verità “certe”, tra l’altro spacciandole come coraggiose “rivelazioni” che smontano le false pseudo-verità precedenti; in realtà non fanno altro che intrupparsi nella corrente revisionistica alla moda. Sembrano chiudere un lungo discorso di ricerca e di smascheramento, ma la loro ricerca era mirata solo a convalidare una visione ideologica pre-costituita.
Alla fine, ad essere verificato mi pare solo l’anatema col quale ho esordito. Continuando a “pubblicare” libri su libri, a ritmi industriali, e a “pubblicizzarli” spudoratamente abbassandosi a tutte le più perverse dinamiche del mercato, gli impavidi dissacratori della menzognera narrazione occidentale finiscono per rivelarsi i peggiori nemici di sé stessi.

P.S.
1. Needham e Bernal non costituiscono casi eccezionali di acquiescenza al dogmatismo marxista. Nella cultura anglosassone, e segnatamente in Inghilterra, furono molti, soprattutto nella prima metà del secolo scorso, gli intellettuali che fecero propria questa posizione. Si va dagli scienziati, come J. B. S. Haldane, agli storici, come Christopher Hill o Eric Hobsbawm. Ma all’epoca incombeva sull’Europa la minaccia nazi-fascista, e non tutti avevano la tempra di un George Orwell. Per combattere avevano bisogno di indossare una metaforica divisa.
2. É proprio vero che le immagini a volte sono molto più eloquenti di qualsiasi trattazione scritta. Godetevi le icone dei tre moschettieri dell’anti-occidentalismo. Il quarto non è nemmeno uno scudiero, forse un valletto, ma non può essere considerato solo un intruso. In effetti è la testimonianza vivente che qualcosa nella cultura occidentale è andato storto.
3. Qualcuno tra i miei quattro corrispondenti penserà che queste elucubrazioni siano fini a stesse, frutto di una senile involuzione, e che in definitiva non portino a nulla. Su quest’ultima eventualità sono perfettamente d’accordo, ma credo che ogni tanto vadano comunque fatte le pulizie di primavera. Il cervello sarà di lì a poco nuovamente ingombro e disordinato, ma per qualche tempo almeno le idee potranno circolare un po’ più liberamente. In caso contrario, ci ritroveremo di qui a poco ad ammantarci noi stessi di bandiere, o a bruciarle, a recitare slogan, a rovesciare cassonetti. Ad essere cioè incapaci di relazionarci agli altri e alla storia in maniera civile e consapevole. In parole povere, a odiarci.














