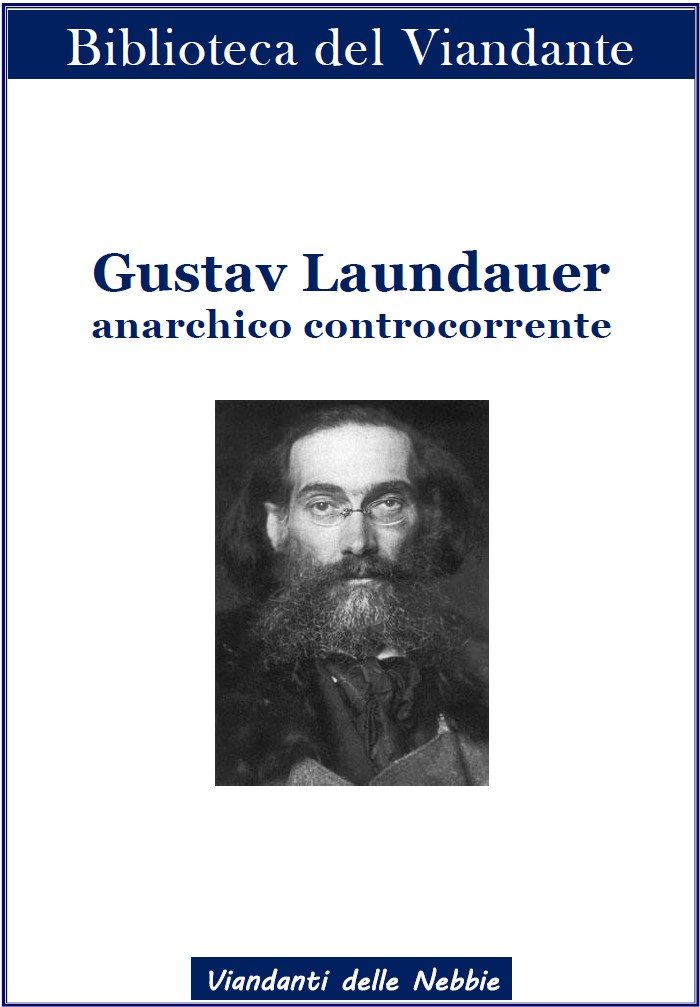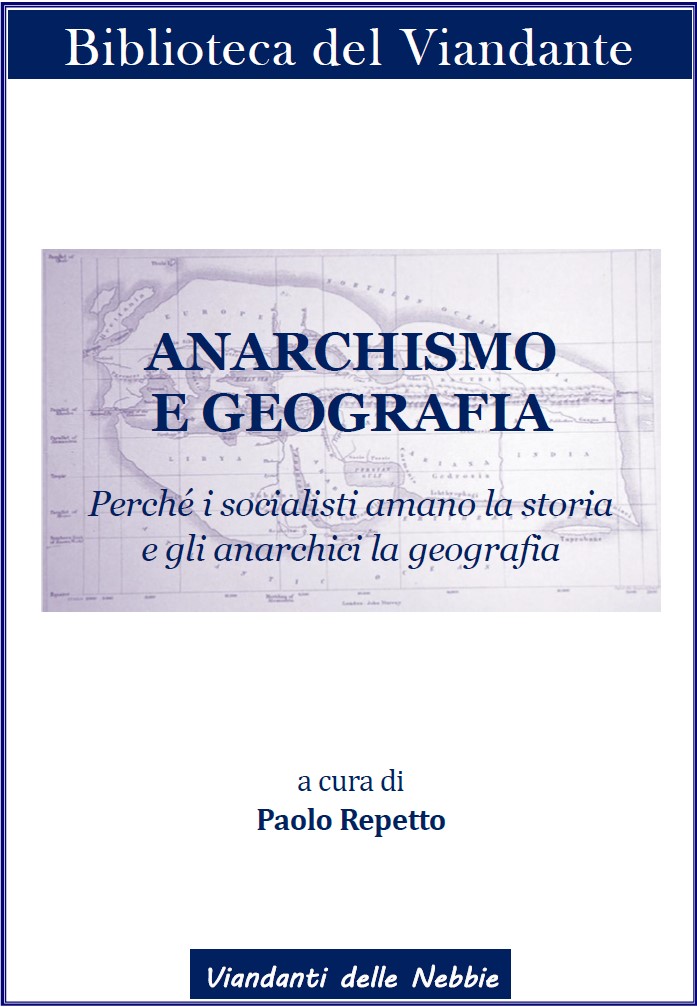a cura di Paolo Repetto, 30 ottobre 2018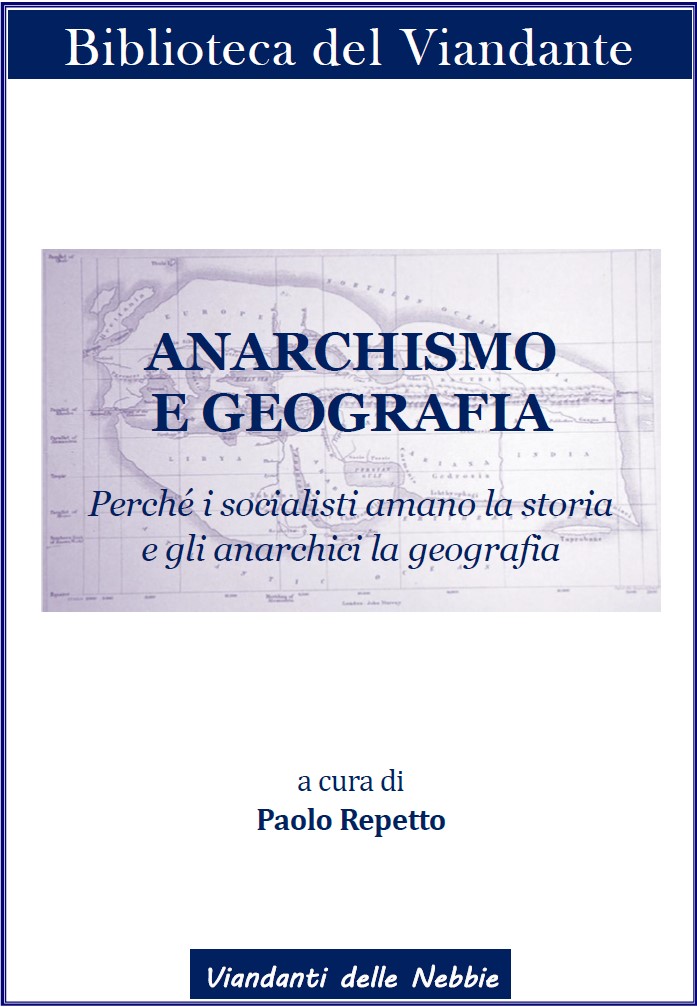
Kant geografo della ragione
Kant grande geografo
La nascita della geografia moderna attraverso il pensiero di Alexander von Humboldt e Carl Ritter
Lezione (hegeliana) di geografia
Geografia e filosofia. Materiali di lavoro
Spazio e geografia in Hegel: la dialettica terra-mare
Geografia
Il pensiero anarchico
I principali pensatori anarchici
Simon Springer
Anarchismo! quello che dovrebbe essere la geografia
Kant geografo della ragione *
Hansmichael Hohenegger
How absolute the knave is! we must speak by
the card, or equivocation will undo us.
(Hamlet, V, 1, 132)
Nel breve scritto in cui annuncia il corso di geografia fisica del semestre estivo del 1757, Kant dichiara che il suo insegnamento non mira alla precisione e alla completezza filosofica che sono richiesti dalla fisica e dalla descrizione della natura, ma segue piuttosto il filo conduttore della «curiosità razionale del viaggiatore».1 Certo, Kant è stato un viaggiatore davvero sui generis, non essendosi mai allontanato dalla sua città natale se non di poche miglia,2 ma la sua curiosità è fuori questione: basta pensare alle testimonianze dei suoi biografi e alle sue estesissime letture di manuali di geografia e di resoconti di viaggi.3 L’attenzione alla geografia dipende forse dal fatto che Kant ha insegnato per più di quarant’anni geografia fisica (dal 1755 al 1796), ma l’intensità e l’estrema articolazione di livelli della sua conoscenza fa supporre che alla base di tutto il suo modo di pensare ci sia una dialettica più profonda tra un’istanza spaziale di ordine e una passione avventurosa per la scoperta e il viaggio. Pur giustificato dai dati biografici, il cliché del geografo da poltrona ha impedito di valutare proprio questo contrasto tra la sua Reiselust e la sua articolata e profonda idea della spazialità.4 A partire da questi due fattori si vuole fornire qualche nuovo elemento per ulteriori indagini riguardo alla genesi dell’architettonica filosofica di Kant.
Il primo passo potrebbe essere quello di notare come la stessa idea di viaggio (il contrario della nostalgia; Fernweh, diranno poi i romantici) sia alla base del suo impulso metafisico. In una nota manoscritta del decennio di preparazione alla Critica della ragione pura, Kant considera la stessa filosofia critica un viaggio:
“La critica della ragione pura è una misura di prevenzione contro una malattia della ragione, che ha il suo germe nella nostra natura. Essa è il contrario dell’inclinazione che ci incatena alla nostra patria (nostalgia, Heimweh). È il desiderio di perderci al di fuori delle nostre cerchie e di rivolgerci ad altri mondi.” 5
Già qualche anno prima, nella Dissertatio (1770), Kant aveva usato la metafora del viaggio quando aveva scritto di aver osato un passo oltre i confini della certezza apodittica (ultra terminos certitudinis apodicticae). Si era chiesto infatti quali fossero le «cause dell’intuizione sensibile». La sorprendente risposta di Kant non è lontana, per sua stessa ammissione, dal «nos omnia intueri in Deo» di Malebranche, ma già la domanda aveva i tratti dell’avventura in alto mare (in altum): nell’oceano delle «indagationes mysticae». Nel 1770 l’impulso metafisico è così manifesto perché è ancora alimentato dalla speranza di risultati positivi derivanti dall’uso reale dell’intelletto; la cautela critica è, però, ben presente: conscio dell’incerto mare delle conoscenze riguardanti le cause dei fenomeni, Kant dichiara infatti che è più raccomandabile (consultius) navigare lungo la costa (littus legere).6
Nel famoso passo dei Paralogismi della prima edizione della Critica della ragione pura, Kant sembra aver preso definitivamente partito per la «sobrietà di una severa, ma giusta critica» che sia in grado di tracciare «sicuri limiti in base a principi» e scriva con la massima sicurezza il nihil ulterius sulle colonne d’Ercole, che la natura stessa ha eretto, affinché il viaggio della nostra ragione continui solo fin dove si estendono le coste ininterrotte dell’esperienza.7
Il viaggio per l’oceano senza rive (uferloser Ocean) deve essere abbandonato perché, secondo questa radicalizzazione quasi empiristica, non rimangono speranze di espandere le conoscenze della ragione. Da allora, l’immagine del costeggiare, del prudente rimanere dentro i confini dell’esperienza, accompagna da sempre la filosofia trascendentale anch’essa come un cliché che, in quanto tale, è vero, ma solo parzialmente. Infatti, l’autentico simbolo (Sinnbild) della filosofia critica, come è espresso icasticamente nei Prolegomeni, non è il limite, ma la «conoscenza del limite»,8 la quale è possibile solo se si riesce a pensare il limite insieme all’impulso a fare un passo oltre di esso. In una delle più famose metafore geografiche di Kant, quella dell’isola della verità, la necessità della navigazione (sia pure di quella non errabonda, herumschwärmende 9) ha lo stesso peso dell’istanza, se si vuol dire così, agrimensoria:
“Noi abbiamo fin qui non solo percorso il paese dell’intelletto puro esaminandone con cura ogni parte; ma lo abbiamo anche misurato, e abbiamo in esso assegnato a ciascuna cosa il suo posto. Ma questo paese è un’isola, chiusa dalla stessa natura entro confini immutabili. È il paese della verità (nome seducente), circondata da un vasto oceano tempestoso, la vera e propria sede della parvenza, dove qualche banco di nebbia e qualche ghiacciaio, pronto a liquefarsi, fingono nuovi paesi, e, incessantemente ingannando con vane speranze il navigante errabondo (herumschwärmende) in cerca di nuove scoperte, lo traggono in avventure, alle quali egli non sa mai sottrarsi, e delle quali non può mai venire a capo. Ma, prima di arrischiarci in questo mare, per indagarlo in tutta la sua distesa, e assicurarci se mai qualche cosa vi sia da sperare, sarà utile che prima diamo ancora uno sguardo alla carta del paese, che vogliamo abbandonare, e chiederci anzi tutto se non possiamo in ogni caso star contenti con ciò che esso contiene; o, anche, se non dobbiamo accontentarcene per necessità, nel caso che altrove non ci fosse assolutamente un terreno, sul quale poterci fabbricare una casa; e in secondo luogo, a qual titolo noi possediamo questo stesso paese, e come possiamo assicurarlo contro ogni pretesa nemica.” 10
Questo passo si trova proprio all’inizio del capitolo «Sul fondamento della distinzione di tutti gli oggetti in genere in phaenomena e noumena», che funge da vera e propria cerniera tra l’analitica e la dialettica trascendentale. Kant vuole mettere sotto gli occhi, come su una carta nautica, la regione dove l’intelletto ha un suo dominio (ditio) e quindi dov’è possibile la conoscenza (territorium), rispetto a quella in cui i concetti della facoltà conoscitiva fanno solo riferimento alla facoltà stessa e quindi possono solo avere un campo (Feld 11). In questo capitolo, Kant ha bisogno di distinguere tra uso empirico e significato trascendentale delle categorie 12 per permettere la navigazione nell’oceano della parvenza dialettica, cioè per esplorare il campo dei concetti dell’intelletto oltre il loro uso empirico: per esempio la categoria di causa-effetto come causalità libera nella terza antinomia della ragione pura. Prima di aprire questa indagine sulla parvenza dialettica, in cui la ragione dovrà disegnare da sé i limiti del proprio dominio legittimo (sia esso dei concetti della natura sia esso di quello della libertà), Kant propone una ricognizione del dominio in cui l’intelletto con i suoi principi è legislativo.
Kant e Bacon
Un confronto tra Kant e Bacon può aiutare a chiarire la natura di questa metafora geografica. 13 Anche in Bacon si può trovare un’articolazione della filosofia in una parte in cui si critica la parvenza e gli errori e una parte positiva in cui vengono stabilite le verità. La bella immagine dell’isola della verità, d’altronde, Kant la prende proprio da Bacon. 14 Infatti la causa dell’errore è dovuta anche per lui al fatto che l’insula veritatis è «circondata da un oceano immenso cui si aggiungono anche straordinari danni e dispersioni prodotte dai venti degli idoli (Immensum enim pelagus veritatis insulam circumluit; et supersunt adhuc novae ventorum idolorum injuriae et disjectiones)». 15 Anche per Bacon inoltre la peragratio è dannosa se non è guidata da quella scienza che è «ex naturae lumine petenda, non ex antiquitatis obscuritate repetenda». 16 Le conoscenze degli antichi sono repertori di errori e tradizioni che avrebbero potuto essere ancora più vari e numerosi se le circostanze politiche e la provvidenza non avessero impedito tali peregrinationes ingeniorum. Inoltre, se per Kant alla logica della verità come analitica trascendentale corrisponde la logica della parvenza trascendentale insita nelle stesse idee della ragione o dialettica trascendentale, per Bacon alla scientia ex lumine naturae con il suo organon fa da pendant il falso sapere, frutto degli idola, in particolare degli idola theatri, o idola scenae, effetto dell’accettazione cieca delle opinioni incontrollate che ci vengono dalla tradizione filosofica.
Il Temporis partus masculus è, sì, un’opera appena abbozzata in età relativamente giovanile in cui, almeno nella presentazione retorica, prevale lo spirito polemico e distruttivo. Anche in questo contesto, però, Bacon dichiara che per distruggere la falsa scienza bisogna comunque proporre una nuova scienza.17
Nell’opera più matura De dignitate et augmentis scientiarum (1623), Bacon è molto più moderato e scrive che è utile studiare le varie opinioni dei filosofi, che sono «veluti diversas Naturae glossas», 18 ma non rapsodicamente, debbono essere presentate come un tutto compiuto e continuo: «Philosophia integra seipsam sustentat, atque dogmata ejus sibi mutuo lumen et robur adjiciunt». Quando si traggono citazioni a caso o si estrapola da un contesto che non si conosce più, le singole affermazioni «portenta quaedam videntur et plane incredibilia». 19 Se si confronta questo passo con la chiusura della prefazione della seconda edizione della Critica della ragione pura, in cui si dice che chi padroneggia l’Idee im Ganzen di un’opera non si lascia fuorviare da apparenti contraddizioni che sorgono quando da un discorso continuo sono stati tolti singoli passi dal loro contesto, si dovrà ammettere che le somiglianze non sono solo linguistiche. 20 Kant può aver apprezzato in Bacon proprio questo metodo inteso in senso architettonico. Sempre nel De augmentis, Bacon sembra di nuovo anticipare il Kant del capitolo sull’Architettonica della Critica della ragione pura. Bacon scrive: «Methodus vero veluti scientiarum Architectura est». 21
Un tema fondamentale della Dottrina del metodo nella Critica della ragione pura è infatti proprio quello dell’unità sistematica delle conoscenze sotto un’idea, ovvero sotto il concetto razionale «della forma di un tutto nella misura in cui mediante esso determina a priori sia la sfera [Umfang] del molteplice sia la posizione reciproca della parti». 22
Sia la singola scienza sia le scienze tutte debbono fare riferimento a questa possibile unità sistematica che ne fa un totum delimitato e organico.
Un elemento essenziale del progetto baconiano è quello di disegnare i confini delle scienze: già nel Temporis partus masculus Bacon vuole spingere il dominio dell’uomo sull’universo ad datos fines. 23 Questa nozione di sistematicità e di delimitazione delle scienze, sembra però in contrasto con l’altrettanto potente spinta al progresso delle conoscenze. Il motto di Bacon è, infatti, il colombiano «plus ultra» come efficacemente rappresentato nel frontespizio dell’Instauratio magna che mostra una nave che passa le colonne d’Ercole.
Spingere le conoscenze oltre i limiti dettati dalla tradizione ha, tuttavia, proprio lo scopo di stabilire limiti certi della scienza. Come si è visto nell’allegoria del viaggio oltre l’isola della verità, anche in Kant da un lato c’è la pulsione al viaggio avventuroso, dall’altro l’esigenza di disegnare i limiti della scienza. Perfino in alcuni aspetti metodologici il progetto di Bacon e quello di Kant coincidono. Per Bacon sono necessari all’impresa scientifica nuovi strumenti (per la navigazione mediterranea bastavano le stelle, per quella oceanica sarà necessario usum acus nauticae 24) e la collaborazione di molti (il motto del frontespizio è multi pertransibunt et augebitur scientia).
Kant sottoscrive l’esigenza baconiana della dimensione pubblica e collaborativa nella costruzione della scienza, come risulta dall’exergo nella seconda edizione della Critica della ragione pura tratto dalla prefazione alla Instauratio magna: «Chiediamo poi che gli uomini secondo il loro stesso interesse […] – prendendo consiglio in comune (in commune consulant) – […] partecipino all’opera». 25 La dimensione pubblica e storica della divisione del sapere è un tema centrale per Kant: gli scienziati e il governo politico debbono cooperare per costituire un’enciclopedia delle scienze (orbis scientiarum) in modo tale da organizzarle non solo in un tutto secondo principi oggettivi, ma anche organizzarle soggettivamente riguardo a coloro che le indagano e insegnano. Questa dimensione soggettiva delle scienze rimanda all’esigenza di organizzare in un corpo comune i docenti: un compito della ragione che deve indagare l’«Idee von einer Universität überhaupt» sulla base della quale debbono essere misurati statuti e piani delle università esistenti. 26 La dimensione pubblica della ragione è intrinsecamente storica, ma ciò non impedisce che abbia anche, laddove l’universale ragione umana è come una repubblica in cui «ognuno ha il suo voto»,27 una valenza trascendentale. In entrambi i casi, la dimensione repubblicana è essenziale all’impresa, solamente è diversa la qualità del sapere a cui si fa riferimento.
Dove si tratta dell’enciclopedia del sapere l’orizzonte è quello del singolo individuo che può e deve allargarlo, riassumere le conoscenze apprese da altri e renderle a sua volta disponibili, mentre dove è in gioco l’architettonica si tratta di un’istanza oggettiva che appartiene all’orizzonte degli uomini in generale. Naturalmente, in quanto entrambe queste due istanze fanno riferimento a una possibile unificazione e sistematicità delle conoscenze, esse debbono essere pensate come convergenti.28
Per Kant l’esigenza di un sapere organizzato sistematicamente, i cui limiti siano stabiliti non arbitrariamente, è essenziale per lo sviluppo delle scienze, come si vede fin nell’Opus postumum,29 ma è innanzitutto un compito filosofico che precede ogni scienza in quanto sua condizione. Per Bacon, invece, la filosofia non è nettamente separata dalla scienza, il suo progetto è enciclopedico e mira a una descriptio globi intellectualis (così si intitola un suo libro scritto nel 1612 e pubblicato nel 1653 30), ma non prevede una scienza specifica che determini l’orizzonte della stessa ragione.
Kant è consapevole della novità della scienza che propone: nei Prolegomeni dice esplicitamente che nessuno aveva mai avuto l’idea di questa scienza, quel che è stato pensato prima di essa non poteva essere utilizzato per costruirla: unica eccezione è rappresentata dalla indicazione che poteva essere data dal dubbio di Hume; neanche lui ebbe il presentimento di una tale possibile scienza formale, anzi trasse sulla spiaggia (dello scetticismo) la sua nave per metterla al sicuro, dove poteva stare e marcire; mentre a me importa fornirgli un pilota che, seguendo i principi sicuri dell’arte nautica derivati dalla conoscenza del globo, munito di una carta nautica completa e di un compasso, possa portare con sicurezza la nave dove gli paia giusto. 31
Kant e Hume
Le somiglianze anche strutturali tra Kant e Bacon sono certo significative per quanto riguarda la rappresentazione spaziale della sistematicità e del progresso delle conoscenze, ma, se si vuole esaminare nella sua massima generalità il ruolo della spazialità nella concezione della filosofia trascendentale, è il ruolo che ha avuto Hume a essere essenziale, e non solo perché è Kant a attribuirglielo. 32 Non è qui, in ogni caso, questione della maggiore o minore importanza di un autore, ma è rilevante, al di là della questione della filiazione di metafore spaziali,33 il diverso valore che queste metafore hanno a livelli diversi dell’architettonica kantiana: l’organizzazione soggettiva delle conoscenze (la carta nautica usata, ma anche aggiornata, dai navigatori), l’organizzazione oggettiva delle scienze (la carta nautica per come deve essere approntata) e, infine, quello che si potrebbe chiamare il livello trascendentale, la stessa possibilità della carta nautica, le sue condizioni di possibilità.
Cassirer aveva scritto che, già nel periodo precritico, Kant era passato dalla determinazione del cosmo spaziale alla determinazione del cosmo intellettuale, «da geografo empirico Kant diviene “geografo della ragione” in quanto intraprende a misurare tutta l’ampiezza della sua facoltà secondo principi determinati».34 In realtà Kant non ha mai detto di se stesso di essere un geografo della ragione, ma di Hume che era uno di questi geografi della ragione, che credeva aver fatto abbastanza per sbarazzarsi di tutti quei problemi con il relegarli al di fuori dell’orizzonte della ragione, orizzonte che però non poteva determinare.35
Potrebbe sembrare che Kant usi questa caratterizzazione per evidenziare la disposizione solo empirica di Hume a descrivere la ragione umana senza riferimento ad alcun principio, appunto secondo una scienza come la geografia che è eminentemente empirica. Il contesto sembra suggerirlo, si tratta infatti del capitolo Dell’impossibilità di un appagamento scettico di una ragione pura che sia in dissidio con se stessa, in cui Kant distingue due tipi di ignoranza, quella accidentale che riguarda le cose e quella «della determinazione e dei limiti della mia conoscenza». Nel primo caso si è autorizzati a indagare dogmaticamente, mentre nel secondo si deve indagare criticamente.36 Se l’ignoranza è assolutamente necessaria (schlechthin nothwendig) ci si può astenere dalla ricerca, ma, in effetti, è esclusa solo l’indagine empirica in quanto sarebbe insensata, mentre quella critica è possibile «mediante l’indagine delle ragioni (Ergründung) delle prime fonti della nostra conoscenza». In questo caso posso sperare, procedendo con argomenti a priori, di determinare i limiti (Grenzen) del conoscibile. Quando, invece, si tratta di limitazioni (Einschränkungen) poste alla nostra ragione, la conoscenza della ignoranza può essere determinata solo a posteriori perché se pure si riesce a sapere qualcosa, sappiamo che ci resta ancora dell’altro da sapere e quindi essa rimane complessivamente indeterminata. Dei limiti, quindi, si può dare scienza, delle limitazioni no, solo percezione (Wahrnehmung).37
Per chiarire questo punto Kant espone la distinzione, già spaziale, della differenza tra Grenzen e Schranken (Einschränkungen) con un’immagine spaziale.38
Chi trovandosi sulla superficie terrestre se la rappresenta, secondo una percezione dei sensi, come un piatto, non sa quanto essa si estenda; procedendo nell’esplorazione conoscerà sempre porzioni di questa superficie, saprà di non averle prima conosciute, conoscerà, quindi, le limitazioni (Schranken) della geografia (Erdkunde) di questa superficie, ma, appunto, non i limiti (Grenzen) di ogni possibile descrizione della terra. Se, invece, si è arrivati a sapere (wissen) che la terra è una sfera, si può conoscere in modo determinato e secondo principi, anche da una piccola sua porzione, per esempio quella di un grado, il suo diametro e così anche la compiuta delimitazione della terra, cioè la sua superficie. Potrò essere ignorante riguardo agli oggetti che si trovano su questa superficie, ma non riguardo all’estensione che li contiene, alle sue delimitazioni e alla sua grandezza.39 Se quindi Hume è un «geografo della ragione» per il fatto di essersi sbarazzato dei problemi filosofici relegandoli «al di fuori dell’orizzonte della ragione», è però, pur sempre, un geografo empirico che in quanto tale non può determinare questo stesso orizzonte e quindi nessuna fondata indagine critica sulle fonti della conoscenza.40
Questa considerazione contrasta, però, con il passo già citato dei Prolegomeni in cui Kant sostiene che Hume è l’unico ad aver dato almeno un’indicazione sulla possibilità della filosofia critica come nuova scienza formale: il suo contributo a questa nuova scienza non può consistere solo nella censura empiristica del dogmatismo. Descrivere Hume come semplice geografo empirico-percettivo non dà conto in modo accurato della sua filosofia.
Già il fatto che sia Hume stesso a caratterizzare la sua indagine come mental geography suggerisce che Kant non faccia un uso polemico dell’idea di una geografia empirica della ragione, soprattutto se si considera che Hume introduce questa espressione proprio per dimostrare la necessità della filosofia:
And if we can go no farther than this mental geography, or delineation of the distinct parts and powers of the mind, it is at least a satisfaction to go so far; and the more obvious this science may appear (and it is by no means obvious) the more contemptible still must the ignorance of it be esteemed, in all pretenders to learning and philosophy.41
In questo contesto Hume non sostiene una tesi scettica, il tono è semmai quello di un dogmatico in quanto nutre la speranza (there is no reasonto despair) che questo tipo di ricerche possa permettere anche di «discover, at least in some degree, the secret springs and principles, by which the human mind is actuated in its operations»; 42 Hume pensa, infatti, che si possa passare dalla descrizione delle facoltà alla loro spiegazione come mental powers and oeconomy. Poco dopo Hume si spinge a dire che, poiché un’operazione e un principio della mente sono dipendenti da un’altra operazione e un altro principio, questa «may be resolved into one more general and universal». Non è dunque il mancato riferimento ai principi quel che Kant critica a Hume, ma il fatto che Hume non sappia determinare esattamente fin dove possano arrivare queste indagini. Hume stesso lo dice: «how far these researches may possibly be carried, it will be difficult for us, before, or even after, a careful trial, exactly to determine». Hume ha dunque avuto l’idea di un careful trial che preceda o segua queste indagini e quindi stabilisca la filosofia come un sapere che si sappia autodelimitare, ma ne ha dichiarato l’inutilità. L’idea di completezza della filosofia che si può trovare in Hume è quella dell’unione di concretezza a rigore dei saperi filosofici: «Happy, if we can unite the boundaries of the different species of philosophy, by reconciling profound enquiry with clearness, and truth with novelty!».43 Intenzione e auspicio questo che non va oltre l’enunciazione, appartenente anche al razionalismo, del connubium rationis et experientiae, o, baconianamente, inter mentem et naturam, e si colloca semmai come ideale regolativo della ragione, non come descrizione della stessa ragione, come vuole Kant. Sia lo scettico sia il dogmatico concepiscono la ragione come un piano in cui l’indagine prosegue indeterminatamente in quanto considerano le cose come cose in sé e «l’insieme di tutti gli oggetti possibili della nostra conoscenza » come una «totalità incondizionata».44 La differenza sta nel fatto che lo scettico ritiene che, negando la necessità di un concetto a priori, che sia al di fuori dell’orizzonte di conoscibilità o che appartenga alla linea di confine (Grenzlinie), si possa escludere la possibilità di qualsiasi concetto di quel tipo, mentre il dogmatico conserva la fiducia, perfezionandosi la conoscenza, di poter possedere concetti a priori. Sia quella non completamente provata sfiducia, sia questa eccessiva fiducia si contrappongono in un conflitto inconcludente. L’unico modo di porvi termine è un esame preliminare che la ragione riesce a fare di se stessa, disegnando, nello stesso tempo, i limiti dell’esperienza possibile:
La nostra ragione non è, per così dire, un piano di estensione indeterminabile, le cui limitazioni siano in genere conosciute solo in questo modo, deve piuttosto essere paragonata a una sfera [Sphäre] il cui raggio può essere determinato dalla curvatura di un arco della sua superficie (dalla natura delle proposizioni sintetiche a priori), in modo tale però che sia possibile da ciò stabilire con sicurezza volume e delimitazione di questa sfera.45
Anche se Hume non è citato esplicitamente, è chiaro dall’ inciso riguardante le proposizioni sintetiche a priori che il contributo determinante di Hume in questa geografia della ragione è quello di aver sollevato un dubbio sulla necessità del legame causale. È questo dubbio che, oltre a rappresentare una censura difficilmente eludibile di ogni dogmatismo rispetto all’uso trascendente di concetti a priori, impone di indagare la stessa ragione. La censura humiana colpisce, sì, il dogmatico che è messo in difficoltà dal non riuscire a ribattere sia pure a un solo dubbio scettico, ma il merito principale di Hume rispetto a Kant è quello di aver posto la domanda su come siano possibili i giudizi sintetici a priori. Il suo contributo a questa scienza del tutto nuova della critica della ragione pura non va, però, oltre questo, perché il geografo della ragione Hume proponeva solo la cartografia di un’ignoranza locale. Per passare dal metodo scettico a quello critico è necessario descrivere con completezza l’orizzonte della ragione, e cioè, appunto, l’«ignoranza riguardo a tutte le questioni possibili di una data specie».46
Secondo Kant, Hume è destinato inevitabilmente a confusioni, proprio perché non si pone il problema di «abbracciare con lo sguardo a priori e sistematicamente tutti i tipi di sintesi dell’intelletto»,47 e non può quindi porre Grenzen alla conoscenza, ma unicamente Schranken, che, certo, sono d’impaccio per il dogmatico, ma solo provvisoriamente. Per far tacere il dogmatico nelle sue pretese smisurate, bisogna potergli mostrare «l’ignoranza per noi inevitabile» 48 nella sua intera estensione.
Hume non si è impegnato in una rassegna di tutte le antitetiche, di tutte le sintesi della ragione in quanto sistema delle idee e quindi non ha potuto porsi criticamente la domanda sulla possibilità dei giudizi sintetici a priori. Negando la validità dei giudizi sintetici a priori «non ha infatti posto la distinzione tra le fondate pretese dell’intelletto e le presunzioni dialettiche della ragione».49 Questa distinzione l’ha però fatta Kant a partire proprio da Hume, cosicché quando nei Prolegomeni afferma che è stato Hume – con le sue obiezioni alla necessità del legame causale – a svegliarlo dal sonno dogmatico, e in un’altra parte della stessa opera dice che a svegliarlo sono state le antinomie,50 tra le due affermazioni non c’è vera contraddizione. La causalità e le antinomie hanno infatti un elemento in comune: in entrambi i casi sono in gioco giudizi e inferenze sintetiche a priori che costituiscono rispettivamente due sistemi completi, quello delle categorie e quello delle idee, che sono strettamente interdipendenti e insieme costituiscono la sfera della ragione.51 La conoscenza del limite è proprio la capacità di tracciare questa distinzione, cioè di descrivere, per quanto ciò possa essere paradossale,52 dall’interno dell’esperienza i limiti di quest’ultima, e di conseguenza dar conto del sapere che permette di disegnare dall’interno i limiti della ragione. Questo sapere è il sapere architettonico nella sua forma più universale. In una Reflexion risalente all’epoca di preparazione della Critica della ragione pura dedicata all’architettonica, dopo aver dato la classica definizione della ragione architettonica in quanto «critica tutte le conoscenze e progetta un canone», Kant ne coglie anche l’istanza trascendentale: la ragione architettonica è «la facoltà di descrivere la sua propria sfera».53 Si può chiudere questa nota sull’importanza del pensiero della spazialità nella costruzione del sistema critico citando una Reflexion che deve essere stata scritta quando il pensiero della Critica della ragione pura era in statu nascendi, e che proprio per questo potrebbe farne apprezzare il valore euristico:
Della metafisica come di un paese sconosciuto, di cui intendevamo appropriarci, abbiamo indagato attentamente per prima cosa la posizione e le vie di accesso. (Giace nella [regione] semisfera della pura ragione); abbiamo tracciato perfino il contorno di dove quest’isola della conoscenza è connessa mediante ponti con il paese dell’esperienza o dove essa ne è separata da un mare profondo; ne abbiamo perfino disegnato il contorno e ne conosciamo per così dire la geografia (icnografia); non sappiamo ancora cosa si possa trovare in questo paese, che da alcuni è ritenuto non abitabile da uomini, da altri è considerato la loro vera sede. Dopo la geografia universale di questo paese della ragione, vogliamo prendere in considerazione la storia universale della ragione.54
In questa allegoria sembra che la metafisica sia ancora un’isola vera e propria, non solo una parvenza di isola («banchi di nebbia e ghiacciai pronti a liquefarsi»), che, insomma, all’epoca in cui Kant scriveva essa aveva una dimensione geograficamente più concreta, v’erano, infatti, ancora accessi, ponti, e essa non era circondata solo da un mare profondo. L’unica cosa che non si sapeva era se fosse abitabile. Non è chiaro cosa rappresenti l’emisfero della ragione pura: forse è il mundus intelligibilis che, in parte, è occupato da idee della ragione e in parte da concetti dell’intelletto. In questo caso, l’altro emisfero sarebbe ancora – se è plausibile la datazione della Reflexion intorno al 1772, pochi anni dopo la dissertazione De mundi sensibilis atque intelligibilis forma et principiis del 1770 – il mundus sensibilis che certo è antipodale alla metafisica. In questo caso Kant potrebbe voler dire che l’emisfero della ragione pura è ancora non illuminato, come se la sfera di cui è parte fosse divisa a metà dall’orizzonte in una parte illuminata e in una oscura, il mondo fenomenico e quello noumenico. In questo caso riprenderebbe in qualche modo l’idea lockiana di delimitazione della ragione come di un orizzonte che «sets the bounds between the enlightened and dark parts of things, between what is and what is not comprehensible by us».55
L’elemento di novità in questa nota manoscritta è che, oltre alla spazialità – qui al servizio di un’allegoria della sistematicità della ragione (la rappresentazione delle connessioni tra regioni che insieme costituiscono un tutto organizzato) –, si considera la possibilità di rappresentare temporalmente la ragione. Forse Kant aveva già in mente una storia della ragione come sarà sviluppata nell’ultimo capitolo della Critica della ragione pura, dal titolo, appunto, di «Storia della ragione».56 L’importanza sistematica di questo capitolo è stata spesso ignorata forse anche per via della sua estrema brevità, ma la brevità è inversamente proporzionale alla sua importanza: «sta qui solo per indicare un posto rimasto vuoto nel sistema, e che dovrà essere riempito in futuro».57 Kant enuncia appena le tappe del processo del divenire adulta della ragione come il sorgere del metodo critico dall’opposizione di metodo scettico e metodo dogmatico, ma, ancora più originariamente, a partire dalla dialettica tra metodo naturalistico e metodo scientifico, tra sapere naturale della ragione comune e sapere sistematico in base a principi della ragione pura. Quest’ultima opposizione permette di stabilire un utile parallelismo tra il modello spaziale e il modello temporale della ragione in quanto il suo tema centrale è l’ignoranza. Nel caso della spazialità si è visto che è l’«ignoranza per noi inevitabile» che permette di disegnare estensione e figura della sfera della ragione (anche grazie al dubbio di Hume), mentre nel secondo caso l’ignoranza in gioco è quella della misologia, che non è tanto disprezzo della scienza, quanto dubbio rispetto al valore pratico della ragione intesa esclusivamente come scienza (Wissenschaft). La misologia in senso positivo non è disprezzo di quel che non si sa, ma insoddisfazione di fronte alle scienze che si ritengono autosufficienti, è saggezza (Weisheit), ovvero un’istanza critica che valuta ogni sapere rispetto agli scopi ultimi dell’umanità che non possono appartenere se non alla ragione pratica.
La storia della ragione come teleologia humanae rationis è costituita essenzialmente da questa tensione ineliminabile tra scienza (Wissenschaft) e saggezza (Weisheit). Il risultato critico è che l’unità della ragione teoretica e pratica può essere pensata solo storicamente.58
Da un punto di vista più generale e architettonico, ci si potrebbe domandare, in conclusione, quali prospettive ermeneutiche possa aprire l’esame sistematico dell’istanza humiana insieme a quella rousseauviana. Il dubbio humiano e la misologia rousseauviana hanno in comune di essere filosofie dell’ignoranza,59 e, come si è visto, sono momenti essenziali dell’indagine della ragione, la prima di quella spaziale e la seconda di quella temporale.
Queste due modalità di autocomprensione della ragione non possono essere, però, né tenute insieme né separate in modo assoluto. La conseguenza di ciò è che non è la storicità a tenere aperto un sistema della ragione (se lo fa è quaestio facti), ma de iure è la tensione ineliminabile tra la sistematicità e la processualità della stessa ragione a tenere aperto ogni sistema della ragione.60
* L e opere di I. Kant pubblicate in vita sono citate da Werke in zehn Bänden, a cura di W. Weischedel, Darmstadt, 1981 (19561), con ’indicazione dove possibile della paginazione originale.
‘A’ indica la prima e ‘B’ la seconda edizione. Le opere non pubblicate in vita e le trascrizioni di lezioni sono citate da Kant’s gesammelte Schriften, a cura della Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften (e successori), Berlin, 1900- (d’ora in avanti KGS). In numeri romani si
indica il volume, in numeri arabi la pagina; delle Reflexionen si indica anche il numero progressivo e tra parentesi la datazione, in forma semplificata, proposta dal curatore E. Adickes. Le modifiche apportate alle traduzioni dei testi citati non sono segnalate.
NOTE
1 I. Kant, Entwurf und Ankündigung eines Collegii der physischen Geographie (1757), KGS II, p. 3; cit. in W. Stark, Einleitung a Vorlesungen über physische Geographie, Berlin, 2009, KGS XXVI, 1, p. vi. Kant esclude per esempio la geografia matematica e quella storica dalle sue lezioni (cfr. W. Stark, Einleitung cit., p. vi), mentre include considerazioni che oggi diremmo etnografiche, almeno fino a quando, nel 1772, non inizierà a tenere le lezioni di antropologia.
2 Per avere un quadro completo e preciso dei viaggi di Kant, cfr. W. Stark, http://web.unimarburg.de/kant//webseitn/bio_reis.htm#Wohnsdorf.
3 R iguardo a quest’ultimo punto vedi la bibliografia raccolta da Werner Stark alla fine del primo tomo dedicato alle Vorlesungen über physische Geographie cit., KGS XXVI, 1, pp. 321-363. Riguardo alle testimonianze biografiche, oltre ai vari aneddoti su conversazioni con stranieri nelle quali Kant dimostra una conoscenza di luoghi in cui non è mai stato superiore a quella di chi vi ha abitato per anni, si può ricordare quel che racconta Wasianski, dell’intenso desiderio di viaggiare che Kant ha avuto nell’ultimo anno della sua vita. In inverno, attendendo l’estate per poter realizzare questo suo desiderio, Kant pensava dapprima a «gite, poi a viaggi nel paese e infine a lunghi viaggi». E. A. Ch. Wasianski, Immanuel Kant in seinen letzten Lebensjahren, Königsberg, 1804, in Immanuel Kant. Sein Leben in Darstellungen von Zeitgenossen, a cura di F. Gross, Darmstadt, 1993, p. 238. Arrivata l’estate non smetteva di pensare a quei «lunghi viaggi progettati nel paese e all’estero», p. 242. Il suo medico e biografo Wasianski, per evitare strapazi al vecchio e malato Kant, propose allora una gita nella casa di campagna dove Kant era già stato in passato: «Bene, basta che il viaggio sia lungo», fu la risposta, p. 243. Naturalmente le condizioni di salute e l’assoluta mancanza di abitudine al viaggiare resero breve e faticoso il viaggio, ma, anche dopo l’esperienza penosa, Kant continuò a parlare «con entusiasmo rinnovato di viaggi, lunghi viaggi, viaggi all’estero», ibid.
4 Kant non si è interessato solo alla geografia fisica, che ha insegnato così a lungo, ma, naturalmente, anche alla geografia astronomica. Basta pensare ai due saggi sulle variazioni del moto rotatorio della terra e sull’invecchiamento della terra (entrambi del 1754), oppure alla sua Teoria del cielo (1755). Naturalmente, anche in questo caso, sono molte e importanti le metafore spaziali a partire dall’astronomia che sono disseminate nei suoi scritti. Solo a titolo d’esempio, Kant usa l’immagine dell’errore di parallasse (lo spostamento dell’oggetto rispetto allo sfondo se considerato da punti di vista diversi) per illustrare l’errore connaturato all’universale intelletto umano, in quanto, per essere esaminato, deve potersi valutare sia «dal punto di vista del mio intelletto » sia «dal punto di vista di una ragione estranea e esterna». Sogni di un visionario, A 74; trad. it. in Scritti precritici, a cura di P. Carabellese, successive aggiunte e correzioni di R. Assunto, R. Hohenemser e A. Pupi, Roma-Bari, 19823, pp. 380-381. Questa teoria dell’errore anche in KGS XVIII, pp. 79-80; Refl. 5073 (1777). È chiaro che la metafora più nota e studiata è quella per cui la filosofia critica opera una «rivoluzione copernicana», KrV B XVI; trad. it., p. 24. Ancora, ma in ambito di filosofia delle storia: per giudicare del progresso dell’umanità si deve tenere conto del fatto che la direzione dell’umanità può sembrare come il moto apparente dei pianeti, ovvero retrogrado (epiciclo), se non la si considera dal punto di vista del sole, ovvero, fuori dalla metafora, dal punto di vista della ragione. Cfr. Il conflitto delle facoltà, A 140; trad. it. in Scritti di storia, politica e diritto, a cura di F. Gonnelli, Roma-Bari, 1995, p. 227.
5 KGS XVIII, pp. 79-80; Refl. 5073 (1777).
6 De mundi sensibilis atque intelligibilis forma et principiis A 28; trad. it. in Scritti precritici cit., p. 450.
7 Cfr. Critica della ragione pura (d’ora in avanti KrV) A 395-396; trad. it. a cura di G. Colli, Milano, 1976 (Torino 19571), pp. 457-458.
8 Prolegomeni ad ogni futura metafisica che si presenterà come scienza, § 59, A 182; trad. it. di P. Carabellese, rev. e intr. di H. Hohenegger, Roma-Bari, 1996, p. 247.
9 Non si perda, nella scelta della parola, il riferimento allusivo allo sciamare disordinato (schwärmen) dei fanatici (Schwärmer). In questa parola risuona notoriamente il disordinato sciamare delle api, il vagabondaggio senza meta dei ragazzi o dei soldati senza patria, e, con coloritura religiosa, di chi abbandona rumorosamente l’ortodossia e segue una setta: «fanaticum esse, in globo errantium hominum esse, segreges coetus instituere». J. Grimm e W. Grimm, Deutsches Wörterbuch,33 voll., München, 1984, s.v. «Schwärmen». La citazione in latino è dal dizionario tedesco-latino: J. L. Frisch, Teutsch-lateinisches Wörter-Buch, Berlin, 1741, II, p. 243a.
10 KrV B 294-295/A 236-237; trad. it., p. 311.
11 Questa terminologia giuridico-geografica è tratta dalla Critica della facoltà di giudizio, § II,
B XVI-XVII, trad. it. di E. Garroni e H. Hohenegger, Torino, 1999, p. 10.
12 Cfr. KrV B 305/A 248; trad. it., p. 321.
13 L’utilità di un confronto tra Bacon e Kant era già stata sostenuta da Salomon Maimon, uno dei più acuti interpreti di Kant tra i suoi contemporanei. Proprio per il fatto che essi «sono per un verso assai simili e per l’altro così diversi, credo che il loro essere messi a confronto permetta di gettare su entrambi una nuova luce» (S. Maimon, Baco und Kant, in «Berlinisches Journal für Aufklärung» 1790 VII/2, http://www.ub.uni-bielefeld.de/diglib/aufkl/berlaufk/berlaufk.htm. Cfr. anche l’edizione in S. Maimon, Gesammelte Werke, a cura di V. Verra, vol. II, Hildesheim, 1965, pp. 499-522, p. 102). In comune hanno l’essersi proposti «una compiuta [völligen] riforma della filosofia (e di conseguenza di tutte le scienze nella misura in cui esse traggono i loro principi dalla filosofia)», ivi, p. 103. Mentre Kant, però, si sarebbe concentrato sul «provare la possibilità dell’applicazione delle forme logiche agli oggetti reali della natura, in quanto quelle sono date a priori e questi a posteriori», Bacon, non prendendo in considerazione questo problema, si sarebbe preoccupato di trovare «il vero metodo di questo uso [delle forme logiche applicate agli oggetti] in casi particolari», ivi, p. 104. È notevole che Maimon scelga di chiarire il punto prendendo come esempio il concetto di causa: Bacon, secondo lui, «non si preoccup di spiegare come siamo arrivati al concetto di causa, a priori o a posteriori (come vuole che sia D. Hume), né della spiegazione della possibilità dell’uso di questo concetto, che se è a priori lo è di oggetti a posteriori; a lui basta che il factum sia al di là del dubbio, che cioè noi lo usiamo», ivi, pp. 104-105. Anche se Bacon ha di mira un sistema delle scienze, secondo Maimon, se non si pone il problema critico del rapporto tra forme del pensiero a priori e oggetti a posteriori, non riuscirà con l’induzione ad attingere a un sistema come quello kantiano in cui «forme e principi possono essere completi (vollzählig)», ma potrà solo approssimarsi regolativamente ad esso come a un’idea (p. 119). Naturalmente Maimon dice anche dei vantaggi di questo empirismo baconiano, e del possibile superamento di questa opposizione in un leibnizismo perfezionato che è poi la proposta della sua filosofia.
14 Neanche Hans Vaihinger nota questa possibile fonte di Kant e, per la metafora dell’oceano, rimanda sì a Bacon, ma a un altro pur importantissimo passo del De dignitate et augmentis scientiarum, lib. IX, § 1 (Cfr. H. Vaihinger, Commentar zu Kants Kritik der reinen Vernunft, 2 voll. [Stuttgart, 1881-1892 ed. orig.], a cura di R. Schmidt, Stuttgart, 1922, p. 40), nel quale Bacon, dopo aver detto che fino a quel punto si è trattato di navigare lungo la costa del vecchio e del nuovo mondo delle scienze (orbis scientiarum), si deve abbandonare la navicula rationis humanae per passare all’ecclesiae navis, cioè dalla scienza alla teologia, per affrontare i temi della re ligione. È anche interessante che questo libro si chiuda con la dichiarazione di aver per quanto possibile esaurito, completato con le parti mancanti, il piccolo continente (mondo) dell’orbe intellettuale (globum exiguum Orbis Intellectualis); resterà ai posteri il compito non solo di giudicare questo suo lavoro, ma anche di accrescerlo ulteriormente. F. Bacon, De dignitate et augmentis scientiarum, in The Works of Francis Bacon, 14 voll., a cura di J. Spedding, R. L. Ellis, D. D. Heath, London, 1857-1874, rist. anast., Stuttgart, 1989, vol. I, pp. 836-837; trad. it. in Opere, a cura di E. De Mas, 2 voll., Bari, 1965, vol. II, pp. 518-519. D’altronde non si trova un riferimento a questa plausibile fonte di Kant neanche nel recente libro, pur ambizioso e ricco di spunti, di Shi-Hyong Kim, Bacon und Kant. Ein erkenntnistheoretischer Vergleich zwischen dem ‘Novum Organum’ und der ‘Kritik der reinen Vernunft’, Kantstudien Ergänzungshefte, Berlin-New York, 2008. Certo, la metafora è davvero diffusa e quando se ne indaga la Quellengeschichte, la prova di una derivazione è sempre assai difficile, perché chi la usa, più essa è diffusa, più non sente il bisogno di citare la propria fonte. Come esempio si può considerare, un autore ben presente a Kant, Johann Nicolas Tetens, il quale cita da una poesia in cui un saggio in cerca della verità «lontano da concetti terreni / osa veleggiare sul vasto oceano della divinità» («von irdischen Begriffen / im weiten Ocean der Gottheit wagt zu schiffen»; A. von Haller, Gedanken über Vernunft, Aberglauben und Unglauben, 1729). Sulle fonti possibili di questo verso (famoso, tanto che Tetens non ne cita l’autore) già varrebbe la pena indagare (Comenius, Locke, Leibniz?). A partire da questa suggestione, Tetens stabilisce un’analogia tra come procede l’intelletto nella scienza e la navigazione, e anche in questo caso non cita alcun autore (è Bacon?). Come il navigante si tiene alla costa, così il filosofo si tiene all’esperienza, ma «la metafisica è un viaggio intorno al mondo, sull’oceano, dove solo di quando in quando si incontrano isole e sponde in alcuni principi universali dell’esperienza, da cui si può apprendere quale sia la direzione che si è presa. Le passioni sono le tempeste, i pregiudizi gli scogli che respingono o fanno naufragare la ragione». J. N. Tetens, Über die allgemeine speculativistische Philosophie (Bützow e Wismar, 1775), stampato insieme al primo vol. dei Philosophische Versuche über die menschliche Natur und ihre Entwicklung (1777), a cura di W. Uebele, Berlin, 1913, vol. I, p. 15 (ed. orig. p. 20). La natura assai produttiva della metafora fa sì che non sia impossibile collegare la circolarità del sapere sia con la sfera sia con l’oceano. Bacon vede nella sapienza di Salomone (1Re 4:29-34), vasta come la sabbia che circonda universas orbis oras, la sapienza che abbraccia ogni sapere umano e divino. De dignitate et augmentis scientiarum cit., vol. I, p. 750; trad. it., vol. II, pp. 418-419.
15 F. Bacon, Temporis partus masculus, in The Works of Francis Bacon cit., vol. III, p. 536.
16 F. Bacon, Temporis partus masculus, cit, p. 535.
17 F. Bacon, Temporis partus masculus cit., vol. III, p. 539; trad. it. p. 52.
18 F. Bacon, De dignitate et augmentis scientiarum cit., III, 4; vol. I, p. 563; trad. it., vol. II, p. 175.
19 F. Bacon, De augmentis scientiarum cit., p. 564; trad. it., pp. 175-176.
20 Cfr. KrV B XLIV; trad. it., p. 43: «Auch scheinbare Widersprüche lassen sich, wenn man einzelne Stellen, aus ihrem Zusammenhange gerissen, gegen einander vergleicht, in jeder, vornehmlich als freie Rede fortgehenden, Schrift ausklauben, die in den Augen dessen, der sich auf fremde Beurteilung verlässt, ein nachteiliges Licht auf diese werfen, demjenigen aber, der sich der Idee im Ganzen bemächtigt hat, sehr leicht aufzulösen sind».
21 F. Bacon, De augmentis scientiarum cit., VI, 2, vol. I, p. 668; trad. it., vol. II, p. 305.
22 KrV B 860/A 832; trad. it., p. 806.
23 F. Bacon, Temporis partus masculus cit., vol. III, p. 528, p. 38.
24 Praefatio generalis, Instauratio magna, in The Works of Francis Bacon cit., vol. I, p. 130; trad. it., vol. I, p. 225.
25 KrV B II. F. Bacon, Instauratio magna cit. p. 132.
26 KGS XXIII, Vorarbeiten zum Streit der Fakultäten, p. 430. Per la questione della divisione del lavoro e quindi della dimensione pubblica e storica dell’architettonica delle scienze rimando alle citazioni che si trovano in H. Hohenegger, Kant, filosofo dell’architettonica. Saggio sulla «Critica della facoltà di giudizio», Macerata, 2004, pp. 37-64.
27 KrV B 780/A 752; trad. it., p. 745.
28 Sulla questione del rapporto tra enciclopedia e architettonica cfr. M. Capozzi, Kant e la logica, Napoli, 2002, pp. 413-418. In generale sulla nozione di orizzonte e in particolare sull’importanza di Georg F. Meier per l’elaborazione kantiana di questa nozione, cfr. R. Pozzo, Prejudices and Horizons: G. F. Meier’s Vernunftlehre and its Relation to Kant, «Journal of the History of Philosophy», 43, n. 2, 2005, pp. 185-202. Per un rapido elenco della pluralità degli orizzonti, dall’universale orizzonte dell’intelletto umano in genere, a quello, pratico, pragmatico, estetico, del sesso, del censo, dell’età, oppure riguardo alle regole per determinare il proprio orizzonte, cfr. Logik Busolt, KGS XXIV, pp. 623-625. La determinazione dell’orizzonte e la divisione del lavoro è chiaramente in rapporto alla «Encyclopaedia vniversalis. Vniversalcharte (g Mappemonde delle scienze)». KGS XVI, Refl. 1998 (1780-89), p. 189.
29 Riguardo alle scienze, la filosofia deve «fin dove è possibile, misurare, tenendosi all’interno dei limiti di ciò che è conoscibile a priori, il campo di questo conoscibile e rappresentarlo in un cerchio (orbis) che sia semplice e unito, cioè in un sistema non escogitato arbitrariamente, ma prescritto dalla ragione pura, la qual cosa non potrebbe accadere con la raccolta di elementi empirici della conoscenza, in quanto, messi insieme frammentariamente, non farebbero sperare in nessuna convinzione di completezza». KGS XXI, p. 524. Ricorre spesso nell’Opus postumum l’espressione orbis scientiae con funzione schematica, di mediazione tra sapere filosofic e empirico, ovvero l’esigenza di completezza, sempre rappresentata dalla tavola delle categorie.
30 F. Bacon, Descriptio globi intellectualis, in The Works of Francis Bacon cit., vol. IV, pp.
31 Prolegomeni A 17; trad. it. p. 17.
32 Al posto di una rassegna dei numerosi passi in cui Kant si richiama a Hume si può citare, per la sua efficace brevità, l’affermazione che si trova nella trascrizione di una lezione di metafisica: c’è «in David Hume», afferma Kant, «qualcosa di simile alla Critica della ragione pura». Metaphysik Mrongovius (1782-1783), KGS XXIX, p. 781.
33 Un’indagine sulle metafore geografiche sarebbe assai desiderabile, e almeno per l’ambito della filosofia inglese, dovrebbe valutare anche l’importanza di Locke nel suo ruolo di mediazione tra Bacon e Hume. Un testo da prendere in considerazione sarebbe sicuramente quello, già citato da Vaihinger come possibile fonte kantiana (Commentar cit., p. 40), ovvero il capitolo introduttivo del Saggio sull’intelletto umano in cui Locke considera la necessità di un «survey of our own understandings», senza «let loose our thoughts into the vast ocean of being» o «letting their thoughts wander into those depths where they can find no sure footing». Il risultato di questo vagabondare non può essere che il perfect skepticism: «Whereas were the capacities of our understanding well considered, the extent of our knowledge once discovered, and the horizon found, which sets the boundary between the enlightened and the dark parts of things; between what is and what is not comprehensible by us, men would perhaps with less scruple acquiesce in the avow’d ignorance of the one; and employ their thoughts and discourse, with more advantage and satisfaction in the other». J. Locke, An Essay Concerning Human Understanding, I, 1, § 7; The Works of John Locke, 10 voll., London, 1823, I, pp. 5-6.
34 E. Cassirer, Kants Leben und Lehre, Berlin, 1921, p. 44; Vita e dottrina di Kant, trad. it. a cura di G. A. De Toni, Firenze, 1977, p. 52.
35 KrV B 788/A 760; trad. it., p. 750.
36 KrV B 786/A 758; trad. it., p. 749.
37 KrV B 787/A 759; trad. it., p. 750.
38 Coglie un’importante caratteristica della spazialità filosofica l’ osservazione di Giorgio Stabile riguardo al fatto che esiste una differenza tra le filosofie che possono essere rappresentate figuratamente come un puzzle, che si costruisce sempre a cominciare dai suoi limiti, cioè, anticipando la totalità, e il caso opposto, quello del meccano o del lego, in cui si procede come su un piano infinito in cui non c’è differenza tra porre i limiti e costruire. G. Stabile, La categoria dell’ubi e le sue implicazioni per il concetto di spazio nell’antichità, in Aa.Vv., Metafisica, Logica, Filosofia della natura. I termini delle categorie aristoteliche dal mondo antico all’età moderna, Atti del seminario dell’ILIESI, Roma gennaio-maggio 2003, a cura di E. Canone, La Spezia, 2004, pp. 1-11, pp. 4-5. Cfr. H. Hohenegger, Kant filosofo dell’architettonica cit., p. 92.
39 KrV B 788/A 760; trad. it., p. 750.
40 KrV B 788/A 760; trad. it., p. 750.
41 D. Hume, An Enquiry Concerning Human Understanding 1.13 (1748), in Essays Moral, Political, and Literary, a cura di T. H. Green e T. H. Grose, 2 voll., London, 1889, vol. II, p. 10; Ricerche sull’intelletto e sui principi della morale, trad. it. a cura di M. Dal Pra, Roma-Bari, 1978, p. 13.
42 D. Hume, An Enquiry cit., p. 11; trad. it., p. 15.
43 D. Hume, An Enquiry cit., pp. 12-13; trad. it., p. 18.
44 Cfr. KrV B 788/A 760; trad. it., p. 750.
45 KrV B 790/A 762; trad. it. 752.
46 KrV B 789/A 761; trad. it., p. 752, c.vo mio.
47 KrV B 795/A 767; trad. it. 756, c.vo mio.
48 KrV B 795/A 767; trad. it. 756.
49 KrV B 791/A 761; trad. it., p. 757.
50 Prolegomeni A 12; trad. it., p. 13 e § 50, A 142; trad. it., p. 193.
51 N el De dignitate et augmentis scientiarum Bacon fa un’interessante apologia di Platone: «in sua de Ideis doctrina Formas esse verum scientiae objectum», De augmentis, vol. I, p. 565; trad. it., p. 177. Il modello della conoscenza è la grammatica (Filebo 18 B-D) che impedisce la confusione dell’infinità della compositione et transpositione literarum. Per Bacon è necessario, come per Platone, cercare gli elementi che per essere non molti possono stare alla base delle «Essentias et Formas omnium substantiarum» ivi, p. 566; trad. it., p. 178. Questa esigenza di una collezione completa di elementi che forniscano le regole per l’unificazione intelligibile del sapere ricorda il kantiano Buchstabieren secondo il sistema completo delle categorie e poi sotto la funzione unificante delle idee. Si potrebbe pensare che questa istanza di completezza delle regole corrisponda all’esigenza di una sfera della ragione, ma può essere al servizio di metafisiche assai diverse, e in effetti potrebbe essere alla base anche della characteristica universalis di Leibniz.
52 «Se voglio capire qualcosa della natura, allora con la mia spiegazione non debbo uscire dalla natura. Se voglio capire la natura nel suo complesso allora debbo essere al di fuori dei suoi limiti [Grenzen]». KGS XVII, p. 375; Refl. 3980 (1769). Oppure, più in generale: «Cerco in un intelletto, che ha bisogno di regole, la conoscenza di queste stesse regole: questo è paradossale». KGS XVI, p. 28; Refl. 1592 (1764-1777).
53 KGS XV, p. 186; Refl. 451 (1772-1778).
54 KGS XVII, p. 559; R 4458 (1772). «Wir haben von der metaphysik als von einem unbekannten Lande, auf dessen Besitz wir bedacht sind, zuerst die (g Lage und) Zugänge fleißig Untersucht. (Es liegt in der (g Gegend) Halbkugel der reinen Vernunft😉 wir haben so gar den Umris davon gezogen, wo diese Insel der [Erkennt] von Erkenntnis [an das] mit dem Lande der Erfahrung durch Brücken zusammenhangt, oder wo sie durch ein tiefes Meer davon abgesondert ist; wir haben so gar den Umris davon gezeichnet und kennen gleichsam die geographie (g ichnographie) desselben, wissen aber noch nicht, was in diesem Lande, welches einige vor unbewohnbar vor menschen gehalten, andre als ihre wirkliche Niederlassung angesehen haben, angetroffen werden möge. Nach dieser allgemeinen Geographie dieses Vernunftlandes wollen wir die allgemeine Geschichte desselben in Erwegung ziehen».
55 Cfr. la citazione data per esteso supra nota n. 35. J. Locke, An Essay Concerning Human Understanding, I, 1, § 7; The Works cit., vol. I, p. 6.
56 KrV B 880-884/A 852-856; trad. it., pp. 821-824.
57 KrV B 880/A 853; trad. it., p. 821.
58 La famosa dichiarazione del debito di Kant verso Rousseau non serve solo a stabilire temporalmente quando Kant ha scoperto cosa voglia dire per lui essere filosofo, ma anche il valore del ruolo architettonico della ragione pratica, che ha la dimensione essenzialmente storica di una scoperta che l’umanità deve fare: «Io stesso sono per inclinazione un indagatore. Sento tutta la sete di conoscenza e l’avida inquietudine di progredire in essa, ma anche l’appagamento per ogni conquista. C’era un tempo in cui credevo che ciò potesse da solo costituire l’onore dell’umanità e disprezzavo il volgo che nulla sa. Rousseau mi ha messo a posto. Questo primato abbagliante scompare, imparo a onorare gli uomini e mi riterrei più inutile di un comune lavoratore se non credessi che questa considerazione possa dare a tutte le altre un valore, e realizzare i diritti dell’umanità». KGS XX, p. 44; trad it. in Bemerkungen. Note per un diario filosofico, a cura di K. Tenenbaum,Roma, 2001, p. 85. Per l’importanza architettonica della misologia roussoviana, pari solo a quella del dubbio humiano, cfr. H. Hohenegger, Kant filosofo dell’architettonica cit., p. 39 ss.
59 «La filosofia dell’ignoranza è molto utile, ma anche difficile perché deve andare fino alle fonti della conoscenza». KGS XVIII, p. 36; Refl. 4940 (1778).
60 Si comprenderà, a questo punto, che le metafore spaziali e temporali sono state qui prese in considerazione in quanto non sono pure metafore. Infatti, l’istanza sistematica (coerenza, compiutezza e interdipendenza delle parti) che è espressa sia dal mappamondo delle scienze sia dalla sfera della ragione sembra essere legata alla spazialità in modo non accidentale. Mentre l’istanza della progresso nelle conoscenze e la storicità della stessa ragione fanno riferimento alla processualità e contingenza temporale, di ciò che ha inizio e fine. Rimando alla nozione esplicitata nella voce Spazialità che Emilio Garroni ha scritto per l’Enciclopedia Einaudi (Enciclopedia, 14 voll.,Torino, 1977-1981, vol. XIII, Torino, 1981, pp. 244-272), ripresa poi nel saggio Comprendere e narrare, in E. Garroni, L’arte e l’altro dall’arte, Roma-Bari, 2003. In quest’ultimo saggio spazialità e temporalità sono opposte come condizioni formali del linguaggio, una del comprendere e l’altra del narrare. Questa distinzione non serve a classificare i testi in filosofici (o critici) e narrativi, ma a cogliere le condizioni formali sia della comprensione dell’unità di senso di un testo (e dell’esperienza correlata) sia della temporalità che, pur non essendo già contraddizione, contiene però la possibilità del non senso (non essere già da sempre, poter non essere); ovvero contiene il dover essere del senso che, in Kant, contraddistingue l’elemento noumenico, anche del sistema filosofico, come o orizzonte di senso o Aufgabe.
Lorenzo Scillitani
Spazio geografico e antropologia filosofico-sociale.
Riflessioni a partire da Kant
- La Geografia di Kant
Immanuel Kant è noto per essere stato un grande filosofo. È meno noto per essere stato uno studioso, e un docente, di geografia, all’ insegnamento della quale Kant dedicò un numero di corsi (49) maggiore di quelli dedicati all’etica (46), all’antropologia (28), alla fisica teorica (24), alla matematica (20), al diritto (16), e minore soltanto rispetto a quelli dedicati alla logica e alla metafisica (54). Dal 1756 al 1796 il pensatore di Königsberg «perse il suo tempo» (come si poté leggere nella pagina culturale di uno dei principali quotidiani italiani di qualche anno fa, che registrava con malcelato disappunto l’iniziativa editoriale di tradurre la Geografia fisica kantiana in francese)1 a insegnare una disciplina che, nelle sue dichiarate intenzioni, doveva costituire una propedeutica alla conoscenza del mondo2. Risale al 1811 l’unica traduzione italiana delle lezioni che furono raccolte dagli allievi di Kant in circa 40 anni. Oltre due secoli più tardi, è stata riproposta, in una nuova versione, sollecitata dall’edizione francese del 1999, e verificata sulla base del testo originale dell’edizione critica del 19683, l’Introduzione alla Geografia, redatta nel 1776, e autorizzata dallo stesso Kant nel 1802 (a cura di Rink)4. L’interesse a sottoporla nuovamente all’attenzione del lettore italiano è stato motivato non tanto da una mera curiosità storico-filologica quanto dall’attualità di una urgenza scientifico-culturale e insieme formativa, che merita di trovare appropriati canali e modalità di espressione. Si tratta infatti di riscoprire la portata innovativa della lettura kantiana della geografia, a livello sia speculativo sia didattico.
A livello conoscitivo, il contributo della geografia nell’istruire la ragione è dettato dalla sua capacità di attingere dall’esperienza gli elementi che formano le fonti della conoscenza del mondo, come Kant ha cura di rilevare proprio nella sua Introduzione, di carattere propedeutico piuttosto che enciclopedico. Questa attitudine, che la geografia condivide con l’antropologia5, impegnata a elaborare la conoscenza degli uomini, alimenta per Kant la vera filosofia, la quale «consiste nel seguire la diversità e la varietà di una cosa attraverso tutte le epoche» 6. Diversità e varietà sono le caratteristiche di prima evidenza, e di prima approssimazione, che la moderna antropologia culturale coglie nei fenomeni dei quali si occupa. Il Kant professore di geografia, e geo-filosofo7 ante litteram, ritiene di poter individuare nella geografia (intesa nella sua valenza descrittiva e rappresentativa di luoghi, terre e mari, e dei loro confini, proiettati in uno scritto) un fattore decisivo di identificazione di elementi conoscitivi che si mostrano già carichi di significati filosofici.
A livello pedagogico, Kant si fa consapevole promotore, oltre che originale interprete, di una disciplina destinata ad attivare negli allievi l’interesse a formarsi una idea di prima approssimazione di che cos’è e di come è fatto realmente il mondo nel quale vivono: a titolo fortemente esemplificativo, la lettura dei giornali implica, secondo Kant, una nozione estesa della superficie terrestre, alla quale soltanto la geografia può dare forma e rilievo specifici. La globalizzazione, prefigurata dal pensatore tedesco nei termini di un cosmopolitismo8 al quale l’umanità tenderebbe per il semplice fatto di abitare un pianeta di forma sferica che avvicina gli uomini tra di loro, è un fenomeno che presuppone l’acquisizione di dimensioni eminentemente geografiche dello spazio9, e come tale si connota intensamente per i suoi aspetti geo-politici e geo-economici. In tal senso, quando Kant riconosce che è la geografia a fondare la storia, «poiché gli avvenimenti debbono pure rapportarsi a qualcosa»10, evoca il potenziale esplicativo, e insieme educativo, di un primato – o comunque di una specificità – della geografia, in quanto scienza a un tempo fisica, matematica, morale (declinata in un linguaggio dell’epoca che recepiva l’istanza di una sorta di geografia dei costumi, oggi declinabile magari in antropologia geografica11, o in geografia culturale), politica, economica, letteraria, religiosa: ovvero scienza della natura e al contempo, in senso prettamente umanistico, scienza della cultura, della società, del diritto. Occidente, Oriente, Nord, Sud, Europa, prima di essere categorie politico-culturali storicamente determinate, corrispondono a espressioni specificamente geografiche, legate a coordinate e a conformazioni ambientali che in quanto tali vanno studiate e pensate, nel presupposto che lo stesso pensiero, filosofico e scientifico, è portatore di una esigenza di orientamento che lo stesso Kant ha avuto cura di evidenziare12.
Orientarsi nell’estensione, e nella profondità, geospaziale del paesaggio umano è il compito che l’Introduzione alla geografia di Kant si è assunto, e che vale la pena riprendere, nella prospettiva di una più articolata rivitalizzazione, come di una più efficace ricollocazione, di una disciplina ingiustamente negletta, che oggi più che mai si impone come necessaria e imprescindibile, e quindi in tutti i sensi utile, per un sapere umanistico e scientifico integrato nei suoi molteplici aspetti epistemologici e metodologici. 224
- Fattori geografici e dimensioni storiche di una antropologia giuridico-politica filosoficamente orientata
Dalla ripresa del Kant speculativamente (a torto) considerato “minore”, ma a pieno titolo (almeno pedagogicamente) “maggiore”, delle lezioni sulla geografia si può essere autorizzati a trarre alcune deduzioni, relativamente all’elaborazione delle linee di una antropologia sociale filosoficamente impostata, e orientata in senso giuridico e politico.
Ogni pensiero filosofico, in quanto storicamente e culturalmente determinato, è anzitutto geograficamente collocato: geo- linguisticamente localizzato, dimensionato e condizionato. Il pensiero greco, ad esempio, veicolato dalla lingua greca, corrisponde a una latitudine prossima al pensiero degli statisti e giuristi romani (per riprendere una sintetica definizione di Jaspers), veicolato dalla lingua latina, ma ne resta, in via più o meno accentuata, distinto. Esso resta greco anche quando, a tratti, riappaia in pensatori che greci in senso anagrafico non sono, come per esempio Heidegger. Analoga impronta non sembra, a livello filosofico, essere ravvisabile in autori cronogeograficamente riconducibili all’ epoca in cui Roma ha dettato la sua legge al mondo euro-mediterraneo. Di nessun pensatore si dice che sia espressione di un modo filosoficamente latino di pensare13. Il pensiero canonizzato come occidentale è, a sua volta, per definizione ambientato in un contesto che lo qualifica in base ad una determinazione geografica, quali sono i punti cardinali. Ma altrettale discorso può farsi per il pensiero europeo in generale 14?
L’incertezza nell’individuare fonti geografiche del filosofare, come nel caso della Magna Graecia, geograficamente situata nell’Italia meridionale costiera, potrebbe peraltro far propendere – come in effetti è troppo spesso accaduto – per un sottodimensionamento dell’elemento geografico, anticamera di una sua sottovalutazione. Ma la problematicità legata all’enucleazione delle coordinate geografiche del formarsi di una civiltà, anche in senso filosofico, lungi dall’essere di ostacolo all’approfondimento del tema in discussione, potrebbe rivelarsi una insospettata risorsa. Si è dovuto aspettare che non un filosofo dichiarato ma un antropologo, come Claude Lévi-Strauss, distribuisse i libri della sua biblioteca personale sulla base dell’ appartenenza dei loro autori, o dei temi trattativi, alle varie zone geografiche della Terra, perché ci si rendesse conto della portata decisiva che il punto di riferimento spazialmente individuato sviluppa accanto ai consueti punti di riferimento storico-evolutivi, largamente prevalenti nell’organizzazione delle enciclopedie piuttosto che nelle trattazioni sistematiche di carattere umanistico o scientifico. Il tentativo di riprodurre in un microcosmo domestico il macrocosmo terrestre delle culture umane riflette la struttura stessa dell’universo delle civiltà, dei popoli, delle lingue, che si dà come un universo geografico.
Certo, la geografia non è solo cartografia. Per estensione, non abusiva, dei significati connessi al termine qui in esame, tutto ciò che è mappatura (si pensi alla mappatura del genoma) procede da un modo di immaginare, percepire, pensare la realtà su di una superficie abitata da significati rappresentabili secondo dimensioni di estensione, e di profondità, e di relative angolature, che non si risolvono in determinanti storico-temporali. La chiave di lettura geografica dei fenomeni culturali consente di attivare la percezione delle loro costanti, trans-storiche e trans-culturali, che un’ottica puntata sulla Storia tende fatalmente a eludere. Ciò sembrerebbe possibile in virtù della peculiare attitudine della geografia, che è scienza dell’uomo e al tempo stesso della natura, a fornire una descrizione di fenomeni naturali suscettibili di essere letti alla luce di leggi fisiche, matematiche. La sovradeterminazione (para) storicistica dei fenomeni culturali ha oscurato le caratteristiche e le risorse di questa attitudine, che mette in condizione di legare la particolarità di un fenomeno a leggi generali.
L’esperienza giuridica, a questo riguardo, offre un interessante piano di riscontro: nei limiti in cui registra e realizza un accesso al mondo degli oggetti – per esempio i beni, oggetto di possesso o di proprietà – che corrispondono a dati di fatto in una certa misura incontrovertibili (quel suolo, come pure quella cosa mobile), essa condivide con la geografia il rispetto dell’elemento naturale nella sua particolarità, generalizzata sotto forma di legge. La stessa esperienza politica, nei termini in cui comporta una qualche sia pur approssimativa corrispondenza tra grandezze di ordine fisico (isole, penisole, spazi delimitati da corsi d’acqua o da barriere naturali), è indice di elementi non interamente storicizzabili: una nazione procede da un atto di nascita certificabile in riferimento a una localizzabilità più o meno precisa, spesso di ascendenza ancestrale. I popoli nomadi, semi-nomadi o stanziali sono qualificati come tali sulla base di un riferimento, meno o più definito, allo spazio geografico nel quale si muovono, o viceversa si radicano. Un’entità etnica non può inventarsi per un atto arbitrario, perché non può prescindere dalle pianure, dalle foreste, dai monti nei quali si è forgiato il suo primo prender forma. Non si sottrae a questa valenza in qualche maniera nomo-grafica della geografia neppure l’esperienza economica, a misura che procede dalla raccolta e dalla selezione di materiali relativi a risorse del suolo, o del sottosuolo, che costituiscono la materia della gestione e dello sviluppo stesso dell’economia.
Qualcosa come una statica sociale15, risultando intrinseca al complesso dell’esperienza sociale umana in generale, almeno nelle sue declinazioni giuridica, politica, economica (per tacere della sacrale-religiosa), si mostra quindi caratterizzata dall’incidere essenziale di fattori non riducibili alla storicità dei fenomeni culturali. Nella prospettiva di una statica sociale ampiamente documentata dalle ricerche antropologico-culturali, può articolarsi una fenomenologia di tutti quegli aspetti della socialità umana che non si risolvono in sequenze di eventi o di epoche. Tutto ciò che è rito, costume, uso, tradizione introduce una dimensione ciclico-ripetitiva nel flusso temporale, determinando una scansione degli avvenimenti che rispecchia il succedersi delle stagioni. Lì dove la Storia concentra, fino al dettaglio, bruciando le possibilità che non si dischiusero nell’episodicità di un evento, la geografia dilata, perché custodisce la necessità sulla base della quale nuovi mondi e nuove forme di vita possono emergere: sulla superficie terrestre può costruirsi una civiltà, che poi decade fino a ridursi in macerie, ma il fondo tellurico che l’ha vista sorgere, crescere e infine declinare resta. E le radici di quell’albero penetrano in inesplorate profondità, che forse solo una geografia dell’inconscio potrebbe sondare.
In quanto stratigrafia, la geografia sta lì a ricordare, a significare, che il volere e il potere umani incontrano un limite: in questo senso, la geografia dà una costante lezione di realismo. Il viaggio che essa apre è un percorso attraverso luoghi, della natura e dello spirito, che, nella loro costitutiva dimensione di realtà, impediscono all’esistenza umana storica – quale viaggio nel tempo – di percepirsi come un fluttuare abbandonato al caso. In quest’ottica, la geografia ridà senso e significato a un Paese che sia anche, o meglio in primo luogo, una patria rispetto alla quale anche il senza patria trovi posto, ovvero ritrovi la sua dignità, e le sue prerogative, di cittadino. Un non-luogo16, in tal senso, restando una pura ipotesi, si annuncia come il prodotto di una pretesa storicistica assoluta di prescindere dal dato di fatto geografico, nella supposizione, tutta da verificare, che l’uomo sia in ultima analisi cultura, e non anche natura. Invero, nella misura in cui la geografia umana reca le tracce, talora monumentali, di passaggi al limite, non solo tra natura e cultura, ma anche tra queste e la sopranatura, non si dà genuina geografia fisica che non si atteggi, in qualche modo, a geografia metafisica, ipotizzabile ove si consideri che l’anima di certi luoghi fa da punto di orientamento di culti, scelte, decisioni, talora di forte valenza politica (si pensi alle “terre sante”, o promesse, per le quali, talvolta metro dopo metro, ancor oggi si lotta senza tregua).
L’abitare stesso (in senso heideggeriano), del resto, è sempre stato – come dimorare – un fenomeno strettamente legato ad aspetti sia materiali sia immateriali, o spirituali in senso lato: la sacralità di una sorgente, o di una montagna, rende l’idea di una geo-metafisica nella quale il pensiero umano si trova impegnato fin dai primordi. I riti di sepoltura simboleggiano, in particolare, la riassunzione nel grembo materno ctonio di un essere che pure se ne è staccato per vincere, quando non per tentare di annullare le stesse distanze spaziali (come nell’esperienza della ipertelecomunicazione odierna). A questa postura metafisica della geografia non è estranea la stessa categoria estetica di bellezza, che ritrae proprio dal naturale (bellezza naturale) la fecondità di canoni consacrati nella grande arte, in particolare quella figurativa.
Una antropologia filosofica non può pertanto evitare di considerare l’uomo come ente che descrive la terra, che scrive sulla terra, e con la terra, ma con ec-centramento dalla terra che lo rende ultimamente sovraterrestre nelle sue conclamate manifestazioni di ordine spirituale. Non sarebbe attestazione dell’umano una geografia che non fosse capace di ricomprendere nel suo ambito la posizione singolarmente eccezionale dell’uomo: anzi, che si dia qualcosa come una geografia sta ad indicare che vi è all’opera un soggetto di pensieri e di atti che ha bisogno, per ri-trovarsi, proprio del dimensionamento e della strutturazione geografici, quali ad esempio si evidenziano nella matrice geo-mitica dell’identità dei popoli senza scrittura17.
L’integrazione dell’antropologia con la geografia rende possibile la formulazione di un sapere che metta a tema le componenti naturali (biologiche e geografiche) dell’umano, rinviandole a un livello nel quale si produce una pre-comprensione di strutture portanti dei processi culturali e sociali, ivi compresi quelli attinenti all’etica, al diritto, alla politica, all’economia, alla religione. Se è vero che l’uomo è un ente storico, nel senso che la sua esistenza si concepisce come eminentemente storico-culturale, in divenire, è altrettanto vero che è inseparabile dall’autorappresentazione individuale e collettiva dell’uomo la dimensione geo-naturale, che attesta il suo essere-nel-mondo come essere in un mondo, sotto quel cielo.
Una antropologia filosofico-sociale (nel senso, comprensivo, di filosofico-giuridica e filosofico-politica) è tanto più avvertita di questa necessaria integrazione quanto più assume a tema delle sue analisi e delle sue interpretazioni l’insieme del fenomeno sociale umano: sia come storia sia come geografia del sociale. Le conoscenze che l’antropologia culturale, con la paleontologia, ha acquisito ci mettono in condizione di confrontarci con una durata della specie umana rispetto alla quale la fase assunta come storica corrisponde a un lasso di tempo minimo, estremamente significativo per i contemporanei, ma trascurabile se rapportato all’intero arco temporale dell’esistenza del genere umano sulla faccia della terra. Il complesso della vicenda umana richiede un approccio geo-sociale di portata esplicativa almeno pari a quella tradizionalmente sviluppata dall’approccio storico-sociale. Ne va della possibilità stessa di intendere umanisticamente il fenomeno umano, superando l’equivoco di scambiare la Storia per una scienza. Se proprio di scienza umana deve trattarsi, questa deve farsi carico di tutti gli elementi fondamentali che richiedono di essere conosciuti, e valutati. La temporalizzazione dell’elemento umano non può fare a meno di reagire sul piano nel quale, prima di qualsiasi “progetto” o di qualsiasi “costruzione”, l’uomo si dà a conoscere: come un essere-nello-spazio18.
La rappresentazione della socialità umana di base come una rete di relazioni che si inscrivono in filiazioni (livello giuridico-familiare) e in alleanze (livello politico) richiede, per essere elaborata filosoficamente, una lettura antropologico-sociale che filtra una vera e propria geografia sociale, non metaforica ma reale come possono essere reali i simboli che la esprimono, su di un piano mitico-fondativo che l’antropologia strutturale di Lévi-Strauss ha tradotto in formule di precisione geometrica. La rappresentazione del sociale, presso l’umanità di tutte le latitudini geoculturali, ha preso inizialmente la forma di una planimetria, ovvero di un disegno dello spazio relazionale (tra individui e tra gruppi) che ha preceduto qualsiasi progetto di edificazione puntato su traguardi storici. In questo senso – nella ricostruzione di un percorso, e con un filo logico, che da Kant giunge a Lévi-Strauss – la geografia ha preceduto e fondato la Storia, costituendo la pre-condizione di qualsiasi formazione storico-umana. Se dunque di un primato si tratta, questo primato è documentabile antropologicamente, prima di potere, e di dovere, essere filosoficamente argomentabile.
Una prima implicazione del primato quanto meno fenomenologico (se non proprio ipotizzabile come onto-fenomenologico) dell’elemento geo-umano sta nell’ipotizzare la preesistenza della geo-strutturazione delle forme associative umane rispetto all’articolazione dialettica che mette in moto i processi registrabili come storici. Una seconda implicazione sta nel congetturare che la geostrutturazione del tessuto socio-umano di base precorre, prefigura e preforma il cristallizzarsi di determinati processi in istituzioni, le quali si danno già come stabilizzazione, più o meno duratura, di una dinamica sociale19. La stessa tendenza inerziale delle istituzioni umane a durare nel tempo, malgrado contraddizioni e contestazioni di vario genere, riflette un ancoraggio meta-storico, che ritrae dalla geografia, lato sensu intesa, cioè terrestre, ctonia, cosmica, le immagini che veicolano i significati di saldezza, sicurezza, perennità. È vero che l’orografia e la stessa topografia sono soggette a mutamenti, ma generalmente nel lungo, anzi lunghissimo periodo: la persistenza dei caratteri salienti della conformazione di un territorio, della dolcezza o della durezza delle sue condizioni climatiche, offrono la prima modalità di espressione di un’invarianza categoriale, la quale si traduce in strutture fondamentali che, resistendo al mutamento, rendono al tempo stesso possibile la tensione dialettica da cui si sprigionano le forze che portano a superare, in parte o in tutto, le forme istituzionali consolidate. Il conflitto, da interpretare, in questa prospettiva, quale espressione più intensa del dinamismo sociale, generatore di Storia, deve il suo sorgere alla solida resistenza che gli oppone la spessa coltre del suolo che esige di essere curato, conservato e perpetuato, prima di essere magari sfruttato.
Il substrato geo-socio-grafico della statica sociale, che si annuncia quale fattore di comunicazione e di coordinazione tra individui, maschili e femminili, e tra gruppi di individui, corrisponde alla spazializzazione di questi rapporti, traducendosi in geografia giuridica delle parentele e delle filiazioni, e in geografia politica delle alleanze. La pre-incidenza dell’elemento geografico così declinato, sul piano giuridico-e-politico, relativizza il dato storico a punti di riferimento, a veri e propri assi cardinali non suscettibili di ulteriore dialettizzazione: i rilievi possono essere spianati, i passi possono essere attraversati, le rive dei fiumi possono essere collegate da ponti, uomini e donne possono simbolizzare in molteplici maniere le loro differenze, fin quasi a sovvertirle, ma il cambiamento di una situazione geografica, o di una geo-istituzionale, sarà sempre relativo a una permanenza, comunque percepita o elaborata, o anche semplicemente sottintesa. La dis-continuità del mondo umano storico rispetto a quello naturale non è assoluta proprio perché quel mondo resta mondo, cioè uno spazio che dipende da un orizzonte non ulteriormente superabile, anche quando venga proiettato nella dimensione ultra-mondana della sopranatura.
Le nominazioni di parentela, inquadrate nei sei sistemi di parentela a tutt’oggi noti20, formano l’atlante geografico dei sistemi sociali di base, che a loro volta costituiscono l’ordito attorno al quale vengono a strutturarsi gli insiemi sociali degli altri aggregati umani rilevanti sui piani geografico (dal villaggio ai nuclei abitativi più complessi), geo-sociologico (dalla famiglia al clan alla tribù), geo-antropologico (gruppi umani etnicamente o linguisticamente identificabili). Al pari di un atlante storico, che ripercorre le diverse fasi di sviluppo delle civiltà umane, la carta geografica delle nomenclature di parentela offre un quadro sufficientemente illustrativo di che cosa significa una statica sociale, tema di una scienza antropologica piuttosto che di una storia sociale, impegnata con la storia della famiglia, e delle unità sociali più estese, con specifico riguardo ai rapporti di sovraordinazione/subordinazione che innescano la dinamica sociale dei rapporti di forza e di potere.
Il punto è che, finora, la fenomenologia filosofica dei principi di messa in forma dell’archeo-socialità umana è stata pressoché interamente assorbita dalla rappresentazione storico-dialettica delle dinamiche, evitando di sostare nel riconoscimento che i principi di organizzazione della socialità umana dipendono da assi geo-antropologicamente pre-ordinati: sistemi elementari socio-familiari-parentali strutturati già attorno a categorie giuridiche. Una presa d’atto, e di coscienza, di segno filosofico dovrebbe partire dall’acquisizione che, se il politico vanta sicuramente un primato a livello storico-storiografico, il giuridico può vantare un primato a livello antropo-geografico. Una geografia filosofica, anche nelle sue declinazioni filosofico-giuridica e filosofico-politica, capace di restituire allo spazio tutto lo spessore ermeneutico che il primato attribuito al tempo storico gli ha sottratto, potrebbe in tal senso offrire un utile contributo introduttivo all’elaborazione di una complessiva antropologia filosofica della socialità umana.
Con la globalizzazione21, inaugurata da tesi sulla fine della Storia che, attualizzando la lezione hegeliana22, sembravano aver “fermato” il tempo, lo spazio annunciava di essersi ripreso le sue prerogative: la controtendenza storico-politologica alla focalizzazione degli scontri di civiltà23, pur rimettendo in gioco una filosofia della cultura imperniata su categorie temporali ben definite, ha peraltro mostrato che, al di là di geo-localismi più o meno accentuati, mai come oggi la politica dipende dalla geografia, della terra ma, forse oggi più che mai, anche del mare24. Perché, in una certa misura, è la stessa Storia a dipendere dalla geografia, sia questa intesa in senso strettamente scientifico, sia questa reinterpretata come geografia filosofico-sociale, indice di un significativo nesso di dipendenza della stessa geopolitica da un geo-diritto25 tutto da indagare, e da interrogare e approfondire nelle sue possibili valenze teoretiche.
Note
1 I. KANT, Géographie, trad. fr. a cura di M. Cohen-Halimi, M. Marcuzzi e V. Seroussi, Aubier, Paris 1999. Per una prima presa di contatto con questa edizione francese si rinvia alla lettura di I. LABOULAIS-LESAGE, La Géographie de Kant, in “Revue d’Histoire des Sciences Humaines”, 2 (1/2000), pp. 147-153.
2 A Kant (il quale dimostrava in tal modo quanto prendesse sul serio l’ampliamento del proprio modo di pensare; cfr. H. ARENDT, Teoria del giudizio politico, trad. it. P.P. Portinaro, il Melangolo, Genova 2005, p. 70) si deve di essere stato il primo filosofo a impartire corsi universitari di geografia, ancor prima dell’assegnazione della prima cattedra di geografia a Carl Ritter (Berlino, 1820; cfr. M. MARCUZZI, Introduction a I. KANT, Géographie, ed. cit., p. 11). Sulla geografia kantianamente intesa quale propedeutica alla scienza e alla vita si rinvia in particolare a A.-L. SANGUIN, Redécouvrir la pensée géographique de Kant, in “Annales de Géographie”, 576 (1994), p. 144. 222
3 Il Corso di Physische Geographie è stato pubblicato nel 1902 dall’Accademia prussiana delle Scienze, ed editato nel tomo IX, pp. 151-436, dei Kants Werke. Logik, Physische Geographie, Pädagogik (de Gruyter, Berlin 1968).
4 La versione italiana della Einleitung kantiana della quale trattasi, curata da L. Scillitani con la collaborazione di S. Nienhaus, è stata pubblicata, col titolo Geografia fisica, in A. LANDOLFI (a cura di), Geografia: dalla ricerca alla didattica. Due autori a confronto, Università degli Studi del Molise, Campobasso 2013, pp. 21-30.
5 Cfr. I. KANT, Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, F. Nicolovius, Königsberg 1798; trad. it. G. Vidari e A. Guerra, Antropologia pragmatica, Laterza, Roma-Bari 1985. Se la conoscenza del mondo «ha lo stesso significato di antropologia pragmatica (conoscenza degli uomini)» (M. HEIDEGGER, Vom Wesen des Grundes, Klostermann, Frankfurt a.M. 1955, p. 31; trad. it. P. Chiodi, L’essenza del fondamento, in ID., Essere e tempo – L’essenza del fondamento, Utet, Torino 1978, p. 655), proprio dalla conoscenza del mondo che si esprime nella geografia fisica «sorgeranno quegli interrogativi che spingeranno Kant ad impostare un autonomo corso di antropologia, dopo aver preparato un testo (Urtext) nel 1759 di geografia ed aver ampliato il campo di indagine della geografia stessa, che dev’essere anche morale e politica oltre che fisica» (I.F. BALDO, Kant e la ricerca antropologica, in AA.VV., Il problema dell’antropologia, Editrice Gregoriana, Padova 1980, p. 75).
6 I. KANT, Geografia fisica, ed. cit., p. 27.
7 La geofilosofia alla Deleuze o alla Cacciari non ha tuttavia a che vedere con l’orizzonte al quale l’approccio kantiano rinvia. Piuttosto valgono, in questa sede, le riflessioni di O. DEKENS, D’un point de vue géographique sur la philosophie kantienne, in “Revue de Métaphysique et de Morale”, 2 (1998), pp. 269-272. In ogni caso, per un ampliamento geofilosofico della tematica qui trattata si rinvia, oltre che ai testi consultabili nel sito http://www.geofilosofia.it, a L. BONESIO-C. RESTA, Intervista sulla Geofilosofia, a cura di R. Gardenal, Diabasis, Reggio Emilia 2010; L. BONESIO, Geofilosofia del paesaggio, Mimesis, Milano 20012; ID., Oltre il paesaggio. I luoghi tra estetica e geofilosofia, Arianna, Casalecchio 2002; ID., Paesaggio, identità e comunità tra locale e globale, Diabasis, Reggio Emilia 2007; A. BERQUE, Médiance de milieux en paysages, Belin, Paris 1990; ID., Être humains sur la Terre, Gallimard, Paris 1996; I., Ecoumène: introduction à l’étude des milieux humains, Belin, Paris 2009; F. FARINELLI, Geografia. Un’introduzione ai modelli del mondo, Einaudi, Torino 2003; ID., La crisi della ragione cartografica, Einaudi, Torino 2009; ID., L’invenzione della Terra, Sellerio, Palermo 2007.
8 Attirano l’attenzione sul nesso essenziale tra geografia e cosmopolitismo in Kant le considerazioni di J.-M. BESSE, La philosophie et la géographie, in Encyclopédie Philosophique Universelle, diretta da J.-F. Mattéi, PUF, Paris 1998, p. 2553.
9 Su di una prima configurazione del tema dello spazio in Kant si veda, di questo, Von dem ersten Grunde des Unterschiedes der Gegenden im Raume, in “Königsberger Trag- und Anzeigungsnachrichten”, 6-8 (1768); trad. it. R. Assunto, R. Hohenemser e A. Pupi, Sul primo fondamento della distinzione delle regioni nello spazio, in ID., Scritti precritici, Laterza, Roma-Bari 2000, pp. 409-418.
10 I. KANT, Geografia fisica, ed. cit., p. 27.
11 Sulla natura pragmatica della geografia kantiana attira l’attenzione M. TANCA, Geografia e filosofia, Franco Angeli, Milano 2012, p. 40.
12 Cfr. I. KANT, Was heisst sich im Denken orienieren?, in ID., Gesammelte Schriften, de Gruyter, Berlin-Leipzig 1902; trad. it. P. Dal Santo, Che cosa significa orientarsi nel pensiero, a cura di F. Volpi, Adelphi, Milano 1996.
13 Per una diversa lettura del tema cfr. però S. MASO, Filosofia a Roma. Dalla riflessione sui principi all’arte della vita, Carocci, Roma 2012.
14 Cfr. R.B. ONIANS, Le origini del pensiero europeo, trad. it. P. Zaninoni, a cura di L. Perilli, Adelphi, Milano 1998.
15 Per quanto desueta nell’omologo significato di “sociologia statica” (cfr. L. GALLINO, Statica sociale, in Dizionario di sociologia, Istituto Geografico De Agostini, Novara 2006, vol. 2, pp. 476-478), questa espressione meriterebbe di essere rivisitata, al di là di riduzionismi sociologici, in sede specificamente antropologico-filosofica. 226
16 Cfr. M. AUGÉ, Nonluoghi. Introduzione a una antropologia della surmodernità, trad. it. D. Rolland e C. Milani, Elèuthera, Milano 2009.
17 Circa gli itinerari del sogno presso gli Aborigeni australiani studiati da Freud, sulla base delle ricerche di James Frazer, cfr. B. GLOWCZEWSKI, Du rêve à la loi chez les Aborigènes, PUF, Paris 1991.
18 A una meditazione complessiva, in chiave fenomenologica, sulle componenti simboliche di questo dimensionamento antropo-geografico rimanda la lettura di E. DARDEL, L’uomo e la terra. Natura della realtà geografica, trad. it. C. Copeta, Unicopli, Milano 1986, sul quale vedasi C. COPETA, Il mio incontro con Dardel (ovvero perché sono geografa!), in E. DARDEL, L’uomo e la terra, ed. cit., pp. 201-223. Più in generale, sul tema della spazialità, si rinvia alla omonima voce dell’Enciclopedia Einaudi (Torino 1981, vol. 13, pp. 244-272), redatta da E. GARRONI.
19 Per la dinamica sociale, o sociologia dinamica, vale quanto detto supra, nella n. 14, a proposito della statica sociale (cfr. L. GALLINO, Dinamica sociale, in Dizionario di sociologia, ed. cit., vol. 1, pp. 414-417).
20 L’elenco formato dagli etnologi annovera i seguenti sei sistemi: eschimese, hawaiiano, irochese, crow, omaha, sudanese. Su questo impianto le società umane strutturano il loro assetto in quanto reti di parentele.
21 Sulla difficoltà di definire i processi di globalizzazione nella prospettiva della de-territorializzazione, cfr. in particolare S. SASSEN, Né globale, né nazionale; la terza dimensione dello spazio nel mondo contemporaneo, in “il Mulino”, 6 (2008), pp. 969-979.
22 Cfr. F. FUKUYAMA, La fine della storia e l’ultimo uomo, trad. it. D. Ceni, Rizzoli, Milano 1992. Più in generale sui rapporti fra geografia e Storia in Hegel si rinvia a P. ROSSI, Storia universale e geografia in Hegel, Sansoni, Firenze 1975. Peraltro, nella misura in cui i Fukuyama o gli Huntington continuano, insieme con molti altri, a porsi il problema della definizione del ruolo dello spazio e dei fattori geografici nella Storia mondiale nei termini delle forme di vita politica che coincidono con Stati, si è portati, almeno in questo senso, ad essere ancora hegeliani (cfr. M. TANCA, Geografia e filosofia, ed. cit., pp. 74-75).
23 Cfr. S.P. HUNTINGTON, Lo scontro di civiltà?, trad. it. S. Pighini, in ID., Ordine politico e scontro di civiltà, a cura di G. Pasquino, il Mulino, Bologna 2013, pp. 273-301.
24 F. ROSENZWEIG, Globus. Studien zur weltgeschichtlichen Raumlehre, in ID., Der Mensch und sein Werk. Gesammelte Schriften, vol. III: Zweistromland. Kleinere Schriften zu Glauben und Denken, Martinus Nijhoff, Dordrecht-Boston-Lancaster 1984, p. 348; trad. it. S. Carretti, Globus. Per una teoria storico-universale dello spazio, a cura di F.P. Ciglia, Marietti 1820, Genova-Milano 2007, p. 83. Sulle “vendette” che la geografia, ogni tanto, si prende sulla politica – da Napoleone a Hitler, fino ai nostri giorni –, può essere illuminante la lettura di R. KAPLAN, The Revenge of Geography, in “Foreign Policy”, maggio/giugno 2009.
25 Sui significati e sull’uso di questo neologismo si rinvia agli esordi sull’argomento in N. IRTI, Geo-diritto, in “Rivista trimestrale di diritto e procedura civile”, 1 (2005), pp. 21-37.
© SpazioFilosofico 2014 – ISSN: 2038-6788
Kant grande geografo
La traduzione della Geografia fisica di Kant impegnò August Eckerlin a lungo: i sei volumi vennero pubblicati in successione tra il 1807 e il 1811.
Come apparve subito chiaro, si trattava di un lavoro importante, ma privo di uno sforzo di sistematizzazione che avrebbe potuto e dovuto facilitarne la lettura e la consultazione. Questo è poi il motivo principale per il quale all’edizione Vollmer (su cui si basò Eckerlin per la traduzione italiana) si è sempre poi preferita in seguito quella, più snella, curata da Theodor Rink. Per tutte le questioni annesse alla vicenda editoriale si può ora vedere il vol. 26.1 delle Kant’s gesammelte Schriften che contiene le lezioni sulla geografia fisica curate da Werner Stark in collaborazione con Reinhard Brandt (Berlin-New York, de Gruyter, 2009).
Nel 1816 Lorenzo Nesi, abate toscano all’epoca impegnato a Milano in attività di insegnamento, pubblica una Storia fisica della terra espressamente compilata «sulle tracce della Geografia fisica di Kant», con l’intento dichiarato di procedere a una riorganizzazione delle sparse osservazioni ricavate dagli appunti degli studenti proposte nell’edizione Vollmer.
Il più conosciuto fra i moderni, che siasi esclusivamente occupato di questa scienza importante, è stato il Sig. Kant, Professore celeberrimo dell’Università di Koënisberga, che tanto onore ha procurato al Secolo XVIII, alla repubblica letteraria, ed alla dotta sua patria. Se in quest’opera fosse egli stato meno ambizioso d’originalità, e più ordinato nella distribuzione delle materie, potrebbe questa a ragione riguardarsi come l’unica classica in questo genere, poichè nè i Malthebrun, nè i Pinkerton, nè i Guthrie hanno avuto campo di dare nelle loro Geografie Universali un competente sviluppo a questa parte, che di tutte è forse la più interessante, come la più dilettevole (vol. I, p. 6).
Lo scopo di Nesi è quello di liberare l’opera di Kant delle cose superflue, delle ipotesi azzardate, di accorciarla e armonizzarne le parti.
L’opera di Nesi venne pubblicata in due volumi: il primo nel 1816 presso l’editore Baret di Milano, il secondo nel 1817 presso l’editore Buccinelli, sempre di Milano.
Di questo curioso tentativo di rimaneggiamento della traduzione della Geografia fisica non v’è traccia in nessuna delle discussioni sul tema che da noi conosciute, né ci sembra sia mai citato (anche soltanto come curiosità) nelle bibliografie specialistiche.
Pertanto, se non andiamo errati, questa è la prima volta che si fa menzione di questo testo, la cui articolazione ricorda certamente la Geografia fisica di Kant, in rapporto alla storia della fortuna testuale di Kant in Italia.
Geografia e antropologia
Nel 1843, cioè trentasei anni dopo l’uscita del primo volume della Geografia fisica, l’editore milanese Giovanni Silvestri dà alle stampe un ausilio all’opera di Kant che Augusto Eckerlin aveva tradotto e pubblicato per lui tra il 1807 e il 1881 in sei volumi.
Si tratta di un dizionario che ordina alfabeticamente una serie di voci tratte dall’opera maggiore di Kant e che sostituisce l’indice analitico che Eckerlin non aveva accompagnato alla sua edizione e che molti avevano lamentato come mancanza grave. In effetti, la mole della Geografia fisica e, soprattutto, la vastità delle materie esposte richiedevano uno strumento di guida che consentisse di orientarsi in quella selva di dati e di notizie.
La geografia per Kant non si limitava alla fisica in quanto tale, benché tutte le cognizioni note sulla formazione della terra, dei mari, dei ghiacci e via dicendo fossero presentate in maniera più o meno sistematica. La geografia è, per Kant, principalmente una forma di conoscenza del mondo umano, un criterio di ordinamento delle caratteristiche antropologiche che devono poter essere descritte per ottenere un’immagine effettivamente cosmopolitica dell’uomo e del suo ambiente.
Questa prospettiva pragmatica era stata anche considerata negativamente da qualche recensore italiano, che riteneva del tutto improprio parlare delle situazioni concrete dei commerci, degli assetti politici e via dicendo all’interno di un trattato di geografia. Ma è invece proprio questa la caratteristica essenziale e, in qualche modo, innovativa dell’opera di Kant. La quale, in ogni caso, venendo diffusa in Italia in un’epoca fortemente segnata da trasformazioni politiche, poteva soccorrere la necessaria spinta propulsiva in avanti delle cognizioni tecniche. Non è un caso che, già a partire dalla stagione delle riforme settecentesche, in campo editoriale si facessero diversi sforzi per proporre un ampliamento della conoscenza della geografia, sforzi che vennero poi crescendo in età napoleonica e poi nella prima metà dell’Ottocento. La letteratura e la manualistica di settore in quest’epoca cresce in modo progressivo e porta alla traduzioni in italiano di altri manuali tedeschi di questo genere.
Quello kantiano è caratteristico e risulta ancora oggi un apax nell’attività dei filosofi, che caso mai tra fine Settecento e inizio Ottocento preferiscono indugiare sulla storia, attraverso prospettive universalistiche o sistematiche (da Herder a Hegel, per intendersi).
Il Manuale di geografia fisica è un altro esempio della particolare direzione che assume in Italia l’irradiazione di Kant, la cui attività antropologica è vista con molto interesse e talvolta con quel favore che non si poteva concedere al suo criticismo. Basti pensare che la cosiddetta macrobiotica di Kant, vale a dire le regole per il controllo spirituale degli stati patologici del corpo (il terzo saggio che compone il Conflitto delle facoltà) venne tradotto in italiano sia nella prima parte dell’Ottocento, sia nel clima positivistico di fine secolo.
Tra storia naturale e etnografia. La geografia kantiana
Kant tenne lezioni sulla Geografia fisica fino al Sommerse-mester del 1796: aveva cominciato quarant’anni prima, nel 1756. Il corso non era basato su un manuale, come richiesto poi dai regolamenti universitari, ma elaborato personalmente. E questo, come opportunamente fa notare Werner Stark nella prefazione al primo volume delle Vorlesungen über Physische Geographie apparso nel 2009 nell’ambito dell’edizione dell’ Accademia, vuol dire che il programma delle lezioni preparate da Kant, può essere considerato, entro certi limiti, opera autonoma. I limiti, peraltro, sono costituiti dal fatto che le lezioni così come ci sono rimaste, entrano nel patrimonio di studio di studenti e uditori, a volte eccellenti (come dimostra il caso di Herder).
La caratteristica essenziale delle tre parti in cui si divideva l’insegnamento della Geografia fisica, è che la prima è dedicata alla descrizione fisica, la seconda alla storia naturale e la terza all’etnografia. Kant raccoglie una grande quantità di materiali tratti da diari di viaggio, riviste, manuali che organizza poi in modo autonomo. L’esposizione in aula non può certo entrare nei particolari, dice Kant presentando il corso del 1757, ma cercare ciò che desta meraviglia dappertutto e la bellezza con la curiosità razionale di un viaggiatore.
Su manoscritti di uditori di Kant si fonda l’edizione Vollmer (1801-1805), sebbene non si sappia nulla di questa fonte diretta. Come giustamente nota Stark, l’edizione Vollmer si presenta come un progetto editoriale autonomi rispetto alle lezioni kantiane. Infatti, vi si trovano assemblate informazioni che risalgono anche a periodo successivi il ritiro di Kant dall’Università e rimontano fino ai primi anni dell’Ottocento, quando ormai Kant (che muore nel 1804) non ha certo modo e tempo di dedicarsi ad aggiornamenti simili.
Vollmer ebbe a che fare con Theodor Rink a proposito di questa voluminosa edizione (in quattro volumi e sette tomi), ritenuta da Rink una contraffazione e oggetto di una disputa in tribunale che trascinò anche il vecchio Kant, il quale dettò una sua dichiarazione contro Vollmer e a favore di Rink, al quale aveva affidato il materiale per la pubblicazione delle lezioni di geografia fisica.
La polemica si protrasse per un certo tempo, ma lasciò il segno: nella seconda edizione, infatti, Vollmer presenta l’opera come propria trattazione ricavata dalle idee di Kant («nach kantischen Ideen») e, soprattutto, il curatore esce dall’anonimato e si fa riconoscere come Johann Jakob Wilhelm Vollmer «direttore, primo professore e bibliotecario del ginnasio dell’Accademia, ispettore delle scuole cittadine, predicatore della cattedrale di Thorn» (l’attuale Torun in Polonia). Per lo stesso curatore, quindi, l’opera non è di Kant, ma risulta una compilazione di materiali di varia natura, molti dei quali tratti da importanti manuali dell’epoca, comela Erdbeschreibung di Anton Friedrich Büsching.
Non abbiamo una conoscenza precisa di Vollmer: Il Gelehrte Teutschland di Hamberger e Meusel (vol. VI, p. 113) ne riporta poche notizie, senza nemmeno indicare la data e il luogo di nascita, ma sappiamo che nacque a Thorn, ricordando che è stato l’editore della geografia kantiana e l’autore di un Kritisches Handbuch der Geschichte für die Jugend, eine Revision alles dessen, was wir mit Sicherheit in der Geschichte wissen (Hamburg 1805) – Manuale critico di storia per la gioventù, una revisione di tutto ciò che della storia sappiano con certezza.
Un altro cenno a Vollmer, non elogiativo, si trova in una storia della città di Thorn del 1842: Jiulius Emil Wernicke, Geschichte Thorns aus Urkunden, Dokumente und Handschriften, Thorn 1842, vol. I, p. 580, in cui si dice che Vollmer, nominato nel 1803 direttore del Ginnasio, ne disperse lo splendore cui l’aveva portato il suo predecessore.
La Geografia fisica proposta da Rink si presenta come corrispondente a quella Vollmer soltanto per la parte introduttiva (le prenozioni matematiche), mentre per il resto i due volumi che compongono l’opera differiscono per l’ampiezza di sguardo, più che per i temi. L’ultima sezione, la sommaria considerazione delle più notevoli meraviglie naturale di tutti i paesi in ordine geografico, risulta un anello di congiunzione con l’antropologia pragmatica, in particolare con la caratteristica, ossia l’osservazione del mondo esterno per comprendere il lato interno dell’uomo.
La Geografia fisica tradotta in italiano non presenta questo elemento etnografico, poiché il «cittadino Vollmer» (così si firma Johann Jakob Wilhelm Vollmer, da non confondere con l’editore dell’opera che si chiamava Gottfried Vollmer) l’aveva escluso dalla sua edizione, che è alla base della traduzione italiana di August Eckerlin. La conseguenza della scelta di quest’ultimo, che non riteneva opportuno tradurre la Geografia fisica di Rink – senza peraltro darne una motivazione –, è stata che del Kant antropologo e cosmopolita in Italia non si è saputo per un periodo piuttosto lungo. Qualche acuta osservazione di Bertrando Spaventa a metà secolo ha poi consentito di avere, effettiva, sebbene fugace, visione del pensiero antropologico kantiano.
La nascita della geografia moderna
attraverso il pensiero di Alexander von Humboldt e Carl Ritter
Wolfgang Francesco Pili
L’interesse per lo studio geografico sin dai tempi antichi non è mai mancato. Anzi, questo si è dimostrato un elemento unificante fra tutte le varie nazioni europee e mondiali che rivaleggiavano fra di loro per accaparrarsi il maggior numero di scoperte, ma che cercavano sempre di unire il sapere affinché tutti potessero usufruirne e poterne sfruttare al massimo i risultati. Fra il settecento e l’ottocento nuovi studi più approfonditi e dotati di una loro metodologia scientifica vengono intrapresi ed è così che emergono due importanti figure: Alexander von Humboldt e Carl Ritter.
Alexander von Humboldt è stato un uomo poliedrico e dagli interessi multiformi che dedicò la sua vita per intero allo studio e alla conoscenza geografica. Nato nel 1769 egli fu prima di tutto un naturalista, specializzato in botanica e in mineralogia, e alacre viaggiatore: infatti è proprio nei suoi numerosi viaggi che von Humboldt, attraverso le sue osservazioni e rilevamenti, si presenta come un grande geografo, tanto da essere considerato il fondatore vero e proprio della geografia moderna. Laureatosi nel 1790 in biologia all’università di Gottinga, nel biennio successivo studiò nell’accademia mineraria di Freiberg. Non è un caso che poco dopo fu nominato direttore dell’area mineraria della Franconia. Effettuò diversi viaggi nella sua giovinezza, specialmente in Europa e, in particolare, in Italia: dopo la morte della madre eredita una grande somma, poté organizzare una grande spedizione verso i tropici nelle colonie spagnole americane fra il 1799 e il 1804 con l’ausilio del botanico Aimè Bonpland (La Rochelle, 1773 – Restauraciòn, 1858). In questo viaggio ebbe modo di approntare molte ricerche sulla botanica: provò la scalata del Chimoborazo (un monte ecuadoregno) senza raggiungerne la vetta e scoprì un collegamento fra i bacini dell’Orinoco e del Rio delle Amazzoni, attraverso il fiume Casiquiare. Esplorò inoltre l’isola di Cuba, il Messico e il Perù facendo a volte anche studi di tipo etnologico e linguistico. Stabilitosi nuovamente in Europa, a Parigi per i successivi vent’anni, ebbe modo di scrivere la monumentale opera intitolata Voyage auc règions èquinoxiales du Nouveau Continent: questo fu il primo trattato di geografia socioeconomica del vicereame della Nuova Spagna, esteso dall’America istmica alla California e al Texas. Fondata a Berlino la Società Geografica tedesca nel 1828, nel 1829 invitato dallo zar Nicola I, effettuò un viaggio scientifico nella Russia orientale e in Asia centrale. Questo viaggio gli permetterà di dedicarsi alla sua opera magistrale intitolata Kosmos, redatta da cinque volumi, in cui von Humboldt tratta dei diversi aspetti geografici, con particolare riguardo alla fisica, all’astronomia e alle scienze naturali. Ad Alexander von Humboldt si deve l’inserimento negli studi geografici delle isoterme, ovvero la correlazione fra la diminuzione della temperatura e il crescere dell’altezza; inoltre fu proprio il geografo tedesco a valorizzare l’uso del barometro per misurare l’altitudine. Scoprì ancora le variazioni d’intensità del campo magnetico terrestre con la latitudine e viene considerato, fra gli altri, anche il fondatore della geografia botanica. La grande differenza fra Humboldt e i precedenti geografi consiste nel fatto che fu in grado di correlare i diversi fenomeni e argomenti geografici ad altre discipline come la fisica o la sociologia e questo è un aspetto tutt’ora fondamentale per un buono studio accademico geografico. Alexander von Humboldt morì a Berlino nel 1859 all’età di 89, proprio mentre si apprestava a scrivere l’ultimo tomo del Kosmos, che verrà completato e redatto grazie alle sue accurate note bibliografiche. Humboldt fu anche un insigne linguista.
Carl Ritter è stato uno studioso di geografia totalmente diverso dal suo contemporaneo Humboldt: infatti pur avendo anch’egli effettuato numerosi viaggi specialmente in Italia e sulle Alpi, fu un geografo che si dedicò più alla teoria che alla pratica. È’ per questo che la produzione libraria enciclopedica di Ritter è stata molto più prolifica rispetto a quella del suo collega Humboldt. Egli diede alla propria ricerca uno stampo fortemente umanistico. Fu il primo studioso geografo a diventare professore di un corso di Geografia all’università di Berlino nel 1820 e dal 1821 fu direttore della Società geografica berlinese di cui era cofondatore. Le sue opere principali sono due: Die Erdkunde im Verhaltniss zur Natur und zur Geschichte des Menschen e la Erkunde (geografia). Quest’ultima opera fu quella che determinò un profondo mutamento a livello enciclopedico anche se la sua opera rimase incompiuta: era infatti un’opera monumentale (19 volumi con 21 tomi e più di 30.000 pagine) pubblicata a Berlino dal 1822 fino al 1859 dove descrisse minuziosamente l’Asia e l’Africa. Quest’opera ritteriana è tutt’oggi molto poco conosciuta al di fuori delle ristrette cerchie tedesche in quanto è stata tradotta in poche lingue e con poche edizioni (mai in italiano) e appare di difficile lettura e spesso oscura; senz’altro Ritter fu influenzato dal pensiero storicista di Herder, dalla pedagogia di Johann H. Pestalozzi e dai principi generali del luteranesimo. Quest’ultimo punto porterà Ritter a parlare della teleologia o principio di finalità, che Ritter intravedeva nella predestinazione dei popoli e dei paesi. Ritter nell’opera intitolata Vorlesungen über allgemeine Erdkunde (1852), afferma che la teleologia cerca di rispondere all’esigenza di studiare la saggezza del creatore nelle opere della natura e di comprendere lo scopo finale della creazione: lo studio della Terra in ciò è importante perché non è solo il luogo in cui la divina natura si manifesta, ma anche perché è il luogo dove dimora il genere umano. Carl Ritter si definisce uno dei fondatori della geografia scientifica vista intesa come lo studio teorico e filosofico fra natura e uomo: infatti, afferma nell’introduzione alla Erdkunde, che l’influenza della natura sui popoli è maggiore di quella degli singoli uomini, perché si tratta di una massa che agisce su un’altra massa. Tuttavia la natura, al contrario del popolo, agisce in maniera progressiva e la sua influenza in genere è più profonda di quanto sembri. È dunque Ritter un geografo filosofo e storico? Potremmo rispondere affermativamente a questa domanda. Egli studia come detto in modo analitico e teorico tutte le cause della natura e di come essa agisce sull’uomo. Affermerà Ritter che l’influenza della natura sullo sviluppo dei popoli diminuisce di pari passo con l’evoluzione della civiltà, per cui i rapporti di stampo deterministico (vedi bibliografia essenziale) non rimangono uguali nel tempo. Ritter fu un geografo dunque che a differenza di Humboldt riuscì a sottolineare in maniera più compiuta l’eterogeneità dei fenomeni di cui si interessa la geografia e, tuttavia, come ci dice la critica successiva, la sua descrizione dell’Asia e dell’Africa appare arida e noiosa. D’altronde Ritter nei due continenti non ebbe modo (o probabilmente interesse) di andarci: questo rende la sua opera principale, l’Erdkunde, non così importante come potrebbe sembrare, e fornisce anche una ragione anche perché non sia stata tradotta nei vari stati europei.
BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE
Bartaletti F., Geografia Teoria e prassi, Bollati Beringhieri, Torino, 2006
http://it.wikipedia.org/wiki/Aim%C3%A9_Bonpland
http://www.openfisica.com/fisica_ipertesto/openfisica4/principio_isoterme.php
http://geography.about.com/od/historyofgeography/a/vonhumboldt.htm
http://www.treccani.it/enciclopedia/carl-ritter/
http://geography.about.com/od/historyofgeography/a/carlritter.htm
http://www.vialattea.net/esperti/php/risposta.php?num=13271 riguardo la teleologia
http://www.sapere.it/enciclopedia/determinismo.html per quanto concerne il determinismo geografico
Lezione (hegeliana) di geografia
Quando mi misi a pensare all’argomento per la tesi di laurea – prima di focalizzare la mia attenzione su Rousseau, i selvaggi e l’antropologia – sottoposi a un docente germanofilo della cattedra di Storia della filosofia moderna e contemporanea dell’Università Statale di Milano, l’idea di vederci chiaro sul rapporto tra geografia e storia nella filosofia hegeliana. Un argomento non semplice, poco studiato in Italia, e che dunque avrebbe richiesto una buona conoscenza della lingua tedesca, ostacolo per me all’epoca insormontabile. Tra l’altro avrei dovuto leggermi alcuni saggi di geografi e storici tedeschi a cavallo tra ‘700 e ‘800 (tra cui quelli di un certo Ritter, geografo spesso citato da Hegel), che se andava bene erano stati tradotti in francese. Mi sarebbe poi piaciuto tirar dentro Johann Gottfried Herder, che aveva scritto due opere splendide dedicate alla filosofia della storia. Ma poiché ero già abbondantemente fuori corso, finii per lasciar perdere. (Forse giocava anche un riflesso condizionato della mia passione di bambino per tutto ciò che aveva a che fare con la geografia e, soprattutto, con le carte geografiche; senza ancora sospettare che la cartografia – e la crisi della ragione cartografica di cui parla ad esempio il geografo Franco Farinelli – è cosa serissima, tanto più in epoca globale).
Hegel, nella sua filosofia della storia, aveva costruito una vera e propria cartografia e mappa dello sviluppo spirituale, generalmente semplificato nell’arco che da Oriente va ad Occidente – l’alba e il tramonto-compimento dello spirito, in chiave chiaramente eurocentrica. Anche se poi tale spirito finiva per sostare un po’ troppo nelle terre germaniche e prussiane, prima di (forse e comunque con poco entusiasmo da parte del filosofo tedesco) intraprendere la traversata dell’oceano e migrare in terra americana. Pur trincerandosi dietro la frase che “il filosofo non s’intende di profezie”, Hegel deve comunque ammettere a denti stretti che l’America sarà il paese dell’avvenire. Non so che cosa avrebbe obiettato se gli si fosse fatto presente che, proprio perché la filosofia non produce profezie, non si poteva escludere che la circolarità dello spirito avrebbe finito per doppiare lo stretto di Bering e ripartire così dal suo luminoso inizio – e che dopo il secolo americano ci sarebbe stato il secolo cinese, ad onta del fatto che per i cinesi “il mare è solo il cessare della terra”.
Ad ogni modo lo spirito – la cultura umana – ha sempre una precisa collocazione geografica: Hegel la definisce nelle sue Lezioni “situazione di natura, ossia la base geografica della storia del mondo”. I popoli, per esser tali, devono avere una loro “configurazione naturale […] da cui si sprigiona lo spirito”. Questo, dunque, si impasta con il clima e si innesta sul materico-naturale, anche se suo compito essenziale è di elevarsi da questa sua naturalità e fisicità, per riconoscersi in qualità di libero spirito.
Ciò non toglie nulla alla sua valenza fortemente geografica (e dunque storica): Hegel riconosce ad esempio, sulla scorta degli studi settecenteschi, in particolare di Montesquieu, che il clima è un elemento determinante. In particolare, solo la zona temperata può essere a suo giudizio il vero teatro della storia del mondo; mentre il mare ricopre una funzione essenziale in termini di superamento del limite, pericolosità, coraggio, scoperta, astuzia: “nel mare è implicita quella specialissima tendenza verso l’esterno, che manca alla vita asiatica: il procedere della vita oltre sé medesima”. Insomma, non c’è in Hegel una filosofia della storia che non sia contemporaneamente una filosofia della geografia, una geofilosofia o una geopolitica.(Oggi, a distanza di ben due secoli, si tratta di una branca nuova ed interessante della filosofia: per averne un’idea basta consultare il Sito italiano di Geofilosofia o dare un’occhiata alle 10 tesi di Geofilosofia di Caterina Resta)..
Questa lunga (e forse poco interessante) premessa, per dire che la lezione di geografia è essenziale, e che forse bisognerebbe tornare a studiarla con più attenzione, a prescindere dalla facilità con cui wikipedia o google map ci fiondano sul globo in un batter di clic.
La geografia è cosa serissima; i numeri della demografia sono pesantissimi; lo spazio, anche se apparentemente annullato dai media e dalla rete, è un’estensione imprescindibile; i colori delle mappe geografiche, gli istogrammi e i dati statistici nascondono sotto la loro patina brillante guerre e conflitti, corpi e macerie, lavoro e fatica, vita e speranze insieme ad un bel po’ di promesse tradite.
Faccio solo tre esempi, cercando di applicare quanto ho detto finora a quel che va accadendo in questi mesi in giro per il pianeta:
a) sui numeri, mi pare che la prussiana (e forse un po’ hegeliana) Angela Merkel abbia detto una cosa geofilosofica ovvia, su cui però non molti stanno ragionando: l’Unione europea incide in termini demografici solo per il 7% della popolazione mondiale (il 10% se allarghiamo all’intera Europa), mentre l’Italia non arriva nemmeno all’1%. Quando si usa la categoria di potenza mondiale non possiamo non ragionare anche su questi dati;
b) che cosa vuol dire oggi essere europei od occidentali? perché mai dovrei sentirmi più europeo di quanto non mi senta mediterraneo o ugrofinnico o micronesiano? E poi: insulare – continentale – fluviale – lacustre – marino – montano – campagnolo – metropolitano – centrale – periferico – nomade – migrante… potrei continuare a lungo con questa cartografia geoantropologica che nasconde e svela ad un tempo il destino di miriadi di esseri umani, insieme alle loro collocazioni biografiche ed esistenziali, difficilmente rappresentabili e riducibili a quelle mappe e a quei numeri;
c) ma la lezione più drammatica ed istantanea di geografia, di geofilosofia e di geopolitica, ce la dà – tanto per fare un esempio paradigmatico – la Siria di quest’ultimo anno: gli abitanti di quella nazione, con quei confini, quella densità, quella superficie, quella conformazione orografica ed idrografica, quel clima e quel fuso orario, quelle religioni e lingue ed etnie – e con quelle risorse (o non risorse) – ebbene loro sì che stanno scrivendo la lezione di geografia con il proprio sangue.
- Ogni cultura umana è legata alla terra, alla natura in cui si sviluppa, sembra essere vero, se pensiamo anche soltanto all’influenza sulla costituzione culturale non solo del clima, ma anche del cibo autoctono e delle abitudini, degli usi e costumi ad esso connesse. Anche se ormai mangiamo cibi esotici, e persino il grano proviene in gran parte da paesi d’oltremare. E senza contare l’oggetto di fede che è ormai diventata la fede universale, il danaro e i flussi del capitale finanziario, quanto mai liquido, per il quale non si danno confini.
In“Terra e il Mare” Carl Schmitt, sosteneva che la supremazia europea era sulla via del tramonto, e con essa il diritto e lo statalismo europeo. la storia del mondo è la storia delle potenze marittime contro le potenze terrestri, e viceversa.
Per Schmitt: “Il Mare è innanzitutto la negazione della differenza, conosce solo l’uniformità, mentre nella Terra si dà sempre la variazione, la difformità. Il Mare non ha confini se non le masse continentali ai suoi estremi. La Terra è sempre solcata dai confini tracciati dall’uomo, oltre alle barriere naturali. Il Mare è mobilità permanente, flusso privo di un centro stabile. È caos e dissoluzione. La Terra è costanza, stabilità, gravità. È gerarchia e ordine. Il Mare è il Capitale, la Terra è il Lavoro. Eccetera.
Allo stesso modo la fluida uniformità marittima genera il dio-denaro, ciò tramite cui ogni merce può essere scambiata ma che non è a sua volta una merce. L’era moderna in effetti è l’era dei flussi: flussi di informazioni, flussi di capitali, flussi di merci, flussi di individui. Il monoteismo del mercato (capitalistico e finanziario) nasce dal Mare.
Concretamente e storicamente, il Mare sarebbe incarnato dalle talassocrazie anglosassoni, la Terra dalla tellurocrazia continentale eurasiatica.
E l’America sarebbe in tutto e per tutto l’erede geopolitico e geofilosofico dell’Inghilterra. In essa lo spirito mercantile, l’istinto predatorio e l’individualismo borghese raggiungono livelli deliranti. Il titanismo predatore, piratesco, mercantile tipico delle talassocrazie è animato da una brama di dominio inestinguibile che non può essere limitata da alcuna regola.
L’istinto di predone dei mari che caratterizza il popolo insulare (Inghilterra e America) intende in modo tutto diverso la vita economica. Qui si tratta di lotta e di bottino, anziché di politica, come sulla terra.Nell’isola, quindi, il capitalista sostituisce il politico ed il corsaro prende il posto del soldato; solo sulla Terra l’esistenza dell’uomo è immediatamente politica.”
Comunque ormai anche la Cina ha “attraversato la grande acqua”, ed è un oceano, a confronto del piccolo stagno che è l’Europa.
Geografia e filosofia. Materiali di lavoro
di Marcello Tanca Franco Angeli, 2013
Nei nostri ricordi scolastici geografia e filosofia rappresentano mondi separati e lontani, che poco o nulla hanno a che fare l’uno con l’altro. Questa spartizione ha dietro di sé una lunga storia – che se non è lunghissima, è ancora viva e presente nella cultura contemporanea. Nonostante lo “spatial turn” registratosi nelle scienze sociali negli ultimi anni, la storia dei prestiti e delle contaminazioni tra discorso filosofico e discorso geografico attende ancora, in larga parte, di essere scritta. Questo lavoro parte da una precisa ipotesi interpretativa: l’esplorazione conoscitiva e materiale della Terra, il tratto che più di ogni altro caratterizza l’epoca moderna e senza il quale non si darebbe globalizzazione, sarebbe stata impensabile senza le molteplici connessioni, interferenze e sovrapposizioni tra geografia e filosofia. Si tratta allora di ripensare il rapporto tra quelli che sono a tutti gli effetti dei dispositivi di produzione di immagini del mondo e di riportare alla luce alcune delle tappe più significative di un percorso comune così poco conosciuto: da Kant a Foucault, passando per Hegel, Marx e Heidegger.
Recensione (di Dino Gavinelli):
Geografia e Filosofia, due discipline ben delineate nell’immaginario collettivo come distanti e ben separate tra loro e che invece Marcello Tanca riavvicina per evidenziarne codici, discorsi, linguaggi, saperi, percorsi e evoluzioni di volta in volta vicini, mescolati, complementari. La sua analisi si inserisce dunque sul solco dei non numerosi lavori che hanno indagato sugli incontri, gli scontri, le mediazioni, le sovrapposizioni e le interferenze tra geografia e filosofia. Nel lavoro monografico si spazia da quell’Illuminismo settecentesco, tutto teso a trasporre l’ordine razionale della scienza sul piano della storia e della geografia, alla filosofia novecentesca di Foucault che, con la sua microfisica del potere e le sue frequenti preoccupazioni per la dimensione spaziale, non lascia certamente indifferenti i geografi contemporanei. Tra questi estremi temporali Marcello Tanca si muove agevolmente per raccogliere, ordinare e presentarci i suoi “materiali di lavoro”: Kant e la “geografia fisica” (capitolo 1); Hegel e la “geografia dello spirito” (capitolo 2); Marx e la geografia (capitolo 3); il paesaggio come categoria logica della descrizione geografica e della riflessione filosofica (capitolo 4); abitare il mondo: Heidegger, Dardel, Le Lannou (capitolo 5); Foucault: per una geografia del potere (capitolo 6). Tra questi materiali ritroviamo anche testi che, in alcuni casi, sono tradotti per la prima volta in italiano per recuperare, come ben dice l’autore nella sua Introduzione, la dimensione storica del sapere geografico e risalire, con metodo filologico, alle origini di modelli ontologici e di precise figure teoriche e geografiche (il paesaggio, l’abitare).
Nel primo capitolo, dedicato a Kant e alla sua geografia fisica, l’autore ci porta al centro delle riflessioni del filosofo di Königsberg sulla storia umana, sull’operatività dei gruppi sociali sulla scena del mondo con il fine di creare un ordinamento cosmopolitico, tipicamente settecentesco. In tale contesto la geografia fisica e quella umana acquisiscono una loro grande utilità perché svolgono un’importante funzione pratica, popolare e di orientamento. Attraverso la geografia gli individui sono in grado di avere non solo uno sguardo regionale ma anche uno d’insieme sul pianeta per poter così indagare e conoscere i suoi molteplici paesaggi.
Nel secondo capitolo domina la figura di Hegel che, nel suo sistema filosofico tutto teso a riconoscere il presente (quello tra la fine del Settecento egli inizi dell’Ottocento) nella sua positività e a contrastare il moralismo di chi contrappone l’ideale astratto al reale, lascia un certo spazio alla geografia. La filosofia della storia di Hegel ci presenta infatti il grande scenario della vita degli stati, espressione dello spirito di quei popoli che, nelle diverse epoche, hanno non solo rappresentato un momento significativo del progresso complessivo dello spirito umano ma disegnato anche luoghi specifici. La dimensione evolutiva è dunque selettiva non solo nel tempo ma anche nello spazio, come il nostro autore ben evidenzia in diversi punti della sua lettura geografica dell’opera hegeliana.
Nel terzo capitolo viene proposta una rilettura del pensiero di Karl Marx in chiave geografica. Questa rilettura consente di richiamare succintamente le tappe principale del rapporto tra il filosofo tedesco e la geografia. All’interno del suo complesso impianto speculativo e espositivo, conosciuto ai più per i suoi aspetti filosofici, politici ed economici perché incentrato sull’unità del processo di produzione e di circolazione del capitale, Marx ha inserito infatti ampie parti documentarie, storiche, ecologiche e geografiche. La sua teoria critica della globalizzazione, che Tanca interpreta giustamente come evidente superamento dell’influsso hegeliano, è molto utile al geografo alla ricerca di “preziosi strumenti di lettura dei meccanismi di esclusione sociospaziale e delle contraddizioni ecologiche e territoriali del sistema-globo”. L’attualità del pensiero di Marx rispetto alla presente globalizzazione capitalistica che plasma ambienti, culture, economie, società, territori e paesaggi è sorprendente.
Nel quarto capitolo è il paesaggio, come categoria logica della descrizione geografica e della riflessione filosofica, a imporsi all’attenzione del lettore. Il concetto polisemico di paesaggio, elemento paradigmatico della complessità attuale del mondo, con i suoi molti valori estetici, romantici, patrimoniali, scientifici, soggettivi, per citarne solo alcuni, consente di richiamare termini quali “mimesis”, “graphikos”, “pictura”, di ricordare Humboldt e i suoi schemi progettuali di acuto geografo, di inquadrare i termini di un Vidal de la Blache ermeneuta e di riflettere su ricchi e variegati percorsi geofilosofici ottocenteschi e novecenteschi. Con queste analisi il paesaggio si dimostra in tutta la sua “plasticità” e offre numerosi spunti all’autore che, a ragione, avversa l’idea dell’immutabilità dei caratteri naturali, culturali e paesaggistici. Proprio i paesaggi della contemporaneità, trattati nell’ultimo paragrafo del capitolo, ci ricordano che il discorso rimane aperto e in divenire.
Nel quinto capitolo è il popolamento del pianeta e le modalità dell’abitare ad essere trattato da tre punti di vista filosofici e geografici di spessore: Heidegger, Dardel e Le Lannou. Il percorso speculativo di Heidegger, che nel problema dell’essere ha posto la sua maggiore attenzione, non si limita agli aspetti metafisici ma implica anche una dimensione spaziale polisemica nella quale i luoghi e gli ambienti sono intimamente legati alle grandi questioni filosofiche e si prestano agli approfondimenti delle successive correnti fenomenologiche, umanistiche e esistenziali presenti in filosofia e in geografia. Anche Dardel indaga discretamente sulla natura della realtà geografica, e in particolare dell’abitare, nel suo ormai celebre “L’uomo e la terra” così ricco di richiami a Heidegger e, più in generale, alla filosofia. Negli stessi anni anche Le Lannou si interessa alla geografia come scienza dell’uomo-abitante e anticipa la sua riflessione critica sulla pianificazione territoriale che troverà ampio spazio nel dibattito culturale francese degli ultimi decenni del XX secolo. I tre punti di vista, pur tra loro diversi, mettono in campo metodi e strumenti della filosofia e della geografia per sottolineare che l’azione dell’abitare è sempre complessa, si presta a tante letture ed è una questione che riguarda tutti noi.
Nel sesto capitolo l’analisi dell’opera del filosofo e saggista francese Foucault consente al nostro autore di rimettere in questione la centralità del soggetto, della storia e dello spazio intesi come esito positivo della progettualità umana secondo un tragitto lineare e continuo. Al contrario, il divenire storico e geografico passano attraverso brusche fratture, tra loro spesso contraddittorie o eterotopiche, che possono essere descritte e registrate ma non spiegate. In questo senso Foucault fornisce un contributo notevole alla geografia postmoderna pur non avendo elaborato un’organica teoria generale dello spazio. Ma è soprattutto nell’analisi dei rapporti di potere che egli influenza il pensiero geografico sul presente e alimenta decise opposizioni al suo punto di vista critico. Il potere è infatti inteso non come istanza centralizzante e gerarchizzante ma piuttosto come insieme plurimo, reticolare e circolare di relazioni. Verso di esso possono strutturarsi forme di resistenza che rimettono in causa le pratiche discorsive e le strategie dominanti e alimentano gli studi di geopolitica.
Il testo, denso nei contenuti e foriero di stimoli, è arricchito da una Prefazione di Franco Farinelli. In essa si ricorda il lungo cammino compiuto dalla geografia e si sottolinea come questa disciplina abbia preso ampio spunto dapprima dalla filosofia greca delle origini. Le successive analisi filosofiche hanno poi consentito, più o meno direttamente, alla geografia di rendersi maggiormente articolata, variegata e complessa a riprova dei proficui contatti tra le due discipline.
L’esplorazione conoscitiva e materiale della Terra, il tratto che più caratterizza l’epoca moderna e senza il quale non si darebbe globalizzazione, sarebbe stata impensabile senza le molteplici connessioni, interferenze e sovrapposizioni tra geografia e filosofia. Il testo vuole ripercorrere alcune delle tappe più significative di un percorso comune così poco conosciuto e di cui si è minimizzata l’importanza: da Kant a Foucault, da Hegel a Marx e Heidegger.
Bollettino della Società Geografica Italiana Riflessioni sul postmodernismo (di M.Marconi)…
Nei nostri ricordi scolastici geografia e filosofia rappresentano mondi separati e lontani, che poco o nulla hanno a che fare l’uno con l’altro. La geografia ci riporta alle carte appese alle pareti delle aule e ad elenchi interminabili come quello degli affluenti di destra del Po. La filosofia al proprio tempo appreso col pensiero, al Cogito e agli imperativi categorici. Questa spartizione ha dietro di sé una lunga storia – che se non è lunghissima, è ancora viva e presente nella cultura contemporanea.
Nonostante lo spatial turn registratosi nelle scienze sociali negli ultimi anni, la storia dei prestiti e delle contaminazioni tra discorso geografico e discorso filosofico attende ancora, in larga parte, di essere scritta. La responsabilità va ripartita in parti uguali tra geografi e filosofi. I primi hanno teorizzato poco o nulla e guardato come pericolose deviazione quei tentativi di elaborare un’immagine della Terra che non fosse semplicemente il mero calco della rappresentazione cartografica (sono emblematici, da questo punto di vista, i casi di Reclus e Dardel). I secondi si sono generalmente disinteressati ad una disciplina che sembrava offrire pochi appigli alla riflessione critica a causa del suo statuto epistemologico ambiguo e incerto, a metà strada tra il fisico e l’umano, dunque di difficile collocazione in un quadro teorico dominato da dicotomie come quella tra “natura” e “spirito”.
Questo lavoro parte da una precisa ipotesi interpretativa: l’esplorazione conoscitiva e materiale della Terra, l’impresa che ha cambiato per sempre la faccia del pianeta ma alla quale né i geografi né i filosofi hanno preso parte direttamente, non sarebbe stata possibile senza l’apporto di quegli straordinari codici di scrittura del mondo che sono geografia e filosofia. Si tratta allora di riportare alla luce, attraverso uno scavo archeologico, alcune delle tappe più significative di un percorso comune così poco conosciuto e di cui oggi è più che mai urgente scrivere la storia: da Kant a Foucault, passando per Hegel, Marx e Heidegger.
Spazio e geografia in Hegel:
la dialettica terra-mare
Nella filosofia hegeliana troviamo sempre la natura definita inizialmente, per la coscienza ordinaria, come l’elemento immediato, esteriore, molteplice ed estrinseco, un Proteo che ci troviamo di fronte senza averlo prodotto17, caratterizzato da rapporti di giustapposizione spaziale e successione temporale18. Questa accezione di natura è contrapposta allo spirito umano inteso da Hegel sempre in termini di razionalità come risultato, ritorno in se stessi, farsi per mezzo della propria attività, in modo autonomo e libero, autodeterminato.
Quale significato ha allora la sensibilità dell’uomo, il suo aspetto biologico, rispetto alla sua natura razionale e alla natura esterna? Sicuramente, per Hegel, l’uomo si dice sensibile in quanto non lo si dice libero, ma il nesso che lega alla natura esterna il carattere dell’uomo (termine con cui Hegel indica forme specifiche di indole, tendenza ed attitudine interiori) non è un rapporto di meccanica dipendenza causale, come se la determinatezza naturale del suolo o del clima avesse come effetto la formazione del carattere di un popolo, riempiendo di contenuto attitudini di per sé vuote ed astratte. Hegel è fortemente critico rispetto a supposti effetti determinanti e specifici del clima, per lui un clima aspro e duro non avrebbe alcuna relazione causale o analogica significativa con destini di eroi e/o suicidi:
Si parla spessissimo del mite cielo ionico, che avrebbe prodotto Omero. Certo esso ha molto contribuito alla grazia della poesia omerica. Ma la costa dell’Asia Minore è stata sempre la stessa, e lo è ancora: eppure dal popolo ionico non è sorto che un Omero19.
L’influenza del clima è per Hegel più generale, e (specialmente negli estremi del torrido e del gelo) riguarda la sua potenza e la sua forza di oppressione sulla liberazione delle forze spirituali umane. Tale liberazione per Hegel non può che iniziare a livello della sensibilità stessa dell’uomo, nel suo nesso con la natura esterna, con l’evidente richiamo alla tesi aristotelica secondo cui l’uomo si rivolge all’universale solo quando non è depresso e ottuso dai bisogni, ma è in grado di distaccarsi e ritrarsi dalla propria immersione nel mondo esterno. Da questa prima serie di considerazioni, che senza dubbio privilegiano le terre temperate come terre di sviluppo della libertà 20, emerge che è il rapporto con la natura con ciò che è fuori di noi, non l’introspezione, il rapporto con noi stessi, la prima posizione a partire dalla quale l’uomo è in grado di riflettere in sé e acquistare libertà, e che è nel rapporto con la differenza da sé, e non nelle profondità della individualità, che l’uomo trova per Hegel il suo originario punto di partenza per muovere verso il sapere di sé. Inoltre, va notato che emerge anche come la separazione dalla natura, il distacco da un rapporto semplicemente immediato con essa, sia la prima condizione per separare da sé bisogni e pulsioni, l’irretimento nei rapporti primari di possesso e dipendenza: con le cose, con la terra, con i legami famigliari (“la voce del sangue”), e per sviluppare una cultura spirituale21.
Si vede allora come, per Hegel, la maniera naturale di essere dell’uomo sia tanto il suo essere sensibile e non libero, immerso nell’esteriorità, sia il suo stesso ritrarsi dalla immediatezza di tale immersione, se la natura esterna non glielo impedisce:
Il gelo che serra i Lapponi o il calore torrido dell’Africa sono forze troppo potenti a petto dell’uomo perché lo spirito possa acquistare fra esse libero movimento e giungere a quella sua ricchezza, che è necessaria perché una civiltà assuma forma reale. In quelle zone il bisogno non può esser mai allontanato: l’uomo è perpetuamente obbligato a rivolgere la sua attenzione alla natura.22
In altre parole, il clima è determinante solo nella misura in cui la sua potenza impedisce all’uomo di ritornare a sé stesso e in sé stesso. Circoscrivere alla zona temperata il fiorire della civiltà, si badi bene, non è stato affatto determinato da Hegel dallo stanziamento di certe popolazioni geneticamente superiori a scapito di altre, non è basato su argomenti che oggi definiremo “razzisti”. Il primato, sotto l’aspetto spirituale, dell’Europeo e della razza caucasica (su criteri osteologici e non sul colore della pelle come in Kant)23 che troviamo ad esempio nella sua Filosofia dello spirito soggettivo è affermato solo nei mutabili termini della storia e della antropologia culturale, non su immutabili fondamenti biologici ed ereditari: «la differenza delle razze umane è ancora una differenza naturale, cioè una differenza che riguarda anzitutto l’anima naturale. Come tale, essa è legata alle differenze geografiche del suolo sul quale gli uomini si riuniscono in grandi masse 24».
Da qui l’importanza, inedita nel pensiero filosofico, delle basi geografiche della storia del mondo, e in particolare del Mediterraneo come espressione del rapporto tra mare e terra, vista come l’opposizione più universale della determinazione naturale e di maggiore significato storico. Hegel considera infatti quanto il movimento concettuale, oggetto e compito della considerazione filosofica, si ritrovi nelle considerazioni delle diversità fra i continenti, per sottrarre tali differenze dalla casualità e poterne fare discorso razionale.
Ricordo brevemente come Hegel codifica i momenti necessari della attività logico-reale del pensiero25. Il pensiero come attività formale si muove a partire dalla intuizione immediata della sensazione, dalla apprensione della individualità concreta. La nega intellettivamente nella unità di una universalità indifferenziata e compatta, che sussume quella singolarità insieme al molteplice che gli è omogeneo. Ma il pensiero non si ferma a questa attività di isolamento e separazione di un universale astratto, come un che di ideale saldamente contrapposto al reale singolare della sensazione. L’antitesi prodotta dal momento intellettuale non fissa che apparentemente degli estremi indipendenti e autosussistenti, la loro verità speculativa o razionale si riconosce quando ogni determinazione isolata, ogni essere finito, si mostra, dialetticamente, in relazione con ciò che esclude, si rovescia nel suo opposto. In altre parole, ogni determinata identità con sé, in quanto non è mai un termine fisso e ultimo ma è soggetta a mutamento e divenire, contiene anche la propria negazione, contraddicendo così la propria autosufficienza, che si rivela dunque una mera apparenza. I due opposti estremi della universalità e della singolarità, ognuno passato nell’altro, risultano così relativi l’uno all’altro e compenetrati sillogisticamente nel medio della loro unità: una unità non iniziale, ma riflessa in sé, prodotta dal pensiero.
Il modo di pensare dialettico mostra dunque in generale la finitezza delle determinazioni unilaterali dell’intelletto, esponendole per quello che sono, tali che si rovesciano in quel loro opposto da cui avevano astratto per circoscrivere e fissare la propria identità esclusiva, e così si superano. Da qui la dialettica come «immanente oltrepassare», come finito che non viene limitato dal di fuori ma che si contraddice in se stesso, passa nel suo contrario mediante se stesso. Solo per questo aspetto di anima motrice la dialettica è per Hegel il principio mediante cui il contenuto della scienza acquista un nesso immanente o una necessità, e il suo è un risultato positivo, una unità mediata di determinazioni distinte 26.
Hegel ha così gli strumenti filosofici per pensare il “nesso immanente” tra le grandi suddivisioni continentali, come porzioni limitate e finite, del nostro pianeta, mostrando come sia possibile razionalmente (dialetticamente) “dedurre” l’Africa come unità indifferenziata, universale massa continentale compatta, l’Asia come suo opposto, per gli altipiani e le grandi valli irrigate da ampi fiumi che spezzano tale uniformità, e infine l’Europa, dove montagna e pianura non sono giustapposte, ma si compenetrano costantemente.
L’Europa, in questa considerazione filosofica, per Hegel «rivela l’unità di quella unità indifferenziata dell’Africa e dell’opposizione non mediata dell’Asia. Questi tre continenti sono, non separati, ma uniti dal Mediterraneo, attorno al quale si stendono» 27. Analogamente, le differenze fondamentali dello spazio naturale vengono pensate secondo la scansione della compattezza indifferente e chiusa, informe dell’altopiano con le sue grandi steppe e pianure, della massa montana rotta da corsi di acqua che si scavano il passaggio verso il mare nella transizione della pianura fluviale, mentre il terzo elemento è la zona costiera, la terra che è a contatto con il mare.
Nella comprensione concettuale (necessaria) delle tre differenze fondamentali dal punto di vista della terra, i corsi di acqua giocano un ruolo fondamentale. Nella terra abitata, lo spazio, la nostra prima intuizione dell’esteriorità che corrisponde alla categoria della quantità 28, non vale più unicamente come giustapposizione indifferente ed estrinseca, ma è ambiente, la mera esteriorità quantitativa viene subordinata a rapporti vitali più complessi: «il sussistere in modo reciprocamente estrinseco della spazialità non ha alcuna verità per l’anima» 29. La fertilità del terreno porta allo sviluppo dell’agricoltura e quindi alla regolamentazione del ciclo di soddisfacimento dei bisogni primari su ciclici tempi stagionali, la sedentarietà e il possesso prolungato causano il sorgere dei diritti sociali (proprietà, diritto, classi), rapporti collettivi che unificano esistenze che prima erano nomadi o meramente singole. In questo schema geopolitico dell’avanzare della cultura e della civiltà dall’altipiano interno al mare, l’acqua, per Hegel, ha dunque sempre il valore di ciò che unisce, mai di ciò che separa:
in tempi recenti, in cui si è voluto sostenere che gli stati debbono essere necessariamente divisi da elementi naturali, ci si è abituati a considerare l’acqua come il principio separatore. Contro questa opinione è invece di importanza essenziale il dire che nulla riunisce quanto l’acqua, chè i paesi di cultura non sono altro che bacini fluviali. L’acqua è infatti ciò che congiunge; sono i monti che separano. Quando i paesi sono separati da monti, lo sono maggiormente che quando son divisi da un fiume o persino dal mare 30.
Hegel si riferisce probabilmente al ruolo del Reno e dell’Elba durante le campagne napoleoniche in Germania nel primo decennio dell’800: un «falso principio » dei Francesi far valere che i fiumi siano confini naturali, come nel caso della Confederazione del Reno (Rheinbund) seguita all’abolizione del Sacro Romano Impero (1806), da cui erano escluse Prussia ed Austria. Ma mi piace pensare che per una filosofia hegeliana degli spazi naturali e umani egli fosse portato a sottolineare la comunicazione di popoli, costumi e caratteri attraverso le vie di acqua anche perché attento a registrare un nuovo fenomeno del suo tempo: il flusso turistico che venne a svilupparsi sul Reno dopo la sconfitta di Napoleone del 1815, in quella Confederazione germanica (Deutscher Bund) di cui facevano di nuovo parte Regno di Prussia e Impero austriaco, con l’introduzione della navigazione a vapore nel 1817 (da Bonn fino a Coblenza) e nel 1827 (fino a Magonza) grazie alla Compagnia prussiano-renana di battelli a vapore. 31
Può essere interessante notare come anche oggi, pur in un panorama storico profondamente mutato, l’approccio di Hegel conservi il suo valore: basti pensare a come un sociologo come Franco Cassano guarda all’Adriatico, quando, tra tracce passate di guerre recenti e proiezioni di future integrazioni comunitarie, scrive che attraversarlo:
significa avvicinare popoli dello stesso continente, completare l’Europa, ma anche cambiarla mutando l’equilibrio delle sue voci […] l’Adriatico è un invito a fare un salto, un salto possibile e non metafisico, un invito a guardare lontano, ma non troppo. L’Adriatico non chiede di essere angeli, ma solo gabbiani 32.
Nell’ottica di Hegel, dunque, non tanto la corrispondenza tra terra aspra e composita, stretta tra mare e altipiano, e i popoli e le lingue diverse, sarebbero oggetto di discorso filosofico, quanto il contatto tra terra e mare, l’aspetto della comunicazione con il mare e i modi in cui la costa sviluppa le sue relazioni con esso, attraverso i commerci e la navigazione, come poi riprenderà Carl Schmitt nel suo Land und Meer, sempre in termini di reinterpretazione della storia universale, attraverso però il conflitto intrinseco, nella rivoluzione spaziale globale scaturita dalla scoperta del nuovo mondo, tra potenze di terra e di mare 33. La zona costiera sembra invece unificare per Hegel la saldezza dell’aspetto continentale, del legame con la terra che fissa l’uomo al suolo, restringendone la libertà nel complesso dei rapporti di proprietà, lavoro, bisogno, e l’aspetto del superamento del limite.
Scrive Hegel che il ‘senso’ del mare come di qualcosa che porti oltre la limitatezza della terra manca all’Asia, nonostante che la Cina confini con il mare, per tali popoli «il mare è solo il cessare della terra». Il condizionamento della natura sulla vita dei popoli che si affacciano sul Mediterraneo risveglia invece il coraggio e il rischio, la cui anticipazione e decisione di correrlo svincolano l’uomo dalla catena di rapporti con la cose, creando uno scarto interiore che dà all’individuo la autocoscienza di una maggiore libertà. Chi cerca il guadagno, chi lavora per soddisfare i bisogni usando come mezzo il mare e non la terra si mette esistenzialmente in gioco, in modo radicale, accettando di mettere a rischio vita e ricchezze, e come tale conquista un maggiore senso di autonomia e indipendenza del volere.
Il coraggio poi in questo caso sarebbe unito con l’astuzia. In una bella pagina, che riscrive filosoficamente la tipologia poetica di ogni Odìsseo e del suo navigare, come istanza di compenetrazione fra la solidità del suolo e la cedevolezza del fluido, Hegel così si esprime:
Il coraggio di fronte al mare deve quindi essere insieme astuzia, perché ha a che fare con ciò che è astuto, con l’elemento più malsicuro e mendace. Questo infinito piano è assolutamente morbido, non resiste affatto ad alcuna pressione, neanche al soffio: ha l’aria infinitamente innocente, remissiva, amabile, carezzevole, ed è appunto questa cedevolezza che cambia il mare nel più pericoloso e formidabile elemento. A tale insidia e violenza l’uomo […] contrappone solo un semplice pezzo di legno, in cui sale, affidandosi soltanto al suo coraggio e alla sua presenza di spirito; e così passa da ciò che è saldo a qualcosa che non offre punto d’appoggio, conducendo con sé il proprio suolo artificiale. La nave, questo cigno del mare, che con agili e rotondi movimenti solca il piano delle onde o vi traccia cerchi, è uno strumento la cui invenzione fa il più grande onore tanto all’arditezza quanto all’intelligenza dell’uomo 34.
In conclusione, perché il mito di Trieste, come si auspica, continui a vivere non solo di luce riflessa, forse non ci si dovrebbe attardare sul pluralismo culturale asburgico, che è storia remota, ma individuare l’aspetto essenziale, e non transeunte o accidentale, di ciò che ha avuto in quel periodo la possibilità di svilupparsi ed esprimersi, quello che Hegel chiamerebbe l’in sé, la dynamis o potenzialità “costiera” della vita di Trieste. Forse, dopo tutto, basterebbere leggere con altre categorie il nesso tra conformazione geografica e fisionomia culturale, e invece di scrivere di equilibrismi fra altipiano e mare, di strettoie fra frontiere naturali e artificiali, di etnie e lingue giustapposte, pensare in termini di innovazione, arditezza e intelligenza, di comunicazione, cultura e commercio, al mare non come al cessare della terra, ma come al superamento del limite: spazio di unione, contatto, scambio. L’opposizione dialettica tra fissità al suolo, saldezza continentale, e mobilità delle acque, imprevedibilità e accidentalità del rischio, tra agricoltura e navigazione, nella filosofia degli spazi naturali e umani di Hegel, può offrirci le condizioni di intelligibilità di una Trieste (in teoria) come città potenzialmente capace di integrare, in una medesima esperienza più avanzata, le differenze delle culture di terra e di mare e in questo sta, a mio parere, la sua possibile identità, la sua riducibile differenza “insulare”.
17 Cfr. HEGEL, Enciclopedia, II, cit., p. 80; si veda anche §246,Agg, p. 86.
18 Cfr. HEGEL, Enciclopedia, II, cit., §247, p. 90.
19 HEGEL, Lezioni sulla filosofia della storia, I, trad. it. G. Calogero e C. Fatta, Firenze, La Nuova Italia, 1978, p. 209.
20 Cfr. R. M. dAINOTTO, Europe (in Theory), Durham and London, Duke Universty Press, 2007, p. 168, che, senza darne le ragioni, ricostruisce «la trama tracciata dalla vera storia» per Hegel come quella di un «avanzamento climatologico dello spirito da un ‘torrido’ sud ad un nord ‘temperato’».
21 Il passaggio da un rapporto di desiderio (e distruzione egoistica, consumo) con l’oggetto ad un rapporto formativo, il superamento della propria soggettività e dell’oggetto esterno come elevazione, l’esperienza dell’essere-altro come altro Io, che porta al riconoscimento di un essenza comune di tutti gli uomini, sono i temi della fenomenologia dell’autocoscienza (cfr. HEGEL, Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio, III, Filosofia dello spirito, trad. it. A. Bosi, UTET, Torino, 2005, §§428-430, pp. 270-272).
22 HEGEL, Lezioni sulla filosofia della storia, cit., pp. 210-11.
23 Cfr. I. KANT, “Determinazione del concetto di razza umana” [1785], in: Id., Scritti di storia, politica e diritto, [a cura di F. Gonnelli], Laterza, Roma-Bari, 2007, pp. 87-102.
24 Hegel, Enciclopedia, III, cit., § 393, Aggiunta, p. 124.
25 Quanto segue riassume il contenuto dei §§ 79-82 di HEGEL, Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio, I, La Scienza della logica, trad. it. V. Verra, UTET, Torino, 1981, pp. 246-256.
26 HEGEL, Enciclopedia, I, cit., § 81, p. 250.
27 Ci pare interessante notare come le più recenti considerazioni geopolitiche sull’Adriatico, che lo ricollocano nel quadro della fine delle ideologie e dei blocchi contrapposti e alla luce della tesi che la politica mondiale si stia ristrutturando su assi culturali, con la convergenza di paesi affini per civiltà, osservino che esso è l’unico mare del Mediterraneo «dove non semplicemente due, come altrove accade, ma ben tre delle nove civiltà individuate da Huntigton entrano in contatto: l’occidentale, dalla parte italiana e dalla parte opposta sino all’altezza delle bocche di Cattaro; ’ortodossa, lungo la costa montenegrina; l’islamica, in Albania. A soltanto un altro mare al mondo, il Mar del Giappone, che separa quest’ultimo dalla Corea e dai territori dell’ex Unione Sovietica, si interpone tra altri tre diversi insiemi culturali, ’ortodosso, il sinnico e il giapponese. Ma nemmeno là il diaframma liquido è così uniforme e sottile come in Adriatico» (F. FARINELLI, L’eccezione adriatica, in “Lettera internazionale”, cit., p. 5).
28 Cfr. HEGEL, Enciclopedia, II, cit., §254, Aggiunta, p. 106.
29 HEGEL, II, cit., § 350, Aggiunta, p. 448.
30 HEGEL, Lezioni di filosofia della storia, cit., pp. 216-7.
31 Nel 1881, nella sua prefazione a una guida turistica del Danubio, per una filosofia hegeliana degli spazi naturali e umani da Passau a Linz, Ferdinand Zoehrer celebra il fiume del futuro, via commerciale più importante fra Oriente e Occidente le cui onde «trasportano continuamente la cultura verso est» (Cfr. Signori, si parte! Come viaggiavamo nella Mitteleuropa 1815-1915, a cura di M. bRESSAN, Mariano del Friuli, Edizioni della Laguna, 2011, p. 161). A Trieste, le linee di navigazione vapore del LLoyd Austriaco verso l’Oriente, sin dalla prima metà dell’800, verso Istria e Dalmazia (1845), e poi verso le Americhe, sono tutti esempi per cui Hegel fornisce un quadro teorico di riferimento quando sottolinea che fra America ed Europa il contatto è più facile di quanto sia nell’interno dell’Asia o dell’America. 32 Cfr. F. ¢ASSANO, Come I gabbiani. L’Adriatico per completare l’Europa, in: “Lettera internazionale”,cit., p. 11.
33 Cfr. C. sCHMITT, Terra e mare. Una riflessione sulla storia del mondo [1942], trad. it. G. Gurisatti. Con un saggio di F. Volpi, Adelphi, 2002.
34 HEGEL, Lezioni di filosofia della storia, cit., pp. 219-20.
BIBLIOGRAFIA
BRESSAN m. (a c. di), Signori, si parte! Come viaggiavamo nella Mitteleuropa 1815-1915. Mariano del Friuli, Edizioni della Laguna, 2011.
CANOVA G., FARINOTTI l. (a c. di), Atlante del cinema italiano. Corpi, paesaggi, figure del contemporaneo. Milano, Garzanti, 2011.
DAINOTTO R. M., Europe (in Theory), Durham and London, Duke Universty Press, 2007.
D’AGOSTINI F., Breve storia della filosofia del Novecento. L’anomalia
paradigmatica, Torino, Einaudi, 1999.
GALLIO G., Trieste dove. Giardinieri al limite della pianura, Trieste,
Edizioni e, 2008.
KANT I., “Determinazione del concetto di razza umana” [1785], in: Id., Scritti di storia, politica e diritto, [a cura di F. Gonnelli], Laterza, Roma-Bari, 2007, pp. 87-102.
HEGEL G.fi.F., Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio, II,
Filosofia della natura, trad. it. V. Verra, Torino, UTET, 2002.
HEGEL G.fi.F., Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio, III,
Filosofia dello spirito, trad. it. A. Bosi, UTET, Torino, 2005.
HEGEL G.fi.F., Lezioni sulla filosofia della storia, I, trad. it. G. Calogero e
- Fatta, Firenze, La Nuova Italia, 1978
HEGEL G.fi.F., Scienza della logica, I, trad. it. A. Moni, rivista da C. Cesa,
Roma-Bari, Laterza, 1999.
HEGEL G.fi.F., Vorlesungen über die Logik, Berlin 1831. Nachgeschrieben
von Karl Hegel (a cura di U. rAMEIL),
Geografia
La geografia (dal latino geographia, a sua volta dal greco antico: γῆ, “terra” e γραφία, “descrizione, scrittura”) è la scienza che ha per oggetto lo studio, la descrizione e la rappresentazione della Terra nella configurazione della sua superficie e nella estensione e distribuzione dei fenomeni fisici, biologici, umani che la interessano e che, interagendo tra loro, ne modificano continuamente l’aspetto.
La geografia è molto più che la cartografia, cioè lo studio delle mappe, o la topografia. Rispetto ad esse, infatti, la geografia aggiunge l’indagine della dinamica e delle cause della posizione della Terra nello spazio, dei fenomeni che avvengono su di essa e delle sue caratteristiche.
Tra i popoli dell’area circum-mediterranea, i primi ad elaborare un vero concetto di geografia sono stati i Greci, dai quali deriva appunto il nome in uso in Occidente. Eratostene (al quale si deve anche l’introduzione del nome) introdusse l’uso delle coordinate sferiche (latitudine e longitudine) per individuare le località geografiche. Importanti progressi furono poi compiuti da Ipparco di Nicea, che in particolare introdusse l’uso di metodi astronomici per il calcolo delle longitudini.
Il primo geografo romano di cui abbiamo notizie fu Pomponio Mela che scrisse il breve trattato Chorogràphia; poi il greco Strabone (vissuto fra il I secolo a.C. ed il I secolo d.C.), compose un’imponente Storia (pervenutaci solo in pochi frammenti) ed una non meno importante e completa Geografia, che invece ci è giunta in buone condizioni. L’opera di Strabone è tuttavia qualitativa e non usa le tecniche di geografia matematica che erano state introdotte da Eratostene e Ipparco.
Lo studio della geografia matematica fu ripreso nel II secolo d.C. da Marino di Tiro e, soprattutto, da Claudio Tolomeo, la cui Geografia non solo riporta le coordinate sferiche di 8000 diverse località, ma espone anche i metodi di proiezione usati nella cartografia.
Il Medioevo, come con altre scienze, dovette prima difendere (nelle biblioteche monastiche) quanto avevano prodotto gli antichi dalle distruzioni operate dai barbari, poi ricominciare a produrre opere nuove, che hanno per noi oggi l’aspetto di cataloghi, o carte molto approssimate e addirittura spesso inventate. Spiccano però le mappe della cartografia nautica, per la loro precisione ed accuratezza (spesso corredate da testi contenuti in un libro portolano), soprattutto quelle realizzate nell’Europa meridionale. Anche i geografi Arabi crearono opere di estrema qualità, come per esempio il “Libro del Re Ruggiero”, di Idrisi (del XII secolo), e altri autori ancora come Ibn Battuta e Ibn Khaldun.
Con le grandi esplorazioni terrestri dirette in Asia (Il Milione di Marco Polo, nel XIII secolo, ne è un esempio affascinante) e quelle marittime, o ancora verso l’Asia o verso le Americhe, l’uomo “riscoprì” la passione per la geografia, e il bisogno di uno studio più accurato. Nella seconda metà del XV secolo la riscoperta in Europa dell’opera geografica di Tolomeo fu essenziale per la rinascita della cartografia. Sono infatti di quell’epoca i primi atlanti europei ottenuti con l’uso dei metodi della cartografia matematica. Al XVII secolo risalgono i tentativi di Varenio di sistemare la scienza geografica.
Nel Settecento si cominciò a intendere come scopo principale della geografia la raccolta di dati sulle caratteristiche fisiche, sociali, economiche, storiche di ogni paese.
Nell’Ottocento nacque la cosiddetta geografia moderna, per merito (soprattutto) dei tedeschi Alexander von Humboldt (che ne fondò l’indirizzo naturalistico) e Carl Ritter (che ne fondò l’indirizzo antropico-storico): con il passare del tempo questi due indirizzi si fusero poi in uno solo. Presto divenne una disciplina universitaria, a cominciare da Parigi e Berlino.
Negli ultimi due secoli, la quantità di conoscenze e il numero di strumenti disponibili sono aumentati molto. Ci sono forti legami tra la geografia e le scienze di geologia e botanica, come anche economia, sociologia e demografia. Nel XX secolo, in occidente, la disciplina geografica venne esaminata in quattro diverse fasi: determinismo geografico, geografia regionale, rivoluzione quantitativa e geografia critica.
La “rivoluzione quantitativa” della geografia si diffonde a partire dagli anni Sessanta, grazie anche allo sviluppo delle tecniche statistiche e matematiche. Questa “rivoluzione” porta a un rinnovamento della geografia, infatti si inserisce il termine di “nuova geografia” poiché si spera di racchiudere ogni fatto e avvenimento geografico entro una misurazione espressa quantitativamente e perciò la possibilità di capire (attraverso algoritmi matematici e strumentazioni computerizzate), le relazioni tra fenomeni molto diversi che l’osservazione di una singola persona o studioso non avrebbe potuto indicare con perfetta precisione. Questa nuova concezione della geografia, nella seconda metà degli anni Settanta viene quasi rigettata perché si sostiene che i dati raccolti non sono sempre affidabili e questo può portare a conclusioni contrastanti.
Il pensiero anarchico
A cura di Silvia Ferbri
“Vuoi rendere impossibile per chiunque opprimere un suo simile? Allora, assicurati che nessuno possa possedere il potere” (M. Bakunin)
È possibile accostare il pensiero anarchico alla filosofia? Se “filosofia” significa amore per il “sapere”, ricerca mai conclusa del “sapere”, del “conoscere”, del “comprendere”, forse non sono molte le correnti filosofiche dall’età moderna in poi, pur così nominate, a poter rivendicare per sé questa qualifica in senso pieno. La maggior parte di esse si limita infatti ad offrire una specifica visione del mondo o dell’uomo, spesso dettagliata e argomentata, il più delle volte considerata un punto di arrivo. Non è anche l’anarchia una particolare dottrina politica, legata a un determinato momento storico? Se approfondiamo un poco la conoscenza di questo pensiero, ci renderemo conto che una definizione più corretta può essere invece “dottrina etico-politica” (molti pensatori anarchici si sono occupati di problemi etici, basti l’esempio di Kropotkin), e se andiamo ancora avanti nella nostra esplorazione, alla fine arriveremo a concludere che può essere ancora più opportuno riconoscerla come “filosofia etico-politica”, e attribuirle quindi lo spazio a cui ha pieno diritto all’interno del pensiero filosofico in senso lato. Potremmo anche dire, rifacendoci ad Aristotele, che si tratta di una “filosofia pratica”, in quanto caratterizzata dall’azione, sia come scopo che come oggetto.
Ma per rispondere con maggiore certezza a simili domande e affrontare con la massima apertura e disponibilità questa ricerca, occorre innanzitutto abbandonare i vari pregiudizi, chiarirci il più possibile le idee, e cioè partire dall’inizio. Il termine “anarchia” è infatti ancora un po’ troppo avvolto nella confusione. Muoviamo allora dalle origini, dal significato della parola “anarchia”.
Il termine “an-archia” deriva dal greco “αναρχία”, parola composta dalla radice α-(a-), senza, e dalla radice αρχ- (arch), governo, dominio, e viene solitamente tradotto con le espressioni “senza-comando”, “senza-potere”, “senza-autorità”. “Archi” (archi), primo termine di numerosi composti, deriva dal verbo “archein”, archein, comandare. Così “archia”, archia, da “archos”, archos, “arca”, nelle parole composte dotte significa “governo”, “dominio” (mon-archia, olig-archia) e “an-archos”, an-archos, può essere pertanto tradotto “senza un superiore”. Ma si considera anche, come secondo termine, “arch ”, arché, che unito alla radice α- diviene “an-arch”, an-arché. “Arché” però, prima ancora di “comando”, “potere”, “autorità”, significa “principio”, “origine e fine di tutte le cose”, perciò “anarchia” può anche voler dire “senza principio”, “senza divinità”, “senza dogmi”.
Una delle definizioni del pensiero anarchico (in forma sintetica) è infatti “né Dio né padrone”. Sébastien Faure disse: “Chiunque neghi l’autorità e combatta contro di essa è un anarchico”. Definizione molto semplice, e per questo incompleta e alla fine fuorviante. Il pensiero anarchico è in realtà un pensiero complesso, policromo, talvolta contraddittorio. Semplificarlo non aiuta a conoscerlo e a liberarsi dalla confusione cui accennavamo prima. E’ un pensiero che ha una sua storia peculiare e un proprio originale nucleo teorico-concettuale, che lo distingue da altre dottrine politiche, come il socialismo o il liberalismo, e che lo rende in un certo senso più ampio di queste, in quanto tende ad occuparsi dell’intera vita umana e non soltanto della gestione politica o di quella economica. Ma ciò che soprattutto lo distingue dalle altre dottrine politiche, è che per l’anarchismo non esiste una “umanità astratta” (di cui invece trattano tanto il liberalismo quanto il socialismo di stato e il comunismo autoritario), ma singoli uomini concreti. Il pensiero anarchico pertanto, diversamente dalle altre dottrine politiche, non ritiene di aver compreso per via filosofica la “natura” dell’uomo, e non si considera legittimato a prescrivere un codice morale e un’etica di comportamento che implichino diritti e doveri uguali per tutti gli uomini. Nell’anarchia è di fondamentale importanza l’autodeterminazione dell’individuo, di ogni singolo individuo, che è unico e diverso da tutti gli altri, e il suo totale e pieno diritto di scelta, di consenso o di rifiuto. Potremmo provare a definirla quindi una filosofia della libertà. Ma anche così otteniamo una definizione in un certo senso riduttiva e vaga al tempo stesso. Quello anarchico non è un pensiero che rimane tale: è un pensiero legato strettamente all’azione, dando immediata origine all’”anarchismo”. Precisando meglio, l’anarchismo non deriva da riflessioni astratte di qualche intellettuale o filosofo, ma dalla lotta diretta dei lavoratori contro il capitalismo, dalla ribellione degli oppressi contro i loro oppressori, dai bisogni e dalle necessità di questi uomini e dalle loro aspirazioni di libertà ed eguaglianza. I pensatori anarchici, quindi, come Bakunin o Kropotkin, non inventarono l’idea dell’anarchismo, semplicemente la scoprirono nelle masse oppresse e sfruttate e la rafforzarono, la chiarirono e la divulgarono. E’ l’azione pertanto che dà origine al pensiero. Il fine ultimo dell’anarchismo è infatti quello di un cambiamento sociale. L’anarchia critica la società esistente, di conseguenza non respinge il potere terreno in base a considerazioni prettamente filosofiche o religiose (come i mistici o gli stoici, ad esempio).
Per inciso, si può, senza eccedere in fantasia, tanto per quanto riguarda il pensiero anarchico come per altri pensieri “moderni”, fare accostamenti in alcuni punti con correnti filosofiche più antiche, e in questo caso quindi rilevare alcune somiglianze tra il pensiero anarchico e lo stesso stoicismo, ad esempio, per la sua visione cosmopolita, o ancora meglio lo scetticismo, per il suo rifiuto di ogni dogma, o l’epicureismo, per la sua concezione materialistica e atomistica, per il suo contatto con la realtà concreta, per la scelta della situazione, delle persone e dei fatti che meglio si armonizzano con la costituzione intellettuale dell’individuo, per l’esclusione delle sterili dispute sulle questioni “supreme”, per la pluralità delle ipotesi, per la vita piacevole accompagnata però dalla rinuncia “al più”, quindi la semplicità e non lo spreco, per il suo rifiuto dell’attività politica fine a se stessa, o, ancora, si può accostare il pensiero e il sentire anarchico ad alcuni aspetti del libertinismo, per il suo richiamo alla dignità e all’autonomia della ragione dell’uomo, per il suo volersi emancipare da ogni forma di servitù intellettuale e per la sua ribellione morale alla legge e alla tradizione invecchiata, a tutto ciò che non permette all’uomo di liberare la sua creatività, quindi per quel suo spirito innovativo, scanzonato e ribelle. Portiamo dentro di noi in vari modi l’intera storia del pensiero che ci ha preceduti, che spesso riemerge in forme nuove.
Riprendendo il filo del discorso, l’anarchia, come abbiamo osservato, non sogna un mondo ultraterreno. Si occupa di questo, dove ora ci troviamo a vivere. Non si esaurisce in desideri o fughe individuali. Né si è mai considerata un pensiero elitario. E’ un pensiero concreto e radicato nel mondo che lo circonda, aperto a tutti quanti gli uomini. Esistono infatti sia il pensiero anarchico che il movimento anarchico, nelle sue varie fasi, forme ed espressioni. E sono qualcosa di inscindibile. Uno non può esistere senza l’altro. L’anarchia in senso astratto non ha senso per gli anarchici, ciò che essi desiderano è realizzarla concretamente, qui e ora. Le idee da sole non significano nulla: vanno messe in pratica nella vita di tutti i giorni, in quella pubblica come in quella privata (per gli anarchici non esiste questa distinzione, così come non esiste distinzione tra i mezzi e il fine che si vuole raggiungere; non si può voler ottenere la libertà, ad esempio, restringendola o negandola), tentando di realizzare in ogni gesto, singolarmente e in comunione con gli altri, quel mondo più umano, più libero, più giusto, che è al centro dell’ideale anarchico. A questo punto è necessario osservare come invece nell’immaginario della maggioranza degli individui il termine “anarchia” venga associato al caos, al disordine, alla violenza. O all’individualismo e all’egoismo. Oppure, anche riconoscendola come dottrina socio-politica, si tende ad accostarla al “nichilismo” o al “terrorismo”. Tutto questo avviene perché tanto la storia del pensiero anarchico quanto quella del suo movimento sono ben poco conosciute e sono sempre state tenute in ombra. Non è facile così riuscire a capire che anarchia non significa affatto disordine: caso mai il suo contrario, nel senso che gli anarchici tentano di ritrovare, di ricostituire quello che per loro è l’”ordine naturale” delle cose e della vita, deformato e stravolto nel tempo dalle varie forme di sopraffazione, di dominio, di sfruttamento e di potere. Come pensare che uomini come Tolstoj e Godwin, Thoreau e Kropotkin, le cui teorie sociali sono state definite anarchiche, volessero portare nient’altro che il caos, il disordine, la violenza nella società? Altrettanto difficile è in genere comprendere come il rispetto per la libertà dell’individuo, del singolo, visto spesso, in modo errato, unicamente come esaltazione del singolo, come puro egoismo, possa unirsi alla solidarietà nei confronti degli altri, in particolare nei confronti degli ultimi, degli emarginati, degli oppressi.
L’immagine distorta dell’idea anarchica ha diverse cause. Una può forse essere imputata agli stessi anarchici o a una parte di loro, e cioè a quella propaganda che poneva principalmente l’accento sugli aspetti distruttivi della dottrina. Ma non è mancata in realtà neppure la propaganda contraria, quella propositiva e costruttiva, sostenuta costantemente, tra l’altro, da concreti esempi di vita. La ragione principale, invece, parrebbe essere la versione spesso faziosa, in ogni caso superficiale, fornita da sempre dalla storiografia, tanto di destra quanto di sinistra (con grosse responsabilità da parte dei marxisti, a cominciare da Marx in persona, che qualificò l’anarchismo come una ideologia piccolo borghese, espressione immatura, disorganica e unicamente individualistica di ceti sociali in crisi per la disgregazione del mondo contadino e artigiano, e non ancora inseriti nel processo di produzione capitalistico, senza considerare lo scontro di potere all’interno della Prima Internazionale dei Lavoratori). Non di certo ultima, un’altra ragione è il fatto in sé evidente che il pensiero anarchico non piace a chi è al potere (o a chi il potere lo ama o lo condivide): anarchia e potere sono nemici da sempre. (Così come anarchia e gerarchia, anarchia e autoritarismo, anarchia e verticismo). Gli anarchici non vogliono conquistare il potere (neppure in “nome del popolo”), vogliono eliminarlo. In altre parole si può dire che vogliono frantumarlo e ridistribuirlo in migliaia e migliaia di piccole unità, tante quanti sono gli esseri umani. I governi perciò, di qualsiasi colore, hanno sempre dato la caccia agli anarchici, hanno cercato di metterli a tacere, hanno sempre tentato di accusarli di ogni atto di terrorismo o violenza e di ogni azione nei confronti della ricchezza e della proprietà privata, così come nei confronti del capitalismo di stato e della sua burocrazia tirannica, tutte cose che gli anarchici desiderano abolire e che i governi e le loro polizie intendono invece difendere ad ogni costo. L’ineguale distribuzione della ricchezza e la proprietà privata, così come il potere di pochi sulla vita dei molti, sono alla base stessa dell’esistenza dei governi e della polizia, secondo l’analisi anarchica ma non solo. Nei nostri tribunali si dovrebbe amministrare la giustizia. Ma come si può considerare giusto, equo, il mondo in cui viviamo? Questo è quanto gli anarchici si chiedono e mettono da sempre in discussione.
Quali sono dunque i caratteri fondamentali del pensiero anarchico? Quali i suoi valori di riferimento? Prima di tutto: quando hanno cominciato ad essere effettivamente utilizzate le parole “anarchia”, “anarchismo”, “anarchico”?
Durante la Rivoluzione francese il girondino Brissot definiva anarchici il movimento degli Enragés, e nel 1793 dava questa definizione dell’”anarchia”: “Leggi non tradotte in effetto, autorità prive di forza e disprezzate, il delitto impunito, la proprietà minacciata, la sicurezza dell’individuo violata, la moralità del popolo corrotta, nessuna costituzione, nessun governo, nessuna giustizia: queste le caratteristiche dell’anarchia.” Definizione quindi del tutto negativa, rafforzata in seguito dal Direttorio, che sarebbe sceso addirittura alle ingiurie: “Per «anarchici» il Direttorio intende quegli uomini carichi di delitti, macchiati di sangue, impinguati dalle ruberie, nemici di tutte le leggi che non sono state fatte da loro, di tutti i governi in cui loro non governano...”
Possiamo invece attribuire una prima riconoscibile e coerente formulazione del pensiero anarchico all’illuminista inglese William Godwin (1756-1836), quando venne data alle stampe nel 1793 la sua opera Enquiry Concerning Political Justice (che si basa su di un assunto di matrice liberal-libertaria, già sviluppato tra gli altri da Thomas Paine, John Locke e Thomas Jefferson, e cioè la contrapposizione tra la società, considerata naturale e buona, e il governo, lo stato, ritenuto artificioso e malvagio, nato in un’epoca di immaturità della ragione e che si basa unicamente sulla forza, al di là delle varie giustificazioni mitiche sulle quali pretende di reggersi) mentre il primo ad adottare orgogliosamente per sé il termine “anarchico” fu il pensatore francese socialista Pierre Joseph Proudhon, nel suo Che cos’è la proprietà? che uscì nel 1840. “Quale dev’essere la forma del governo nel futuro? Sento alcuni dei miei lettori rispondere: «Ma via, come puoi fare una domanda simile? Tu sei un repubblicano.» Un repubblicano! Si, ma questa parola non dice ancora nulla di preciso. Res publica significa la cosa pubblica; chiunque si interessi alla condotta della cosa pubblica, sotto qualsiasi forma di governo, può dunque chiamarsi repubblicano. Persino i re sono repubblicani. «Ma tu sei un democratico.» Neanche per sogno….«Che cosa sei allora?» Sono un anarchico!”. Proudhon, convinto che nella società operi una legge naturale d’equilibrio, ritenne l’autorità nemica e non amica dell’ordine, e ribaltò così le accuse rivolte agli anarchici, rivolgendole a sua volta ai fautori del principio autoritario.
Possiamo citare come valori di riferimento quelli emersi dalla Rivoluzione francese: libertà, eguaglianza, solidarietà. (Valori che non hanno poi trovato, a seguito di quella lunga e sanguinosa vicenda, la loro vera e piena applicazione e realizzazione, essendo si in questo caso espressione dell’emergente borghesia, o almeno essa se ne impadronì e li adoperò per i propri interessi).
Anche il liberalismo e il socialismo fecero propri questi valori, ma l’interpretazione anarchica è profondamente diversa: se per il socialismo il valore principale di riferimento è l’uguaglianza e per il liberalismo la libertà, per l’anarchismo tali valori sono del tutto inscindibili e non possono che darsi contemporaneamente. Non vi può essere libertà senza uguaglianza né uguaglianza senza libertà. E la solidarietà verso gli oppressi è sempre presente. L’anarchismo quindi fa riferimento a questi valori, ma in un modo ben preciso, rigoroso e totale. Ciò che è importante rilevare è che l’affermazione anarchica della libertà, individuale e sociale, è radicale e completa, e si unisce all’altrettanto radicale critica nei confronti del principio di autorità, nei confronti del potere e del dominio in quanto tale.
L’anarchismo ne ha combattuto perciò ogni manifestazione storica, in particolare la forma politica assunta dal dominio nella società moderna: lo stato. La critica anarchica non nasce isolata: pensiamo alle svariate espressioni di lotta al potere, tanto religioso che politico, tanto culturale che economico- sociale che percorrono l’era moderna, fino a giungere alla decapitazione di un re sulla piazza della Rivoluzione a Parigi. Ma la critica anarchica appare l’approdo ultimo e quello più radicale e completo, che non accetterà mai compromessi e continuerà a negare ogni tipo di società scissa in governanti e governati. Continuerà a criticare e combattere l’autoritarismo in ogni sua forma, le gerarchie, le istituzioni oppressive nemiche dell’autodeterminazione e della libertà, le disuguaglianze e le ingiustizie sociali, quindi la proprietà privata, l’appropriazione della ricchezza, lo sfruttamento del lavoro altrui, e in tempi più recenti lo sfruttamento delle risorse naturali e ambientali, lo sfruttamento animale, l’inquinamento e lo spreco. Gli anarchici allora, ci si può chiedere, sono contro o a favore del progresso? La risposta è semplice: l’anarchico non concepisce il progresso come continuo e sfrenato aumento della ricchezza materiale e del consumo, dello sfruttamento tanto del lavoro quanto delle risorse, come distruzione dell’ambiente, come incremento della complessità della vita, ma piuttosto come moralizzazione della società attraverso l’abolizione dell’autorità, dell’ineguaglianza, dello sfruttamento economico e ambientale, e, insieme, come offerta ad ogni singolo essere umano, e a tutti quanti gli uomini, delle stesse possibilità di sviluppo individuale in termini di benessere, cultura, qualità della vita, senza privilegi o discriminazioni di sorta (economiche, etniche, razziali, di genere…). L’anarchismo critica inoltre le barriere nazionali e le disuguaglianze tra i popoli, e il concetto di patria, in nome della quale troppi uomini hanno perduto inutilmente la vita. Non le guerre tra i popoli, tra gli oppressi, quindi, ma un’unica guerra agli oppressori, ai potenti, che per i loro interessi hanno sempre sacrificato la vita dei giovani, dei lavoratori, dei proletari.
A fianco della critica e della lotta, il sogno e il progetto di una società di liberi ed uguali. Una società armonica, che ritrovi il suo proprio equilibrio e quello con la natura intorno a sé.
Come deve essere composta, organizzata la società secondo il pensiero anarchico?
Innanzitutto, nessuna divisione tra governanti e governati, come abbiamo visto.
L’amministrazione degli affari sociali ed economici sarà affidata a piccoli gruppi locali, libere associazioni tra individui, senza regie dall’alto, senza padroni o capi di alcun genere. Quindi federazioni di comuni e di lavoratori, coordinate tra loro in modo circolare e orizzontale, fondate sull’autogestione e la cooperazione, una rete organica di interessi che si equilibrano a vicenda, basata sulla naturale tendenza degli uomini ad aiutarsi reciprocamente, senza necessità alcuna di schemi artificiali di coercizione (mutualismo ed associazionismo, ad esempio, fanno parte della storia del movimento anarchico). La produzione sarà il più possibile locale e differenziata a seconda del terreno, l’industrializzazione non sarà sfrenata e massiccia, avrà grande importanza l’artigianato, il lavoro concreto, bello, creativo, gli oggetti fatti per durare e non “usa e getta” come è nella logica del consumismo. L’impatto ambientale dovrà essere il più basso possibile. L’anarchia non è una forma estrema di democrazia: se nella democrazia sovrano è (teoricamente) il popolo, per gli anarchici “sovrano” deve essere l’individuo, che non ha alcun bisogno di delegare ad altri la gestione dei suoi interessi né di essere “rappresentato”, e che ha pieno diritto di scelta. Inoltre, il pensiero anarchico nega il diritto di qualsiasi maggioranza di imporre la sua volontà a una minoranza. Nega quindi valore in sé alle leggi degli uomini. “Qualsiasi legge deve comparire prima di tutto davanti al tribunale della nostra coscienza.” disse Elisée Reclus, geografo anarchico francese protagonista della Comune di Parigi. “V’è un solo potere”, scrisse Godwin, “al quale posso prestare un’obbedienza convinta: la decisione della mia intelligenza, il comando della mia coscienza.”. L’anarchismo rifiuta poi, oltre a qualsiasi forma di monopolio dei mezzi di produzione e dei prodotti, così come del sapere, la divisione gerarchica del lavoro (intellettuale e manuale) e qualsiasi dicotomia e antagonismo tra città e campagna, tra mente e corpo. Né può l’anarchismo essere qualificato come “ideologia”, perché sempre aperto, mai dogmatico, contrario da sempre a qualsiasi astratta norma morale e a qualsiasi servitù del pensiero.
Questo sogno e questo progetto sono stati descritti e rincorsi in modi diversi: l’anarchismo non possiede una sola anima, al suo interno hanno sempre convissuto approcci differenti, tra cui quello rivoluzionario tout court, che considera legittimo il ricorso alla violenza per distruggere gli istituti del dominio, quello gradualista, basato principalmente sulla costruzione graduale e pacifica, quello educazionista o “pedagogico”, che mette al primo posto l’educazione del popolo, la diffusione di una cultura libertaria e il risveglio delle coscienze, anche se queste distinzioni sono in qualche modo arbitrarie e discutibili, un po’ perché i confini non sono così netti e poi perché l’anima più profonda è in realtà una sola, ed è l’amore per la libertà nella sua espressione più alta. Solo una autentica libertà in questa vita e in questo mondo può rendere felici gli uomini e in grado di sviluppare al meglio le loro qualità di esseri umani. A questo ideale di libertà (tutt’altro che egoistico) molti anarchici hanno dedicato o sacrificato la propria vita. Tutti questi modi, o correnti, rappresentano in ogni caso un progetto che in sé è sempre rivoluzionario. L’utopia anarchica, lungi dal rifugiarsi in un mondo fantastico, perduto in un remoto passato o in un ipotetico e improbabile futuro, è essenzialmente concreta, perché si fonda e muove da una approfondita critica dell’esistente, ed è l’esistente a dover essere capovolto e trasformato.
La rivoluzione, per gli anarchici, è da intendersi prima di tutto rivoluzione sociale, non meramente politica. E’ la rivoluzione del popolo. Ed è proprio per questo che ad ogni rivoluzione del popolo (che ne fosse promotore o partecipe con altre classi sociali) è sempre stato impedito di andare avanti oltre un certo punto, è per questo che ogni rivoluzione che voleva essere rivoluzione sociale oltre che politica è stata soffocata e tradita. Il potere e i privilegi (contro cui il popolo lottava) non dovevano scomparire, infatti, ma solo passare di mano. E la lotta del popolo è servita a questo, è stata strumentalizzata a questo scopo da chi di volta in volta ha assunto la regia della rivoluzione. La rabbia e la volontà di lotta e di cambiamento sociale espresse dal popolo sono state usate finché potevano essere utili, poi messe da parte, tradite o punite duramente quando non ve ne era più bisogno. Questa vicenda si è ripetuta più di una volta nella storia, con le varie differenze dovute al contesto, al luogo e al periodo, che si tratti della rivoluzione inglese, francese, messicana, russa, spagnola. E’ una storia poco conosciuta e compresa, e che solo gli anarchici hanno raccontato fino in fondo.
Per quanto riguarda l’uso della violenza, bisogna innanzitutto osservare che anarchia significa non-violenza, dal momento che significa non-imposizione dell’uomo sull’uomo, come sottolineava l’anarchico Errico Malatesta (1853-1932). La società alla quale tende l’anarchismo è infatti una società pacifica. Le differenze sono emerse nel momento di scegliere (a seconda anche delle circostanze e del momento storico contingente, ad esempio sotto una dittatura, o appunto nel corso di una rivoluzione) quali mezzi adoperare per raggiungere o avvicinarsi alla società desiderata, quindi ci sono stati coloro che hanno adottato l’uso individuale della violenza, altri invece un suo uso di massa, ma sempre come unica scelta possibile all’interno della realtà concreta e determinata in cui si sono trovati a dover agire. E la violenza da usare è sempre soltanto quella necessaria, niente di peggio o di più.
Per quanto riguarda invece l’educazione libertaria, si tratta di un approccio che mette al primo posto un rapporto paritario e non gerarchico tra l’adulto e il bambino e tra ogni educatore e i suoi allievi, e la possibilità offerta al bambino e ad ogni essere umano di realizzare completamente se stesso, di svilupparsi liberamente, senza imposizioni, costrizioni, premi, castighi. Quindi rifiuto dell’autorità, rispetto della libertà e delle propensioni individuali, progettualità autogestionaria, libertà di pensiero e di giudizio, “educazione integrale”, inserendo così l’educazione libertaria in una più ampia visione politica. Uno dei primi sostenitori dell’autonomia e dell’indipendenza del bambino fu proprio William Godwin, respingendo ogni tipo di coercizione nel processo educativo ed evidenziando la necessità di svincolare l’istruzione dal controllo dello stato, affinché l’istruzione non sia uno strumento del controllo sociale e un mezzo per rafforzare la visione e l’impostazione gerarchica e anti-libertaria della società. Temi analoghi li ritroviamo in Charles Fourier (1772-1837), secondo il quale nell’azione educativa occorre ridurre al minimo l’esercizio dell’autorità e permettere lo sviluppo di tutte le potenzialità della persona e in Max Stirner (1806-1865). Il concetto fourieriano di “educazione integrale” (un’educazione che comprenda in egual misura attività manuali ed intellettuali) verrà ripreso da molti pensatori anarchici, tra cui Pëtr Kropotkin (1842-1921) Altri anarchici che si sono interessati all’importanza dell’educazione libertaria sono stati gli italiani Errico Malatesta (1853-1932) e Camillo Berneri (1897-1937), vittima quest’ultimo come tanti altri della persecuzione da parte dello stalinismo nei confronti degli anarchici, in questo caso durante la rivoluzione spagnola del 1936. Gli esempi di scuole libertarie e antiautoritarie sono stati numerosi. La prima esperienza del genere è da attribuirsi a Lev Tolstoj (1828-1910), a Jasnaja Poljana tra il 1859 e il 1862, anno in cui la sua scuola verrà chiusa dalle autorità. Poi l’orfanotrofio francese di Cempuis diretto tra il 1880 e il 1894 da Paul Robin, esempio seguito da Sébastian Faure (1857-1942) con la sua scuola libertaria La Ruche (L’alveare), istituita fuori Parigi nel 1904, attiva fino al 1914, e poi ancora l’esperienza del libertario spagnolo Francisco Ferrer y Guardia (1859-1909) che fondò nel 1901 la sua Escuela Moderna a Barcellona, scuola laica e mista, con lo scopo di permettere ai ragazzi di diventare persone indipendenti, capaci di creare e vivere in una società libertaria (Ferrer verrà fatto fucilare dal governo spagnolo nel 1909), l’Université Nouvelle di Bruxelles fondata nel 1894 insieme ad altri dal geografo anarchico francese Elisée Reclus (1830-1905), che si terrà a lungo in contatto con Ferrer, con il quale collaborerà per i suoi programmi educativi in particolare riguardo l’insegnamento della geografia (nel 1896 uscì un Manifesto europeo anarchico per la fondazione di scuole libertarie, tra i primi firmatari troviamo Reclus e Kropotkin), la scuola libera di Summerhill fondata nel 1921 da Alexander S.Neill (1883-1973) nel Suffolk, fino ad arrivare al movimento delle Free Schools negli anni successivi al 1960 negli Stati Uniti e in Europa, che si richiamavano ai principi di Tolstoj, Neill e Paul Goodman (basate su principi libertari quali la cooperazione, l’autogestione del progetto da parte di tutti i soggetti coinvolti, il rifiuto di un’organizzazione burocratica e gerarchica, l’assenza di un’autorità formale), poi alle Freie Schulen in Germania a partire dagli anni Settanta, e ai vari esperimenti di licei autogestiti in particolare in Francia fino al caso più recente di Bonaventure, sorta sempre in Francia nel 1993 nell’Ile d’Oleron, scuola per bambini dai tre ai dieci anni.
Per quanto riguarda l’”individualismo anarchico”, occorre dire che rispetto all’anarchismo che si è espresso in Europa nell’età contemporanea è una acquisizione abbastanza recente. Se fino agli anni Ottanta dell’Ottocento il termine “individualista” era adoperato in chiave polemica nei confronti di ideologie di derivazione liberale, in seguito tale significato si modifica, in particolare a causa delle trasformazioni della società, che diviene poco a poco una società di massa. All’uniformità che si va imponendo, si contrappone per contrasto l’individualità, che non intende sottomettersi alle norme e alle convenzioni “borghesi”, termine, quest’ultimo, che non aveva all’epoca un vero e proprio significato classista. Certe forme di individualismo infatti si ricollegavano a una lunga tradizione di ribellismo letterario, piuttosto che appartenere all’associazionismo operaio o essere in continuità con l’Internazionale anarchica. Si tratta inoltre di un fenomeno tutt’altro che unitario, presentando tendenze ed espressioni alquanto disomogenee. All’interno del movimento anarchico comincia così a manifestarsi la propensione all’atto isolato o ad opera di piccoli gruppi, frutto di una scelta individuale o espressione orgogliosa di una totale autonomia, rispetto anche all’organizzazione anarchica, intorno alla quale si dibatteva significativamente in quegli anni, anche se il passaggio dall’individualismo antiorganizzatore tradizionale a quello che venne definito individualismo d’azione non è così automatico. Quest’ultimo infatti costituiva una tendenza minoritaria all’interno del movimento anarchico, tendenza che ebbe il suo culmine in tutta una serie di azioni dimostrative fino ai tragici attentati della fine dell’Ottocento. Veniva intanto precisata una teorizzazione dell’individualismo d’azione, tramite la parola d’ordine “propaganda mediante il fatto”. In seguito questi filoni anarcoindividualisti andarono perdendo vitalità. Alla vigilia della prima guerra mondiale ci fu tra di essi chi scelse l’interventismo, chi invece si oppose (come il movimento anarchico nel suo complesso) alla costrizione alla violenza da parte degli stati.
Esistono altre anime o sfumature dell’anarchismo. Tra queste ricordiamo l’anarcosindacalismo, i cui maggiori ispiratori furono Émile Pouget (1860-1931), Fernand Pelloutier (1867-1901), Paul Delasalle (1870-1848) e il danese Cristian Cornelissen (1864-1943). Molti anarchici italiani militarono nell’Unione Sindacale Italiana, U.S.I., sindacato di ispirazione anarco sindacalista il cui segretario fu Armando Borghi (1882-1968) nel corso del primo ventennio del Novecento e furono protagonisti di importanti lotte operaie. Stessa cosa avvenne in altri paesi europei e non solo. Molti anarchici e libertari militano tutt’oggi in diverse organizzazioni sindacali, tra cui la stessa USI, ricostituita alcuni anni dopo la seconda guerra mondiale, e altre organizzazioni all’estero, alla ricerca di un sindacalismo realmente autogestionario, un sindacato dei lavoratori, non compromesso politicamente, che sia anche in appoggio ad ogni altra categoria di persone in difficoltà, lavoratori precari, disoccupati, extracomunitari, senza tetto, non ponendo al primo posto quindi la difesa di interessi di tipo corporativo, ma lavorando sempre nell’ambito di una più ampia visione di trasformazione sociale. Ricordiamo ancora l’anticlericalismo, l’antimilitarismo, il femminismo, l’antipsichiatria, l’utopia, l’ecologia sociale, la lotta contro l’istituzione carceraria e contro il razzismo (attualmente contro i centri di permanenza per gli extracomunitari ad esempio, e in generale contro tutte le gravi discriminazioni e persecuzioni a cui sono soggetti gli uomini che nascono nelle zone meno fortunate del mondo), la lotta contro le discriminazioni sessuali (la difesa della piena libertà di scelta, tra cui la scelta omosessuale), gli esperimenti di comuni autogestite, laboratori dove mettere in pratica l’utopia e la libertà (esempio tipico la Colonia Cecilia, fondata da Giovanni Rossi con un gruppo di circa centocinquanta lavoratori italiani in Brasile, nel Paranà, nel 1890, ma tanti altri esperimenti hanno continuato ad avere luogo e tutt’ora continuano).
I principali pensatori anarchici
Non è facile un’esposizione dei pensatori anarchici o una scelta tra di essi. Occorre anche tenere presente che la maggior parte di loro non visse soltanto di pensiero ma soprattutto di azione, inserendosi a vari livelli nel movimento anarchico e nelle lotte sociali, le cui opere scritte vanno quindi in qualche modo a completare una testimonianza offerta innanzitutto con la propria vita. Quello che segue qui non è che un elenco del tutto ridotto e incompleto, che esclude forzatamente alcune grandi figure che si sono distinte in numerosi e drammatici eventi rivoluzionari, tra cui l’Ucraina machnovista (da Nestor Machno, leader del movimento ucraino) nel contesto della rivoluzione russa, la rivoluzione messicana (un nome dobbiamo farlo, ed è quello di Ricardo Flores Magón), la Catalogna libertaria durante la guerra civile spagnola, senza contare la partecipazione del movimento anarchico alla lotta contro il fascismo e alla Resistenza.
Dopo William Godwin (1756-1836) e Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865), cui abbiamo già accennato, e Max Stirner (pseudonimo di Johann Caspar Schmidt, 1806-1865), l’autore di Der Einzige und sein Eigentum (L’Unico e la sua proprietà) che uscì nel 1843, ricordiamo Michail Bakunin (1814-1876), grande rivoluzionario e pensatore russo, promotore dell’Internazionale Antiautoritaria dopo la rottura con Marx, autore di numerose opere tra cui Stato e Anarchia (1873), Pëtr Kropotkin (1842-1921), di cui sono da menzionare in particolare Il Mutuo Appoggio e L’Etica, (Kropotkin in maniera approfondita si è occupato tra il resto di problemi etici, muovendo da una rivisitazione critica del darwinismo ed elaborando il suo concetto del mutuo appoggio come fondamentale fattore evolutivo per tutte le specie viventi compreso l’uomo), quindi i francesi Elisée Reclus (1830-1905) e Jean Grave (1854-1939), vicini a Kropotkin insieme all’italiano Riccardo Mella (1861-1925). E ancora, per l’anarchismo italiano: Carlo Cafiero (1846-1892), Andrea Costa (1851-1910), Errico Malatesta (1853-1932), fondatore del quotidiano anarchico Umanità Nova e promotore dell’Unione Anarchica Italiana, Francesco Saverio Merlino (1856-1930), Pietro Gori (1865-1911), Luigi Fabbri (1877-1935), Camillo Berneri (1897-1937), uomini che insieme a tanti altri hanno dedicato la propria vita, in anni estremamente difficili, alla causa dell’emancipazione e della libertà, nel nostro paese e nel mondo intero. (E non ne abbiamo citato che alcuni). Purtroppo ancora oggi non sono in molti a sapere che cosa furono davvero quegli anni, a conoscere la portata del contributo anarchico e ad attribuire agli anarchici il posto che spetta loro nella storia politica e sociale della società italiana, per i motivi che abbiamo esposto in precedenza. Occorre quindi ricordare che la Prima Internazionale italiana fu principalmente anarchica, così come il primo socialismo italiano, e che solo in seguito esso diventò un socialismo riformista e parlamentarista. La storia del movimento anarchico italiano si sviluppa dalla nascita della Prima Internazionale allo scontro con i mazziniani prima (il nemico non appare più lo straniero, il nemico ora è il nemico di classe) e con i seguaci di Marx poi (contro l’autoritarismo e la gestione centralista), attraverso l’emergere delle correnti individualiste, nell’ambito dell’associazionismo operaio e del nascente sindacalismo di classe fino all’opposizione alla prima guerra mondiale, un movimento di grande ricchezza culturale e politica, che ha sempre lottato per la libertà e l’uguaglianza, per un grande ideale che doveva essere il “sol dell’avvenire” per l’intera società, soggetto pertanto costantemente alle persecuzioni più dure. Dopo le drammatiche vicende del periodo fascista, la seconda guerra mondiale e la partecipazione alla Resistenza, il movimento anarchico si ricostituisce in forme sempre nuove, dovute alle trasformazioni che si susseguono incessanti nel corso degli anni e al panorama sociale, politico ed economico che muta enormemente, continuando a portare avanti la sua ricerca della libertà e a tenere in vita il suo ideale di un mondo che sia davvero a misura d’uomo.
Storie in parte diverse hanno avuto gli anarchici negli altri paesi europei ed extraeuropei. Ricordiamo ad esempio il maggio francese del 1968, ma ovunque si lotti per la libertà, contro le oppressioni e le ingiustizie, contro le guerre e le occupazioni militari dei territori, gli anarchici non possono fare a meno di essere presenti. L’anarchismo continua a vivere oggi, sempre nel mirino della repressione, in una situazione e in un contesto che mutano e si trasformano ma soltanto in apparenza, perché il nodo centrale del dominio non è ancora stato sciolto. Il mondo odierno è gestito dalla pubblicità e dalla menzogna, dalle multinazionali, dal potere finanziario e militare, è un mondo molto più difficile da decifrare e comprendere rispetto a quello di un tempo, dotato di un controllo totale e onnipervasivo nei confronti degli esseri umani come mai prima, un mondo solo apparentemente democratico e libero, che propaganda in ogni modo la sua missione di difendere la “sicurezza” dei “cittadini”, ma che è invece ormai del tutto privo di libertà.
Molti intellettuali e artisti che si sono espressi in campi diversi da quello della riflessione politico-sociale in senso stretto possono essere compresi a buon diritto in questo sommario elenco, avendo mostrato una sensibilità affine in vari modi a quella anarchica. Nel campo della letteratura ricordiamo i poeti inglesi Samuel Coleridge (1772-1834), William Blake (1757-1827), Percey Bysshe Shelley, discepoli di Godwin, William Morris (1834-1896), autore del romanzo utopico News from Nowhere (Notizie da nessun luogo, 1891), Oscar Wilde (1854-1900), autore tra le altre sue opere di un breve saggio dove è evidente l’influenza di Kropotkin, L’anima dell’uomo sotto il socialismo, Lev Tolstoj (1828-1910), già ricordato, lo scrittore statunitense David Thoreau, autore di un trattato sulla disobbedienza civile, Franz Kafka, che espresse con forza un odio assoluto per il potere e la burocrazia, Henri Miller (1891-1980), libertino e libertario, in contatto con Emma Goldman (1869-1940), grande figura di donna anarchica e rivoluzionaria, le opere di George Orwell (1903-1950), Ignazio Silone (1900-1978), Albert Camus (1913-1960), e trascureremo qui gli autori della controcultura degli anni Sessanta, in particolare la beat generation e il Living Theatre. Anche nelle arti figurative c’è stato un fecondo incontro con l’anarchismo: Camille Pissarro, Carlo Carrà, André Breton, Enrico Baj ne sono un esempio. Nel cinema due nomi soprattutto sono significativi: Jean Vigo e Luis Buñuel. E ancora (dopo la pedagogia, già trattata): Lewis Mumford, Carlo Doglio, Giancarlo De Carlo per l’urbanistica, Pierre Clastres e Marc Augé per l’antropologia, Paul Feyerabend per la filosofia della scienza, Henri Laborit per la biologia, Thomas Szasz e Giorgio Antonucci per l’antipsichiatria.
Infine, in ordine sparso: Rudolf Rocker (1873-1958), intellettuale anarchico, i chansonniers francesi Brassens e Ferré, Paul Goodman (1911-1972) e Noam Chomsky (1928), Michel Foucault (1926-1984), Murray Bookchin (1921-2006), grande teorico dell’ecologia sociale, così definita in quanto afferma e dimostra che una vera trasformazione ecologica non può che basarsi su profonde trasformazioni sociali.
Ci si può davvero perdere nel tentativo di riconoscere temi e sentimenti anarchici: l’anarchia è infatti un modo di sentire e di essere, e alcuni suoi tratti o aspetti potrebbero essere scoperti un po’ ovunque e teoricamente in chiunque.
Ma torniamo all’ambito più strettamente filosofico, rispetto al quale, a questo punto, un interrogativo forse un po’ azzardato sembra presentarsi da sé e portarci a concludere questa breve esposizione.
Proviamo a considerare le principali caratteristiche della filosofia contemporanea. Come prima cosa rileviamo il carattere antimetafisico di gran parte di essa, essendo ormai venuto meno l’atteggiamento della tradizione filosofica che intendeva la conoscenza della “verità” come guida dell’azione umana e innanzitutto dell’azione morale e politica. Oggi si nega che l’esistenza dell’uomo possa avere un qualsiasi “fine” stabilito necessariamente dal posto assegnatogli “di diritto” nell’ordine dell’universo, e si riconosce invece che i fini dell’uomo sono soltanto quelli che egli sceglie liberamente: non ci troviamo più di fronte alla richiesta della contemplazione della verità del mondo, ma alla necessità della sua trasformazione pratica in base a progetti liberamente scelti e costruiti dall’uomo, nonché alla necessità di un’etica, ovvero di una responsabilità che occorre assumersi in questo mondo lacerato dai dolori e dalle ingiustizie. Se consideriamo poi che la filosofia ha un’altra fondamentale caratteristica, e cioè quella di mettere ogni cosa in dubbio e non prendere mai niente “per buono” (secondo Aristotele, come “scienza fine a se stessa” e non asservita ad altro, è l’unica a poter essere davvero libera), e che l’autentico filosofo è colui che è sempre alla ricerca, che pensa liberamente e autonomamente, che non si sottomette ad alcuna autorità di pensiero, non si arresta, non si accontenta e non si piega a una sola verità, che continua a porre in discussione qualsiasi presunta certezza, non ci viene spontaneo allora dedurne che non si può essere davvero filosofi, senza essere al tempo stesso anche un po’ anarchici?
BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE
William Godwin, La giustizia politica, Trimestre, Chieti, 1994
Carlo Pisacane, La rivoluzione, Cosenza, Brenner, 1989
Nello Rosselli, Mazzini e Bakunin. Dodici anni di movimento operaio in Italia (1860-1872), Einaudi, Torino, 1967
Michail Bakunin, Libertà, uguaglianza, rivoluzione, Antistato, Milano 1976
Michail Bakunin, Stato e anarchia, Milano, Feltrinelli, 1996
Pëtr Kropotkin, Campi fabbriche e officine, a cura di Colin Ward, Antistato, Milano, 1975
Pëtr Kropotkin, Il mutuo appoggio, Salerno, Roma, 1982
Pëtr Kropotkin, L’Etica, La Fiaccola, Ragusa,, 1990
Errico Malatesta, Rivoluzione e lotta quotidiana, Antistato, 1982
Emma Goldman, Anarchismo e altri saggi, La Salamandra, Milano, 1976
Pierre-Joseph Proudhon, Filosofia della miseria, Anarchismo, Catania, 1975
Pierre-Joseph Proudhon, Che cos’è la proprietà, Laterza, Bari, 1967
Max Stirner, L’Unico e la sua proprietà, Adelphi, Milano, 1991
Daniel Guerin, Né Dio né padrone, Jaca Book, Milano, 1970
George Woodcock, L’anarchia. Storia delle idee e dei movimenti libertari, Milano, Feltrinelli, 1966
David Henry Thoreau, La disobbedienza civile, Mondadori, Milano, 1993
Pier Carlo Masini, Storia degli anarchici italiani da Bakunin a Mala testa (1862-1892), Rizzoli, Milano, 1969
Pier Carlo Masini, Storia degli anarchici italiani nell’epoca degli attentati, Rizzoli, Milano, 1981
P.C. Masini, Maurizio Antonioli, Il sol dell’avvenire. L’anarchismo in Italia dalle origini alla prima guerra mondiale, Pisa, B.F.,S., 1999
Max Nettlau, Bakunin e l’Internazionale in Italia, Savelli, Roma, 1975
James Guillaume, L’Internazionale, documenti e ricordi (1864-1878), Centro studi libertari, Chieti, 2004-2006
Murray Bookchin, L’ecologia della libertà, emergenza e dissoluzione della gerarchia, Eleuthera, Milano, 1996
Murray Bookchin, Democrazia diretta, idee per un municipalismo libertario, Eleuthera, Milano, 1993
- Armand, Vivere l’anarchia, Antistato, Milano, 1982
Colin Ward, Anarchia come organizzazione, Antistato, 1976
Pietro Adamo, Il dio dei blasfemi, anarchici e libertini nella rivoluzione inglese, Unicopli, Milano, 1993
Daniel Guerin, Borghesi e proletari nella rivoluzione francese, La Salamandra, Milano, 1979
Camillo Berneri, Pietrogrado ’17-Barcellona ’37, La Fiaccola, Ragusa, 1990
Paul Avrich, Kronstadt 1921, Mondandori, Milano, 1971
Pëtr Arsinov, La rivoluzione anarchica in Ucraina, Sapere, Milano, 1972
Arthur Lehning, Marxismo e anarchismo nella rivoluzione russa, Antistato,Cesena, 1973
Volin, La rivoluzione sconosciuta, Franchini, Carrara, 1976
Hans Erich Kaminski, Quelli di Barcellona, Il Saggiatore, 1966
Pietro Ferrua, Ricardo Flores Magón e la Rivoluzione Messicana, Ed. Anarchismo, Catania, 1975
AA.VV., La resistenza sconosciuta, Zero in Condotta, Milano, 1995
Martin Buber, Sentieri in utopia, Comunità, Milano, 1981
William Morris, Notizie da nessun luogo, Garzanti, Milano, 1989
Joel Spring, L’educazione libertaria, Eleuthera, Milano, 1988
Arthur Lehning, L’anarcosindacalismo, BFS, Pisa, 1994
Bertrand Russel, Socialismo, Anarchismo, Sindacalismo, Longanesi, Milano, 1968
Erich Mühsam, Ragion di stato, Salerno, Roma, 1980
Antonin Artaud, Il teatro e il suo doppio, Einaudi, Torino 1972
- Artaud, Per farla finita con il giudizio di dio, El Paso, To , 1991
Arturo Schwarz, Anarchia e creatività, La Salamandra, Milano, 1981
Pierre Clastres, La società contro lo stato, Feltrinelli, Milano, 1977
Gino Cerrito, L’antimilitarismo anarchico in Italia, RL, Pistoia, 1968
Simon Springer
Anarchismo!
quello che dovrebbe essere la geografia
«Noi, “terribili anarchici” come siamo, conosciamo un solo modo per stabilire pace e benessere tra donne e uomini: la soppressione del privilegio e il riconoscimento dei diritti. Non ci piace vivere se le gioie della vita sono solo per noi; noi protestiamo contro la nostra buona fortuna se non possiamo dividerla con gli altri; è più dolce per noi frequentare gli emarginati che sedere, coronati di rose, al banchetto del ricco. Siamo stanchi di quelle ineguaglianze che ci fanno nemici l’un l’altro; noi vogliamo porre fi ne alla furia che spinge i popoli a scontri ostili e a tutto ciò che incatena il debole al forte sotto la forma di schiavitù, servaggio e dipendenza» (Elisèe Reclus 1884, p.641).
«Se voi volete, come noi, che sia rispettata la completa libertà
dell’individuo e, conseguentemente, la sua vita, necessariamente siete portati a ripudiare il governo dell’uomo sull’uomo, qualunque forma esso assuma; voi siete forzati ad accettare i principi della anarchia che voi avete disdegnato così a lungo. Voi dovete allora cercare con noi le forme della società che possano meglio realizzare questo ideale e mettere fine a tutta la violenza che suscita la vostra indignazione» (Piotr Kropotkin 2005 [1898]) p.144).
L’anarchismo è una filosofia politica calunniata; su questo non ci possono essere dubbi.
Comunemente l’anarchismo è descritto come una caotica espressione di violenza perpetrata contro il supposto pacifico «ordine» dello stato. Questa rappresentazione mistifica il cuore del pensiero anarchico, che è propriamente compreso come il rifiuto di tutte le forme di dominazione, sfruttamento, e «archia» (sistema di regole, governo), da cui la parola «an-archia» (contro il sistema di regole, non governo). L’anarchismo è una teoria e una pratica che cerca di produrre una società in cui gli individui possano cooperare liberamente come uguali in ogni aspetto, non in base alla legge o a una garanzia sovrana (che introduce nuove forme di autorità, impone criteri di appartenenza e rigidi legami territoriali), ma a partire da sé stessi in solidarietà e mutuo rispetto. Conseguentemente l’anarchismo si oppone a tutti i sistemi di regole o forme di archia (cioè gerarchia, patriarchia, monarchia, oligarchia, antropoarchia, eccetera) ed è invece fondata su forme cooperative ed egualitarie di organizzazione sociale, politica ed economica, dove possono fiorire spazialità autonome e in continua evoluzione. Sebbene sia stato spesso detto che ci sono tanti anarchismi quanti sono gli anarchici, il mio assunto è che l’anarchismo debba abbracciare un’etica della non violenza precisamente perché la violenza si riconosce sia come un atto che come un processo di dominazione.
La violenza è stata la base di molti movimenti storici anarchici e sarebbe semplicistico definire questo elemento come qualcosa di «non anarchico». In effetti prima che anarchici come Paul Brousse, Johann Most, Enrico Malatesta e Alexander Berkman sostenessero la violenza rivoluzionaria e la propaganda del fatto, i primi anarchici o «protoanarchici» come William Godwin, Pierre-Joseph Proudhon, Henry David Thoreau e Leo Tolstoi, rifiutarono la violenza come mezzo giustificabile per abbattere la tirannia dello stato. In accordo con queste posizioni l’anarchismo simpatizzava con la nonviolenza come si poteva vedere nel The Peaceful Re24 La pratica della libertà e i suoi limiti volutionist, un settimanale edito da Josiah Warren nel 1833 e primo periodico anarchico mai stampato. Che l’ anarchismo sia diventato da allora un diretto sinonimo di violenza (piuttosto che riconoscerla come politico-economiche alternative e della limitata immaginazione geopolitica o l’i ndottrinamento ideologico di coloro che non possono o semplicemente rifiutano di concepire un mondo senza stati. Infatti la critica originaria dello anarchismo è che lo stato è la quintessenza della violenza o come Godwin (1976 [1793], p. 380) puntualizza: «Soprattutto noi non dobbiamo dimenticare che il governo è un male, un’ usurpazione del giudizio personale e della coscienza individuale dell’umanità». Dato l’approccio postcoloniale che la geografia umana contemporanea oggi sposa, i geografi radicali dovrebbero considerare più criticamente su come l’accettazione dello stato in effetti reintegri la violenza di pensiero e la pratica del colonialismo. Nel rinvigorire il potenziale delle geografie anarchiche e mettendo in pratica la prassi critica che l’ anarchismo richiede, il mio pensiero è che la non violenza dovrebbe essere compresa come un ideale in cui vivere per gli anarchici. Questa è la storia dell’anarco-femminista Emma Goldman (1996 [1923], p. 253) che nei suoi anni giovanili aveva flirtato con la violenza ma, alla fine, l’aveva rifiutata:
una cosa di cui mi sono convinta come mai nella mia vita, è che le armi non decidono assolutamente niente. Anche se raggiungono quello che si prefiggono, cosa che raramente avviene, producono così tante conseguenze negative da inficiare gli obiettivi originali.
Per questo, se l’anarchismo si pone contro lo stato e in particolare contro il monopolio, l’istituzionalizzazione e la codificazione della violenza che questa organizzazione spaziale rappresenta, allora ne consegue che l’anarchismo propone un’immaginazione geografica alternativa che rifiuta mezzi violenti. Inizio esplorando come i geografi hanno considerato il pensiero anarchico. Sostengo che sebbene l’anarchismo abbia contribuito fortemente alla radicalizzazione della geografia umana negli anni Settanta questa prima prospettiva è stata velocemente eclissata dal marxismo che da allora (insieme al femminismo) è diventato la pietra angolare della geografia radicale contemporanea. La sezione seguente problematizza l’utilitarismo del pensiero marxiano che, si sostiene, reitera i principi coloniali che il marxismo esplicitamente cerca di distruggere. L’anarchismo è presentato come un’alternativa preferibile per il fatto che si contrappone al nazionalismo e riconosce che non c’è una fondamentale differenza tra la colonizzazione e la formazione di uno stato se non per la scala secondo cui questi progetti paralleli operano, significando in tal modo che qualsiasi posizione «post coloniale» deve essere anche «post statale» o anarchica. In seguito cerco di dare una parziale risposta alla questione delle alternative allo stato e come nuove forme di organizzazioni umane volontarie possano esseremesse in condizione di fiorire. Piuttosto che proporre un imperativo rivoluzionario sostengo il valore dell’immediato, del qui e ora come la più emancipatoria dimensione spazio-temporale, precisamente perché è il luogo e il momento in cui noi effettivamente viviamo le nostre vite.
Considero a questo punto l’illusione neoliberista della dissoluzione dello stato un accessorio e ricordo che un «governo leggero» è sempre un governo per cui, mentre i disegni, le strategie, le tecnologie e le tecniche del governo neoliberista sono nuove, la logica disciplinare dello stato rimane la stessa. Nelle conclusioni propongo qualche pensiero sul futuro della geografia radicale e in particolare dove penso che le geografie anarchiche possano costituire un quadro concettuale più libero che potenzialmente rompa sia la struttura discorsiva del neoliberismo sia i limiti del marxismo in relazione alle contemporanee lotte di opposizione.
Quindi questo articolo può essere letto come un manifesto delle geografi e anarchiche che sono concepite come spazialità caleidoscopiche che consentono connessioni multiple, non gerarchiche e propulsive tra entità autonome dove solidarietà, legami, e affinità sono unite volontariamente in opposizione alla violenza sovrana, di norme predeterminate e categorie di appartenenza assegnate. Nel suo rifiuto di questi multiformi apparati di dominazione questo articolo è un richiamo all’uso di armi non violente per quei geografi e non geografi che cercano di porre fine all’apparente infinita serie di tragedie, sfortune e catastrofi che caratterizzano l’attuale maleodorante momento neoliberista. Ma questa non è semplicemente una richiesta che finisca il neoliberismo e il suo rimpiazzo con una più moderata e umana versione del capitalismo, né che si voglia una più egualitaria versione dello stato. È piuttosto una condanna del capitalismo e dello stato in qualsiasi forma si presentino; una condanna di tutti i modi di sfruttamento, manipolazione e dominazione dell’ umanità; un’opposizione alla deprivazione della maggioranza e ai privilegi della minoranza che fino a oggi e per comune accettazione sono state chiamate «ordine»; e il recupero di un progetto della geografia che risale ai primi giorni della disciplina. Questo non è niente di più e niente di meno che una rinnovata chiamata all’anarchismo.
Per geografi e anarchiche
Alla luce dei contributi fondamentali alla disciplina geografi ca di Kropotkin e di Reclus e dell’importante ruolo dell’anarchismo nella crescita di una prassi geografica più radicale, è sorprendente che questa vibrante tradizione intellettuale sia stata, fino a tempi recenti, largamente ignorata dai geografi dai tardi anni Settanta. Scrivendo nel periodo della maggiore infatuazione della geografi a per il colonialismo durante la fi ne dell’Ottocento e i primi del Novecento, e in forte contrasto con i contemporanei come David Livingstone, Halford Mckinder e Friederich Ratzel, che spesero i loro giorni sostenendo una visione imperialista della disciplina, sia Kropotkin sia Reclus avevano una risoluta immaginazione antiautoritaria. La teoria di Kropotkin del volontario reciproco scambio di risorse per il bene comune, o «mutuo appoggio», era una diretta sfi da al darwinismo sociale presente negli scritti di Mckinder, Ratzel e in particolare nel saggio del biologo Thomas Henry Huxley, La lotta per l’ esistenza, (1888). «Loro arrivarono a concepire il mondo animale come un mondo di lotta perpetua tra malnutriti individui assetati del sangue degli altri», scrive Kropotkin nella sua grande opera Il mutuo appoggio: Loro hanno fatto risuonare la moderna letteratura con il grido di guerra e la sofferenza del vinto, come se fosse una parola definitiva nella moderna biologia. Hanno innalzato la battaglia “senza pietà” per vantaggi personali alle altezze di un principio biologico cui pure gli umani devono sottomettersi sotto la minaccia di soccombere in un mondo fondato sul mutuo sterminio.
Sostenendo che la realtà del mutuo appoggio tra animali non umani minava gli argomenti naturalistici in favore di capitalismo, guerra e imperialismo che dominavano il pensiero geografi co del tempo, come pure i darwinisti sociali, precisamente in modo opposto Kropotkin voleva trovare in natura quanto voleva legittimare nella società. La geografi a di conseguenza doveva essere concepita non come un programma di prepotenza imperiale, ma come mezzo per dissolvere pregiudizi e realizzare la cooperazione tra le comunità (Kropotkin 1978 [1880]).
Come per il suo amico e compagno Kropotkin la visione anarchica di Reclus era similmente radicata nella geografi a. Reclus ha proposto un approccio integrale verso ogni fenomeno inclusa l’umanità che era concepita come inseparabile dalle altre forme di vita e dalle caratteristiche geografiche della terra stessa. La terra, di conseguenza, era concepita come un tutt’uno in cui ogni coerente elemento del mondo richiedeva un simultaneo riconoscimento di tutti i multipli fattori di interconnessione. Per Reclus (1905-1908, p.114- 115) «È solo attraverso un atto di pura astrazione che uno possa pensare di presentare un particolare aspetto dell’ambiente come se avesse un’ esistenza distinta e cerchi di isolarlo da tutti gli altri per studiare la sua influenza essenziale». Sebbene il focus fosse il sistema «naturale» il lavoro olistico di Reclus in effetti richiedeva che i fenomeni sociali fossero considerati come intrecciati e costitutivi della naturale «geografia universale» che aveva in mente (vedi Reclus 1876-1894). Per Reclus la sopracitata affermazione sulla natura aveva la stessa rilevanza delle idee prevalenti sull’ organizzazione umana, fossero quella marxiana o quella neoclassica, e questo riporta ai limiti di quelle due teorie economiche. Così mentre le idee reclusiane di integralità hanno ispirato l’ecologia sociale di Murray Bookchin e altre parti del movimento ambientalista radicale, le implicazioni politiche del suo lavoro rispetto all’organizzazione umana sono state sostanzialmente ignorate dai geografi per più di un secolo.
Il suo permanente significato politico deriva in larga parte dalla sua visione egualitaria di una «globalizzazione dal basso» basata sulla integralità che lui ha descritto e promosso, e che offre un’alternativa teorica alla dominante versione della globalizzazione aziendale e statale. In contrasto con la situazione corrente di un mondo diviso tra chi ha e chi non ha dove la geografia dell’accesso al capitale aderisce largamente agli alti e bassi del sistema vestfaliano, Reclus (1876-1894, citato in Clark e Martin, 2004) preconizzava un mondo libero e senza stati con «il suo centro ovunque, la sua periferia in nessun posto».
Mentre la geografia umana contemporanea è opportunamente andata oltre all’affermazione della scienza come sinonimo di «verità», il medesimo scetticismo di Reclus e Kropotkin e le sfide alle ideologie dominanti di allora hanno molto da offrire agli studi geografi ci contemporanei e alla loro irriflessiva accettazione del «discorso» di civiltà, legalità capitalista che converge nello stato. La perpetuazione dell’idea che la spazialità umana necessiti della formazione degli stati è piuttosto ampia in una disciplina che da un lato ha deriso la «trappola territoriale» (vedi Agnew, 1994), ma dall’altro ha rifiutato di portare la critica dello statocentrismo verso la dissoluzione dello stato. I geografi contemporanei di conseguenza hanno evitato di co nfrontarsi con il potenziale emancipatorio della prassi anarchica, sottostimando largamente i contributi di Hakim Bey, Bookchin e Pierre Clastres sull’importanza di alternative configurazioni rispetto allo stato, favorendo invece discussioni su alternative configurazioni dello stato, in particolare da parte della teoria marxiana. Nella forma odierna l’attenzione si concentra sulla spiegazione di come il processo neoliberista faciliti la trasformazione dello stato e la sua permanenza facendo da contraltare alle diffuse teorie che la globalizzazione stia erodendo lo stato e producendo un mondo senza confini, il che significa la fine sia della storia sia della geografia. In altre parole mentre le idee neoclassiche e neoliberiste sono state vigorosamente dibattute e screditate dai geografi che si muovono in una ampia prospettiva marxiana, la geografia contemporanea non ha visto le critiche anarchiche al marxismo svilupparsi con la stessa forza empirica e teorica del suo rivale radicale; un impresa assolutamente da fare.
Sebbene molto sottorappresentati nella letteratura geografica recenti contributi offrono graditi interventi che prestano attenzione alle promettenti idee anarchiche sia teoriche sia pratiche.
Graditi come sono offrono grandi spunti in un terreno teorico ancora molto da esplorare dai geografi . In particolare penso ai profondi contributi di studiosi non geografi quali Lewis Call, Todd May, Saul Newman e di Douane Rousselle e Süreyyya Evren sulle possibilità e il potenziale del post-anarchismo. Mentre il post- strutturalismo è cosa comune nella disciplina, i geografi umani hanno mancato di esplorare il potenziale del pensiero post-anarchico con poche eccezioni. Altri hanno esplorato largamente spazialità «anarchiche» attraverso lenti poststrutturaliste, ma senza inserire questa attenzione nella emergente letteratura che esplici tamente sviluppa una teoria post-anarchica. Il post-anarchismo non è un movimento oltre l’ anarchismo, ma un rinnovamento di idee anarchiche attraverso «l’ infusione» con la teoria post-strutturalista, consentendoci così di mantenere uno spirito emancipatorio, nel mentre si abbandona il richiamo alla scienza e le essenzialiste epistemologie e ontologie che caratterizzano il pensiero anarchico classico. È doveroso per i geografi radicali cominciare a esaminare l’importanza contemporanea
dell’azione anarchica e delle teorie post-anarchiche nel resistere al capitalismo piuttosto che semplicemente ripetere quegli statocentrici e senza via d’uscita argomenti che puntano a una più equa distribuzione del potere all’interno dello stato. Lo stato dopotutto, nella classica critica anarchica, è un’istituzione gerarchica che presume il rispetto dell’autorità. Come hanno riconosciuto chiaramente pensatori «non anarchici» quali Giorgio Agamben e Walter Benjamin è precisamente a causa del carattere giuridico sovrano dello stato che non può mai essere effettivamente egualitario. E così i geografi dovrebbero domandarsi: dove possono portarci supposti argomenti liberatori che continuano ad accettare lo stato se non a strutture di gerarchia e dominazioni fermamente stabili?
Nonostante non sia l’unica preoccupazione degli anarchici, lo stato è il primario argomento del pensiero anarchico. Sebbene i marxisti abbiano sempre più criticato la logica del potere statale, va oltre lo scopo di questo articolo sviluppare una tassonomia che indichi con precisione la posizione verso lo stato delle multiple varianti del pensiero marxiano. A rischio di semplificare eccessivamente la complessità delle intersezioni tra le due principali alternative del pensiero socialista, ciò nonostante è facile dire che la questione dello stato è la differenziazione originaria tra marxismo e anarchismo. Infatti la principale divisione tra anarchismo e marxismo si riferisce alle differenti opinioni sul grado di autonomia concesso ai lavoratori in un contesto post-rivoluzionario e la strettamente legata questione del monopolio della violenza. Gli anarchici rifiutano decisamente tale monopolio sulla base che la violenza è soprattutto la primaria dimensione del potere dello stato e di ogni stato; sia controllato dalla borghesia o conquistato dai lavoratori inevitabilmente funzionerà come strumento della dominazione di classe. Al contrario i marxisti credevano che poiché una classe minoritaria governa la maggior parte delle società, prima del socialismo il raggiungimento di una società senza classi richiede che, preventivamente, la classe più svantaggiata conquisti lo stato e acquisisca il monopolio della violenza. Dunque il desiderio di superare lo stato e creare un sistema socialista liberato attraverso un potere dispotico è una contraddizione che gli anarchici negano. La correlata nozione marxiana dell’estinzione dello stato era similmente vista come una contraddizione. E Bakunin ha osservato (1953 [1873], p. 288): Se il loro Stato è un genuino Stato popolare, perché dovrebbe dissolversi? …(i marxisti) dicono che questo giogo statale (la dittatura) è un necessario mezzo temporaneo per raggiungere l’emancipazione del popolo: l’anarchismo o la libertà è lo scopo, lo Stato o la dittatura è il mezzo.
Quindi per liberare le masse lavoratrici per prima cosa è necessario schiavizzarle. Questa notevole contraddizione inorridiva gli anarchici e durante la Prima Internazionale questa differenza divenne la fondamentale divisione tra i socialisti. Mentre il marxismo tradizionalmente rappresenta il confine statista dello spettro politico socialista, o in ultima analisi, l’accettazione dello stato in termini utilitaristici come mezzo verso una finalità attraverso una provvisoria dittatura del proletariato, l’anarchismo è sempre stato il campo del socialismo libertario rifiutando l’idea che uno stato, sia pur modificato, possa mai scomparire e condurre a una condizione di emancipazione.
Il colonialismo è morto, lunga vita al colonialismo?
Non condivido l’entusiasmo di Marx per il capitalismo. Marx e gli economisti politici classici vedono il capitalismo attraverso simili lenti celebratorie; solo che Marx mitigava la sua visione suggerendo che era una necessaria fase da passare sulla via del comunismo e non una gloriosa fase finale come nel progetto liberale di Adam Smith. Scrivendo un secolo dopo Bill Warren, uno dei più controversi scrittori della tradizione marxista, lo ha colto come essenza del lavoro di Marx. Warren (1980, p. 136) sosteneva che: l’ imperialismo era il mezzo attraverso cui tecnica, cultura e istituzioni che si erano sviluppate in Europa lungo molti secoli (la cultura del Rinascimento, la Riforma, l’Illuminismo e la Rivoluzione Industriale) hanno sparso i loro semi rivoluzionari nel resto del mondo».
Warren ha interpretato correttamente la relazione integrale tra capitalismo e imperialismo, ma ha dipinto l’imperialismo come un «male necessario» sulla strada verso un bene più grande. La banalità della descrizione di Warren dell’imperialismo ha stimolato molti detrattori, ma egli in effetti ha rivisitato il marxismo espresso nel Manifesto comunista dove, sebbene Marx condanni la violenza dell’accumulazione primitiva, ciò nonostante ritiene «questa violenta espropriazione come necessaria per lo sviluppo delle possibilità umane» (Glassman 2006, p. 610). Malgrado trovi il capitalismo moralmente ripugnante se comparato con il modo di produzione feudale che lo ha preceduto, Marx attribuisce al capitalismo molte virtù, riconoscendolo come straordinariamente produttivo, suscitatore di creatività umana, produttore di grandi cambiamenti tecnologici e iniziatore di potenziali forme democratiche di governo. In linea con questa ottimistica visione di Marx, Warren sostiene che nella sua fase iniziale l’esplorazione capitalista di nuovi territori è stata condotta in forma di colonialismo e imperialismo e mentre questa forma di capitalismo è stata un arretramento per quei territori occupati ci sono stati però anche importanti benefici. I livelli di istruzione sono cresciuti, le aspettative di vita anche e le forme di controllo politico sono da considerarsi più democratiche di quelle preesistenti il colonialismo.
Se tutto questo suona familiare è perché è la stessa struttura «discorsiva» che orienta il neoliberismo oggi; correttamente David Harvey (2003) lo ha definito «nuovo imperialismo ». Il ritornello è che la gente potrebbe fare meglio e sebbene imperfetta nella sua esecuzione (largamente attribuita alla continua «interferenza» dello stato nei mercati) alla fine «l’effetto gocciolamento» produrrà i suoi frutti e la promessa utopia si materializzerà.
Invece di aspettare che il mercato produca i suoi effetti secondo i suoi tempi Marx intendeva accelerarne il passo per raggiungere un contratto sociale egualitario attraverso la rivoluzione. Per essere chiari non sto sostenendo che ci sia una ideologica consonanza tra il marxismo e il neoliberismo, piuttosto cerco di chiarire che ambedue condividono la nozione che lo stato può essere usato per raggiungere un fi ne «liberato». Per contrasto la posizione anarchica rifiuta la violenza dello stato, dell’imperialismo e del capitalismo e non si fa convincere dall’utilitarismo di Marx. I mezzi del capitalismo e le sue violenze non giustificano un non-stato finale comunista né questo fi ne giustifica tali mezzi. Questo particolare aspetto del pensiero marxista richiama il neoliberismo: sebbene l’utopico non stato finale sia concettualizzato in modo differente, i mezzi «penultimi» per raggiungere il «prodotto finale» sono virtualmente gli stessi. Mentre i post-marxisti opportunamente sostengono che genere, sesso, etnicità, razza, e altre evidenti categorie «non capitaliste» siano ugualmente importanti linee di differenziazione che segnano gerarchie, disuguaglianze e violenze nel nostro mondo neoliberista l’ anarchismo va oltre rifiutando la sostanziale violenza che è intrinseca e implicitamente accettata dall’approccio lineare alla storia fondato sugli «stadi di sviluppo». Non coerente con l’utilitarismo e l’ essenzialismo del pensiero di Marx può allo stesso modo essere vista la genesi del post-strutturalismo, che invece si focalizza sulla complessità ed eterogeneità della condizione attuale e rifiuta teorie totalizzanti nel rigettare le «verità» assolute.
Sebbene la critica post strutturalista sia diventata velocemente una delle più vibranti varianti filosofiche nella disciplina geografica e Michel Foucault, Gilles Deleuze e Jacques Lacan abbiano tutti elaborato critiche all’interno del fertile terreno del pensiero antistatale la geografia contemporanea è stata lenta nel confrontarsi con le idee che auspicano la fine del Leviatano. Posso solo formulare ipotesi sulle ragioni di questa lacuna, ma sembra che il predominio delle idee marxiste abbia avuto un ruolo. Il marxismo tradizionale con la sua compagna ideologia statalista è largamente presente nella letteratura geografica dove l’influenza di Harvey domina. Sebbene occasionalmente qualche geografo politico abbia criticato la limitata visione geopolitica dello stato-centrismo, ciononostante la forma di organizzazione statale è un dato di fatto scontato nella disciplina. Lo stato è o implicitamente accettato o non sottoposto a un tipo di esame che ne analizzi i suoi principi fondamentali, anche se i/le geografi /e femministi/e hanno contribuito a ridefinire i parametri sui quali lo stato è correntemente concepito. Nonostante questo una parte significativa della geografia umana ha sollevato la questione dello stato solo per cercare di determinare quanto il neoliberismo abbia riconfigurato le sue funzioni, con i geografi marxisti che auspicano una rinnovata e reimmaginata versione del welfare sociale, e i post-strutturalisti che argomentano che la governabilità rende lo stato quasi invisibile grazie a soggetti capaci di autoregolarsi e di autocorreggersi. È scarsamente evidenziata la potenzialità di quest’ ultimo approccio nello svelare la perdurante forza della logica statuale e della violenza che la pervade tramite alterate razionalità disciplinari e le mutate tecniche di controllo biopolitico; per non parlare delle coincidenze del post-strutturalismo con il pensiero anarchico (vedi Newman 2010).
Che la geografia radicale mantenga l’orientamento statuale forse testimonia delle origini coloniali della disciplina stessa e una esitazione nel rompere con vecchie abitudini. Così il contemporaneo stato-nazione va visto come una replica in scala minore dello stato coloniale.
Sebbene differenziati per diffusione e distribuzione nello spazio sia il potere dello stato nazionale sia quello coloniale mostrano gli stessi violenti principi del privilegio di pochi sopra i molti e l’imposizione di un’identità unica prevalente su antecedenti modi di concepire l’appartenenza. Marx ne era consapevole, ma ancora una volta ha sostenuto la sua idea utilitarista. Nel momento in cui il capitalismo si diffonde nel mondo ha suscitato forti movimenti di resistenza da parte di lavoratori e contadini oppressi (guidati da avanguardie) che, secondo Marx, avrebbero incubato alla fine il superamento del capitalismo.
In casi particolari Marx aveva sostenuto lotte nazionaliste vedendo in questo una «fase di sviluppo» verso il futuro internazionalismo dei lavoratori. Dal punto di vista anarchico è difficile vedere il fine emancipatorio quando si usano mezzi violenti. Quello che la «liberazione nazionale» rappresenta in effetti è il cambio di una élite con un’altra e quindi di una forma di colonialismo con un’altra. Mentre l’espressione territoriale è stata dismessa, la sottostante logica rimane la stessa. Esattamente come lo stato coloniale suscitava e spesso imponeva il monopolio della violenza la lotta per creare uno stato-nazione è allo stesso modo una lotta per il monopolio della violenza. Quello che si crea in ambedue i casi (uno stato coloniale o nazionale) è esso stesso uno strumento di violenza. Nel riconoscere questa corrispondenza, e a dispetto del cosiddetto «precipuo quadro di comprensione postcoloniale» di Gillian Hart (Hart 2008, p.680), essere «postcoloniali» in ogni senso è essere anche «poststatali» o anarchici come pure sono da rifiutare totalmente gerarchie, ordine, autorità e violenza su cui quei progetti paralleli sono stati costruiti. Inoltre l’internazionalismo, per definizione, non può andare oltre lo stato; al contrario continua a presupporre e assumere l’esistenza delle nazioni. Nell’auspicare la cooperazione tra le nazioni a prescindere dalla geografia, l’internazionalismo di Marx non va oltre la nozione dello stato-nazione quale unità di base dell’appartenenza.
Perché allora la geografia radicale contemporanea non ha sviluppato una «immaginazione anti coloniale» che giunga fino alla sfida post statuale come Anderson (2005) ritiene che in effetti sia necessario? Reclus e Kropotkin hanno dimostrato da molto tempo che la geografia si presta essa stessa a idee emancipatorie e «non è stato per caso che due dei più importanti anarchici della fi ne del secolo fossero geografi » (Ward 2010, p.209). C’è un latente straordinario potenziale per la geografia radicale contemporanea di diventare ancora più radicale nella sua critica e quindi maggiormente libertaria nei suoi interessi aderendo all’ethos anarchico. L’anarchismo è in grado di comprendere capitalismo, imperialismo, colonialismo, neoliberismo, militarismo, nazionalismo, classismo, razzismo, etnocentrismo, orientalismo, sessismo e genere, omofobia e transfobia, età, abilità, specie, vegetarianismo, sovranità e lo stato come sistemi intrecciati di dominazione. Il mutuo rinforzo della composizione di queste varie dimensioni di «archia» significa, conseguentemente, che escluderne acriticamente una dall’analisi perpetua quella conglomerazione nel suo insieme. A differenza delle compartimentazioni della geografi a marxiana la promessa delle geografi e anarchiche consta precisamente nella loro capacità di pensare in modo integrato e quindi di rifiutare di dare priorità a uno qualsiasi dei molteplici apparati di dominazione, in quanto tutti irriducibili uno all’altro. Questo significa che nessuna lotta può venire dopo una qualsiasi altra. È tutto o niente e il privilegio aprioristico dei lavoratori, delle avanguardie, o di qualsiasi altra classe sopra le altre devono essere rifiutati sulla base della loro insita gerarchia.
Immaginare alternative
In effetti non ci sono peggiori controrivoluzionari dei rivoluzionari; perché non ci sono peggiori cittadini degli invidiosi (Anselme Bellegarrigue 1848) Non ci sono sogni per un lontano futuro e neppure tappe da raggiungere dopo altre, ma nostri processi di vita ovunque nei quali noi possiamo sia avanzare sia arretrare (Roger Baldwin 2005, p.114)
La questione delle alternative allo stato è comunque nella mente degli scettici dell’anarchismo. In questo senso Harvey (2009, p.200) domanda: «Come funzionerà concretamente la reificazione di questo ideale anarchico nello spazio e nel tempo assoluti?».
Sebbene gli anarchici abbiano teorizzato molteplici possibilità da quella collettivista a quella individualista, dalla sindacalista alla mutualista, dalla volontaristica alla comunista, io rivendico un non dottrinario, post-anarchico approccio e conseguentemente la mia risposta è cominciare a rifiutare di dare visioni prescrittive sulle forme di organizzazione sociale che io penso debbano essere sviluppate. La risposta a questa domanda non può dipendere da un singolo individuo, ma piuttosto collettivamente attraverso il dialogo e una permanente flessibile innovazione. In questo senso la critica di Harvey all’anarchismo è problematica da due punti di vista. Primo, quando mai spazio e tempo sono stati «assoluti » se non attraverso le lenti riduzioniste del positivismo? Questa affermazione nega
lo stesso riconoscimento di Harvey sulla reciproca influenza dialettica di spazio e tempo, espressa da lui come «spazio-tempo». Secondo, cerca di applicare i principi del pensiero marxiano e della «teoria delle fasi» a una posizione filosofica che escluda questa linearità predeterminata. Harvey concettualizza la costruzione del luogo come una politica di fine stato, cosa che posiziona non correttamente l’anarchismo come un progetto chiaramente definito (idea condivisa da marxismo e neo-liberismo) piuttosto che riconoscerlo come un processo vivente, flessibile e sempre dinamico (Springer 2011). Qualcuno potrebbe giudicare la mia posizione come un tentativo di svicolare, ma desidero ricordare al lettore che qualsiasi tentativo di preconizzare un modello fisso isolato dal più ampio corpo sociale riassume sia il progetto neoliberista sia una disposizione autoritaria visto che ciascuno di essi sostiene un unico modo di fare le cose. Questo rinforza l’arroganza/ignoranza dei cosiddetti «esperti» che presumono di sapere che cosa è meglio senza riconoscere i propri limiti. Persino Sara Haraway, quale brillante pensatrice che è, una volta manifestò i propri limiti rivelando: «io ho quasi perso la capacità di immaginare come potrebbe essere un mondo non capitalista. E questo mi spaventa» (Harvey e Haraway 1995, p.519). La stessa incipiente paura dovrebbe essere ugualmente evocata quando si riflette criticamente sullo stato e sulla sua apparente totalizzante pervasività. Noi trattiamo questa particolare forma gerarchica di organizzazione e di dominio territoriale come imprescindibile e facendo questo noi concretamente dimentichiamo che la gran parte del tempo che gli umani hanno passato sul pianeta Terra è stato caratterizzato da una organizzazione non statale. Lo stato quindi non è né inevitabile né necessario. Il neoliberismo è particolarmente virulento nella misura in cui inserisce un nuovo elemento nella nostra collettiva dimenticanza riconfigurando lo stato in modo tale che impedisce di notare i suoi continui effetti deleteri. Il discorso dietro questa illusione di dissoluzione cerca di convincerci che il neoliberismo rappresenti la nostra liberazione come individui, emancipandoci dalle catene che chiama «il grande governo». Ma lo stato continua a essere rilevante nelle dinamiche neoliberiste.
Allo stesso modo il monopolio della violenza che lo stato reclama per sé rimane ugualmente potente e oppressivo sotto la logica disciplinare di uno stato neoliberista come lo fa sotto ogni altra configurazione di stato; malgrado «i bei momenti» della apparente democrazia (leggi «autoritarismo elettorale») (Springer 2011). Quello che è effettivamente perso nel supposto stato neoliberista in streaming sono ovviamente i benefici sociali forniti ai cittadini. Questa retromarcia è il risultato del collasso della fiducia sociale, che attivamente anticipa il mito hobbesiano- darwiniano di tutti contro tutti dove solo il più forte sopravvive. La gente è incoraggiata non a rivolgersi agli altri per risolvere i problemi di tutti i giorni o anche solo quando ci sono problemi, ma semplicemente deve smettere di essere «pigra» e mettersi al lavoro. Il discorso neoliberista pone il sistema stesso al di sopra di qualsiasi rimprovero così che ogni «anomalia», come l’impoverimento o la disoccupazione, sono derubricate quali fallimenti individuali. Quelli che non hanno «successo» in questo gioco perverso sono facilmente estromessi dal punitivo stato neoliberista grazie alla loro criminalizzazione. Il carcere è visto come la più valida soluzione che affronta il crescere delle ineguaglianze e della povertà della maggioranza. Questo strumento disciplinare è particolarmente debilitante perché per la realizzazione del potere popolare le condizioni per la cooperazione sociale devono essere presenti per il semplice motivo che la gente deve avere fiducia negli altri.
Il neoliberismo in particolare e il capitalismo più generalmente lavorano per distruggere la fiducia facendoci competere l’un l’altro e approfittare della reciproca vulnerabilità.
Allo stesso modo lo stato distrugge la fiducia avvertendoci che homo homini lupus diventerebbe la legge in assenza di un potere sovrano. Per ristabilire la fiducia sembrerebbe che sconfiggere il capitalismo non sia sufficiente. Nell’allestire una realtà post-neoliberista, cioè la realizzazione di un contesto che rompa con il corrente Zeitgeist (spirito del tempo), la sovranità e lo stato stesso devono essere smantellati. Facendo questo, a prima vista, sembra apparire il problema del muoverci dal qui al là e dall’ora al poi. Nonostante collochi l’idea della rivoluzione come sparita dalla vista Neil Smith 2010) esemplifica la permanente infatuazione della sinistra suggerendo che la recente crisi finanziaria potrebbe essere la base sulla quale «l’ imperativo rivoluzionario» può essere rinnovato. Ma desiderando che una rivoluzione globale emerga dalla recente crisi economica attribuisce un ruolo strumentale a un singolo sistema economico che stranamente recupera l’argomento del neoliberismo come monolitismo. Questo tipo di critica riporta all’implicita accettazione di Smith del ruolo utilitaristico che Marx attribuisce al capitalismo /colonialismo, una posizione che gli anarchici trovano discutibile. Mentre compiange le vittime del colonialismo Marx si consola con il pensiero che i suoi continui abusi non faranno che avvicinare il giorno in cui l’intero mondo verrebbe consumato da un’unica crisi e quindi inaugurando la rivolta rivoluzionaria così desiderata. Questo è un approccio ultra passivo perché se la rivoluzione deve risultare da una crisi capitalista allora questo implica una politica di attesa per il giorno in cui «tutto si dissolve».
La questione della perdita di fiducia diventa particolarmente acuta al momento del «dissolvimento» perché, come Proudhon (2005 [1864], p.108) avvertiva, c’è un «pericolo nell’aspettare fi no ai momenti di crisi, quando le passioni diventano incandescenti dalla diffusa sofferenza». Nel tempo che è passato dall’inizio della crisi nel tardo 2008 è tristemente diventato ovvio di come sia possibile, in assenza di fiducia, per la gente, accettare alternative razziste, nazionaliste e fondamentaliste. Invece che occupare il tempo nell’attesa della rottura i geografi dovrebbero invece aderire anarchicamente al «qui e ora» come spazio-tempo in cui le nostre vite sono effettivamente vissute. Riconoscendo che la potenzialità di questa immediatezza sia emancipatoria di per sé in quanto ci fa rendere conto della possibilità che noi possiamo immediatamente rifiutare di partecipare al consumismo, di praticare il nazionalismo e di non agire gerarchicamente per evitare di legittimare l’ordine esistente, ci porta ad aderire alla cultura del «do it yourself» centrata sull’azione diretta, il non consumismo e il mutuo aiuto. Aderendo all’idea della coppia di autrici che si firma J-K Gibson-Grahan (2008) che «altri mondi» sono possibili e all’impegno di Sara Koopman (2011) per una battaglia contro egemonica non violenta di quello che lei chiama «altra-geopolitica», il potere del «qui e ora» ci offre la libertà ’immaginare e di cominciare a costruire le libere alternative istituzioni e le volontarie associazioni che faciliteranno la transizione verso un vero futuro post-coloniale/post-neoliberista. Così il significato di immaginare alternative all’ordine corrente non è quello di fissare un programma per ogni tempo, ma invece di fornire un esempio di alterità o di esternalità come un mezzo per sfidare i limiti di questo ordine. È solo nel preciso spazio e momento del rifiuto, che è il «qui e ora», che gli individui si prendono il potere di scegliere la propria via, liberi dalla guida coercitiva di un’autorità sovrana o dalla persuasiva influenza di un patrocinio accademico. L’ambito dove i geografi sono effettivamente in buona posizione per essere efficaci, come i/le pensatori/rici femministi/e hanno dimostrato, è nei riguardi della questione del costruire fiducia, abbattendo pregiudizi e agendo con nuove energie creative radicate nella continua capacità delle emozioni e della vita quotidiana come effettivo terreno dell’interazione umana. Nell’accettare la «svolta affettiva» (Thien 2005) che vede la connettività emozionale e la politica dell’affinità come basi fondamentali su cui qualsiasi durevole trasformazione può avvenire, è precisamente a questa intimità e immediatezza che possono dedicarsi produttivamente le geografi e anarchiche. Piuttosto che dare priorità al particolarismo di classe, come nell’imperativo marxiano, o arrenderci alla politica del razzismo, come vorrebbe il neoliberismo, l’anarchismo chiede che qualsiasi processo di emancipazione sia pervaso da relazioni non universali, non gerarchiche e non coercitive, fondate sul mutuo appoggio e sull’impegno eticamente condiviso.
Infine, quello che l’anarchismo ha da offrire è esattamente l’opposto del neoliberismo. Differenziandosi dall’insito elitismo e autoritarismo dello stato, l’anarchismo punta alla produzione di beni comuni tramite la cooperazione umana in accordo ai bisogni, un processo che non richiede una struttura amministrativa, ma invece perni su cui si fonda un’etica di reciprocità. Una prospettiva anarchica riconosce inoltre che le nuove latenti forme di organizzazione, che potrebbero svilupparsi oltre la logica territoriale dello stato, possono esistere in un continuo processo di riflessione e revisione da parte di coloro che le praticano, così come impedire la formazione di qualsiasi potenziale gerarchia prima che le si possa permettere di crescere. Le geografi e anarchiche di cooperazione devono nascere all’esterno dell’ordine esistente, nei luoghi che lo stato ha mancato di includere e nelle infinite possibilità che la logica statale ignora, rifiuta, saccheggia e nega. Come Kropotkin (1887 p.153) ha eloquentemente chiarito: mentre tutti concordano che l’armonia è sempre desiderabile non c’è una corrispondente unanimità a proposito dell’ ordine che si immagina che regni nelle nostre società moderne; così che noi non abbiamo nessun tipo di obiezione all’uso della parola “anarchia” come negazione di quello che è stato spesso descritto come ordine.
Le geografie anarchiche sono quelle forze potenziali che continuamente infastidiscono lo stato sostenendo che sia semplicemente una delle possibilità socio-spaziali in un numero illimitato di altre. Così le alternative allo stato non nascono dall’ordine che esse rifiutano,in quanto contraddittorio e oppressivo, ma dall’anarchica profusione di forze che sono aliene a questo ordine e da quelle reali possibilità che questo ordine cerca di dominare e distorcere. I geografi radicali di conseguenza avrebbero molto da imparare dall’ intensificare le connessioni con quei popoli (come le tribù indigene di Zomia) che non hanno mai avuto lo stato e praticato quello che James Scott (2009) chiama «l’arte di non essere governati». La questione qui non è la fine dello stato o la realizzazione di una politica che porti alla fine dello stato, ma piuttosto una «infinita richiesta», una lotta fatta di continua evasione, contestazione e solidarietà (Critchley 2007). Non siamo obbligati a vedere lo stato come l’esclusivo luogo dal cambiamento sociopolitico o l’unico riferimento di un paradigma rivoluzionario, come troppo spesso è avvenuto. Nello spirito delle citazioni che aprono questo articolo noi possiamo invece orientare la nostra rabbia e tristezza dentro di noi, dove la sostenuta indignazione per la nostra buona fortuna può portare a un riallineamento delle nostra bussola etica, forzandoci a fermarci e rifiutare, stando dalla parte di altri meno fortunati. L’empatia è la morte dell’apatia e comincia non quando lo stato è fluidificato, indebolito o smembrato, ma «qui e ora».
Conclusioni
La libertà come mezzo produce più libertà. Per coloro che condannano ciò come sterilità politica e posizione da «torre d’avorio» si risponda che il «realismo» e il loro «circostanzialismo » invariabilmente portano al disastro. Noi crediamo che sia più realistico influenzare le menti con la discussione piuttosto che plasmarle con la coercizione (Vernon Richards 1995, p.214).
L’etimologia di «radicale» viene dal latino radix e significa radice. I geografi radicali contemporanei farebbero meglio a esplorare questa originaria dimensione (ri)confrontandosi con i contributi di Kropotkin e Reclus, che senza timore criticavano la dominazione coloniale in un tempo in cui il «grosso» della geografi a marciava mano nella mano con il progetto imperialista. Ma la geografia radicale oggi non ha bisogno di rileggere il passato, bensì necessita di un futuro, di una iniezione di nuove idee che abbracci i progressi intellettuali fatti dal pensiero post-strutturalista e femminista per andare oltre quello che è già «conosciuto». All’interno degli studi anarchici il confine critico di questo tentativo è il post-anarchismo, che non cerca di muovere il «vecchio» anarchismo, ma rifiuta le basi epistemologiche delle teorie anarchiche «classiche» e il loro attaccamento all’essenzialismo del metodo scientifico. Il pensiero post-anarchico di conseguenza cerca di rinvigorire la critica anarchica espandendo il suo concetto di dominazione oltre lo stato e il capitalismo per comprendere le reti tortuose e molteplici che caratterizzano il potere contemporaneo; e rimuovendo i suoi quadri concettuali normativi e «naturali» per aderire a conoscenze specifiche ed empatiche. Applicare questa critica filosofica alla geografia radicale oggi richiede che si faccia una scelta consapevole etica e emozionale, scegliere se «essere alleati con la stabilità dei vincitori e dei governanti, oppure, cosa più difficile, considerare tale stabilità come uno stato di emergenza che minaccia i meno fortunati con il pericolo della completa estinzione» (Said 1993, p. 26). La seconda scelta richiede un deciso sforzo per rompere il fascino del «senso comune» della governabilità neoliberista, in quanto il governo non è solo la struttura politica o le procedure gestionali dello stato, ma l’indirizzo della condotta dei singoli e dei gruppi, significa «strutturare il possibile campo di azione degli altri», la loro direzione e la loro posizione (Foucault 1982, p.790).
Questo è un processo che molti geografi hanno già iniziato prestando attenzione all’intrico del potere, facendo ricerche sulle azioni partecipative e attraverso la teoria non rappresentativa (Thrift 2007), ma senza riferirla esplicitamente alla critica anarchica. Così se i mutevoli orizzonti dello spazio-tempo assicurano che le nostre esperienze vissute sono continui comportamenti che sfidano la divisione teorica di identità predeterminate e di soggettività codificate, allora che cosa è più «realistico» se non riconoscere la perpetua fioritura dei significati dell’anarchismo? Le geografi e anarchiche allora cercherebbero di mettere in dubbio la spazialità su cui il «governo» è fondato, per sostenere un non strutturato «campo di azione» dove gli individui volontariamente e/o collettivamente possano decidere la loro direzione, liberi dalla presenza e dalle pressioni di qualsiasi alta o ultima autorità. Il luogo di questa liberazione da tutte le varianti del potere sovrano non è radicato nell’idea di fissità, come è nella «trappola territoriale» dello stato, ma nella inesorabile affermazione di libertà attraverso dinamiche associazioni per affinità che possano essere interamente transitorie o solo poco permanenti. Il pensiero potenziale chiave è quello che ogni affiliazione è libera di rafforzarsi o dissolversi grazie alla condizione di una libera e individuale scelta, dove nessun soggetto, come il monopolio della forza o il controllo dei mezzi di produzione, faccia rispettare la sottomissione o la continuità condivisa.
Le geografie politiche delle frontiere e dei confini diventerebbero infinitamente intricate, sovrapponibili e variabili fi no al punto che cercare di fissarle in un rigido ordine o una griglia, come è nella epistemologia sottostante la moderna cartografi a, diventerebbe un esercizio di futilità. Questa mappatura, sia letteralmente come nella attuali carte sia attraverso tecniche come i dati censuari, è costitutiva della logica dello stato da cui cominciare ad agire e la proposizione delle geografi e anarchiche dovrebbe essere quella di dissolvere qualsiasi schema di categorizzazione e classificazione che promuova permanenze spaziotemporali.
Questo non significa che l’anarchismo sia un caos, ma che ogni organizzazione geografica debba procedere come un’etica di empatia invece che una politica di differenze, visto che queste ultime sono sempre forgiate dall’oppressione. L’anarchismo, spazialmente organizzato in questi termini, ci permetterebbe di comprendere l’ insieme delle persone piuttosto che considerarli soggetti o cittadini conformi a particolari spazi e a parziali obiettivi politici. Kropotkin ha descritto una simile visione quando scrisse: in questo tempo di guerre, di auto-centrature nazionali, di gelosie nazionali e odii abilmente alimentati da gente che persegue i propri egoistici interessi o di classe, la geografi a deve essere … un mezzo per dissipare i pregiudizi e creare altri sentimenti più nobili per l’umanità.
Le geografie anarchiche possono di conseguenza essere produttivamente caratterizzate dalla loro integralità, dove tutti i tentativi di creare false dicotomie di separazione sono rifiutate e al contrario l’umanità è riconosciuta come intimamente interconnessa con tutti i processi e flussi dell’intero pianeta (Massey 2005). Questa radicale riconcettualizzazione della disciplina la renderebbe simile, realizzando la visione di Reclus, sia alla Rete dei Gioielli di Indra della filosofia buddista sia all’ipotesi di Gaia, dato che i tentativi di separare ogni tipo di variante da quella politica a quella economica, da quella sociale a quella culturale e così via, sarebbe vista come una costruzione che tenti di addomesticare, costringere, dividere e contenere l’irriducibile intero.
Nuove forme di affinità stanno già emergendo in forma di «etiche relazionali di lotta» (Routledge 2009) dove non è più il lavoratore che è concepito come il soggetto del cambiamento storico, ma gli oppositori anticapitalisti che comprendono gruppi eterogenei che sfuggono alla soggettivazione universale dell’identità proletaria. Riconoscere questo potrebbe essere il punto di partenza per scalzare la posizione che il marxismo detiene oggi nella geografi a radicale. Questa emergente forma di lotta è chiaramente non interessata a formulare strategie che replichino tradizionali strutture rappresentative, volendo significare uno spostamento paradigmatico dal cambiare lo stato modificandone i caratteri, prestando invece attenzione a movimenti autonomi in opposizione allo stato. In questo contesto Newman (2010, p.182) identifica una serie di nuove questioni e sfide politiche: «libertà oltre la sicurezza, democrazia oltre lo stato, politica oltre i partiti, organizzazione economica oltre il capitalismo, globalizzazione oltre i confini, [e] vita oltre la biopolitica».
E ancora, queste non sono solo questioni politiche, ma ciascuna è anche profondamente geografica. Mentre i geografi stanno già esaminando queste concrete questioni c’è stata un’attenzione molto ridotta ai modi in cui l’anarchismo può favorire una più rigorosa analisi di queste emergenti geografie. Di conseguenza concettualizzare un «andare avanti», oltre le dominanti strutture del neoliberismo e le perduranti animosità del colonialismo, significa un più profondo rapporto con le filosofie anarchiche. Impegnare la geografia radicale in un programma anarchico vorrebbe dire la negazione della falsa dicotomia che la disciplina mantiene tra l’accademia come luogo della produzione della conoscenza da una parte e dall’altra la più ampia società come campo della lotta sociale. Perciò reti di solidarietà con coloro che svolgono azione diretta nelle strade potrebbe ben essere il futuro della geografi a radicale. Da qui possono fiorire idee che permettano nuove immaginazioni geografi che e materializzazioni che vadano oltre politiche stato-centriche; possono fiorire forme di organizzazione non istituzionali, «glocalizzate», temporanee e volontarie, e la teoria kropotkiniana del mutuo appoggio come pure il contributo di Reclus agli ideali della libertà umana possono avere lo stesso tipo di attenzione che finora Marx ha avuto dalla geografia radicale. L’anarchismo, come Kropotkin (1978 [1885]) ha riconosciuto più di un secolo fa, è «quello che la geografi a dovrebbe essere».
traduzione di Fabrizio Eva
Bibliografia
John Agnew, The territorial trap: The geographical assumptions of international relations theory, in Review of International Political Economy, 1994, n.1, pp.53-80.
Benedict Anderson, Under Three Flags: Anarchism and the Anti-Colonial Imagination, Verso, London, 2005.
Michail Bakunin, Criticism of Marxism, in The Political Philosophy of Bakunin: Scientifi c Anarchism, a cura di G.P.Maximoff, Free Press, New York, 1953 [1873], pp. 283-289.
Roger N. Baldwin, nota di Anarchism: Its philosophy and ideal, in Kropotkin’s Revolutionary Pamphlets,a cura di R. Baldwin, Whitefi sh, Kessinger, p.114.
Anselme Bellegarrigue, L’Anarchie, journal de l’ordre, http://kropot.fre.fr/Bellegarrigue-A02.htm(ultimo accesso 20 ottobre 2011)
Alison Blunt e Jane Willis, Dissident Geographies, Pearson Education, London, 2000.
John Clark e Camille Martin (a cura di), Anarchy, Geography, Modernity: The Radica Social Thought od Elisée Reclus, Lexington, Oxford, 2004.
Simon Critchley, Infi nitely Demanding: Ethics of Committment, Politics of Resistance, Verso, London,2007.
Kim England, Kevin Ward (a cura di), Neoliberalization: States, Networks, Peoples, Blackwell,Oxford, 2007.
Michel Foucault, The subject and power, in Critical Inquiry, n.8 pp. 777-795, 1982.
J-K Gibson-Graham, Diverse Economies: Performative practices for «other worlds», Progress in Human Geography, n.32 pp. 613-632, 2008.
Jim Glassman, Primitive accumulation, accumulation by dispossession, accumulation by “extraeconomic” means, in Progress in Human Geography, n.30 pp.608-625, 2006.
William Godwin, Enquiry Concerning Political Justice and Its Infl uence on Modern Morals and Happiness, Penguin, London, 1976 [1793].
- Springer – Anarchismo! Quello che dovrebbe essere la geografia
Emma Goldman, Read Emma Speaks: An Emma Goldman Reader, Humanity, New York, 1996[1923].
Emma Goldman, My Disillusionment in Russia, Dover, Mineola, 2003 [1923].
Gillian Hart, The provocation of neoliberalism: Contesting the nation and liberation after apartheid, in Antipode, n. 40 pp. 678-705, 2008.
David Harvey, The New Imperialism, Oxford University Press, Oxford, 2003.
David Harvey, Cosmopolitanism and the Geographies of Freedom, Columbia University Press, New York, 2009.
David Harvey and Donna Haraway, Nature, politics, and possibilities: A debate and discussion with
David Harvey and Donna Haraway, in Environment and Planning D: Society and Space, n.13 pp. 507-527, 1995.
Thomas Henry Huxley, The struggle for existence: A programme, in The Nineteenth Century, XXIII Febbraio, pp. 160-180, 1888.
Sara Koopman, Altergeopolitics: Other securities are happening, in Geoforum, n.42 pp. 274-284, 2011.
Piotr Kropotkin, What geography ought to be, in Antipode, n.10 pp. 6-15, 1978 [1885].
Piotr Kropotkin, The coming anarchy, in The Nineteenth Century, CXXVI (agosto), pp. 149-164, 1887.
Piotr Kropotkin, Anarchism. Its philosophy and ideal, in Kropotkin’s Revolutionary Pamphlets, a cura di R.Baldwin, Whitefi sh, Kessinger, p. 115-143, 2005 [1898].
Piotr Kropotkin, Mutual Aid: A Factor in Evolution, Forgotten, Charleston, 2008 [1902].
Doreen Massey, For Space, Sage, London, 2005.
Saul Newman, The Politics of Postanarchism, Edinburgh University Press, Edinburgh, 2010.
Pierre-Joseph Proudhon, Manifesto of sixty workers from the Seine Departement (17 February 1864)’, in Daniel Guerin (a cura di), No Gods, No Masters: An Anthology of Anarchism, AK Press, Oakland, pp. 103-110, 2005 [1864].
Élisée Reclus, Anarchy: By an anarchist’, Contemporary Review, n.45 pp. 627-641, 1884.
Élisée Reclus, The Earth and its Inhabitants: The Universal Geography, Volume I, J.S.Virtue and Co., London, 1876-1894.
Élisée Reclus, L’Homme et la Terre, Librairie Universelle, Volume I, 1905-1908.
Vernon Richards, Lessons of the Spanish Revolution, 1936-39, terza edizione, Freedom , London, 1995.
Paul Routledge, Relation ethics of struggle, in Radical Theory/Critical Praxis: Making a Difference Beyond the Academy?, a cura di D.Fuller e R.Kitchen, Praxis, Kelowna, pp.79-91, 2009.
Edward Said, Culture and Imperialism, Knopf, New York, 1993.
James C. Scott, The Art of Not Being Governed: An Anarchist History of Upland Southeast Asia, Yale University Press, London, 2009.
Neil Smith, The revolutionary imperative, in Antipode, n.41(s1) pp.50-65, 2010.
Simon Springer, Public space as emancipation: Meditation on anarchism, radical democracy, neoliberalism, and violence, in Antipode, n.43 pp. 525-562. 2011.
Simon Springer, Violent accumulation: A postanarchist critique of property, dispossession, and the state of exception in neoliberalizing Cambodia, in Annals of the Association of American Geographers, (di prossima pubblicazione).
Deborah Thien, After or beyond feeling? A consideration of affect and emotion in geography, in Area, n.37 pp. 450-454.
Nigel Thrift, Non-Representational Theory: Space, Politics, Affect, Routledge, London, 2007.
Dana Ward, Alchemy in Clarens: Kropotkin and Reclus, 1877-1881, in New Perspectives on Anarchism, a cura di N.Jun e S.Wahl, Lexington, Lanham, pp. 209-226, 2010.
Bill Warren, Imperialism: Pioneer of Capitalism, Verso, London, 1980.

 “Per molti la medicina rischia di essere peggiore della malattia.” Lo penso ancora e questo è vero specialmente se si considerano i devastanti effetti delle chiusure generalizzate. Vorrei precisare una cosa però: non dobbiamo pensare che esista una mutua esclusione tra decidere di salvare l’economia o di salvare delle vite umane, né che queste siano le uniche due possibilità. Se, come sembra, questa pandemia ci accompagnerà per chissà quanto tempo ancora, dobbiamo trovare un’alternativa valida alla chiusura come unico mezzo per combattere la diffusione del virus. Non sono un medico né faccio parte del famoso comitato tecnico scientifico in qualità di “esperto”, ma mi rifiuto di credere che l’unica via sia quelle delle chiusure: vorrei semplicemente che si investisse di più nella ricerca di alternative, potenziando la sanità e al contempo elaborando dei protocolli affinché le attività possano riaprire in sicurezza. Badate, non è una questione puramente economica, è una questione di dignità: il mio lavoro mi ha salvato in questa pandemia, perché mi ha dato uno scopo, dei compiti e delle attività da svolgere quando tutto intorno era fermo e non si vedeva una via di uscita. Posso ritenermi molto fortunato, ma non è stato così per tutti purtroppo: chiudere un’attività non significa solamente togliere una fonte di sostentamento economico a chi su quell’attività campa (e non venitemi a parlare dei ridicoli indennizzi statali, buoni solo a far del debito), ma anche privare la vita di quelle persone di un pezzo importante del loro essere, perché quando sentiamo dire che “il lavoro nobilita l’uomo” è dannatamente vero.
“Per molti la medicina rischia di essere peggiore della malattia.” Lo penso ancora e questo è vero specialmente se si considerano i devastanti effetti delle chiusure generalizzate. Vorrei precisare una cosa però: non dobbiamo pensare che esista una mutua esclusione tra decidere di salvare l’economia o di salvare delle vite umane, né che queste siano le uniche due possibilità. Se, come sembra, questa pandemia ci accompagnerà per chissà quanto tempo ancora, dobbiamo trovare un’alternativa valida alla chiusura come unico mezzo per combattere la diffusione del virus. Non sono un medico né faccio parte del famoso comitato tecnico scientifico in qualità di “esperto”, ma mi rifiuto di credere che l’unica via sia quelle delle chiusure: vorrei semplicemente che si investisse di più nella ricerca di alternative, potenziando la sanità e al contempo elaborando dei protocolli affinché le attività possano riaprire in sicurezza. Badate, non è una questione puramente economica, è una questione di dignità: il mio lavoro mi ha salvato in questa pandemia, perché mi ha dato uno scopo, dei compiti e delle attività da svolgere quando tutto intorno era fermo e non si vedeva una via di uscita. Posso ritenermi molto fortunato, ma non è stato così per tutti purtroppo: chiudere un’attività non significa solamente togliere una fonte di sostentamento economico a chi su quell’attività campa (e non venitemi a parlare dei ridicoli indennizzi statali, buoni solo a far del debito), ma anche privare la vita di quelle persone di un pezzo importante del loro essere, perché quando sentiamo dire che “il lavoro nobilita l’uomo” è dannatamente vero. “Tutti i cittadini devono rispettare le regole (leggi) dello Stato”. Ve lo confesso, su questa ho dei seri dubbi e la colpa è mia che non ho ancora capito Thoreau. Perché in questo anno di decreti legge e DPCM ne abbiamo lette e sentite come si dice “di cotte e di crude”, e se sarà pur vero che “la libertà è coscienza del dovere”, la mia coscienza mi impone di non stare zitto di fronte all’assurdità di certi provvedimenti, suggerendomi che la vera libertà è scegliere deliberatamente di non rispettarli, non per nuocere a qualcuno, ma per evitare che essi stessi possano continuare a prendersi gioco della nostra intelligenza. Sono stato il primo ad accettare i sacrifici e anzi, a rendermi conto che la vera libertà era scegliere di essere dalla parte della responsabilità, ma l’immobilismo e l’irrazionalità di certe decisioni mi hanno decisamente stufato: non sto dicendo che da domani inizierò a uscire dopo le 10 di sera o a fare delle feste in casa, continuerò a non vedere gli amici, a rispettare il coprifuoco e a mettere la mascherina all’aria aperta, ma se un anno fa lo facevo con convinzione, adesso proseguo solamente per inerzia. La verità è che dopotutto non sono così coraggioso: uscirei volentieri a fare una passeggiata dopo le 22 pur di contravvenire a una norma idiota e lo farei nel pieno rispetto di alcune misure che invece ritengo efficaci, ovvero uscire da solo e indossando la mascherina. Ed è qui che entra in scena Thoreau e vorrei davvero che qualcuno me lo spiegasse, perché forse non l’ho capito: se mi comportassi come ho detto starei praticando quella forma di protesta definita come disobbedienza civile o sarei più idiota della norma stessa? Quand’è che la nostra insubordinazione smette di essere un gesto nobile e diventa invece prevaricazione? Siamo noi a decidere sulla base delle nostre convinzioni personali, oppure ci dev’essere un comune sentire affinché si tratti di disobbedienza civile? La pandemia ha scatenato in me queste domande, perché mi ha posto di fronte a delle scelte: prima non le avevo mai avvertite perché ero in pieno accordo con le leggi dello Stato, o quantomeno le leggi che conosco. Non mi sarei mai sognato di ammazzare qualcuno come forma di disobbedienza civile, ma ora che queste leggi (non tutte, sia chiaro) mi appaiono così distanti dalla logica, non so come comportarmi. Se ci siete, vi prego, aiutatemi, ci vediamo in piazza alle 22.
“Tutti i cittadini devono rispettare le regole (leggi) dello Stato”. Ve lo confesso, su questa ho dei seri dubbi e la colpa è mia che non ho ancora capito Thoreau. Perché in questo anno di decreti legge e DPCM ne abbiamo lette e sentite come si dice “di cotte e di crude”, e se sarà pur vero che “la libertà è coscienza del dovere”, la mia coscienza mi impone di non stare zitto di fronte all’assurdità di certi provvedimenti, suggerendomi che la vera libertà è scegliere deliberatamente di non rispettarli, non per nuocere a qualcuno, ma per evitare che essi stessi possano continuare a prendersi gioco della nostra intelligenza. Sono stato il primo ad accettare i sacrifici e anzi, a rendermi conto che la vera libertà era scegliere di essere dalla parte della responsabilità, ma l’immobilismo e l’irrazionalità di certe decisioni mi hanno decisamente stufato: non sto dicendo che da domani inizierò a uscire dopo le 10 di sera o a fare delle feste in casa, continuerò a non vedere gli amici, a rispettare il coprifuoco e a mettere la mascherina all’aria aperta, ma se un anno fa lo facevo con convinzione, adesso proseguo solamente per inerzia. La verità è che dopotutto non sono così coraggioso: uscirei volentieri a fare una passeggiata dopo le 22 pur di contravvenire a una norma idiota e lo farei nel pieno rispetto di alcune misure che invece ritengo efficaci, ovvero uscire da solo e indossando la mascherina. Ed è qui che entra in scena Thoreau e vorrei davvero che qualcuno me lo spiegasse, perché forse non l’ho capito: se mi comportassi come ho detto starei praticando quella forma di protesta definita come disobbedienza civile o sarei più idiota della norma stessa? Quand’è che la nostra insubordinazione smette di essere un gesto nobile e diventa invece prevaricazione? Siamo noi a decidere sulla base delle nostre convinzioni personali, oppure ci dev’essere un comune sentire affinché si tratti di disobbedienza civile? La pandemia ha scatenato in me queste domande, perché mi ha posto di fronte a delle scelte: prima non le avevo mai avvertite perché ero in pieno accordo con le leggi dello Stato, o quantomeno le leggi che conosco. Non mi sarei mai sognato di ammazzare qualcuno come forma di disobbedienza civile, ma ora che queste leggi (non tutte, sia chiaro) mi appaiono così distanti dalla logica, non so come comportarmi. Se ci siete, vi prego, aiutatemi, ci vediamo in piazza alle 22.





 Con la crescita demografica successiva al VII secolo la fame di terra moltiplica gli attriti. Le scaramucce tra villaggi diventano ora vere e proprie campagne belliche e coinvolgono un numero sempre maggiore di combattenti. Da locali i conflitti diventano regionali. Le bande lasciano il posto agli eserciti, e per forza di cose il nucleo di questi ultimi non è più costituito dalla cavalleria, ma dalle falangi degli opliti. L’evoluzione delle tecniche militari consente la partecipazione attiva alle guerre anche a coloro che possono disporre solo di un armamento semplice: una cerchia sociale molto più ampia si trova quindi ad essere protagonista nei conflitti e chiede quale contropartita di diventare tale anche nei momenti decisionali. I privilegi della aristocrazia dei cavalieri sono sempre meno accetti, mentre si fa strada una concezione più “democratica” delle prerogative politiche. Se ne ha già un accenno, sia pure in termini totalmente spregiativi, con la vicenda di Tersite nel secondo libro dell’Iliade.
Con la crescita demografica successiva al VII secolo la fame di terra moltiplica gli attriti. Le scaramucce tra villaggi diventano ora vere e proprie campagne belliche e coinvolgono un numero sempre maggiore di combattenti. Da locali i conflitti diventano regionali. Le bande lasciano il posto agli eserciti, e per forza di cose il nucleo di questi ultimi non è più costituito dalla cavalleria, ma dalle falangi degli opliti. L’evoluzione delle tecniche militari consente la partecipazione attiva alle guerre anche a coloro che possono disporre solo di un armamento semplice: una cerchia sociale molto più ampia si trova quindi ad essere protagonista nei conflitti e chiede quale contropartita di diventare tale anche nei momenti decisionali. I privilegi della aristocrazia dei cavalieri sono sempre meno accetti, mentre si fa strada una concezione più “democratica” delle prerogative politiche. Se ne ha già un accenno, sia pure in termini totalmente spregiativi, con la vicenda di Tersite nel secondo libro dell’Iliade. Le tensioni si scaricano però anche al di fuori della penisola, incrementando la diaspora ellenica sia verso occidente, in quella che sarà la Magna Grecia, che verso la sponda asiatica dell’Egeo. I Greci, gli Ioni in particolare, si affidano sempre di più al mare. La vicenda stessa di Troia rievoca già un episodio di colonizzazione oltremare, ma sono soprattutto le peripezie di Odisseo a raccontarci i rischi e i modi di questa vocazione (ereditata peraltro dalla civiltà minoica, e alimentata dal desiderio di sottrarsi al nuovo ordine dorico). Il rapporto col mare diventa, soprattutto per le pòleis costiere, fondamentale, e non solo sul piano economico. Segna profondamente ogni aspetto della mentalità, a partire da quello politico. Lo sguardo rivolto al mare e quello rivolto alla terra sono diversi. Il primo induce a una “desacralizzazione” della natura molto più radicale: “Il mare è natura in un senso differente da quello della terraferma: è estraneo e ostile e come tale richiede, perché lo si possa addomesticare, artifici tecnici, e la nave è l’unico strumento che consente all’uomo di dominare gli sconfinati e pericolosi oceani. Sotto questo profilo la nave è simbolo di movimento, di espansione commerciale e di progresso. La peculiarità del progresso è il fatto di non conoscere alcuna sorta di limite, di ordine, di confine […] Il passo verso un’esistenza puramente marittima provoca, in se stesso e nella sua interna ulteriore consequenzialità, la creazione della tecnica in quanto forza dotata di leggi proprie […] L’incondizionata fede nel progresso è sintomo del passo compiuto verso un esistenza marittima”. (C. Schmitt, Terra e Mare)
Le tensioni si scaricano però anche al di fuori della penisola, incrementando la diaspora ellenica sia verso occidente, in quella che sarà la Magna Grecia, che verso la sponda asiatica dell’Egeo. I Greci, gli Ioni in particolare, si affidano sempre di più al mare. La vicenda stessa di Troia rievoca già un episodio di colonizzazione oltremare, ma sono soprattutto le peripezie di Odisseo a raccontarci i rischi e i modi di questa vocazione (ereditata peraltro dalla civiltà minoica, e alimentata dal desiderio di sottrarsi al nuovo ordine dorico). Il rapporto col mare diventa, soprattutto per le pòleis costiere, fondamentale, e non solo sul piano economico. Segna profondamente ogni aspetto della mentalità, a partire da quello politico. Lo sguardo rivolto al mare e quello rivolto alla terra sono diversi. Il primo induce a una “desacralizzazione” della natura molto più radicale: “Il mare è natura in un senso differente da quello della terraferma: è estraneo e ostile e come tale richiede, perché lo si possa addomesticare, artifici tecnici, e la nave è l’unico strumento che consente all’uomo di dominare gli sconfinati e pericolosi oceani. Sotto questo profilo la nave è simbolo di movimento, di espansione commerciale e di progresso. La peculiarità del progresso è il fatto di non conoscere alcuna sorta di limite, di ordine, di confine […] Il passo verso un’esistenza puramente marittima provoca, in se stesso e nella sua interna ulteriore consequenzialità, la creazione della tecnica in quanto forza dotata di leggi proprie […] L’incondizionata fede nel progresso è sintomo del passo compiuto verso un esistenza marittima”. (C. Schmitt, Terra e Mare)




 L’insistenza di Esiodo su una sensualità torbida è confermata quando Clitennestra ricorda l’uccisione di Cassandra, e dice che “aggiunse condimento al piacere del mio letto” (vv. 1446-1447) .
L’insistenza di Esiodo su una sensualità torbida è confermata quando Clitennestra ricorda l’uccisione di Cassandra, e dice che “aggiunse condimento al piacere del mio letto” (vv. 1446-1447) .


 Vorremmo condividere con tutti gli amici dei Viandanti delle Nebbie il piacere, e il sollievo, che abbiamo provato nel leggere finalmente delle analisi politiche – ma non solo – intelligenti e oneste.
Vorremmo condividere con tutti gli amici dei Viandanti delle Nebbie il piacere, e il sollievo, che abbiamo provato nel leggere finalmente delle analisi politiche – ma non solo – intelligenti e oneste.