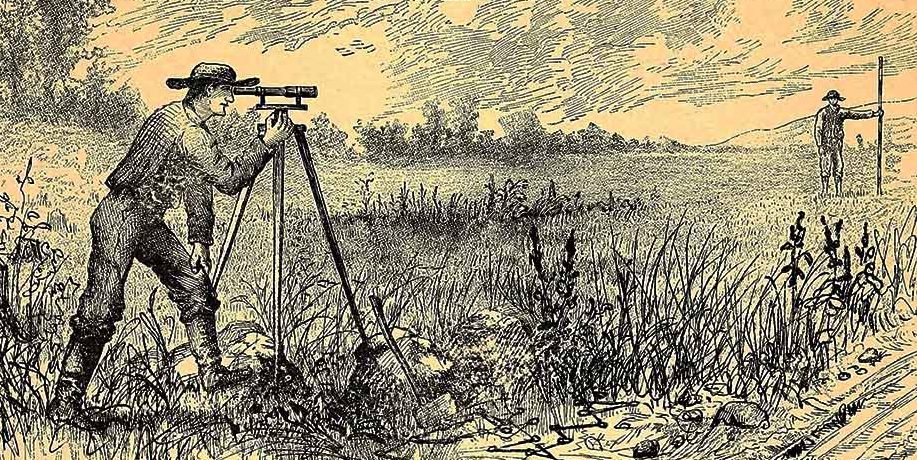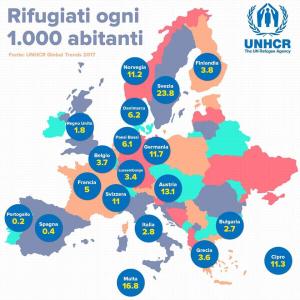Carlo Vidua e il destino della Virtù
 di Paolo Repetto, 6 maggio 2023, vedi il Quaderno
di Paolo Repetto, 6 maggio 2023, vedi il Quaderno
Introduzione
Un’educazione casalese
I primi viaggi
Romantico controvoglia
Dalla Lapponia all’Equatore
Nella culla della civiltà europea
In America!
Verso ovest e verso sud
Nell’Estremo Oriente
Morire nelle isole della Sonda
Sulle consonanze
Una bibliografia commentata

Introduzione
Un uomo che logorò la sua vita
viaggiando in rimoti paesi,
e morì nell’Oceanica.
(Vincenzo Gioberti a Pier Luigi Pinelli, 1834)
Leggetelo. È il libro di un saggio;
un po’ arretrato, come me.
(Gino Capponi a Niccolò Tommaseo, 1834)
Non ho un buon rapporto col Romanticismo italiano. Forse perché un autentico Romanticismo in Italia non c’è mai stato, e coloro che più gli si avvicinano in realtà ne hanno preso le distanze: Leopardi vale per tutti, e Manzoni è quanto di meno romantico riesca ad immaginare. Dal momento però che non può essere applicata al fenomeno una denominazione di origine controllata, ma soprattutto che le mie idiosincrasie non interessano giustamente a nessuno, mi limito a dire che come tutti i prodotti culturali d’importazione il Romanticismo è stato recepito da noi con le cautele e i distinguo e le ammortizzazioni del caso (vedi appunto Manzoni), sino a farne un’altra cosa, oppure si è ridotto ad una serie di dignitosissime cover degli originali nordici (vedi Berchet o D’Azeglio). Il che, intendiamoci, per quanto mi riguarda non implica alcun giudizio negativo o riduttivo: se I promessi sposi fosse stato scritto in uno stile più autenticamente romantico ne sarebbe uscito un feuilleton o una telenovela. Che poi mi ci riconosca o meno, è un altro discorso.
Eppure, a volerlo cercare, qualcuno che interpreta appieno quello spirito (per come, appunto, lo intendo io), negli intenti, nella pratica e purtroppo anche negli esiti, lo si trova. Personalmente l’ho trovato nella figura di Carlo Vidua, che ho incontrato troppo tardi perché potesse entrare nel mio ristrettissimo Pantheon, ma che si è senz’altro guadagnato il diritto di non finire nell’armadio degli accumuli inutili. Se proprio volessimo classificarlo entro gli schemi canonici, Vidua potrebbe essere ascritto alla scuola tedesca, a dispetto del fatto che la sua lingua madre fosse praticamente il francese: è apparentabile per molti più versi a Goethe e ad Alexander von Humboldt che a Chateaubriand (che pure amava particolarmente) e a Lamartine (che non amava affatto). Col che, chiudo le etichettature e passo al nostro protagonista.
La vita di Vidua è un emozionante romanzo di vagabondaggio, e proprio di questo voglio raccontare, del fuoco che ardeva nei suoi polpacci (e che fuor di metafora letteralmente glieli bruciò): cercando tuttavia di non trascurarne gli aspetti e gli interessi meno “avventurosi”, quelli che ardevano nella sua mente, a partire dalla politica (intesa in senso “globale”) sino alla linguistica, all’archeologia e alla musica. Nei limiti di questa breve presentazione cercherò dunque di dare spazio anche ad essi, anticipando, quando mi parrà il caso, quelle che dovrebbero essere considerazioni conclusive. Insomma, si sarà già capito che proverò a documentare il più possibile il Vidua “autentico”, ma che ne uscirà soprattutto l’idea che di Vidua mi sono fatto.

Un’educazione casalese
Carlo Vidua nasce conte di Conzano, paesino a metà strada tra Alessandria e Casale Monferrato, nel 1785. Tanto per “contestualizzarlo”, nasce lo stesso anno di Manzoni (li separa una settimana). Troppo tardi dunque per partecipare, anche solo emotivamente, all’infervoramento per la rivoluzione e agli umori contrastanti del periodo napoleonico, e troppo presto per vivere con ardore giovanile i primi moti carbonari. Diciamo che arriva giusto in tempo a beccarsi in pieno l’ondata reazionaria.
Si spiega così quello che potrebbe apparire un suo “disimpegno”: Vidua non è disimpegnato, è piuttosto un “non allineato”, che non si riconosce in alcuno dei modelli politici del suo tempo. È invece intrigato dalla loro varietà, quella che va emergendo mano a mano che gli orizzonti europei si allargano e nuovi popoli e nuove istituzioni si affacciano alla ribalta. Inoltre è un provinciale, e come Leopardi vive tutta la giovinezza lontano dai grandi centri dove la politica la si fa e la cultura ha i suoi luoghi deputati: cosa che in genere, e alla sua epoca ancor più, concorre a far vedere le cose con maggiore distacco (e, oserei dire, anche con maggior chiarezza).
Sempre come Leopardi, ha un padre convinto legittimista, col quale lo scontro è inevitabile, anche se per motivi che poco hanno a vedere con le opinioni politiche. Pio Vidua è un conservatore prudente, che ha evitato di compromettersi col bonapartismo ma anche di rovinare i propri interessi opponendoglisi apertamente, e che ottiene nel 1814 la nomina a ministro degli Interni nel primo gabinetto della restaurata monarchia sabauda per meriti puramente cortigiani. Non si segnala per spirito d’iniziativa o per particolari capacità politiche: è solo un passatista arroccato in difesa del prestigio e del rango del proprio casato. Per questo si opporrà sempre testardamente alle ambizioni e alla natura dell’unico figlio maschio, dal quale si attende solo la continuità della stirpe. Fino a quando gli è possibile ne condiziona quindi pesantemente le scelte, costringendolo a studiare privatamente con precettori religiosi (non gli consente nemmeno di iscriversi all’università e gli compera una laurea vaticana) e a tenersi lontano dagli ambienti “pericolosi”. Con tutto ciò, credo che quest’uomo abbia amato sinceramente, anche al netto delle motivazioni dinastiche, un figlio che ai suoi occhi pareva cercare ogni maniera e ogni pretesto per scontentarlo.
Da parte sua il giovane Vidua non riuscirà mai ad emanciparsi del tutto dalla soggezione filiale: anche se da un certo punto in avanti farà ciò che vuole, arrivando sino alla rottura insanabile, vivrà sempre la propria ribellione con un pesante senso di colpa. Continuerà a considerare sino all’ultimo il padre il suo principale interlocutore (delle 286 lettere di Carlo raccolte e pubblicate da Cesare Balbo la metà sono indirizzate a lui), e cercherà costantemente di rabbonirlo e consolarlo informandolo degli incontri con le massime personalità e autorità in ogni angolo del globo, del rispetto portato al suo nome e di come in fondo egli stesso contribuisca a farlo conoscere nel mondo e ad onorarlo. E comunque, quanto alle restrizioni impostegli in gioventù, il giovane patrizio ne fa buon uso, perché oltre che nelle lettere e nel diritto si impratichisce nel disegno e nella musica, e si sfoga con la scherma, l’equitazione e la danza.
Diversamente da Manzoni, Carlo non ha una madre (l’ha persa a quattro anni) che gli spalanchi le porte dei circoli intellettuali più avanzati. Ha in compenso un nonno materno che è stato un grande viaggiatore, dal quale eredita la passione, sia per via genetica che attraverso le rievocazioni serali (ed erediterà poi anche i mezzi per coltivarla). Lui stesso racconta che ancora molto piccolo, avendo udito un giorno il nonno narrare degli antipodi che abitano l’altra faccia della terra, aveva cominciato a scavare in giardino per andare a conoscerli. Credo che questo episodio, se anche fosse inventato, aiuti a capire per quale motivo Carlo rimanga tutto sommato estraneo al movimento patriottico e costituzionalista nel quale saranno coinvolti tutti i suoi migliori amici: nutre una conservatrice diffidenza nei confronti delle cospirazioni carbonare, ma soprattutto ha orizzonti e ambizioni più vasti.
Queste ultime le manifesta sin dalla giovane età. La matrigna Elisabetta, attenta ai sentimenti del ragazzo indubbiamente molto più del padre, scrive che “covava un fuoco segreto sin dall’età di otto anni e solo l’affliggeva il pensiero di non aver forse l’ingegno da farlo”. Un ritratto perfetto dell’animo di Carlo. Un ritratto che torna a più riprese nel diario e nelle lettere di quest’ultimo: “Se non sono gettato in un tourbillon io non farò mai e poi mai niente […] io, a venticinque, ventisei anni, voglio qualcosa di buono o nulla”. E continuerà a ribadirle (e a rimpiangerle), sino all’ultimo: “Ho tardato troppo, ho dilungato, nulla lascio di finito, e questa fama che sarà od è vanità, ma il cui desiderio mi animò tutta la vita, non la potrò conseguire fuor di pochi amici o parenti che in quarant’anni saran finiti, nessuno saprà che ho esistito” scriverà poco prima di morire.
Dunque: dobbiamo immaginare un’infanzia e un’adolescenza tutt’altro che libere e spensierate, ma in realtà molto meno oppressive di quanto a posteriori Carlo le ricordi (arriva a definire a più riprese la villa di Conzano “un carcere”). Più di una volta, mentre sta dall’altra parte del globo, gli capiterà di confrontare i paesaggi e le atmosfere con quelli della sua adolescenza monferrina, di trovare questi ultimi sempre superiori e di provare nostalgia per il grande giardino e per le cavalcate e le passeggiate, anche notturne, nelle “selve” e sulle colline tra Casale ed Asti (“Malgrado la presenza di briganti e ladri”, sottolinea). Queste “uscite” sono già una manifestazione dello spirito avventuroso e un po’ avventato che lo caratterizzerà, nonché di una propensione al protagonismo, e sono comprensibilmente viste con una certa apprensione in famiglia. La sorella, in una lettera alla nonna, scrive: “Sapevo già, cara nonna, delle scappate che il nostro giovanotto ha fatto quest’inverno, da un lato ne ho piacere, perché il movimento e le scappate con qualche amico gli sono necessarie e giovano alla sua salute, poi se lui prende le cose sempre in maniera un po’ eccessiva mi pare lo si possa perdonare a causa della sua età, tutti i giovani sono così”. A quanto pare, così prigioniero poi non era.
La nostalgia per l’aria di casa è tuttavia ogni volta smentita, non appena rimette piede nel regno di Sardegna. Non lo infastidisce solo la pressione dei familiari, ma tutto il vuoto apparato di convenzioni nel quale la classe cui appartiene si muove, quelle che lui stesso definisce “coglionerie”. “La mia solita felicità mi abbandona solo quando voglio fare ritorno in Piemonte; pare, che qualche genio me ne volesse allontanare per forza. Se fossi ai tempi degli antichi greci crederei che v’è una divinità nemica che mi caccia lungi dal Piemonte, come Ulisse lungi da Itaca.”
Se si escludono comunque pochi casi, ad esempio quello di Foscolo, la sua educazione non è diversa da quella dei giovinetti suoi contemporanei di condizione nobiliare o agiata. Ed è comprensibile che nei ritagli di libertà dagli impegni di studio e dai rituali domestici il ragazzo abbia cercato di evadere a piedi o a cavallo nei dintorni, e almeno con la mente negli spazi più remoti. Con la differenza, rispetto agli altri, che di là non è poi più rientrato.

Da Casale Monferrato, dov’è cresciuto, Carlo si trasferisce poco prima dei vent’anni con la famiglia a Torino. Lì frequenta i circoli letterari e politici “che contano”, stringendo amicizia particolarmente con Cesare Balbo, futuro patriota, ideologo (Le speranze d’Italia), storico e primo ministro del regno di Sardegna, nonché suo primo biografo. Con Balbo e coi rampolli di altre famiglie dell’aristocrazia torinese fonda un sodalizio (la Società dei Concordi), avente come scopo niente meno che il riscatto dell’Italia dal ritardo culturale in cui giace, e in particolare dalla soggezione, non solo politica, nei confronti degli occupanti francesi. Nel gruppo Vidua (che ha assunto il soprannome de “L’allungato”) mantiene una posizione defilata: da un lato è senz’altro una figura di riferimento, per la sua intelligenza e la sua erudizione, e anche per sua alfieriana intransigenza: dall’altro si riconosce solo sino ad un certo punto negli scopi della società, sia per una spiccata tendenza all’individualismo, sia perché convinto che occorra guardare oltre gli angusti confini della patria. La sua smania di viaggiare non sempre è compresa dagli altri affiliati, e questo creerà col tempo una crescente distanza.
Lo disturba anche il fatto che alcuni di loro ad un certo punto scendano a patti con quello che egli considera un invasore e un despota. Balbo stesso ad esempio accetta incarichi nell’amministrazione napoleonica a Firenze, e Carlo non esita a rinfacciarglielo. “Oserai tu entrare nella chiesa di Santa Croce? Non temerai l’ombre di quei grandi?” Quanto ad un personale impegno nella politica però è molto restio. Le sue simpatie vanno all’ala più liberale del movimento patriottico piemontese, impersonata da Santorre di Santarosa, piuttosto che a quella moderata facente capo a Balbo: ma nella sostanza, poi, dei destini politici del Piemonte gli importa solo fino ad un certo punto. Lo dimostra anche la scelta dei temi dai lui proposti e trattati nel corso delle adunanze dei Concordi: Pensieri sulla Gloria; Sopra il destino della Virtù; Sull’oblio in cui sono caduti alcuni uomini grandi, ecc…. La dimensione nella quale vuole dare senso e visibilità alla sua esistenza è ben altra.
Oltre a quella per i viaggi, la sua grande passione sono i libri. È un raffinato bibliofilo, ma non è mosso dal puro istinto collezionistico: la sua bibliofilia è sin dall’inizio finalizzata al disegno che va concependo. Dovunque arrivi si procura ogni possibile documento su qualsivoglia aspetto della vita politica, sociale, economica e culturale del paese, e spedisce poi il tutto in patria: nel corso dell’esperienza americana raccoglierà ad esempio oltre milletrecento volumi. Nelle lettere agli amici e ai famigliari ricorre costante l’ansia per le casse zeppe di scritti, oggetti d’arte, cimeli storici, inviate dai luoghi più impensati.
È anche un lettore appassionato e vorace, che rivendica e mantiene una forte autonomia di giudizio rispetto a quanto legge. È significativo, ad esempio, che sia un grande ammiratore dell’intelligenza di Joseph de Maistre, ma che non condivida affatto le idee espresse dal conte savoiardo ne Le serate di San Pietroburgo. O che adori le tragedie alfieriane, ma non esiti a deprecarne gli accenti anti-gerarchici e anti-religiosi. E lo stesso vale per l’Ortis.
Le sue letture sono sterminate: nella prima gioventù si nutre naturalmente, oltre che di Alfieri e di Foscolo, di Chateaubriand ma anche di Vico, dei classici della storiografia italiani e latini, degli illuministi francesi (e un po’ più tardi, quando avrà acquisito una sufficiente padronanza linguistica da quelli inglesi): in seguito si volgerà sempre più specificamente ad opere legate alle mete dei suoi viaggi, per preparare questi ultimi e per poi commentarli. Humboldt, naturalmente, e Ferguson, Gibbon, Montesquieu, Robertson, De Las Casas, ecc…
Come ho già accennato, tra i suoi amori c’è anche la musica. Questo gli è stato trasmesso soprattutto dalla nonna materna, ma in famiglia sono tutti appassionati, compreso il padre. È un ottimo esecutore, oltre che un discreto compositore. Scrive di lui Cesare Balbo: “Studiò la musica su varii strumenti e principalmente sul cembalo. Fece progressi grandi nell’ esecuzione e nell’accompagnamento, e tali poi nella composizione che non solo la musica sua corse il paese e l’Italia, ma egli ebbe il piacere navigando molti anni appresso tra i mari di Grecia d’udir risonare le sue melodie in quei climi così propizi”. Magari Balbo enfatizza un po’, ma pare davvero che il Vidua cembalista riscuotesse un gran successo nei palazzi e alle corti frequentati durante i suoi viaggi. Senza dubbio usava anche la musica come passepartout per entrare in confidenza con gli interlocutori che lo interessavano.
 E sempre a proposito di amori, poco o nulla si sa di una sua vita sentimentale “attiva”. Il giovanile accenno ad una fanciulla morta prematuramente (che si chiamava Teresa, come la Teresa Fattorini di A Silvia) è molto generico, e più che da un moto di commozione sincera sembra dettato dalla moda romantico-sepolcrale dell’epoca: “Io mirava quei flutti: e come l’onda, mio dicevo tra me stesso, che vedo trascorrere e confondersi, ratto così passò la gentile donzella, e già sta per confondersi, o si confonde il suo nome nella notte del tempo, e le sue belle forme tra le altre ceneri del sepolcro […]” . Più tardi ironizza sul fatto che gli sia stato attribuito un innamoramento per una “ninfa sestrina”, chiarendo che: “Nessuna donna possiederà mai una parte del mio cuore. Conviene che questo sesso sia al servizio del nostro divertimento e delle nostre necessità, non che sconvolga l’anima”. Il che lo escluderebbe da ogni sospetto di romanticismo, e parrebbe condannarlo all’aridità sentimentale. Anche se poi, quando arriva il tempo dei bilanci, sembra provare rimpianto quel flirt appena accennato: “[…] ricorderò con dolore di aver seguito i tuoi suggerimenti, e di non aver tolto quella ninfa sestrina di cui nel 1813 ti feci già una sì vantaggiosa descrizione”.
E sempre a proposito di amori, poco o nulla si sa di una sua vita sentimentale “attiva”. Il giovanile accenno ad una fanciulla morta prematuramente (che si chiamava Teresa, come la Teresa Fattorini di A Silvia) è molto generico, e più che da un moto di commozione sincera sembra dettato dalla moda romantico-sepolcrale dell’epoca: “Io mirava quei flutti: e come l’onda, mio dicevo tra me stesso, che vedo trascorrere e confondersi, ratto così passò la gentile donzella, e già sta per confondersi, o si confonde il suo nome nella notte del tempo, e le sue belle forme tra le altre ceneri del sepolcro […]” . Più tardi ironizza sul fatto che gli sia stato attribuito un innamoramento per una “ninfa sestrina”, chiarendo che: “Nessuna donna possiederà mai una parte del mio cuore. Conviene che questo sesso sia al servizio del nostro divertimento e delle nostre necessità, non che sconvolga l’anima”. Il che lo escluderebbe da ogni sospetto di romanticismo, e parrebbe condannarlo all’aridità sentimentale. Anche se poi, quando arriva il tempo dei bilanci, sembra provare rimpianto quel flirt appena accennato: “[…] ricorderò con dolore di aver seguito i tuoi suggerimenti, e di non aver tolto quella ninfa sestrina di cui nel 1813 ti feci già una sì vantaggiosa descrizione”.
In verità, l’ostinata resistenza che Vidua oppone al destino matrimoniale impostogli dal padre e dagli obblighi del suo status viene sempre da lui stesso intesa come una scelta non definitiva. “La sola ragione che mi indurrebbe ad abbandonare la libertà, che tanto apprezzo, sarebbe consolare mio padre che moltissimo rispetto, e che amo. Vedo dunque che alla fine per compiacerlo, finirò per rinunziare al genere di vita indipendente che finora ho goduto.” La sua opposizione non è ideologica, ma strategica. Ha pianificato la propria esistenza in funzione di un’opera che ne eterni la memoria, e questa opera suppone una conoscenza che può essere acquisita solo attraverso i viaggi. La passione per i viaggi, che in un’ottica del genere diventa strumentale, è tale che tutto di fronte ad essa passa in second’ordine. È l’unica cosa per la quale valga la pena ribellarsi e difendere le proprie scelte, e va vissuta sin a quando si regge. “Io voglio preparare alla mia età matura meno regrets che possa. Ne avrei certo se mi maritassi senza compiere il corso dei miei viaggi.” Una volta appagata – e l’appagamento può venire solo dall’aver completato il giro del mondo e dall’aver conosciuto tutte le civiltà possibili – al resto ci si può adattare di buon grado.
Può anzi essere la condizione indispensabile per tirare le somme e dedicarsi finalmente alla scrittura: “Ma per tutto questo ci vorrebbe tempo, tranquillità, ritiro e compagnia, e in questo inclino al parer tuo, compagnia di una donna, che assorbendo a sé l’affetto, non lo lasciasse più divagare. Hai ragione, è tempo di stabilirsi.”
Non fosse per la smania di muoversi, Vidua potrebbe dunque essere il perfetto protagonista dei salotti romantici torinesi, e permettersi anche il brivido della cospirazione. Tutto questo però non lo soddisfa: “Molte cose ci sono in questo particolare degne di attenzione, che non si possono o malagevolmente apprender dai libri; onde è necessario vederle ove sono, osservare come vengono poste in uso e qual effetto ne procede, per questo motivo i viaggi potranno servire di strumento efficacissimo, onde ampliare le idee e moltiplicare le cognizioni”.

I primi viaggi
Vallo però a spiegare al padre, che lo vorrebbe sposato e avviato ad una carriera amministrativa o politica di alto livello e che tiene ben stretti i cordoni della borsa. Di fatto Carlo riesce a sganciarsi e ad allontanarsi più spesso da casa solo dopo i venticinque anni, quando comincia a godere di una rendita propria. “Io era dunque così sovranamente stufo di non far niente, di non avere nessuno scopo nella mia vita, così annoiato, senza alcuna speranza nemmeno di poter viaggiare stanti le difficoltà di mio padre, che mi saltò l’idea di partire da Torino, andare in qualche città lontana […].” Lo fa viaggiando nel 1810 per la prima volta fuori d’Italia, in terra francese, compiendo una sorta di pellegrinaggio nei luoghi petrarcheschi. Si porta dietro tutti i suoi pregiudizi nei confronti della patria del giacobinismo (“Più vedo questa Francia e più mi insuperbisco di essere nato italiano.”), pregiudizi che conserverà per tutta la vita, ma matura per Petrarca una vera adorazione. E soprattutto ha la conferma che il suo futuro non può essere che nel viaggio: “Trovo che l’agitazione dei viaggi, il moto, il cambiamento di oggetti, la varietà dei naturali e dei costumi delle persone che vi si incontrano, innalzano l’animo, fanno nascere delle riflessioni, vi tolgono molti pregiudizi e maniere di pensare, vi danno dell’esperienza di mondo, vi accostumano a parlar bene”. E infatti al rientro intraprende subito un lungo giro per l’Italia centrale. Percorre a cavallo tutta la Toscana e buona parte dell’Umbria, riempiendosi gli occhi di arte e di natura e il cuore di emozioni: ad esempio davanti alle selve di abeti di Vallombrosa, che “fanno parer vere le selve incantate dell’Ariosto”. Naturalmente tutto questo, anziché appagarlo, gli alimenta una irrequietudine e una voglia di fuga sempre maggiori.
È costretto però ancora per qualche tempo a mordere il freno, anche se ormai il bisogno di muoversi è diventato quasi un’ossessione: “Se non esco da quel circolo di Casale, Conzano e Torino languirò eternamente senza far nulla di buono”. Il primo vero strappo con la famiglia avviene nel 1813: dopo un lungo soggiorno in Liguria (dove conosce la “ninfa sestrina”, e tra una camminata e una cavalcata lavora a una storia di Firenze – poi perduta), alla fine dell’anno torna in Francia, passando per Ginevra e raggiungendo questa volta Parigi, in tempo per assistere alla caduta di Napoleone e all’occupazione della città da parte degli Alleati. La cosa non lo emoziona più di tanto, non ne parla quasi. Si potrebbe manzonianamente dire che “di mille voci al sonito / mista la sua non ha”. Si limita a commentare: “Quantunque questi avvenimenti siano degni di memoria, nondimeno se fossi io un Tacito preferirei a tutti gli argomenti e le scene che presentano quei giorni quello della condotta e dei sentimenti della nazione vinta; io non ne fui mai gran cosa ammiratore. Chi non è stato in Francia non può ben apprezzare, e poi chi non li ha veduti in questa occasione non può non conoscere in tutta la sua estensione quel misto di leggerezza e di eccesso, di sedizioso e di pieghevole, che non ne fa un popolo unico”. Col che, i francesi sono sistemati.
Questa volta ha deciso l’itinerario autonomamente, all’insaputa della famiglia (anche se di fronte al fatto compiuto il padre provvederà a finanziargli parte delle spese). E ne approfitta. Infatti non rientra, ma durante l’estate del 1814 si sposta in Inghilterra e in Irlanda, e passa poi in Scozia. Oltremanica constata i primi effetti della rivoluzione industriale sul paesaggio, sulle tradizioni, sui costumi e sui caratteri, e ne è disgustato. “Quel che non si sente più è la voce del Bardo. Né più si incontra la dolce ospitalità né la valorosa ferocia. Grazie a quelle malnate novità si sono aperte per ogni dove delle nuove strade, si sono costruiti dei ponti, si tagliarono i boschi. Invece dei famosi guerrieri si ritrovano dei grossi mercanti accorti nel loro interesse […].” In un viaggio successivo sarà invece positivamente colpito dalle istituzioni anglosassoni, soprattutto dopo aver assistito alla sobrietà di una seduta parlamentare. Per ora rientra infine attraverso Belgio e Olanda, ripassando nuovamente per Parigi e rinnovando il suo giudizio negativo.
Nel frattempo è assai cresciuto, e non solo intellettualmente. La descrizione fattane da un corregionale che lo ha incontrato a Parigi nel 1814 ci offre un sembiante ben diverso da quello rimandato dai suoi unici due ritratti esistenti. “[…] grandissimo di statura, ma cotanto magro che di più nol potea essere. La di lui fisionomia era veramente brutta, la pelle giallognola, la bocca squarciata, mostrando denti e gengive in pessimo stato, dimesso assai nel vestire, gonzo nel camminare e vi si aggiungeva la vista breve […]. Ma allorché parlava, era tanta la sua istruzione, tale la sua eloquenza, che tutto facea dimenticare l’orrido della sua presenza […]. Era erudito nelle lingue italiana, latina francese e inglese, e tutte le parlava con facilità e bella pronuncia. Era avido di apprendere le costumanze delle genti ove egli recavasi […].Era tutto originalità del modo suo di vedere e di giudicare […]. Al clavicembalo […] suonava con grande maestria e profonda espressione. Avea una voce perfida, ma la sapea modulare a cagionar diletto.”
Evidentemente i viaggi, soprattutto se affrontati come in questo caso con scarsità di mezzi, lasciano il segno. Sembra davvero il brutto anatroccolo: e il prosieguo del racconto, dove si parla di un suo brutale arresto a Le Havre per sospetto di spionaggio o di contrabbando, e di come il conte abbia atteso di essere portato davanti a un tribunale per palesare la sua identità e impartire una lezione di civismo alle autorità francesi, completa il quadro.

Romantico controvoglia
La vera vita di Carlo Vidua, quella che a me interessa, comincia dunque proprio mentre si chiude in Europa la parentesi napoleonica. Non è solo una coincidenza. A chi come lui è assetato di gloria la cappa grigia della restaurazione chiude nel vecchio continente ogni orizzonte. Scrive a Cesare Balbo: “Credi tu che gl’istorici dei nostri tempi tra la folla dei nomi da tramandare ai posteri sceglieranno il mio? Mai no: fuori che una qualche circostanza rarissima attacchi il mio nome a qualche grandissimo avvenimento”. Cosa che oggettivamente non solo a Conzano, ma in tutto il Piemonte, per uno che oltretutto rifiuta di entrare nella guardia imperiale, è difficile attendersi. Per qualche tempo, tra il luglio 1815 e la primavera del 1818, torna dunque a muoversi tra Casale e Torino, mettendo mano anche alle osservazioni maturate nel primo viaggio; ma ha ormai chiaro ciò che vuole e già progetta mete lontane (nel mirino ci sono gli Stati Uniti, il Canada e l’America Latina). Coltiva pertanto le amicizie e le conoscenze che possono procurargli agganci e agevolare i suoi futuri spostamenti, si dedica alle studio delle lingue e delle storie, e comincia a maturare il disegno di una grande opera comparativa tra i vari sistemi politici di tutto il mondo, da fondarsi sull’esperienza diretta.
Con tutto questo non rimane estraneo al dibattito culturale acceso in Italia dal clima della Restaurazione, quello che contrappone i “classicisti” ai “romantici”. Vi partecipa anzi tempestivamente, stendendo nel 1816 (o forse già nel 1813) un discorso Dello stato delle cognizioni in Italia che anticipa non solo nei tempi, ma nei modi e nelle conclusioni, il leopardiano discorso Sullo stato presente dei costumi degli italiani, pubblicato otto anni dopo (nel 1824). Lo fa però a modo suo: sia perché sposta il discorso dal piano artistico-letterario e da quello politico all’analisi storico- antropologica, sia perché alla fine non pubblica il trattatello (che verrà dato alle stampe ad opera di Cesare Balbo solo dopo la sua morte, nel 1834).
Nel suo scritto Vidua imputa il ritardo accumulato dalla cultura italiana principalmente a tre fattori. Intanto la tendenza dei nostri intellettuali a oscillare tra l’imitazione pedissequa e idolatra dei classici, che si risolve in pura erudizione, e quella altrettanto acritica degli stranieri. Poi l’ignoranza diffusa tra le classi basse. A questo proposito più tardi scriverà: “Dobbiam confessare per nostra vergogna che in molte parti d’Europa e specialmente in Piemonte v’è molta minor proporzione di persone del popolo che sappian leggere che nelle Filippine e tra’ Cristiani delle Molucche”. Su questa ignoranza hanno fatto sempre leva le classi dominanti (nelle quali Vidua però non fa rientrare la Chiesa: le riconosce anzi una funzione civilizzatrice), usandola strumentalmente per il loro dominio, mentre “ormai la propagazione della lingua, la celebrità della letteratura, ed il vanto delle cognizioni sono divenute una maniera di acquistar reputazione, un titolo di gloria nazionale, uno strumento di potere”. Strumento da utilizzarsi nei confronti del popolo “ad addolcirne i costumi, ad affezionarlo alla patria e ad istruirlo nei rudimenti della religione, della lingua e dell’ agricoltura”.
 Per intanto il primo dei problemi da affrontare è, secondo Vidua, l’assenza di una lingua comune, conseguenza di un desolante provincialismo: “Siamo più stranieri a noi stessi che agli altri: è cosa deplorevole che più differenza e opposizione di idee e di costumi vi sia tra l’una e l’altra delle nostre province e un’altra nazione europea o anche asiatica”. Questo nasce, oltre che dalle contingenze storiche (le diverse dominazioni che si sono susseguite sulla penisola), dal fatto che da noi la classe colta ha continuato testardamente e arrogantemente ad esprimersi in latino, salvo poi nel corso del Settecento volgersi al francese, allargando così sempre più la forbice culturale nei confronti degli altri ceti e non favorendo l’evoluzione dei diversi volgari verso un idioma comune. In realtà, gli esempi per la costruzione di una lingua condivisa esistono, arrivano da tutta la letteratura rinascimentale pre-barocca e possono costituire la base per mettere fine alle sterili dispute in difesa degli usi lessicali localistici. E una volta individuata la direzione, la lingua per Vidua deve essere difesa da un lato contro la “corruzione dei dialetti”, dall’altro dall’“infranciosamento”, dall’adozione di termini e costrutti stranieri che sono le crepe attraverso le quali si insinuano anche le perniciose idee d’oltralpe.
Per intanto il primo dei problemi da affrontare è, secondo Vidua, l’assenza di una lingua comune, conseguenza di un desolante provincialismo: “Siamo più stranieri a noi stessi che agli altri: è cosa deplorevole che più differenza e opposizione di idee e di costumi vi sia tra l’una e l’altra delle nostre province e un’altra nazione europea o anche asiatica”. Questo nasce, oltre che dalle contingenze storiche (le diverse dominazioni che si sono susseguite sulla penisola), dal fatto che da noi la classe colta ha continuato testardamente e arrogantemente ad esprimersi in latino, salvo poi nel corso del Settecento volgersi al francese, allargando così sempre più la forbice culturale nei confronti degli altri ceti e non favorendo l’evoluzione dei diversi volgari verso un idioma comune. In realtà, gli esempi per la costruzione di una lingua condivisa esistono, arrivano da tutta la letteratura rinascimentale pre-barocca e possono costituire la base per mettere fine alle sterili dispute in difesa degli usi lessicali localistici. E una volta individuata la direzione, la lingua per Vidua deve essere difesa da un lato contro la “corruzione dei dialetti”, dall’altro dall’“infranciosamento”, dall’adozione di termini e costrutti stranieri che sono le crepe attraverso le quali si insinuano anche le perniciose idee d’oltralpe.
Ciò non implica assolutamente un atteggiamento di chiusura nei confronti delle culture straniere. Il ritardo nei loro confronti è evidente, e Vidua indica naturalmente come rimedio più efficace per ridurlo quello dei viaggi (citando tra l’altro come esempi proprio i fratelli Humboldt, un linguista e uno scienziato-viaggiatore): “Di due fratelli illustri in Prussica, un passava come ambasciatore dall’una ad altra corte d’Europa, mentre l’altro passava come dotto dall’una all’altra Cordigliera del Perù”.
Quanto alla mancata pubblicazione del suo piccolo trattato, Carlo la spiega poi in una lettera lamentando incertezze sullo stile e accampando la necessità di lasciar decantare lo scritto per qualche mese: ma la ragione vera è che ha altro per la testa. Ha superato i trent’anni, è uno spilungone alto più di un metro e novanta e in buona salute, possiede tutti i numeri e la preparazione di base per svolgere un lavoro scientifico serio, compresa la conoscenza di diverse lingue, antiche e moderne, sa conversare piacevolmente, perché sa porre le domande e soprattutto sa ascoltare le risposte, gode finalmente anche di una discreta indipendenza economica per aver ereditato dai nonni materni: non può perdere altro tempo rispetto ai suoi progetti. E, non ultimo, vuole sottrarsi il più possibile al controllo del padre.

Dalla Lapponia all’Equatore
Per questo continua a scalpitare, e alla fine di aprile del 1818 s’incammina nuovamente per Parigi e Londra, questa volta in compagnia dell’amico Alessandro Doria e di un domestico, Leonardo. È riuscito “dopo qualche difficoltà” a strappare l’assenso del padre – o almeno così lui dice in una lettera alla matrigna, alla quale chiede ora sostegno, e non solo morale: “Il desiderio mio di istruirmi, di non perdere l’occasione di essere con un amico, i grandi vantaggi e per conto della sicurezza e anche pel caso di malattia che derivano dall’essere in buona compagnia, la considerazione che se ritardo ancora a viaggiare, aspetterei poi troppo tardi a maritarmi […] mi spinsero a partir subito ed a fare quanto era in me per non lasciar sfuggire questa opportunità. […]. Ma i viaggi lontani a farli con comodo e senza rischiar la salute esigono assai maggior spesa, a cui lo stato presente dei miei interessi non potrebbero forse bastare, laonde […] la prego volermi aiutare in questa circostanza … Se n’avrò i mezzi, l’idea mia sarebbe di fare tutto in una volta il giro di que’ paesi, che meritano esser veduti, onde poi tornare a casa tranquillo e stabilirmi”.
Dall’Inghilterra, dove si riconcilia se non col paesaggio almeno con la cultura giuridica e politica anglosassone, passa all’inizio dell’estate in Danimarca, e poi in Svezia. Assiste ad alcune udienze concesse dal sovrano ai rappresentanti dei diversi ceti popolari, e le trova decisamente istruttive. Risale quindi la penisola scandinava spingendosi sino alla Lapponia, dove soggiorna per un mese. Ha probabilmente in mente l’esperienza di Giuseppe Acerbi (all’epoca direttore de la Biblioteca Italiana, la rivista dei “classicisti”), che in Lapponia era stato negli anni 1798/99, e aveva poi raccontato i suoi viaggi in due fortunati volumi: ma non è escluso abbia notizia anche del Viaggio settentrionale di Francesco Negri, pubblicato più di un secolo prima. Raccoglie numerose notizie sulla demografia e sui costumi dei Sami, che affida al suo taccuino, e trova e annota le tracce dei viaggiatori che lo hanno preceduto.

Ridiscende quindi attraverso la Finlandia sino a Pietroburgo (1 ottobre), dove è ricevuto persino dallo zar Alessandro I, e a Mosca, dove dimora per altri due mesi. Sin qui ha in pratica seguito l’itinerario del suo quasi concittadino Vittorio Alfieri, che all’epoca, assieme al Foscolo, è un po’ il modello di tutti i giovani italiani, e in specie dei piemontesi. La Russia, al contrario della Svezia, non gli piace granché: ma vi dimora comunque undici mesi e fa incetta di documenti e di incontri. E non ha nei confronti del dispotismo russo la stessa reazione sprezzante che era stata dell’Alfieri (che non aveva neppure voluto essere presentato a Caterina II).
A questo punto, mentre Doria rientra in Italia, Vidua prosegue per Novgorod e quindi verso il Caucaso. Il viaggio occupa la primavera e l’estate del 1819, e durante questi mesi il conte entra a contatto con Cosacchi, Circassi e Tartari, e partecipa anche alle loro attività di caccia. Per un certo periodo si ferma poi presso i Calmucchi, dei quali apprezza soprattutto i riti religiosi, le danze e la musica. Infine passa in Crimea.
Da Odessa attraversa dunque il Mar Nero e il primo di settembre è a Costantinopoli. Trova i turchi sgarbati ed insolenti, sospettosi e ostili nei confronti degli stranieri, per cui è necessario viaggiare sempre accompagnati da un giannizzero. In realtà ciò che maggiormente lo disturba è la difficoltà nel reperire quei piccoli tesori archeologici dei quali altrove fa man bassa. Lascia dunque la capitale ottomana e visita Smirne e le isole greche, e alla fine del 1819 approda in Egitto. Qui si fermerà per un anno, spingendosi nel corso di varie spedizioni lungo il Nilo sino alla seconda cateratta, nella Bassa Nubia.
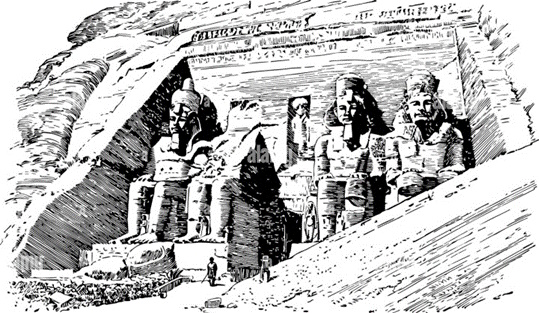 Il trasferimento da Alessandria al Cairo è compiuto con una piccola carovana che consente di farci un’idea di come viaggia Vidua: è accompagnato da due arabi che conducono un cammello, un cavallo e due asini con i bagagli, mentre lui e il suo domestico Lorenzo viaggiano a loro volta a cavallo. Il bagaglio comprende una tenda, due letti, le vesti, la biancheria e le scarpe, i fucili e le pistole, più una batteria da cucina, i viveri e le bevande. Non è l’immagine classica (e romantica) dell’esploratore o del giramondo alla quale noi oggi siamo abituati, ma occorre considerare come all’epoca, e specialmente in quelle terre, non fosse facile trovare sistemazioni notturne e posti di ristoro. Non mancavano certamente gli avventurieri capaci di affrontare i deserti o le foreste africane armati solo del loro coraggio (vedi René Caille o, più tardi, Richard Burton), ma Vidua non è né un esploratore né un avventuriero, è un giovanotto di famiglia patrizia che ha scelto di compiere il suo Gran Tour, il suo viaggio iniziatico, fuori dell’Europa. L’equipaggiamento di cui sopra è comunque praticamente lo stesso col quale si muoveva nei medesimi luoghi, esattamente due secoli prima, un altro viaggiatore italiano, Pietro della Valle.
Il trasferimento da Alessandria al Cairo è compiuto con una piccola carovana che consente di farci un’idea di come viaggia Vidua: è accompagnato da due arabi che conducono un cammello, un cavallo e due asini con i bagagli, mentre lui e il suo domestico Lorenzo viaggiano a loro volta a cavallo. Il bagaglio comprende una tenda, due letti, le vesti, la biancheria e le scarpe, i fucili e le pistole, più una batteria da cucina, i viveri e le bevande. Non è l’immagine classica (e romantica) dell’esploratore o del giramondo alla quale noi oggi siamo abituati, ma occorre considerare come all’epoca, e specialmente in quelle terre, non fosse facile trovare sistemazioni notturne e posti di ristoro. Non mancavano certamente gli avventurieri capaci di affrontare i deserti o le foreste africane armati solo del loro coraggio (vedi René Caille o, più tardi, Richard Burton), ma Vidua non è né un esploratore né un avventuriero, è un giovanotto di famiglia patrizia che ha scelto di compiere il suo Gran Tour, il suo viaggio iniziatico, fuori dell’Europa. L’equipaggiamento di cui sopra è comunque praticamente lo stesso col quale si muoveva nei medesimi luoghi, esattamente due secoli prima, un altro viaggiatore italiano, Pietro della Valle.
In Egitto dà la concreta dimostrazione di non essere un viaggiatore per diporto, ma uno studioso dotato di notevole intuito e di metodo nella ricerca. Lo testimonia l’egittologo Frédéric Caillaud, che condivide con lui un breve periodo di ricerca: “Durante il mio soggiorno al Cairo ho conosciuto un viaggiatore assai interessante, il conte Vidua di Torino, che era arrivato in Egitto dalla Lapponia: aveva già visitato i monumenti della Bassa Nubia, disegnato le piante di quei monumenti con la cura più scrupolosa, e usato la stessa esattezza nel copiare le iscrizioni […]. Eravamo insieme sulla via per Suez quando ho scoperto gli alberi pietrificati […]. Ho ascoltato i suoi racconti con viva curiosità, ed egli volle ascoltare con lo stesso interesse la narrazione dei miei viaggi”. Vidua visita appunto tutti maggiori siti storici, corredando i suoi appunti con disegni, e trascrive una serie di iscrizioni trovate all’interno del tempio di Abu Simbel (che pubblicherà dopo il ritorno, unica opera sua edita in vita). Il colpo da maestro è però l’acquisto a nome del governo sabaudo della collezione di antichità egizie raccolte da Bernardino Drovetti, un ex ufficiale napoleonico con l’animo dell’avventuriero e del saccheggiatore, che ha ammassato una quantità di reperti unica al mondo. Questo acquisto porrà le basi per la nascita del museo egizio di Torino, mentre la raccolta di iscrizioni lo farà conoscere a tutti gli studiosi della nascente egittologia, compreso Champoillon, che cercherà di associarlo alle sue ricerche.
 Carlo Vidua non è però uomo da concentrarsi su un solo paese e votarsi a un unico campo di studi. Vuole lasciare la sua impronta un po’ in tutti. Intanto comincia col lasciarla concretamente. In Egitto, ad esempio, incide il proprio nome su tutti i monumenti visitati, tanto da guadagnarsi lo stigma negativo di Flaubert: “Leggiamo nei templi i nomi dei viaggiatori: mi sembra una vana piccineria. Ce ne sono che hanno richiesto tre giorni per essere incisi. Qualcuno si ritrova dappertutto, con una costanza di imbecillità sublime. C’è uno di nome Vidua, che non ci lascia mai […]”. In effetti, la cosa può riuscire fastidiosa: ma è chiaro che nel caso del nostro non è una imbecillità da turista, bensì quasi un marcare il territorio, e inviare un messaggio agli amici e ai posteri. Che a volte lo recepiscono: è già capitato a lui in Lapponia, e quando qualche anno dopo Santorre di Santarosa troverà su una colonna di un tempio di Atene il nome di Vidua, suo amico, inciderà accanto ad esso il proprio.
Carlo Vidua non è però uomo da concentrarsi su un solo paese e votarsi a un unico campo di studi. Vuole lasciare la sua impronta un po’ in tutti. Intanto comincia col lasciarla concretamente. In Egitto, ad esempio, incide il proprio nome su tutti i monumenti visitati, tanto da guadagnarsi lo stigma negativo di Flaubert: “Leggiamo nei templi i nomi dei viaggiatori: mi sembra una vana piccineria. Ce ne sono che hanno richiesto tre giorni per essere incisi. Qualcuno si ritrova dappertutto, con una costanza di imbecillità sublime. C’è uno di nome Vidua, che non ci lascia mai […]”. In effetti, la cosa può riuscire fastidiosa: ma è chiaro che nel caso del nostro non è una imbecillità da turista, bensì quasi un marcare il territorio, e inviare un messaggio agli amici e ai posteri. Che a volte lo recepiscono: è già capitato a lui in Lapponia, e quando qualche anno dopo Santorre di Santarosa troverà su una colonna di un tempio di Atene il nome di Vidua, suo amico, inciderà accanto ad esso il proprio.
È comunque evidente che il viaggio non è più per lui solo lo “stromento efficacissimo onde ampliare le idee e moltiplicare le cognizioni”: quando fa incidere su uno dei colossi di Abu Simbel “Carlo Vidua Italiano qui venne dalla Lapponia” posa un mattone per un suo futuro monumento. E lo stesso fa quando racconta in termini “eroici” agli amici le proprie esperienze: “Ho sofferto il soffribile, otto giorni con acqua putrida nel mese di luglio sotto questo sole, tre giorni non avendo altro cibo, né bevanda che quattro meloni, trottar sui dromedari: infine ho voluto provare che cosa era un viaggio al deserto, e ne posso dire qualche cosa”.

Nella culla della civiltà europea
Ad agosto del 1820 Vidua lascia l’Egitto e risale verso la Terrasanta. Qui compie il rituale pellegrinaggio a Nazareth, a Betlemme e al Santo Sepolcro di Gerusalemme: poi trascorre l’autunno visitando Tiro, Sidone, Damasco, Tripoli e Beirut, e spingendosi sino a Palmira. Nel dicembre finalmente decide di rientrare in Europa, facendo scalo prima a Cipro e poi a Rodi. Il maltempo che osteggia la navigazione lo costringe a sbarcare nell’isola di Cos, e qui la sua imperturbabilità di fronte al genere femminile viene scossa: “Le donne sono molto belle, molto vivaci, molto disinibite, e lungi dal coprirsi il volto come in tutto il resto della Turchia, esse amano guardare e farsi guardare […]. Le ragazze si affrettano ad andare alla passeggiata o a danzare per le vie, dove piazzate davanti alle porte delle loro case stuzzicano gli uomini con proposte piccanti, e si divertono a ridere, a motteggiare, a sostenere conversazioni sfrontate”. Sembra di leggere pari pari l’elogio delle donne di Cos tessuto due secoli prima da Della Valle. Quindi, delle due l’una: o Vidua ha letto i Viaggi di Della Valle, o le donne di Cos sono davvero sempre state così, belle e impudenti.
Durante la successiva navigazione nell’Egeo deve addirittura sostituirsi al comandante della nave su cui viaggia, visto che “[…] il capitano, il pilota e tutti i marinai erano nelle tenebre”. Approda ad Atene nell’aprile del 1821 e vi si ferma per sei settimane. La città è in rivolta contro il dominio ottomano, ma il conte non sembra affatto essere emotivamente partecipe della vicenda. L’unico suo coinvolgimento arriva da una palla di cannone che gli entra in camera durante il bombardamento turco: “Una palla di cannone venne a trovarmi in camera, mentre ero ancora a letto, senza far altro che guastare un poco il muro […]. Quanto alle palle di fucile, ne vennero molte in casa mia, senza far danno né a me, né ad altri. Se i turchi avessero saputo […]”. Per il resto, passeggia tranquillamente per la città mentre piovono le bombe. Sembra il tipico understatement inglese, un po’ cinico e decisamente antiromantico, ma in realtà è lo stesso atteggiamento col quale Leopardi (ancora lui) prendeva le distanze dai patrioti “progressisti” del circolo Viesseux. È uno sguardo disincantato sulle cose e sulla storia, che non significa rassegnazione, ma ricerca di senso, per sé e per il mondo, in ideali filosofici ed estetici più alti delle infatuazioni patriottiche o delle lotte per le cause perse. Insomma, per dirla in altre parole, Vidua è senz’altro in cerca di gloria e di fama personale, ma vuole guadagnarsi l’una e l’altra con qualcosa che vada oltre il bel gesto o l’atto di insensato coraggio. A combattere con i Greci è invece il suo domestico Leonardo, che rompe gli indugi, lascia il padrone dopo avergli sequestrate tutte le armi e passa nelle fila dei rivoltosi, facendo una carriera militare rapidissima. “A quest’ora sarà diventato generale”, commenta sarcasticamente Carlo quando ne dà notizia al padre. E licenzia il domestico.
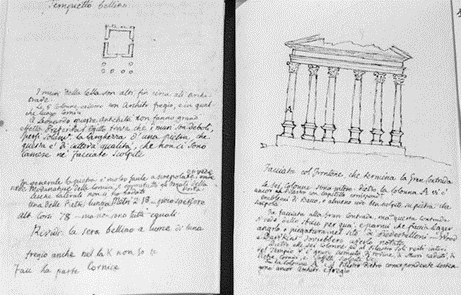 Intanto, le vicende rivoluzionarie che potrebbero magari direttamente coinvolgerlo (i moti piemontesi del 1821), e che vedono protagonisti i suoi amici Balbo e Santorre di Santarosa, si stanno consumando in sua assenza. Ma anche su quelle, a posteriori, il suo giudizio non si spingerà oltre la personale simpatia per gli sfortunati (e ingenui) patrioti.
Intanto, le vicende rivoluzionarie che potrebbero magari direttamente coinvolgerlo (i moti piemontesi del 1821), e che vedono protagonisti i suoi amici Balbo e Santorre di Santarosa, si stanno consumando in sua assenza. Ma anche su quelle, a posteriori, il suo giudizio non si spingerà oltre la personale simpatia per gli sfortunati (e ingenui) patrioti.
A risparmiare a Carlo la necessità di schierarsi interviene comunque il caso. Ripartito da Atene dopo aver assistito alla sua capitolazione, si trova nuovamente bloccato per due mesi a Smirne, dove nel giugno del 1821 assiste inorridito alle stragi compiute dalle milizie ottomane. Anche il resto del viaggio è travagliato, o quanto meno interminabile, tanto da fargli scrivere: “Pareva che fossimo incaricati di disegnare le coste, o di dar l’ispezione ai porti”. Arriva infatti in vista di Marsiglia solo alla fine di settembre del 1821. Qui però deve scontare un lunghissimo periodo di quarantena (due mesi senza poter sbarcare dalla nave e altri due confinato in un lazzaretto della città), perché proveniente da località nelle quali imperversa la peste. La descrizione che fa di questo soggiorno conferma i lati migliori del suo carattere: “Io del resto mi trovo qui molto bene. Ho una buona camera con due gabinetti. In uno dormo io, e nell’altro un Francese molto civile e cortese […]. Egli suona bene del flauto. Mi sono fatto affittare un buon cembalo per opera del console che mi mandò anche della musica. Così facciamo de’ concerti, io compongo delle piccole arie per flauto, egli le eseguisce. Inoltre possiamo aver comunicazione colle nostre signore – Esse vengono la sera in camera mia, e come ce ne sono tre giovani che cantano, io le accompagno, gli altri quarantenari vengono ad ascoltarci, e così passiamo una delle più dolci quarantene che si sieno mai fatte”.
 Le “nostre signore” di cui parla sono le componenti di una bizzarra famiglia di otto donne, che così ha prima descritto: “Una bisava decrepita – due sue figlie vecchie, di cui una ha tre figlie, una delle quali maritata ha una serva indocile, e una bambina che completa la quarta generazione, e ch’è la sola persona tranquilla di tutta la famiglia. S’immagini tutta questa gente col loro cane rinchiusi con me ed un altro passeggiero (negoziante Francese assai buona persona) in una piccola camera, gridando, piangendo, disputando fra loro, con noi, col capitano; la bambina che stride, la decrepita che tosse, il cane che abbaia, non è un vivere, ma è continuo morire. La notte, per caldo che faccia, vogliono restar stivati nella camera colle finestre chiuse, e cento altre indiscrezioni colle quali corrispondono alle cortesie ed attenzioni, che abbiamo usato verso loro”. Il quadretto è fantastico, per l’essenziale efficacia della scrittura ma soprattutto perché dimostra che Vidua è un viaggiatore vero. Riesce prima ad adattarsi ad una simile infernale situazione, e a reinterpretarla poi simpaticamente come una “dolce quarantena”.
Le “nostre signore” di cui parla sono le componenti di una bizzarra famiglia di otto donne, che così ha prima descritto: “Una bisava decrepita – due sue figlie vecchie, di cui una ha tre figlie, una delle quali maritata ha una serva indocile, e una bambina che completa la quarta generazione, e ch’è la sola persona tranquilla di tutta la famiglia. S’immagini tutta questa gente col loro cane rinchiusi con me ed un altro passeggiero (negoziante Francese assai buona persona) in una piccola camera, gridando, piangendo, disputando fra loro, con noi, col capitano; la bambina che stride, la decrepita che tosse, il cane che abbaia, non è un vivere, ma è continuo morire. La notte, per caldo che faccia, vogliono restar stivati nella camera colle finestre chiuse, e cento altre indiscrezioni colle quali corrispondono alle cortesie ed attenzioni, che abbiamo usato verso loro”. Il quadretto è fantastico, per l’essenziale efficacia della scrittura ma soprattutto perché dimostra che Vidua è un viaggiatore vero. Riesce prima ad adattarsi ad una simile infernale situazione, e a reinterpretarla poi simpaticamente come una “dolce quarantena”.
Si capisce comunque molto bene da un’altra lettera dello stesso periodo perché questo indugio non gli pesi affatto. “Il mio viaggio è terminato. Non ho scordato che tu (n.b. il Marchese del Carretto) ne facilitasti il principio, Tutto sta nell’uscir una volta di prigione. Ora vado a costituirmi di nuovo. Veramente il solo stimolo che mi v’induca, e credo il solo piacere che avrò nel rivedere il paese natio sarà quello di rivedere mio padre, mia sorella, e qualche raro amico. come te, e come pochi altri. E che vi farò? Durante il mio viaggio ho trovato de’ peregrini pari miei, che anelavano al momento di finire le loro peregrinazioni. Altri che mi dicevano: oh, quando sarete ritornato in Piemonte sarete un oggetto di curiosità, Vi opprimeranno d’interrogazioni […] io rideva, e pensavo tra me stesso: eh quanto poco conoscete il Piemonte! È vero che altrove i viaggi danno buona riputazione, da noi piuttosto la tolgono. Buono per me, che non li ho intrapresi per vanità ma per mia istruzione, e particolarmente per mio diletto. Posso dire di aver vissuto in questi tre anni e mezzo, e se avrò lunga vita le memorie che ne serbo faranno il divertimento della mia vecchiaia”.
Finalmente agli inizi della primavera del 1822 rientra nel regno di Sardegna. Non è un ritorno trionfale, come Carlo aveva ben presagito. I moti ‘patriottici’ sono stati soffocati da un pezzo, alcuni amici sono in carcere, altri in esilio, e il clima, in generale e in casa Vidua in particolare, è decisamente pesante: lo constata appena mette piede in Piemonte, allorché gli viene imposto di tagliare immediatamente i baffi che aveva lasciato crescere alla turca e che portava da due anni (c’è un’ordinanza reale apposita). Non ha così modo di mostrarsi ai familiari nel suo nuovo look orientaleggiante, spettacolo per il quale si era munito di caffetani e turbanti. Ma, ciò che più importa, non è ancora rientrato che già il padre e tutto il parentado tornano all’attacco con le insistenze sul matrimonio.
Carlo riesce a prendere respiro per altri tre anni opponendo una resistenza passiva. Trova mille motivi per procrastinare: deve stendere le relazioni dei suoi viaggi (ma ha molti dubbi sull’interesse che possono destare nei piemontesi), redigere un libro sulle iscrizioni antiche che ha raccolto in Egitto e in Grecia (le Inscriptiones antiquae a comite Carolo Vidua in Turcico itinere collecte, unica opera sua edita in vita, Parigi 1826), ma soprattutto deve curare la fase decisiva dell’affare Drovetti, che si conclude solo nel 1823 con l’acquisizione della collezione da parte del governo sabaudo, e comporta ora la sistemazione museale dei materiali.

In America!
All’inizio del 1825 lo troviamo nuovamente in Francia: l’aria di casa si è fatta irrespirabile. A Parigi questa volta conosce Alexander von Humboldt. La mia prima curiosità nei confronti di Vidua è nata proprio da questo incontro, dalla menzione che Humboldt ne fa sia nelle sue lettere, lodando il libro sulle iscrizioni, sia nel Kosmos, dove parla di “un viaggiatore dalle molte peregrinazioni e libero ricercatore, il mio amico piemontese conte Vidua”. Il grande viaggiatore-scienziato tedesco è in quegli anni una vera star, ammirata in tutta Europa, ed è estremamente disponibile nei confronti dei giovani animati da curiosità scientifica e spirito d’avventura. Vidua possiede entrambe queste caratteristiche, e in più è fortissimamente determinato a metterle a frutto. E Humboldt gliele riconosce subito. Un loro contemporaneo (il conte Federico Sclopis) qualche anno dopo la morte del viaggiatore racconta: “Ho incontrato in questa biblioteca il signor Humboldt, col quale abbiamo parlato dei viaggi di Vidua, che egli ha personalmente conosciuto e che sembra tenere in grande considerazione. Egli ritiene che l’idea dominante in Vidua fosse quella della politica, e che guardasse soprattutto a quella in tutti i suoi viaggi […]. Il signor Humboldt non conosceva che le iscrizioni raccolte da Vidua nel suo viaggio mediorientale, le ritiene importanti e si è fatto l’idea che questo viaggiatore dovesse avere una grande conoscenza delle lingue antiche”.
È vero che Humboldt ha conosciuto praticamente mezzo mondo, e che tendenzialmente andava d’accordo con tutti, ma l’apprezzamento espresso nei confronti del casalese, anche molti anni dopo la scomparsa di quest’ultimo, è decisamente lusinghiero. Dimostra che i due si sono trovati e subito intesi. Vidua d’altra parte non è lì per caso: sta per mettere finalmente in atto il suo progetto americano. Ne espone al barone le motivazioni e le linee principali e riceve un profluvio di consigli sulle mete, sui tempi di percorrenza, sull’equipaggiamento; ma soprattutto ottiene una serie di lusinghiere commendatizie, che gli permetteranno di incontrare le figure più importanti della politica americana del tempo. Non poteva godere di un viatico migliore.
 Molto diversa, com’era da attendersi, è la reazione paterna. Carlo ha meticolosamente programmato e preparato il viaggio in America, ma non ne ha mai discusso in famiglia. Tutto rischia quindi di saltare quando a Marsiglia, poche settimane prima della data fissata per la partenza, arriva un ordine restrittivo dello stato sabaudo nei suoi confronti, fatto emanare probabilmente proprio dal padre. Il giovane non si rassegna, e in una lettera al genitore fa chiaramente intendere che da un rimpatrio inglorioso non uscirebbe offuscata solo la sua immagine. A quanto pare tocca il tasto giusto, perché l’ordine è rapidamente revocato. Carlo si imbarca dunque per l’America alla fine di febbraio del 1824, salpando dal porto di Le Havre.
Molto diversa, com’era da attendersi, è la reazione paterna. Carlo ha meticolosamente programmato e preparato il viaggio in America, ma non ne ha mai discusso in famiglia. Tutto rischia quindi di saltare quando a Marsiglia, poche settimane prima della data fissata per la partenza, arriva un ordine restrittivo dello stato sabaudo nei suoi confronti, fatto emanare probabilmente proprio dal padre. Il giovane non si rassegna, e in una lettera al genitore fa chiaramente intendere che da un rimpatrio inglorioso non uscirebbe offuscata solo la sua immagine. A quanto pare tocca il tasto giusto, perché l’ordine è rapidamente revocato. Carlo si imbarca dunque per l’America alla fine di febbraio del 1824, salpando dal porto di Le Havre.
In questo periodo l’America non è ancora meta di migranti economici in fuga dal nostro paese, come lo sarà alla fine dell’Ottocento: è frequentata invece dal fior fiore della intellighenzia italiana. I giovani si recano oltreoceano per viaggi più o meno lunghi, come nei casi di Paolo Andreani e di Francesco Arese, o per trapiantarsi definitivamente, spesso in ruoli di prestigio, come il librettista Lorenzo da Ponte, gli storici e politici Filippo Mazzei e Carlo Bellini, il militare e trapper Francesco Vigo, o addirittura per portarne a compimento l’esplorazione, come Costantino Beltrami. In molti casi si tratta di fuorusciti politici, reduci dalla militanza napoleonica o dalle rivoluzioni costituzionaliste degli anni venti (Pietro Maroncelli è uno di questi). Sono attratti da un’istituzione repubblicana che sembra funzionare e si propone come alternativa ai dispotismi restaurati in Europa: ma anche dalla vastità di un mondo aperto sull’Ovest, nel quale è pensabile ogni esperimento sociale, ogni realizzazione economica, ogni fuga dall’avanzata del moderno o, in alternativa, da ogni ritorno dell’antico. Carlo Vidua in qualche modo riassume in sé tutte queste motivazioni.
La traversata oceanica è tutt’altro che tranquilla: la nave passa da un fortunale all’altro, impiegando quarantatre giorni per raggiungere il nuovo continente. Ma anche in questa occasione il conte non si smentisce: mentre fuori infuriano i marosi si distrae suonando la spinetta. Sembra un atteggiamento alla Chateaubriand (che durante la traversata si tuffava in mare dalla nave per fare un po’ di moto – salvo poi dover essere fortunosamente recuperato), un’esibizione per impressionare gli altri passeggeri e farsi precedere da un alone di imperturbabile eccentricità: ma direi che è in linea con la sua personalità, e se anche l’aneddoto, che dobbiamo al protagonista stesso, fosse inventato, sarebbe comunque verosimile.
Vidua approda a New York nei primi giorni di aprile. Di lì prosegue per Filadelfia, e visita in successione Boston, Washington e Monticello. Grazie alle lettere di presentazione di Humboldt e a quelle che si è procurato nelle varie ambasciate ha modo di incontrare durante questo tour tre ex-presidenti e il presidente in carica, prima separatamente e poi eccezionalmente tutti assieme. Certamente l’essere figlio di un ministro di uno stato europeo e l’essere munito di commendatizie autorevoli gli apre le porte: ma è poi lui, col suo genuino interesse e la sua intelligenza a guadagnarsi una sincera e spontanea ospitalità, perché gli americani ci tengono a che il loro sistema di governo sia correttamente conosciuto nel vecchio continente. Tutti coloro che lo incontrano ne sono conquistati.
Eppure Vidua è molto diverso dal barone tedesco che lo aveva preceduto vent’anni prima, e che a sua volta aveva suscitato entusiasmo negli stessi interlocutori. Non li lascia storditi e quasi in soggezione: è al contrario uno che fa domande, è curioso di quel mondo e apprezza l’immediatezza e la semplicità che caratterizza anche i rapporti con persone di altissimo rango. Per questo piace molto ad esempio al presidente Quincy Adams, che così annota nel suo diario: “Il conte è davvero curioso […] è un ottimo concertista al pianoforte, ci ha suonato due o tre arie […]” e ancora “[…] è una persona di grande intelligenza e conoscenza”. A sua volta a Vidua piace Adams, perché è un moderato e perché dotato di un forte senso etico: non a caso il presidente una volta tornato all’avvocatura assumerà, diversi anni più tardi, la difesa degli schiavi ammutinati dell’Amistad, e ne otterrà l’assoluzione. Tra i due si instaura una calda simpatia, tanto che Vidua viene trattenuto a colloquio e a pranzo dal presidente più volte in pochi giorni. “La prima visita fu un dialogo lungo e animato di un’ora. Lunghi discorsi tenemmo pure il giorno che mi invitò a pranzo, ed un’altra sera che passai seco, e se mi fossi fermato lungamente a Washington avrei potuto vederlo bene spesso, giacché mi fece padrone di andare a passare ogni sera con lui.”

La cosa si ripete a casa di Thomas Jefferson, dove si trovano in visita altri due ex-presidenti, Madison e Monroe, oltre allo stesso Quincy Adams. “I momenti che si passano con uomini di questa sorta sono preziosi, ma ordinariamente perduti, perché la presenza di altre persone e la circospezione impediscono di interrogare e di rispondere. Qui invece eravamo in villa, eravamo soli, io straniero, essi ritirati dagli affari, sicchè la conversazione non potè essere né più libera né più interessante. E siccome essi non si mostravano schivi di rispondere, io non mostrai paura di interrogare.” Credo di non sbagliare pensando che i quattro si fossero riuniti lì appositamente per conoscere lui, incuriositi dagli elogi che Adams junior ne aveva tessuto. E credo anche che posti di fronte a domande come: “Quanto tempo è credibile che la loro propria (repubblica) duri senza separarsi?” abbiano capito di avere davanti uno che vedeva lontano.
Un altro ex-presidente, John Adams (il padre di Quincy), incontrato qualche tempo dopo, ne riceve evidentemente un’immagine altrettanto positiva: “[Adams] le aveva parlato molto di me, dicendole che certo io avevo studiato bene la loro storia, e che di tanti viaggiatori che gli erano stati presentati nessuno gli aveva mai fatto interrogazioni di quella natura, che gli avevo fatto io”. E anche il sindaco di Boston scrive: “Analitico, curioso, intelligente, […] Vidua è intento in modo non comune nella ricerca della storia e dello stato attuale di questo paese”.
Questa la favorevolissima impressione che Vidua desta (e che ricambia, parlando dei singoli personaggi). Ma che impressione matura riguardo le istituzioni e le prospettive della giovane repubblica? Quando da Boston e da Washington si sposta a New York incontra un altro tipo di americani. “New York – scrive – non mi piace quanto Boston. È vero che or molta gente è in villa, e poi queste gran città commerciali non sono mai fatte per divertire uno straniero. La gente vi è troppo occupata a far denari.” E anche a fare politica, ma in maniera diversa da quella dell’aristocrazia schiavista della Virginia. Gli uomini nuovi sono i grandi imprenditori, i mercanti alla John Jacob Astor, i lobbisti e i finanzieri come Aaron Burr e Martin Van Buren, che condizionano la macchina elettorale e di lì in poi determineranno la politica americana.
La nube sul futuro degli Stati Uniti è rappresentata per Vidua da personaggi come Andrew Jackson, già candidato alla presidenza e all’epoca probabile futuro presidente, mercante di schiavi e odiatore degli indiani, fondatore del partito democratico e sostenitore del protezionismo: il tipico self made men semi-analfabeta che ha fatto carriera per la sua spregiudicatezza e irruenza, quanto di più lontano dall’aristocrazia intellettuale che ha così benevolmente accolto il giovane conte europeo.
Più in generale, Vidua sembra essersi fatto questa idea. La rivoluzione americana è stata gestita da una minoranza di privilegiati che aveva come scopo principale quello di sostituire la propria egemonia a quella inglese. Lo stesso vecchio Adams gli ha confermato che la maggioranza degli americani era contraria all’indipendenza o era indifferente. Ma tutto sommato gli artefici della rivoluzione, pur partendo da concezioni di fondo molto diseguali, e pur adottando nella competizione politica e nell’ accaparramento del consenso mezzi molto spregiudicati, hanno creato un sistema equilibrato, anche se fragile per l’esistenza nelle diverse ex-colonie di esigenze economiche spesso contrastanti. È un sistema che garantisce in primo luogo le libertà, quindi costituisce un esempio cui guardare. Vidua è colpito ad esempio dalla tranquillità nella quale si svolgono le operazioni di voto: “Ho assistito ad una elezione nello stato del Maine; ciascuno andava a portare il suo biglietto, la gente di diverso partito s’incontravano senza dir nulla, ciascuno dava il voto al suo candidato, i signori di città ne tenevano registro, un silenzio, una quiete, non si sarebbe sentito volare una mosca; quando scadde il tempo fissato per dare i voti, fu fatto lo scrutinio ossia il sommario dei voti in presenza di tutti, e fu dichiarata l’elezione senza gridi, senza tumulto”. (mi chiedo cosa penserebbe oggi!). O ancora, dall’ordine e dalla sicurezza che regnano nelle ex-colonie: “Sui costumi e sulla religione di questo popolo vi sarebbe molto che dire; ma esso merita questo grande encomio, che sebbene si governi da sé, e la forza pubblica vi sia debolissima, pure le persone e le proprietà vi sono talmente sicure che si viaggia ad ogni ora, e le case sono aperte fin di notte, senza serrature, senza chiavi e senza feriate” (anche su questo, avrebbe forse dei ripensamenti).
Ritiene però che quello americano sia un modello difficilmente ripetibile al di qua dell’oceano. In effetti, le condizioni sia fisiche (gli spazi) che sociali (l’eguaglianza dei diritti) degli Stati Uniti sono ben diverse da quelle europee. Inoltre, tutto il conclamato egualitarismo, che teoricamente è la base del modello democratico, è clamorosamente smentito dal fatto che una parte considerevole della popolazione, tra nativi che vengono espropriati delle loro terre e schiavi che sono stati importati (e continuano ad esserlo), non partecipa di nessuna liberà, né civile né politica (nel 1830, a fronte di una popolazione di oltre quindici milioni, i votanti sono un milione e mezzo) Col passare del tempo, secondo Vidua, questi problemi diverranno sempre più gravi, e peseranno moltissimo sulla tenuta dell’unione. “Una tranquillità perfetta che continuerà tanto che non ci sia sovrabbondanza di popolazione, una sicurezza personale illimitata, e indipendente dal capriccio dei governanti, una libertà intera di vivere e di scrivere, limitata però dall’uso dei duelli, da processi per calunnia e in certi punti dalla pubblica opinione, nessun timore di potere arbitrario, questi sono beni reali e preziosi, e certo questi beni si godono in America dai cinque sesti degli abitanti. Ma lo spettacolo dell’altro sesto, cioè di due milioni di creature umane staffilate, vendute, affittate come bestie sol perché non hanno la pelle bianca, mi amareggiava continuamente il soggiorno sì vantato della terra di libertà.”
Ciò che intravvede, e che non ha potuto poi dettagliare e commentare con calma e in maniera più approfondita, è né più né meno ciò che vedrà Alexis de Tocqueville esattamente cinque anni dopo.
Tocqueville arriva in America nel 1831, con Gustave De Beaumont, inseparabile sodale di una vita. La motivazione ufficiale del suo viaggio è lo studio del sistema giuridico e penale degli Stati uniti, ma il soggiorno di quasi un anno gli consente indagare in profondità le differenze tra la “rivoluzione” americana e quella francese. Studia gli effetti della democrazia, e constata che questa promuove l’uguaglianza a scapito della libertà e l’individualismo a scapito della coesione sociale. Il rischio (a suo parere molto concreto) sul lungo termine è quello della massificazione e del trionfo del conformismo: la democrazia finisce allora per scadere nel dispotismo della maggioranza. Questo il succo de La democrazia in America, il poderoso saggio scritto negli anni immediatamente successivi al ritorno, e destinato a dargli la fama.
Vidua non ha modo di ordinare le sue impressioni, non effettua questi collegamenti, ma coglie già perfettamente quelli che ne saranno i presupposti. Nel resoconto della sua esperienza americana inviato all’amico Roberto D’Azeglio, rispondendo alla domanda di quest’ultimo: “Osserva ben quegli uomini, e dimmi se veramente son più felici degli altri. Vi trovi libertà vera?” scrive: “Non andai in America fanatico, ma a dir vero inclinato in favore. Non ho incontrato nessun dispiacere … nessuno disse male di me, e alcuni dissero più bene che non merito. Lungi dall’aver motivo di disgusto, ho dunque doveri di gratitudine. Ma pur la verità, ch’è il primo dei doveri, mi costringe a confessare che quegli uomini e quel paese mi gustaron pochissimo. … quanta diremo sia la felicità di un popolo che tutto intero corre ansante, senza riposo e senza intermissione in cerca del solo guadagno; in cui le scienze e le arti sono coltivate solo nell’interesse commerciale; in cui l’attività individuale tende ad isolare e a infievolire i nodi più stretti di un popolo sommamente industrioso, è vero, ma privo di fantasia, incapace di passioni generose, tenere o magnanime, del popolo il più freddo e il più calcolatore, che la terra abbia visto giammai? Parlo dell’universale, Dio mi guardi dal calunniare i particolari; son pronto a rendere giustizia a questi, e forse ancora sarei inclinato a riconoscere in favore dell’universale, che que’ difetti medesimi li rendon più capaci di sostenere la libertà, la quale difficilmente si può acquistare, o presto sfugge dalle mani delle nazioni dotate di tempra fervida e di calde passioni. Però, se la libertà si paga a tal prezzo […]”.

Verso ovest e verso sud
Vidua ha naturalmente letto i libri di Chateaubriand e quelli di James Feminore Cooper, anche se questi ultimi non lo entusiasmano. Cooper l’ha poi anche conosciuto personalmente durante il viaggio. Vuole ora visitare le foreste canadesi teatro delle gesta dell’ultimo dei Mohicani, ma soprattutto completare la sua ricognizione dei sistemi politici nordamericani andando a verificare i modi della colonizzazione inglese: e vuole anche esplorare la frontiera occidentale statunitense, aperta una ventina d’anni prima con l’acquisto della ex Louisiana francese. Negli ultimi mesi del 1825 compie quindi un itinerario che dal Canada lo porta lungo la linea della frontiera sino a st. Louis, nel Missouri. Ha modo di ammirare le cascate del Niagara, delle quali scrive con entusiasmo: “Non mi sazio di vederle: son qui da due giorni e non fo altro che vagheggiarle: la pioggia, la nebbia e soprattutto la luna diversificano in mille modi la scena, e senza essere tacciati di romanticismo si può dire che questo è uno dei luoghi più romanzeschi del globo”. Altrettanto entusiasmo mostra però, oltre che per gli spettacoli della natura, per quello dell’intraprendenza umana, che in pochissimi anni ha creato città come Rochester e Pittsburg, ricche di manifatture d’ogni genere e pulsanti di vita: “È incredibile l’industria e l’attività di questa nazione, qualità in cui essa sorpassa e la Francia e l’Inghilterra che pur sono reputate le nazioni più industriose d’Europa”.
È un percorso più lungo di quello compiuto dallo scrittore bretone trent’anni prima, e anche di quello che di lì a pochi anni intraprenderà de Tocqueville. Tocca l’Ohio, il Kentuky, l’Indiana, l’Illinois e il Missouri: e Vidua si rende conto che il futuro dell’America è proprio nella frontiera.
“Tutta questa parte degli Stati Uniti chiamata Western Country, che si estende lungo i grandi fiumi dell’Ohio e del Mississippi, è comparativamente agli altri stati sulle sponde dell’Atlantico, un paese nuovo. […] Questo è il più brillante teatro dell’industria di questo attivissimo popolo. L’americano non ha l’attaccamento al campanile, il rincrescimento di staccarsi dagli amici, dai parenti, da una patria. […] All’età di vent’anni ei si prende una moglie e va a cercare fortuna nell’Ovest. La terra è a buon mercato […] i raccolti di due o tre anni bastano a vivere, a pagare la terra e a fabbricare una cascina. A poco a poco la famiglia cresce, ma crescono le braccia: ed i suoi figli a vent’anni imitano il padre, abbandonando la casa paterna e andando a cercar fortuna sempre più all’ovest.”
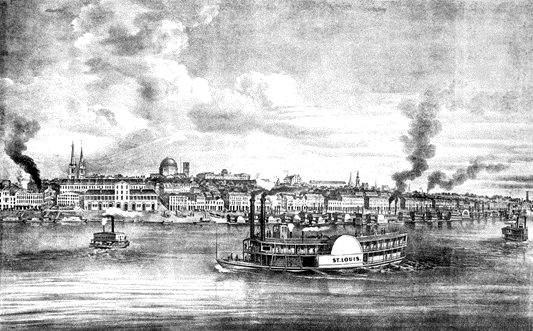
Da St. Louis si imbarca su un battello che discende il Mississippi, e nel febbraio 1826 lascia gli Stati Uniti, partendo da New Orleans e recandosi in nave in Messico. È intenzionato a raccogliere materiali per una storia della rivoluzione messicana e più in generale di tutte le recenti rivoluzioni che si sono prodotte o sono ancora in corso nell’America Latina, nelle ex-colonie spagnole: e anche in questo caso non si accontenta di intervistare le massime autorità nei palazzi del potere, ma intende visitare in lungo e in largo i diversi paesi. Vuole ricalcare quasi passo passo le orme di Humboldt, ed aggiornare le considerazioni riportate da quest’ultimo quando l’ondata rivoluzionaria era ancora all’inizio.
In Messico però la delusione è cocente: riguarda il paesaggio (una campagna squallida e deserta), la viabilità (è questo uno dei paesi in cui viaggiare è più costoso, più difficile, più faticoso), gli abitanti, che hanno una fisionomia selvaggia, l’economia, poverissima e se possibile in dissesto, e poi, soprattutto, le istituzioni. La chiesa tollera manifestazioni religiose carnevalesche: “Il giovedì santo, trovandomi in un borgo presso s. Luis Potosi andai In parrocchia dopo pranzo credendo assistere all’ufficio: ma trovai che invece dell’Ufficio sì commovente […] si facevano in cambio tre processioni con grandi mascheroni, con fiaccole, con tiri e spari e musiche di violini come se fosser balli”. La classe politica uscita dalla rivoluzione non promette granché bene: “Qui in tutte le parti sono occupati a costituirsi; con quanta perizia, e quanta scienza politica e governativa nol so”. Vidua presenzia ad alcune sedute degli organismi di governo provinciali, e constata come nei confronti degli spagnoli l’odio sia radicato (e meritato, a giudicare da quel che sente). Ritiene quindi impossibile che la Spagna possa riprendersi le sue colonie. Ma ha anche forti dubbi sulla tenuta del nuovo assetto politico. “Io sono per l’emancipazione, però dopo che ho visto Messico, desidero per loro bene che i Repubblicani arrabbiati non abbian tanta influenza, e che non sia dato loro il potere di piantare il pugnale nelle viscere della loro patria, come sgraziatamente fanno.”
Mentre è in Messico gli capita anche un fatto tra il comico e l’increscioso. “Passando ad altro soggetto, vorrei raccontarti la storia della mia morte, ma non la so bene. Mentre io stava visitando il Messico fu pubblicato negli Stati Uniti il racconto della maniera con cui io era stato ammazzato ne’ deserti dagli Indiani; colà son tanti i giornali! dall’uno all’altro lo ripeterono, e un letterato di Filadelfia, città ove mi aveano conosciuto molto, fece la mia Necrologia, e la fece stampare nel più famoso di que’ fogli periodici […]. Il console generale negli Stati Uniti scrisse al Ministro al Messico per saper s’era vero, ed io poi seppi da lui la mia morte e la mia risurrezione tutto in una volta quando fui di ritorno a Messico. – Desiderava leggere la mia necrologia per la rarità del caso, che al solito non la legge il morto, però finora non l’ho potuta avere. Il suddetto Ministro degli Stati-Uniti al Messico, ch’è mio amico, mi disse ’che m’avean detto molto bene. – Sia un compenso per quelli che dicon male.” Il problema è che la notizia giunge sino in Europa, e solo il sopraggiungere di una tempestiva smentita evita ai famigliari di Carlo un coccolone.

Anche Città del Messico, dove arriva il 21 giugno dopo aver girovagato per quattro mesi nella zona centrale del paese, non corrisponde affatto alle sue aspettative. La paragona a Torino, per le montagne che le fanno cornice, ma trova che tanto il panorama che la configurazione urbana siano decisamente inferiori. Naturalmente non manca di raccogliere tutto ciò che può, e di spedire dalla capitale il solito stock di casse pieno di libri, tele, statuine, medaglie, ecc…
Nel paese dilaga però la febbre gialla, e decide allora di lasciare il Messico e dirigersi verso il Perù. Non senza concedersi, lungo il cammino che lo porta verso la costa pacifica, un mese di sosta a Guadalajara, che giudica la più bella città del Messico e dove trova ospitalità presso un gentiluomo inglese. In realtà è anche incerto se proseguire nel suo progetto dell’America Latina o volgersi direttamente all’Asia (ha in mente la Persia).
A sciogliere ogni dubbio arriva una missiva della sorella che lo informa del grave stato in cui versa la salute del padre. Sconvolto dal rimorso, Carlo intraprende una galoppata che in un mese lo riporta a Città del Messico, e di lì a vera Cruz, dove trova un passaggio per l’Europa. Si imbarca il 22 febbraio e giunge a Bordeaux nell’aprile del 1827, dopo una traversata ancora una volta tempestosa. Ma sta scritto da qualche parte che il ritorno non sia definitivo. Un duro contrasto epistolare con il padre, nel frattempo ristabilitosi, induce il nostro a non rientrare in patria. I motivi della rottura si possono facilmente immaginare: gli viene dettato l’ennesimo ultimatum, pena l’essere definitivamente diseredato. Carlo non è disposto ad accettarlo e si ritiene quindi sciolto moralmente da ogni vincolo. “Sarebbe stato naturale qualche rincrescimento della strada fatta indietro, e quale strada! Tuttavia pensai che non era possibile pentirsi di aver fatto ciò che si deve, e io sono contento di aver avuto occasione di mostrare in un modo così poco volgare il mio rispetto e affetto per mio padre. Avevo compiuto un dovere. Tal dovere non esistendo più, era naturale di finire ciò che avevo incominciato. Invece di fare il giro della palla da levante a ponente, questo accidente me lo fa fare da ponente a levante.”
Del resto, era già chiaro molto prima, quando a proposito di matrimonio e di carriera scriveva ad un amico: “Se mai mi decidessi, sarebbe unicamente per far piacere a mio padre. Capisco che ei ne dee avere gran desiderio, e s’io fossi a suo luogo l’avrei. Ma la perdita della libertà, l’interruzione de’ miei studi, e soprattutto l’obbligo di dovere vivere in un paese sì diviso, e in mezzo a tante piccolezze, e ad opinioni che per la loro esagerazione da una parte e dall’altra, non si combaciano con le mie idee moderate […]”.

Nell’Estremo Oriente
Vidua deve aggiornare i suoi programmi, e non impiega molto. Solo tre mesi dopo il rientro, nel luglio del 1827, riparte da Bordeaux per quello che nelle intenzioni dovrebbe essere il suo ultimo viaggio (così almeno scrive alla sorella): la destinazione prossima è l’Estremo Oriente, in particolare la penisola indiana e il sud-est asiatico, ma il progetto è molto più ambizioso: prevede l’Australia e la traversata del Pacifico sino al Cile e al Perù, e quindi di valicare le Ande per toccare Buenos Aires e Rio de Janeiro.
Arriva dunque a Calcutta a metà novembre del 1827 (dopo cinque mesi di navigazione!). Nel gennaio dell’anno successivo risale il Gange fino a Benares, per essere poi a Delhi in febbraio. Il tam tam che lo precede funziona, comincia ad essere conosciuto anche negli angoli più remoti del mondo come “il Viaggiatore”. Le credenziali a questo punto se le firma da solo. Incontra così i massimi esponenti della Compagnia delle Indie ed è presentato personalmente al Gran Mogol. Ha il tempo anche di frequentare i “salotti” coloniali, e di biasimare la spocchia che li caratterizza. Gli inglesi guardano con sprezzo alla sua curiosità per culture che ritengono inferiori: e al contrario degli americani ritengono inferiore anche la cultura sua. Significativo è quanto racconta a proposito di un’accesa discussione a casa di un alto funzionario della Compagnia: “Alla fine milady alzandosi mi disse che ero bigot. Le risposi: è bigot chi attacca, non chi si difende, chi vuol perseguitare, non chi apologizza, io amo i protestanti, non ho declamato contro di essi. È bigot chi fa accuse senza fondamento, chi vuole escludere i suoi compatrioti dall’esercizio di egual diritti, ecc […]”. Questo ci rimanda un illuminante quadretto degli ambienti frequentati da Vidua, ma ci dice anche che lo stesso non ci sta a recitare la parte dell’ospite che si fa andare bene tutto.
È indignato soprattutto dalla netta linea di separazione che gli inglesi hanno tirato tra sé e gli indiani, e dallo sfruttamento di questi ultimi: a Calcutta “io tentai qualche passeggiata a piedi: gli indiani mi fissavano come si guarda un pazzo, sì poco sono avvezzi a veder un bianco muovere le gambe. I cavalli stessi paion riservati solo ad usi nobili, condurre carrozze o portar eleganti cavalieri. Raro si vedon cavalli condurre carrette; bestie da soma son gli indiani, cavalli di stanza son gli indiani, l’ufficio degli asini, dei buoi è fatto dagli indiani: tutte le mercanzie son care fuorché la carne umana”.
D’altro canto, “il pregiudizio della casta è insuperabile, e necessita questo numero considerevole di domestici giacché non ridurreste mai quel che vi veste a servirvi a tavola e quel che vi serve a pranzo a salir dietro il cocchio, uno non può toccar le scarpe perché è pelle di animale; l’altro non può portarvi il brodo perché è bevanda immonda, tutto li contamina, tutto li sporca, gettano il resto delle nostre vivande appena abbiamo finito di pranzare! Indi nasce quel notabile e quasi incredibile contrasto, che cento milioni di uomini rispettano ed ubbidiscono a pochi europei, ciascun dei quali è riguardato da loro come creatura sì nauseosa, sozza, immonda, che nemmeno il più povero non consentirebbe a dividere seco lui un pezzo di pane”.

In India non si ferma a lungo. Abbastanza però per raccogliere un sacco di materiale, da spedire a casa in un “ricco baule”, pieno di “manoscritti Indiani in differenti lingue, ornamenti donneschi, rappresentazioni de’ costumes ossia abiti delle differenti condizioni di persone, ed altri vari oggetti”. Nell’aprile del 1828 è comunque sui primi contrafforti dell’Himalaya, senza peraltro sembrarne particolarmente impressionato: si limita a prendere atto che le vette sono indubbiamente molto più alte di quelle alpine, e che per salirle occorrerebbe una sosta prolungata, ma le trova molto meno spettacolari.
Poi, tornato alle pianure, si sposta nell’estate a Singapore e trascorre un intero anno tra il porto aperto di Canton e i possedimenti portoghesi (Macao) e spagnoli (Manila).
Canton è diventata verso la fine del secolo precedente la sede ufficiale dei traffici inglesi con la Cina, soppiantando il ruolo che era stato in precedenza dei portoghesi di Macao (a metà dell’Ottocento sarà a sua volta soppiantata da Hong Kong). In una lettera al padre (col quale la comunicazione epistolare è ripresa) Vidua racconta come gli stranieri che risiedono a Canton siano soggetti a forti restrizioni nei movimenti e a continui controlli. In sostanza non possono uscire dalle aree destinate allo scambio commerciale. Qualora ciò accada, c’è il rischio di essere aggrediti e bastonati da una moltitudine di cinesi furiosi. Gli stessi impiegati della compagnia delle Indie non possono risiedere sul territorio cinese per più di sei mesi l’anno, e trascorrono gli altri sei a Macao. Non possono nemmeno portare con sé le mogli o la famiglia.
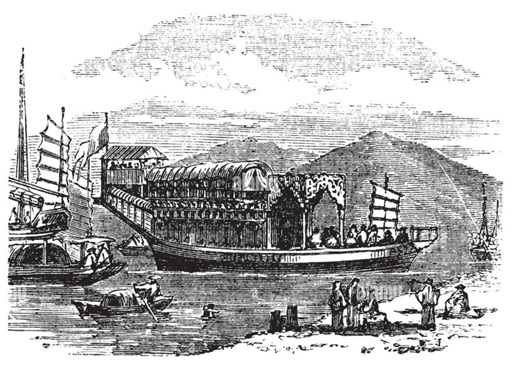
La curiosità di Vidua però la vince. Con vari espedienti, come l’accompagnare un medico della compagnia nelle sue visite ai maggiorenti della città, o dietro invito diretto di ricchi mercanti cinesi, riesce ad intrufolarsi in alcuni templi e monasteri, o in grandi ville con magnifici giardini, e persino ad assistere a rappresentazioni teatrali. Si arrischia anche, assieme ad altri tre giovani europei, a sbarcare su una spiaggia deserta a qualche chilometro dalla città, e a fare poi un giro nell’interno della campagna, mantenendosi sempre fuori vista e annotando tutto il possibile sui sistemi di coltivazione, sulle abitazioni rurali, sulle piantagioni del the, ecc. Scrive a suo padre, forse anche per dimostrargli che non va a spasso senza scopo: “La campagna nei dintorni di Cantòn è molto coltivata e le fattorie frequenti, i canali di irrigazione e i diversi livelli del suolo destinato alla coltivazione del riso molto bene curati, indicano grandi progressi anche in Cina in questo settore così importante dell’agricoltura”. È l’occhio del proprietario di risaie in Italia.
Alla fine del febbraio 1829, data del trasferimento semestrale degli europei, il governatore della Compagnia delle Indie gli offre un passaggio per Macao. A dispetto della sosta forzatamente breve Vidua è riuscito a raccogliere una gran quantità di oggetti che forniscono una importante documentazione sulla Cina dell’epoca: statuine di divinità o di personaggi del taoismo, paesaggi in miniatura, mappe locali o del Giappone, carte da gioco, armi, nonché una intera Bibliothèque Chinoise, che spedisce immediatamente al padre.
Il 3 maggio abbandona definitivamente l’Estremo Oriente continentale diretto a Singapore. Durante la primavera ha intanto iniziato la stesura di un trattato politico, in cui intende riunire proprie le osservazioni sugli ordinamenti dei luoghi visitati. Pervenuto a Cesare Balbo e confluito infine nella Biblioteca nazionale di Torino, il manoscritto dell’opera incompiuta è andato distrutto nell’incendio che devastò la biblioteca nel 1904.

Morire nelle isole della Sonda
A metà del 1829 si trasferisce a Giava, dove rimane sei mesi ed entra in contatto con un sistema di colonizzazione diverso. La compagnia olandese delle Indie pratica una politica più morbida, ma non meno repressiva, rispetto a quella inglese: a Vidua sembra decisamente più intelligente. Ma a Giava, forse per la suggestione del paesaggio, porta avanti un altro progetto, direttamente ispirato dalla Naturgemalde (più o meno, la descrizione della natura) di Humboldt: quello di percorrere e in lungo tutta l’isola e di mapparne l’orografia, determinando con il barometro l’altezza delle principali montagne. In effetti ne scala due che superano i quattromila metri, col risultato di dover poi rimanere a letto e a digiuno per diversi giorni. Giava non è innervata da una vera e propria catena montuosa, ma sulla linea da est ad ovest sorgono ben centoventi vulcani, un quarto dei quali ancora attivi. Vidua si propone di censirli e di redigere poi una serie di tavole che presentino la distribuzione geografica delle piante, che nell’isola varia dalla foresta equatoriale lungo le coste ai boschi di tipo alpino oltre i duemila metri.
Nel marzo del 1830 si sposta alla vicina isola di Madura, e successivamente ad Ambon, nelle Molucche, dove è ospite del governatore olandese. Viaggia sull’Iris, una goletta comandata da Jan Hendrik De Boudyck-Bastiaanse, che gli dedicherà i suoi Voyages faits dans les Moluques, à la Nouvelle-Guinée et à Célèbes, avec le comte Charles de Vidua, de Conzano, à bord de la goëlette royale l’Iris (Parigi 1845). Nel corso della navigazione vengono scoperte alcune nuove isole, e ad una di esse viene dato il nome di Isola di Vidua: ciò che la dice lunga sulla stima e sull’amicizia che “il Viaggiatore”, come ormai è chiamato ovunque, riesce rapidamente a conquistarsi. Il comandante scriverà di lui che era anche un abilissimo navigatore (complimento non comune per un piemontese), e che a bordo lavorava come qualunque altro membro dell’equipaggio.
 L’esplorazione delle isole della Sonda è però solo un’ulteriore tappa di avvicinamento al continente australe, rispetto al quale l’interesse torna ad essere prevalentemente politico. “Il mio scopo nel visitare la Nuova Olanda è di osservare nella sua infanzia una colonia tutta di razza europea, destinata a divenire in cento o centocinquant’anni uno stato importante. Ho visitato gli stati Uniti nell’età giovanile. Visitar la Nuova Olanda è come veder dei secondi Stati uniti ancor bambini […]”
L’esplorazione delle isole della Sonda è però solo un’ulteriore tappa di avvicinamento al continente australe, rispetto al quale l’interesse torna ad essere prevalentemente politico. “Il mio scopo nel visitare la Nuova Olanda è di osservare nella sua infanzia una colonia tutta di razza europea, destinata a divenire in cento o centocinquant’anni uno stato importante. Ho visitato gli stati Uniti nell’età giovanile. Visitar la Nuova Olanda è come veder dei secondi Stati uniti ancor bambini […]”
È anche ossessionato dalla perfetta salute fisica: non che sia un ipocondriaco, anzi, non manca mai, nelle lettere a parenti e amici, di sottolineare come con tutto il suo viaggiare non si sia mai beccato un malanno: e quando questo accade, nell’ultimo anno, lo rileva con rammarico e stupore, quasi un presagio.
A dispetto delle febbri intestinali, ad agosto Vidua è sull’isola di Celebes, viaggiando sempre con Bastiaanse: e qui avviene la tragedia. Durante un’escursione in una caldara scivola con una gamba nella lava bollente. Un po’ se la cerca; il governatore delle Molucche scrive ad un suo omologo: “La rapida fine del conte Vidua deve essere attribuita all’accidente che gli è capitato nelle contrade dell’interno di Menado, e del quale è stato lui stesso la causa, non avendo voluto ascoltare il capo indigeno che lo aveva avvertito del pericolo e voleva trattenerlo, cosa di cui egli si era mostrato irritato. Il defunto era posseduto da un ardore eccessivo: non concedeva al suo corpo alcun riposo”. L’incidente appare subito molto grave, ma non per questo il casalese vuole rinunciare alla sua esplorazione. Trova però un medico solo venti giorni dopo, a Ternate, la regina delle Isole delle Spezie: e qui deve necessariamente fermarsi. Sfrutta comunque l’immobilità forzata mettendo ordine nei suoi appunti e scrivendo. Spera ancora di poter riprendere il viaggio: ma la situazione si va velocemente aggravando. La cancrena alla gamba sale sino alla coscia: l’ultima flebile speranza è legata all’amputazione.
Il 21 dicembre s’imbarca pertanto per Ambon, dove spera di farsi operare: ma è troppo tardi. Muore durante il viaggio, il giorno di Natale del 1830. In una lettera inviata quindici giorni prima al governatore olandese suo amico ha scritto: “Ciò che rimpiango è di non avere davanti altri tre anni di vita, per poter raccogliere il frutto di tante fatiche, di tante ricerche, di tanto lavoro nelle quattro parti del mondo. Sia fatta la volontà di Dio”. Chiede anche che tutti i suoi scritti vengano distrutti. Il suo corpo è tumulato sulla spiaggia dell’isola, dove il governatore fa erigere un sepolcro. Anche il luogo dove è avvenuto l’incidente porta oggi il suo nome: è il Count Vidua Solfatara Field, sul vulcano Tondano.
Poi, nel 1833 almeno le sue spoglie tornano finalmente a casa. Il padre si attiva in tutti i modi e la salma, con un’ultima lunghissima navigazione che passa per Rotterdam e Genova e che sembra rinnovare postuma le peregrinazioni del Viaggiatore, è traslata a Conzano.
Pio Vidua gli sopravvive sei anni. Un anno dopo, nel 1837, muore anche la sorella. Il timore che aveva angustiato il padre per trent’anni si avvera: il ramo casalese dei Vidua si estingue. Ma si avvera anche, almeno in parte, e almeno fino ad oggi, quello che aveva angustiato il figlio: sul suo nome cade l’oblio.

Sulle consonanze
Non mi resta ora che spiegare brevemente i motivi della particolare simpatia che provo per Carlo Vidua. Sono tantissimi e diversi, e in qualche caso anche un po’ difficili da spiegare, perché il personaggio è un groviglio di contraddizioni. Provo a riassumerli.
Intanto c’è il suo straordinario curriculum di viaggiatore. L’ho scoperto colpevolmente tardi ma ha calamitato subito il mio interesse, perché nell’Ottocento nessun altro italiano ha viaggiato quanto lui. Quando poi ho saputo dei suoi rapporti con Humboldt l’interesse naturalmente si è moltiplicato. A rendermelo particolarmente caro è stato infine il suo tragico destino, che non solo lo ha strappato alla vita ma lo ha anche relegato in un angolo in ombra della storia. Diciamo che rientra a pieno titolo tra i “quasi adatti” dei quali mi sono prevalentemente occupato: di quei “perdenti” che non inseguendo il successo, ma la virtù e la conoscenza, a volte anche inconsapevolmente, hanno in realtà vissuto esistenze straordinarie.
Che tipo di viaggiatore fosse l’ho già detto. Non è annoverabile tra i grandi camminatori perché si è mosso quasi sempre a cavallo (o su cammello), in carrozza o in nave, in genere con uno o più servitori al seguito. Nemmeno è stato un viaggiatore “eroico”, di quelli che cercano il confronto coi propri limiti o si spostano sempre sul filo della sopravvivenza. Ha visitato un’enorme fetta di mondo ben coperto sia sul piano economico che su quello delle conoscenze e delle credenziali. Era perfettamente consapevole di godere di una condizione di privilegio, non se ne scusava affatto e riteneva semmai doveroso metterla a frutto: “Coloro appunto, cui la fortuna fu larga de’suoi doni, e che talvolta come usarne non sanno, quelli potrebbero agevolmente andar ricercando le contrade straniere, onde giovare alla patria, ed illustrare il loro nome”. Non dunque da turisti, ma da studiosi. Come tale Vidua pianificava meticolosamente i suoi percorsi, solo che questi poi si dilatavano e si ramificavano in ogni direzione, senz’altro perché poteva permetterselo, ma prima ancora perché trovava costantemente nuovi motivi di interesse, scopriva e inseguiva nuove curiosità. Il fine “scientifico” di tutto questo vagare era autentico, almeno negli intenti, anche se credo che con l’andar del tempo sia diventato quasi un pretesto, e che Vidua abbia continuato a spostare sempre un po’ più in là gli orizzonti per non dover affrontare, una volta fermo, l’onere di un bilancio. A dispetto dei reiterati propositi di ritorno e di stabilizzazione definitiva, espressi soprattutto nelle ultime missive, penso che ad un certo punto il viaggio sia diventato per lui, da strumento che era, il fine. O che lo fosse sin dall’inizio.
Cos’ho trovato dunque di particolarmente attrattivo nel Vidua viaggiatore? Senz’altro la determinazione: intraprendeva quasi tutte le sue avventure in compagnia di amici o conoscenti che ad un certo punto, per vari motivi, rinunciavano, mentre lui proseguiva imperterrito. E fino all’ultimo, anche a dispetto del grave incidente occorsogli, non intendeva rinunciare al completamento del giro del mondo. Mi piace poi il suo senso di responsabilità, anche se talvolta può sembrare pretestuoso: se uno sceglie di viaggiare non è giusto, né nei confronti propri né in quelli altrui, che contragga legami ai quali poi non può convenientemente ottemperare: “Quando l’uomo si marita, conviene che rinunci ai viaggi, e stabilisca di tenere compagnia bene o male a quella donna che per sua ventura o disgrazia ha scelto”.
E mi piace infine la capacità di adattarsi. Non mi riferisco chiaramente alle condizioni materiali del viaggio, che erano comunque disagevoli, anche muovendosi col minimo di comodità concesso dall’epoca, ma a quelle psicologiche. Si trovava altrettanto a suo agio ovunque e con qualunque interlocutore, fossero sovrani, presidenti, marajà, governatori coloniali, mercanti o beduini: non adulava, non si umiliava, li interrogava mostrando un interesse genuino, li ascoltava e cercava di trarre da tutti il numero maggiore di informazioni possibili: non era lì per giudicare, anche se poi nelle lettere i suoi giudizi li esprimeva, ma per capire.

Il Vidua “uomo” mi ha intrigato invece perché sfugge ad ogni incasellamento. È impossibile metterlo perfettamente a fuoco. Lui stesso non ha collaborato granché. Non ha lasciato opere compiute (se si eccettua la raccolta di iscrizioni antiche, che è un lavoro specialistico), fallendo malinconicamente nell’adolescenziale assillo di tutta una vita, la costruzione di una immagine di sé ricalcata su quella degli eroi antichi. Quindi non abbiamo un autoritratto “autorizzato”, la sua versione soggettiva. Ma riesce difficile anche ricostruirne un ritratto sufficientemente oggettivo attraverso ciò che ci è rimasto, perché le sue lettere, che pure di quella immagine sono piene, la cambiano poi in realtà a seconda dei destinatari: la loro scrittura si adatta di volta in volta a trasmettere ciò che Carlo riteneva l’interlocutore si aspettasse.
 Ciò non significa che Vidua fosse uno Zelig, un uomo senza personalità. Era semmai un personaggio un po’ pirandelliano, costantemente lacerato tra la mozione paralizzante degli affetti e quella liberatoria degli istinti. Alla fine ha prevalso la seconda, ma non ha mai soffocato definitivamente la prima: così che ogni esperienza è stata da lui vissuta sotto una doppia luce. Dovessimo giudicare solo dalle lettere al padre, ad esempio, ne verrebbe fuori un aristocratico un po’ eccentrico che si compiace soprattutto delle sue frequentazioni altolocate – oggi sarebbe un cacciatore di selfie con le celebrità –, del rispetto tributato alle sue ascendenze nobiliari e del ruolo di ambasciatore itinerante dello stato savoiardo nel mondo: mentre è evidente che tutto questo serviva solo a tentare di giustificare davanti al genitore la propria disobbedienza, e che la frequentazione di quegli ambienti era strumentale al lavoro che intendeva compiere (e alla fama che sperava ricavarne). Così, in quelle agli altri famigliari la preoccupazione costante è di rassicurarli sul proprio stato di salute, sulla sicurezza dei viaggi e sul fatto che non si dimentica di loro, usando però spesso la formula “è stato un po’ pericoloso, o un po’ difficile, ma comunque sono ancora vivo e sano”, come a tenerli comunque allertati sull’eccezionalità di quanto stava facendo; mentre nelle lettere agli amici si compiace di inserire aneddoti, avventure e osservazioni che rimandino l’immagine di un originale freddo e coraggioso e riscattino la sua apparente diserzione dalle lotte patriottiche.
Ciò non significa che Vidua fosse uno Zelig, un uomo senza personalità. Era semmai un personaggio un po’ pirandelliano, costantemente lacerato tra la mozione paralizzante degli affetti e quella liberatoria degli istinti. Alla fine ha prevalso la seconda, ma non ha mai soffocato definitivamente la prima: così che ogni esperienza è stata da lui vissuta sotto una doppia luce. Dovessimo giudicare solo dalle lettere al padre, ad esempio, ne verrebbe fuori un aristocratico un po’ eccentrico che si compiace soprattutto delle sue frequentazioni altolocate – oggi sarebbe un cacciatore di selfie con le celebrità –, del rispetto tributato alle sue ascendenze nobiliari e del ruolo di ambasciatore itinerante dello stato savoiardo nel mondo: mentre è evidente che tutto questo serviva solo a tentare di giustificare davanti al genitore la propria disobbedienza, e che la frequentazione di quegli ambienti era strumentale al lavoro che intendeva compiere (e alla fama che sperava ricavarne). Così, in quelle agli altri famigliari la preoccupazione costante è di rassicurarli sul proprio stato di salute, sulla sicurezza dei viaggi e sul fatto che non si dimentica di loro, usando però spesso la formula “è stato un po’ pericoloso, o un po’ difficile, ma comunque sono ancora vivo e sano”, come a tenerli comunque allertati sull’eccezionalità di quanto stava facendo; mentre nelle lettere agli amici si compiace di inserire aneddoti, avventure e osservazioni che rimandino l’immagine di un originale freddo e coraggioso e riscattino la sua apparente diserzione dalle lotte patriottiche.
Le testimonianze esterne trasmettono invece un Carlo Vidua molto diverso: Quincey Adams ne parla come di una persona semplice e alla mano; Caillaud è conquistato dalla sua serietà e al tempo stesso dalla sua disponibilità; il comandante olandese dell’Iris racconta come sulla nave si adattasse volenterosamente a qualsiasi compito, pur essendo un passeggero pagante. Alla fine la versione meno credibile è proprio quella del suo già intimo amico e primo biografo Cesare Balbo, che nell’editarne le lettere ha costruito con tagli mirati una oleografica figurina di eroe romantico, malinconico e sfortunato.
Io mi sono fatto questo personalissimo quadro. Vidua è un personaggio anacronistico. Ma lo è nel senso più letterale del termine; sta fuori dal tempo, e non solo dal suo. Non era un romantico, pur avendone tutte le caratteristiche, non era un illuminista, pur utilizzando tutti i criteri illuministici di interpretazione della realtà. Questo crea l’impressione che non abbia mai veramente capito quanto stava accadendo e avesse idee piuttosto confuse su quanto sarebbe potuto accadere in futuro. Io credo invece che Vidua si sia volutamente (e quindi consapevolmente) rifiutato di capirlo, perché ciò che lo circondava andava a configgere, oltre che con la sua indole irrequieta, con tutte le sue idealità: e non parlo delle convinzioni politiche e religiose, ché quelle sono legate all’ambiente in cui era cresciuto e al periodo in cui ha vissuto, ma delle idealità etiche delle quali si era nutrito sin da bambino. C’è un passo di una sua lettera (a Roberto d’Azeglio) che fa intendere benissimo la sua posizione: “È vero che a Torino, a sentir le esagerazioni insopportabili di certa gente, mi sentivo sì trascinato alla liberalità, che mi facevo forza per non diventarlo eccessivamente. – Così nell’altro mondo le esagerazioni liberali mi disgustavano tanto, che mi facevo forza per non diventare partigiano delle Soirée de st.Petersbourg”. È una frase che avrebbe potuto essere pronunciata da Corto Maltese (tra l’altro, fisicamente Vidua gli somiglia un po’), e che naturalmente sottoscrivo.
Vidua era un aristocratico, ma non un codino. Era un conservatore, ma non un reazionario. Si rifaceva agli ideali degli àristoi greci e latini come raccontati da Plutarco e da Tacito, ma quelle idealità le vedeva reincarnate anche nei crociati e nei paladini cristiani, o nei missionari gesuiti del Paraguay (quelli del film Mission). Tra i contemporanei che più ammirava c’erano i quaccheri americani, perché non si limitavano a professare la fede, ma la praticavano, e il filantropo inglese John Howard, uno che aveva girata tutta l’Inghilterra e buona parte dell’Europa visitando le carceri, denunciandone le atrocità e formulando suggerimenti per il miglioramento delle condizioni di vita dei prigionieri. Ecco, Howard era il suo modello più prossimo: un grande viaggiatore (si calcola abbia percorso più di 70.000 chilometri) e un benefattore dell’umanità, ascoltato dai potenti, riconosciuto e celebrato (almeno nella sua epoca) un po’ ovunque. E Vidua lo contrappone in positivo, ad esempio, al nostro Beccaria, che si era conquistato la fama cercando di applicare alla realtà italiana i principi riformatori d’oltralpe, senza mai muoversi dal suo studio.
Insomma, Vidua era un utopista: ma non di quelli che immaginano un’utopia buona per tutti gli uomini, e cercano sciaguratamente di attuarla, bensì di coloro che se ne creano una individuale e cercano il più possibile di abitarla.
Già questo basterebbe ad assicurargli un posto nel mio cuore. C’è però molto di più. Sono convinto infatti come Machiavelli che i lettori più attenti del presente siano sempre i conservatori, che sanno ciò che perdono con il cambiamento, e non i progressisti, che oggettivamente non sanno cosa troveranno e ritengono che ogni novità sia di per sé positiva. E sono anche convinto che per lo stesso motivo i grandi reazionari (si pensi a De Maistre) siano i più sensibili ai dettagli anche minimi del cambiamento, coloro che ne scorgono prima degli altri gli indizi e ne presagiscono più lucidamente le derive negative. Il bilancio che traccia al termine del viaggio in America è la migliore testimonianza di questa capacità premonitoria.
Altri motivi di consonanza sono forse più banali, ma per me non meno significativi. Dell’ammirazione per Humboldt e di quella per De Maistre ho già parlato: aggiungerei quella per Vico, che all’epoca di Vidua era ignorato dalla gran parte dei nostri intellettuali, e ha continuato ad esserlo almeno sino alla riscoperta da parte di Croce. Ma pure quella per Plutarco e Tacito e Senofonte tra i classici antichi, e per Machiavelli tra i moderni.
C’è poi il legame forte con la campagna. Certo, nel suo caso è il legame che può avere un proprietario di risaie, dalle quali trae la rendita che gli consente di viaggiare, troppo distratto da altri impegni negli ultimi quindici anni di vita per curarne l’amministrazione. Ma dalle lettere traspare comunque un certo orgoglio per la propria origine “rurale”. Si manifesta anche in questo caso la bipolarità di Vidua, diviso tra l’ammirazione per l’industriosità e la crescita economica e la nostalgia per un mondo preindustriale che va scomparendo. Ciò spiega il fastidio per i disboscamenti selvaggi in Inghilterra prima e in America poi, la preoccupazione per perdita della centralità economica dell’agricoltura, che porta con sé il tramonto del millenario assetto sociale ad essa connesso. Ma spiega anche l’attenzione ai tipi di coltivazione, alle tecniche, alle rese, laddove la maggioranza dei viaggiatori suoi contemporanei in genere non distingueva una spiga di grano da un’erbaccia.
 Tale senso di appartenenza gli fa anche ad apprezzare, ad esempio, le musiche della tradizione popolare in ogni parte del globo; e persino le espressioni dialettali, dalle quali vorrebbe liberare la nostra lingua, ma delle quali sente comunque, almeno in particolari contesti, la forza e l’espressività: racconta ad esempio divertito delle esclamazioni cui si abbandonava il suo maestro di musica: “così s’fa pu prest”, o “à l’è na bestia”.
Tale senso di appartenenza gli fa anche ad apprezzare, ad esempio, le musiche della tradizione popolare in ogni parte del globo; e persino le espressioni dialettali, dalle quali vorrebbe liberare la nostra lingua, ma delle quali sente comunque, almeno in particolari contesti, la forza e l’espressività: racconta ad esempio divertito delle esclamazioni cui si abbandonava il suo maestro di musica: “così s’fa pu prest”, o “à l’è na bestia”.
E questo ci riporta al tema della lingua. Nel Discorso sullo stato delle cognizioni in Italia parla, come abbiamo già visto, della necessità per la lingua (e per la nostra cultura in genere) di spiemontizzarsi e sfrancesizzarsi, di “sottrarsi all’imbarbarimento”. Ma non è solo questione di tornare ad una purezza lessicale che in fondo il nostro idioma non ha mai conosciuto, e che semmai andrebbe costruita: ciò che Vidua auspica è una lingua il più possibile aderente all’oggetto, senza fronzoli e ghirigori, semplice ed efficace. Chiede di uscire dalle esasperazioni metaforiche e immaginifiche del Barocco, che nascono dall’assenza di contenuti, ma anche di rifiutare gli orrori e i languori lessicali del romanticismo. Oggi dovrebbe chiedere un risciacquo nella prosa calviniana per liberare il nostro lessico dai tecnicismi forzati, dagli anglicismi superflui, dagli idiomatismi virali, ma anche delle massicce iniezioni di concretezza nei temi e nelle argomentazioni. Sarebbe più anacronistico che mai, e si sentirebbe più che mai estraneo alla sua terra e alla sua gente. Sensazioni che conosco bene, così come conosco quella di incompiutezza, che fortunatamente in me è stata messa a tacere dall’età. Lui è stato meno fortunato.
I motivi dell’affezione per Vidua sono dunque svariati. I più significativi sono paradossalmente proprio quelli legati alle sue “debolezze”, alle incoerenze che anziché farmi avvertire una distanza me lo hanno avvicinato: il rapporto contradditorio col padre e con i luoghi dell’infanzia, l’oscillazione costante tra nostalgia del passato e speranza nel futuro, l’anelito all’assoluta libertà e la giustificazione, pur parziale del dispotismo, l’apertura e la disponibilità al confronto e l’intimo arroccamento su posizioni pregiudiziali. Ci accomuna persino il rapporto con la scrittura. Scrive a Roberto d’Azeglio: “Ho bisogno de’ tuoi consigli sullo scrivere o non scrivere viaggi — e in che lingua — la nostra è la più bella. Pur se li scrivo in Italiano, nessuno li leggerà. — Dall’uno canto ci inclino — dall’altro penso che già troppi viaggi sono stampati”.
Come esco, dunque, dal viaggio compiuto in compagnia di questo personaggio e delle sue lettere? Con un sentimento di rammarico: per lui, perché non ha completato il viaggio attorno al mondo, e soprattutto non lo ha potuto degnamente raccontare. Per me, che il viaggio non l’ho nemmeno iniziato, perché non ho mai visitato l’isola di Cos.

Una bibliografia commentata
Nell’intraprendere la scrittura di questo pezzo ero pienamente consapevole dell’inadeguatezza delle mie forze (non ho le capacità di concentrazione indispensabili per una ricerca che risponda ai crismi “scientifici”) e anche del fatto che questo lavoro, indipendentemente dal risultato, non avrebbe contribuito granché ad arricchire e a divulgare la conoscenza del suo oggetto. Dovevo farlo per adempiere ad un impegno preso con Vidua diversi anni fa. Diciamo che era diventata una questione tra me e lui. Ho voluto comunque che nel suo piccolo la narrazione fosse la più esatta possibile. Per questo, oltre che dei testi originali delle lettere e dei pochi scritti editi di Vidua, mi sono avvalso di diversi studi a lui dedicati, scoprendo con mia sorpresa che sono molti più di quanto inizialmente reputassi. Quest’ultima constatazione da un lato mi rallegra, dall’altro mi fa deplorare il fatto che non sia ancora stata realizzata una biografia del Viaggiatore capace di sottrarlo al destino di nicchia, una di quelle cose all’inglese che rendono avvincente anche la storia di impiegato del catasto.
I materiali per un lavoro di questo genere sono a mio giudizio già presenti nel lavoro su Carlo Vidua. Un romantico atipico, di Roberto Coaloa e Andrea Testa, edito a cura del Comune di Casale Monferrato nel 2003, che rimane comunque una raccolta di testi redatti in diverse occasioni. Se organizzati in una corretta sequenza narrativa e depurati delle eccessive ripetizioni potrebbero già offrire un’immagine sufficientemente completa e accattivante del personaggio. Per quanto mi concerne, ho saccheggiato spudoratamente da questo testo le citazioni riferibili ai materiali inediti utilizzati dagli autori. Spero non me ne vogliano.
Per chi si fosse appassionato all’argomento sono reperibili (con un certo sforzo) una serie di testi su aspetti particolari della sua vicenda:
Angela Ferraris – Carlo Vidua. La virtù infelice, in “Piemonte e letteratura 1789-1870” – Atti del convegno di S. Salvatore, ottobre 1981
Vincenzo Moretti – Carlo Vidua viaggiatore, in “Piemonte e letteratura 1789-1870” – Atti del convegno di S. Salvatore, ottobre 1981
Gian Paolo Romagnani – Carlo Vidua. Un inquieto aristocratico subalpino, in “Studi piemontesi”, nov. 1986 vol. XV-2
Gian Paolo Romagnani – Carlo Vidua. Viaggiatore e collezionista – Casale M., 1987
Andrea Testa – Carlo Vidua viaggiatore italiano negli Stati uniti, in “Rivista di storia, arte e archeologia per le province di Alessandria e di Asti” CV 1996
Andrea Testa – Riflessioni sugli ultimi viaggi di Carlo Vidua alla ricerca di nuovi mondi – Atti del convegno “L’altro Piemonte nell’età di Carlo Alberto”, ottobre 1999
Esiste anche uno schizzo biografico di misura analoga a quell0 mi0, un po’ datato nell’approccio “ideologico”, ma nel complesso esauriente e piacevole. È Il conte Carlo Fabrizio Vidua viaggiatore monferrino dell’800, di Mario Cappa, comparso sulla “Rivista di Storia, Arte Archeologia per le province di Alessandria e Asti”, anno LXXXII, 1973
Per leggere direttamente Vidua si possono (insomma!) vedere
Carlo Vidua – Relazioni del viaggio in Levante e in Grecia – Olschki, Firenze 2011 (stampato in facsimile)
Carlo Vidua – In Viaggio Dal Grande Nord All’impero Ottomano – Edizioni Dell’Orso, Alessandria (lo si trova a un prezzo che va dai 350 ai 380 euro)
Carlo Vidua – Narrazione viaggio alla Nuova Guinea 1830 (testo bilingue, a cura di Marisa Viaggi Bonisoli), ed. Angolo Manzoni, Torino 2003
Le Lettere sono rintracciabili invece solo nella versione digitale o a prezzo di antiquariato: Lettere del conte Carlo Vidua pubblicate da Cesare Balbo. Tomi I – II – III, presso G. Pomba, 1834, all’indirizzo https://books.google.it/books/about/Lettere_del_conte_Carlo_Vidua.
Per una bibliografia esauriente (ma aggiornata fino al 2003) rimando al volume di Roberto Coaloa e Andrea Testa.











































 Facciamo un esempio per capirci. Bertrand Russell (1872-1970) è ritenuto generalmente un’importante figura di filosofo e attivista pacifista. È famoso per essersi impegnato per la messa al bando delle armi atomiche. Si è opposto alla partecipazione della Gran Bretagna alla Prima guerra mondiale. Per questo fu privato della cattedra e fu perfino incarcerato. Eppure Russell, dopo un notevole impegno per prevenire il conflitto, giunse ad approvare la guerra contro la Germania nazista. Come dovremmo considerare la sua posizione? Siamo in presenza di un pacifista eroico, oppure di un bellicista guerrafondaio? Oppure di un voltagabbana? Russell ha chiarito la sua posizione in un famoso articolo del 1943
Facciamo un esempio per capirci. Bertrand Russell (1872-1970) è ritenuto generalmente un’importante figura di filosofo e attivista pacifista. È famoso per essersi impegnato per la messa al bando delle armi atomiche. Si è opposto alla partecipazione della Gran Bretagna alla Prima guerra mondiale. Per questo fu privato della cattedra e fu perfino incarcerato. Eppure Russell, dopo un notevole impegno per prevenire il conflitto, giunse ad approvare la guerra contro la Germania nazista. Come dovremmo considerare la sua posizione? Siamo in presenza di un pacifista eroico, oppure di un bellicista guerrafondaio? Oppure di un voltagabbana? Russell ha chiarito la sua posizione in un famoso articolo del 1943




 E sempre a proposito di amori, poco o nulla si sa di una sua vita sentimentale “attiva”. Il giovanile accenno ad una fanciulla morta prematuramente (che si chiamava Teresa, come la Teresa Fattorini di A Silvia) è molto generico, e più che da un moto di commozione sincera sembra dettato dalla moda romantico-sepolcrale dell’epoca: “Io mirava quei flutti: e come l’onda, mio dicevo tra me stesso, che vedo trascorrere e confondersi, ratto così passò la gentile donzella, e già sta per confondersi, o si confonde il suo nome nella notte del tempo, e le sue belle forme tra le altre ceneri del sepolcro […]” . Più tardi ironizza sul fatto che gli sia stato attribuito un innamoramento per una “ninfa sestrina”, chiarendo che: “Nessuna donna possiederà mai una parte del mio cuore. Conviene che questo sesso sia al servizio del nostro divertimento e delle nostre necessità, non che sconvolga l’anima”. Il che lo escluderebbe da ogni sospetto di romanticismo, e parrebbe condannarlo all’aridità sentimentale. Anche se poi, quando arriva il tempo dei bilanci, sembra provare rimpianto quel flirt appena accennato: “[…] ricorderò con dolore di aver seguito i tuoi suggerimenti, e di non aver tolto quella ninfa sestrina di cui nel 1813 ti feci già una sì vantaggiosa descrizione”.
E sempre a proposito di amori, poco o nulla si sa di una sua vita sentimentale “attiva”. Il giovanile accenno ad una fanciulla morta prematuramente (che si chiamava Teresa, come la Teresa Fattorini di A Silvia) è molto generico, e più che da un moto di commozione sincera sembra dettato dalla moda romantico-sepolcrale dell’epoca: “Io mirava quei flutti: e come l’onda, mio dicevo tra me stesso, che vedo trascorrere e confondersi, ratto così passò la gentile donzella, e già sta per confondersi, o si confonde il suo nome nella notte del tempo, e le sue belle forme tra le altre ceneri del sepolcro […]” . Più tardi ironizza sul fatto che gli sia stato attribuito un innamoramento per una “ninfa sestrina”, chiarendo che: “Nessuna donna possiederà mai una parte del mio cuore. Conviene che questo sesso sia al servizio del nostro divertimento e delle nostre necessità, non che sconvolga l’anima”. Il che lo escluderebbe da ogni sospetto di romanticismo, e parrebbe condannarlo all’aridità sentimentale. Anche se poi, quando arriva il tempo dei bilanci, sembra provare rimpianto quel flirt appena accennato: “[…] ricorderò con dolore di aver seguito i tuoi suggerimenti, e di non aver tolto quella ninfa sestrina di cui nel 1813 ti feci già una sì vantaggiosa descrizione”.

 Per intanto il primo dei problemi da affrontare è, secondo Vidua, l’assenza di una lingua comune, conseguenza di un desolante provincialismo: “Siamo più stranieri a noi stessi che agli altri: è cosa deplorevole che più differenza e opposizione di idee e di costumi vi sia tra l’una e l’altra delle nostre province e un’altra nazione europea o anche asiatica”. Questo nasce, oltre che dalle contingenze storiche (le diverse dominazioni che si sono susseguite sulla penisola), dal fatto che da noi la classe colta ha continuato testardamente e arrogantemente ad esprimersi in latino, salvo poi nel corso del Settecento volgersi al francese, allargando così sempre più la forbice culturale nei confronti degli altri ceti e non favorendo l’evoluzione dei diversi volgari verso un idioma comune. In realtà, gli esempi per la costruzione di una lingua condivisa esistono, arrivano da tutta la letteratura rinascimentale pre-barocca e possono costituire la base per mettere fine alle sterili dispute in difesa degli usi lessicali localistici. E una volta individuata la direzione, la lingua per Vidua deve essere difesa da un lato contro la “corruzione dei dialetti”, dall’altro dall’“infranciosamento”, dall’adozione di termini e costrutti stranieri che sono le crepe attraverso le quali si insinuano anche le perniciose idee d’oltralpe.
Per intanto il primo dei problemi da affrontare è, secondo Vidua, l’assenza di una lingua comune, conseguenza di un desolante provincialismo: “Siamo più stranieri a noi stessi che agli altri: è cosa deplorevole che più differenza e opposizione di idee e di costumi vi sia tra l’una e l’altra delle nostre province e un’altra nazione europea o anche asiatica”. Questo nasce, oltre che dalle contingenze storiche (le diverse dominazioni che si sono susseguite sulla penisola), dal fatto che da noi la classe colta ha continuato testardamente e arrogantemente ad esprimersi in latino, salvo poi nel corso del Settecento volgersi al francese, allargando così sempre più la forbice culturale nei confronti degli altri ceti e non favorendo l’evoluzione dei diversi volgari verso un idioma comune. In realtà, gli esempi per la costruzione di una lingua condivisa esistono, arrivano da tutta la letteratura rinascimentale pre-barocca e possono costituire la base per mettere fine alle sterili dispute in difesa degli usi lessicali localistici. E una volta individuata la direzione, la lingua per Vidua deve essere difesa da un lato contro la “corruzione dei dialetti”, dall’altro dall’“infranciosamento”, dall’adozione di termini e costrutti stranieri che sono le crepe attraverso le quali si insinuano anche le perniciose idee d’oltralpe.

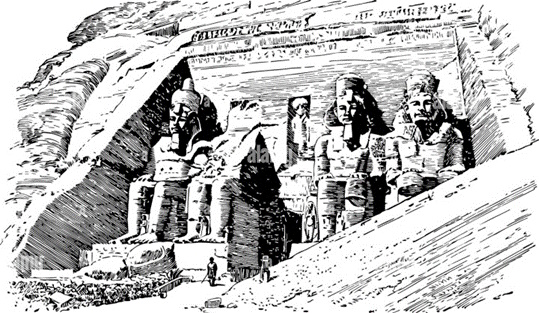 Il trasferimento da Alessandria al Cairo è compiuto con una piccola carovana che consente di farci un’idea di come viaggia Vidua: è accompagnato da due arabi che conducono un cammello, un cavallo e due asini con i bagagli, mentre lui e il suo domestico Lorenzo viaggiano a loro volta a cavallo. Il bagaglio comprende una tenda, due letti, le vesti, la biancheria e le scarpe, i fucili e le pistole, più una batteria da cucina, i viveri e le bevande. Non è l’immagine classica (e romantica) dell’esploratore o del giramondo alla quale noi oggi siamo abituati, ma occorre considerare come all’epoca, e specialmente in quelle terre, non fosse facile trovare sistemazioni notturne e posti di ristoro. Non mancavano certamente gli avventurieri capaci di affrontare i deserti o le foreste africane armati solo del loro coraggio (vedi René Caille o, più tardi, Richard Burton), ma Vidua non è né un esploratore né un avventuriero, è un giovanotto di famiglia patrizia che ha scelto di compiere il suo Gran Tour, il suo viaggio iniziatico, fuori dell’Europa. L’equipaggiamento di cui sopra è comunque praticamente lo stesso col quale si muoveva nei medesimi luoghi, esattamente due secoli prima, un altro viaggiatore italiano, Pietro della Valle.
Il trasferimento da Alessandria al Cairo è compiuto con una piccola carovana che consente di farci un’idea di come viaggia Vidua: è accompagnato da due arabi che conducono un cammello, un cavallo e due asini con i bagagli, mentre lui e il suo domestico Lorenzo viaggiano a loro volta a cavallo. Il bagaglio comprende una tenda, due letti, le vesti, la biancheria e le scarpe, i fucili e le pistole, più una batteria da cucina, i viveri e le bevande. Non è l’immagine classica (e romantica) dell’esploratore o del giramondo alla quale noi oggi siamo abituati, ma occorre considerare come all’epoca, e specialmente in quelle terre, non fosse facile trovare sistemazioni notturne e posti di ristoro. Non mancavano certamente gli avventurieri capaci di affrontare i deserti o le foreste africane armati solo del loro coraggio (vedi René Caille o, più tardi, Richard Burton), ma Vidua non è né un esploratore né un avventuriero, è un giovanotto di famiglia patrizia che ha scelto di compiere il suo Gran Tour, il suo viaggio iniziatico, fuori dell’Europa. L’equipaggiamento di cui sopra è comunque praticamente lo stesso col quale si muoveva nei medesimi luoghi, esattamente due secoli prima, un altro viaggiatore italiano, Pietro della Valle. Carlo Vidua non è però uomo da concentrarsi su un solo paese e votarsi a un unico campo di studi. Vuole lasciare la sua impronta un po’ in tutti. Intanto comincia col lasciarla concretamente. In Egitto, ad esempio, incide il proprio nome su tutti i monumenti visitati, tanto da guadagnarsi lo stigma negativo di Flaubert: “Leggiamo nei templi i nomi dei viaggiatori: mi sembra una vana piccineria. Ce ne sono che hanno richiesto tre giorni per essere incisi. Qualcuno si ritrova dappertutto, con una costanza di imbecillità sublime. C’è uno di nome Vidua, che non ci lascia mai […]”. In effetti, la cosa può riuscire fastidiosa: ma è chiaro che nel caso del nostro non è una imbecillità da turista, bensì quasi un marcare il territorio, e inviare un messaggio agli amici e ai posteri. Che a volte lo recepiscono: è già capitato a lui in Lapponia, e quando qualche anno dopo Santorre di Santarosa troverà su una colonna di un tempio di Atene il nome di Vidua, suo amico, inciderà accanto ad esso il proprio.
Carlo Vidua non è però uomo da concentrarsi su un solo paese e votarsi a un unico campo di studi. Vuole lasciare la sua impronta un po’ in tutti. Intanto comincia col lasciarla concretamente. In Egitto, ad esempio, incide il proprio nome su tutti i monumenti visitati, tanto da guadagnarsi lo stigma negativo di Flaubert: “Leggiamo nei templi i nomi dei viaggiatori: mi sembra una vana piccineria. Ce ne sono che hanno richiesto tre giorni per essere incisi. Qualcuno si ritrova dappertutto, con una costanza di imbecillità sublime. C’è uno di nome Vidua, che non ci lascia mai […]”. In effetti, la cosa può riuscire fastidiosa: ma è chiaro che nel caso del nostro non è una imbecillità da turista, bensì quasi un marcare il territorio, e inviare un messaggio agli amici e ai posteri. Che a volte lo recepiscono: è già capitato a lui in Lapponia, e quando qualche anno dopo Santorre di Santarosa troverà su una colonna di un tempio di Atene il nome di Vidua, suo amico, inciderà accanto ad esso il proprio.
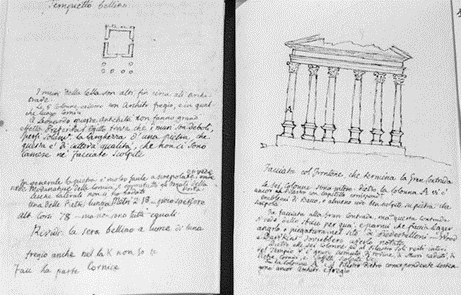 Intanto, le vicende rivoluzionarie che potrebbero magari direttamente coinvolgerlo (i moti piemontesi del 1821), e che vedono protagonisti i suoi amici Balbo e Santorre di Santarosa, si stanno consumando in sua assenza. Ma anche su quelle, a posteriori, il suo giudizio non si spingerà oltre la personale simpatia per gli sfortunati (e ingenui) patrioti.
Intanto, le vicende rivoluzionarie che potrebbero magari direttamente coinvolgerlo (i moti piemontesi del 1821), e che vedono protagonisti i suoi amici Balbo e Santorre di Santarosa, si stanno consumando in sua assenza. Ma anche su quelle, a posteriori, il suo giudizio non si spingerà oltre la personale simpatia per gli sfortunati (e ingenui) patrioti. Le “nostre signore” di cui parla sono le componenti di una bizzarra famiglia di otto donne, che così ha prima descritto: “Una bisava decrepita – due sue figlie vecchie, di cui una ha tre figlie, una delle quali maritata ha una serva indocile, e una bambina che completa la quarta generazione, e ch’è la sola persona tranquilla di tutta la famiglia. S’immagini tutta questa gente col loro cane rinchiusi con me ed un altro passeggiero (negoziante Francese assai buona persona) in una piccola camera, gridando, piangendo, disputando fra loro, con noi, col capitano; la bambina che stride, la decrepita che tosse, il cane che abbaia, non è un vivere, ma è continuo morire. La notte, per caldo che faccia, vogliono restar stivati nella camera colle finestre chiuse, e cento altre indiscrezioni colle quali corrispondono alle cortesie ed attenzioni, che abbiamo usato verso loro”. Il quadretto è fantastico, per l’essenziale efficacia della scrittura ma soprattutto perché dimostra che Vidua è un viaggiatore vero. Riesce prima ad adattarsi ad una simile infernale situazione, e a reinterpretarla poi simpaticamente come una “dolce quarantena”.
Le “nostre signore” di cui parla sono le componenti di una bizzarra famiglia di otto donne, che così ha prima descritto: “Una bisava decrepita – due sue figlie vecchie, di cui una ha tre figlie, una delle quali maritata ha una serva indocile, e una bambina che completa la quarta generazione, e ch’è la sola persona tranquilla di tutta la famiglia. S’immagini tutta questa gente col loro cane rinchiusi con me ed un altro passeggiero (negoziante Francese assai buona persona) in una piccola camera, gridando, piangendo, disputando fra loro, con noi, col capitano; la bambina che stride, la decrepita che tosse, il cane che abbaia, non è un vivere, ma è continuo morire. La notte, per caldo che faccia, vogliono restar stivati nella camera colle finestre chiuse, e cento altre indiscrezioni colle quali corrispondono alle cortesie ed attenzioni, che abbiamo usato verso loro”. Il quadretto è fantastico, per l’essenziale efficacia della scrittura ma soprattutto perché dimostra che Vidua è un viaggiatore vero. Riesce prima ad adattarsi ad una simile infernale situazione, e a reinterpretarla poi simpaticamente come una “dolce quarantena”.
 Molto diversa, com’era da attendersi, è la reazione paterna. Carlo ha meticolosamente programmato e preparato il viaggio in America, ma non ne ha mai discusso in famiglia. Tutto rischia quindi di saltare quando a Marsiglia, poche settimane prima della data fissata per la partenza, arriva un ordine restrittivo dello stato sabaudo nei suoi confronti, fatto emanare probabilmente proprio dal padre. Il giovane non si rassegna, e in una lettera al genitore fa chiaramente intendere che da un rimpatrio inglorioso non uscirebbe offuscata solo la sua immagine. A quanto pare tocca il tasto giusto, perché l’ordine è rapidamente revocato. Carlo si imbarca dunque per l’America alla fine di febbraio del 1824, salpando dal porto di Le Havre.
Molto diversa, com’era da attendersi, è la reazione paterna. Carlo ha meticolosamente programmato e preparato il viaggio in America, ma non ne ha mai discusso in famiglia. Tutto rischia quindi di saltare quando a Marsiglia, poche settimane prima della data fissata per la partenza, arriva un ordine restrittivo dello stato sabaudo nei suoi confronti, fatto emanare probabilmente proprio dal padre. Il giovane non si rassegna, e in una lettera al genitore fa chiaramente intendere che da un rimpatrio inglorioso non uscirebbe offuscata solo la sua immagine. A quanto pare tocca il tasto giusto, perché l’ordine è rapidamente revocato. Carlo si imbarca dunque per l’America alla fine di febbraio del 1824, salpando dal porto di Le Havre.

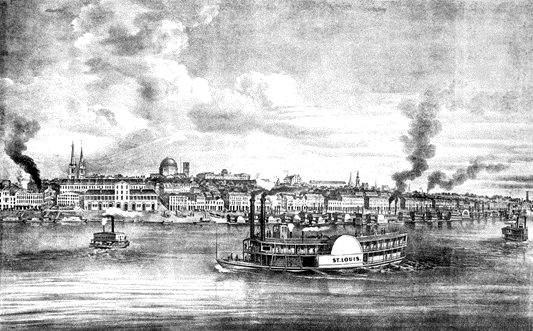



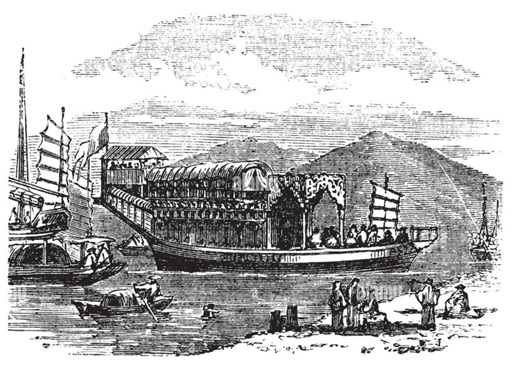

 L’esplorazione delle isole della Sonda è però solo un’ulteriore tappa di avvicinamento al continente australe, rispetto al quale l’interesse torna ad essere prevalentemente politico. “Il mio scopo nel visitare la Nuova Olanda è di osservare nella sua infanzia una colonia tutta di razza europea, destinata a divenire in cento o centocinquant’anni uno stato importante. Ho visitato gli stati Uniti nell’età giovanile. Visitar la Nuova Olanda è come veder dei secondi Stati uniti ancor bambini […]”
L’esplorazione delle isole della Sonda è però solo un’ulteriore tappa di avvicinamento al continente australe, rispetto al quale l’interesse torna ad essere prevalentemente politico. “Il mio scopo nel visitare la Nuova Olanda è di osservare nella sua infanzia una colonia tutta di razza europea, destinata a divenire in cento o centocinquant’anni uno stato importante. Ho visitato gli stati Uniti nell’età giovanile. Visitar la Nuova Olanda è come veder dei secondi Stati uniti ancor bambini […]”

 Ciò non significa che Vidua fosse uno Zelig, un uomo senza personalità. Era semmai un personaggio un po’ pirandelliano, costantemente lacerato tra la mozione paralizzante degli affetti e quella liberatoria degli istinti. Alla fine ha prevalso la seconda, ma non ha mai soffocato definitivamente la prima: così che ogni esperienza è stata da lui vissuta sotto una doppia luce. Dovessimo giudicare solo dalle lettere al padre, ad esempio, ne verrebbe fuori un aristocratico un po’ eccentrico che si compiace soprattutto delle sue frequentazioni altolocate – oggi sarebbe un cacciatore di selfie con le celebrità –, del rispetto tributato alle sue ascendenze nobiliari e del ruolo di ambasciatore itinerante dello stato savoiardo nel mondo: mentre è evidente che tutto questo serviva solo a tentare di giustificare davanti al genitore la propria disobbedienza, e che la frequentazione di quegli ambienti era strumentale al lavoro che intendeva compiere (e alla fama che sperava ricavarne). Così, in quelle agli altri famigliari la preoccupazione costante è di rassicurarli sul proprio stato di salute, sulla sicurezza dei viaggi e sul fatto che non si dimentica di loro, usando però spesso la formula “è stato un po’ pericoloso, o un po’ difficile, ma comunque sono ancora vivo e sano”, come a tenerli comunque allertati sull’eccezionalità di quanto stava facendo; mentre nelle lettere agli amici si compiace di inserire aneddoti, avventure e osservazioni che rimandino l’immagine di un originale freddo e coraggioso e riscattino la sua apparente diserzione dalle lotte patriottiche.
Ciò non significa che Vidua fosse uno Zelig, un uomo senza personalità. Era semmai un personaggio un po’ pirandelliano, costantemente lacerato tra la mozione paralizzante degli affetti e quella liberatoria degli istinti. Alla fine ha prevalso la seconda, ma non ha mai soffocato definitivamente la prima: così che ogni esperienza è stata da lui vissuta sotto una doppia luce. Dovessimo giudicare solo dalle lettere al padre, ad esempio, ne verrebbe fuori un aristocratico un po’ eccentrico che si compiace soprattutto delle sue frequentazioni altolocate – oggi sarebbe un cacciatore di selfie con le celebrità –, del rispetto tributato alle sue ascendenze nobiliari e del ruolo di ambasciatore itinerante dello stato savoiardo nel mondo: mentre è evidente che tutto questo serviva solo a tentare di giustificare davanti al genitore la propria disobbedienza, e che la frequentazione di quegli ambienti era strumentale al lavoro che intendeva compiere (e alla fama che sperava ricavarne). Così, in quelle agli altri famigliari la preoccupazione costante è di rassicurarli sul proprio stato di salute, sulla sicurezza dei viaggi e sul fatto che non si dimentica di loro, usando però spesso la formula “è stato un po’ pericoloso, o un po’ difficile, ma comunque sono ancora vivo e sano”, come a tenerli comunque allertati sull’eccezionalità di quanto stava facendo; mentre nelle lettere agli amici si compiace di inserire aneddoti, avventure e osservazioni che rimandino l’immagine di un originale freddo e coraggioso e riscattino la sua apparente diserzione dalle lotte patriottiche. Tale senso di appartenenza gli fa anche ad apprezzare, ad esempio, le musiche della tradizione popolare in ogni parte del globo; e persino le espressioni dialettali, dalle quali vorrebbe liberare la nostra lingua, ma delle quali sente comunque, almeno in particolari contesti, la forza e l’espressività: racconta ad esempio divertito delle esclamazioni cui si abbandonava il suo maestro di musica: “così s’fa pu prest”, o “à l’è na bestia”.
Tale senso di appartenenza gli fa anche ad apprezzare, ad esempio, le musiche della tradizione popolare in ogni parte del globo; e persino le espressioni dialettali, dalle quali vorrebbe liberare la nostra lingua, ma delle quali sente comunque, almeno in particolari contesti, la forza e l’espressività: racconta ad esempio divertito delle esclamazioni cui si abbandonava il suo maestro di musica: “così s’fa pu prest”, o “à l’è na bestia”.





 matrice. Del resto, allo stesso modo chi professa la sua avversione per motivazioni religiose precisa che il proprio non è antisemitismo, ma antigiudaismo. Quindi l’antisemitismo ufficialmente è un sentimento proprio solo della destra, l’antisionismo è invece un chiodo fisso della sinistra. Ebbene, la mia opinione è che l’antisionismo (come del resto l’antigiudaismo), lo si voglia o no, trasuda antisemitismo da tutti i pori anche nelle persone apparentemente più corrette e imparziali. Proprio di questo voglio parlare: perché c’è qualcosa nel sentire antiebraico della sinistra che a mio parere non trova più nella storia una spiegazione convincente.
matrice. Del resto, allo stesso modo chi professa la sua avversione per motivazioni religiose precisa che il proprio non è antisemitismo, ma antigiudaismo. Quindi l’antisemitismo ufficialmente è un sentimento proprio solo della destra, l’antisionismo è invece un chiodo fisso della sinistra. Ebbene, la mia opinione è che l’antisionismo (come del resto l’antigiudaismo), lo si voglia o no, trasuda antisemitismo da tutti i pori anche nelle persone apparentemente più corrette e imparziali. Proprio di questo voglio parlare: perché c’è qualcosa nel sentire antiebraico della sinistra che a mio parere non trova più nella storia una spiegazione convincente.
 La seconda precisazione riguarda Israele (e il sionismo). La politica attuata oggi da Israele in Palestina non mi piace, segue la stessa logica dei “cuscinetti” difensivi perseguiti a suo tempo da tutti gli stati nazionali, europei e non, e da quelli coloniali: con le idealità del sionismo originale, che prevedeva uno stato socialista e aperto, non ha più alcun legame (per cui anche la dicitura di “anti-sionisti” per gli oppositori dello stato ultra-ebraico odierno è assolutamente impropria). Ma sono comunque convinto del diritto di Israele ad esistere, sia pure in altra forma. E ritengo tra l’altro che la sua politica attuale sia dettata in gran parte proprio dal fatto che gli altri non la pensano affatto così. È ipocrita fingere di dimenticare che nelle carte costitutive dell’Olp prima e di Hamas oggi è indicato come obiettivo principale quello di “sollevare la bandiera di Allah sopra ogni pollice della Palestina”, cioè di eliminare lo Stato di Israele, “perché la Palestina è terra islamica affidata alle generazioni dell’islam sino al giorno del giudizio”. In altri termini, qui si parla di liquidare o cacciare a mare tutti gli ebrei. E non è una formulazione retorica, perché con quattro guerre in venticinque anni a renderla fattuale ci hanno provato tutti gli stati arabi del Vicino Oriente. Quanto al tema dei profughi, andrebbe ricordato, se si vuole impostare un discorso serio, che della popolazione israeliana fanno parte anche gli oltre seicentomila ebrei che dovettero sloggiare alla svelta dagli stati arabi all’epoca della guerra del 1948. E che, a rigor di termini, in quella circostanza le ondate principali dell’esodo palestinese precedettero l’azione militare israeliana e furono provocate in primo luogo dalla fuga dei capi e delle classi dirigenti, che scatenò il panico e diede un pessimo esempio, e poi dagli ordini di evacuazione impartiti dal Supremo Comando Arabo, che incoraggiava i palestinesi a rifugiarsi in “aree sicure”. Da parte israeliana non si fece certamente nulla per trattenerli, ma non fu nemmeno mai diramato un ordine di espulsione (ciò non toglie che l’Haganah e l’Irgun abbiano provveduto in proprio a “sgomberare” villaggi arabi, e che alla fine del conflitto le autorità israeliane abbiano attuato un’opera di “ripulitura” delle frontiere). Il fatto poi che a questi profughi non sia stato consentito rientrare, attiene già ad un altro discorso, molto più complesso. Mi preme solo che quando si parla di queste vicende si tenga davvero conto di tutti i dati.
La seconda precisazione riguarda Israele (e il sionismo). La politica attuata oggi da Israele in Palestina non mi piace, segue la stessa logica dei “cuscinetti” difensivi perseguiti a suo tempo da tutti gli stati nazionali, europei e non, e da quelli coloniali: con le idealità del sionismo originale, che prevedeva uno stato socialista e aperto, non ha più alcun legame (per cui anche la dicitura di “anti-sionisti” per gli oppositori dello stato ultra-ebraico odierno è assolutamente impropria). Ma sono comunque convinto del diritto di Israele ad esistere, sia pure in altra forma. E ritengo tra l’altro che la sua politica attuale sia dettata in gran parte proprio dal fatto che gli altri non la pensano affatto così. È ipocrita fingere di dimenticare che nelle carte costitutive dell’Olp prima e di Hamas oggi è indicato come obiettivo principale quello di “sollevare la bandiera di Allah sopra ogni pollice della Palestina”, cioè di eliminare lo Stato di Israele, “perché la Palestina è terra islamica affidata alle generazioni dell’islam sino al giorno del giudizio”. In altri termini, qui si parla di liquidare o cacciare a mare tutti gli ebrei. E non è una formulazione retorica, perché con quattro guerre in venticinque anni a renderla fattuale ci hanno provato tutti gli stati arabi del Vicino Oriente. Quanto al tema dei profughi, andrebbe ricordato, se si vuole impostare un discorso serio, che della popolazione israeliana fanno parte anche gli oltre seicentomila ebrei che dovettero sloggiare alla svelta dagli stati arabi all’epoca della guerra del 1948. E che, a rigor di termini, in quella circostanza le ondate principali dell’esodo palestinese precedettero l’azione militare israeliana e furono provocate in primo luogo dalla fuga dei capi e delle classi dirigenti, che scatenò il panico e diede un pessimo esempio, e poi dagli ordini di evacuazione impartiti dal Supremo Comando Arabo, che incoraggiava i palestinesi a rifugiarsi in “aree sicure”. Da parte israeliana non si fece certamente nulla per trattenerli, ma non fu nemmeno mai diramato un ordine di espulsione (ciò non toglie che l’Haganah e l’Irgun abbiano provveduto in proprio a “sgomberare” villaggi arabi, e che alla fine del conflitto le autorità israeliane abbiano attuato un’opera di “ripulitura” delle frontiere). Il fatto poi che a questi profughi non sia stato consentito rientrare, attiene già ad un altro discorso, molto più complesso. Mi preme solo che quando si parla di queste vicende si tenga davvero conto di tutti i dati.