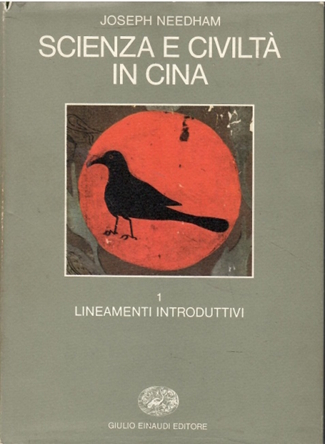di Paolo Repetto, 30 dicembre 2017
La scoperta degli indiani e della loro anima. 1
Buoni e cattivi selvaggi 12
Schiavitù, diversità, razza. 37
La scoperta degli indiani e della loro anima
Nel resoconto dei suoi primi approcci con gli indigeni delle Antille, Colombo ci anticipa attraverso alcune significative considerazioni i tratti che caratterizzano l’atteggiamento futuro dei colonizzatori. Egli annota: “Prendevano tutto quello che loro si regalava, e davano assai volentieri di tutto quello che avevano; ma parvemi che potessero dare ben poca cosa, e fosse gente sotto ogni aspetto molto povera”. Più oltre: “[…] essi debbono essere molto servizievoli e di buon carattere”. E poi ancora: “Mi sembra che se potrebbe fare subito dei cristiani, perché pare che non abbiano alcuna religione”. Infine: “Non hanno ferro. Le loro zagaglie sono bastoni senza ferro […] conoscono male l’uso delle armi […] cinquanta soldati sarebbero sufficienti a renderli inoffensivi e a far fare loro ciò che si vuole”.
C’è in primo luogo la preoccupazione di fondo, che concerne il movente principe della spedizione, quello economico. Gli indigeni sono disponibili allo scambio, e probabilmente la loro ingenuità consentirebbe traffici assai vantaggiosi: ma non possiedono nulla di ciò che muove l’interesse degli europei: né l’oro, né le spezie. Colombo non può fare a meno di rilevarlo, sia pure marginalmente, e lasciando appena trapelare la constatazione in mezzo all’entusiasmo per il compimento della traversata e alla curiosità per l’incontro con i nativi. Deve prendere atto che sotto il profilo economico l’impresa si sta rivelando fallimentare: in Spagna i suoi finanziatori attendono carichi di pepe, di cannella, di chiodi di garofano, oppure di tessuti o di preziosi, non certo pappagalli o selvaggi piumati da esibire. I suoi rivali portoghesi hanno trovato sulla rotta orientale l’oro della Guinea, e sono comunque certi di approdare prima o poi direttamente ai mercati indiani. L’ammiraglio non può ammettere che la “sua” via e le scoperte risultino antieconomiche: gli indigeni hanno poco da offrire, ma sono “molto docili e servizievoli”, e di lì a poco verrà proprio da lui la proposta ai sovrani di utilizzarli o di venderli come schiavi. Per il momento si limita a reclutare nei loro villaggi delle mogli per i propri uomini, e a portarne alcuni con sé, in Europa, come campionario.
Dai prosaici calcoli commerciali, la cui momentanea frustrazione non induce affatto un declino delle speranze, si passa a più elevate preoccupazioni di promozione spirituale. Gli amerindi, privi almeno in apparenza di un culto religioso, offrono una notevole occasione missionaria. I dubbi sulla loro appartenenza o meno al genere umano sorgeranno più tardi, quando sarà ormai comprovato l’isolamento del continente americano e non si riuscirà a farli rientrare in alcuna delle stirpi bibliche. Dall’evidente vacanza di una religiosità “positiva” organizzata, Colombo deduce invece soltanto che gli indigeni non hanno un dio. La sua fede non è formale e convenzionale: egli è fermamente convinto del dovere di diffondere la “vera religione”, con le buone o con le cattive: “se ne potrebbe fare subito dei cristiani”, appunto.
Infine, visto che il livello di organizzazione politica e militare è ben diverso da quello che ci si attendeva (Colombo era munito di lettere dei sovrani per il Gran Khan), emerge anche il dato tutt’altro che trascurabile dell’estrema debolezza bellica dei nativi: armi primitive e spirito fondamentalmente pacifico. Anche se l’ammiraglio sarà parzialmente smentito dalla feroce resistenza offerta dai Caribi, la sostanziale innocuità degli indigeni sarà uno dei fattori di maggiore stimolo per il moltiplicarsi delle spedizioni transoceaniche.
Sugli iniziali contatti con gli abitanti del nuovo mondo pesa tutto il retaggio di sogni, speranze, paure, fantasticherie liberatorie o paurose di cui gli europei hanno da sempre caricato il mistero occidentale. In un primo tempo è presente anche, e lo abbiamo accennato per Colombo, l’inquietudine generata da una supposta profanazione: non ha forse i tratti dell’Eden, questa terra dal clima incredibilmente mite, che nutre i suoi abitanti senza spremere il loro sudore, che appare come un immenso giardino per la varietà e la ricchezza della sua flora? La sensazione di aver violato un mondo estraneo al tempo e alla storia umana resiste anche alla concreta presa di possesso delle nuove terre, alle delusioni che essa arreca e alla nuova barbarie che sembra eccitare negli animi degli europei.
L’innocenza, la semplicità, la gioia di vivere che traspaiono dai primi resoconti sugli indigeni ravvivano l’immaginazione dei contemporanei di Machiavelli (ma non quella del segretario fiorentino), troppo mortificata dalla realtà torbida e violenta in cui sono immersi. Li eccita la libertà e al tempo stesso la naturalezza sessuale, della quale favoleggiano, secondo un inveterato costume, i marinai di ritorno: così come li affascina l’idea di un’esistenza sottratta alla schiavitù del lavoro, fondata sul piacere e sull’abbondanza. Nella fantasia di chi ascolta le meraviglie della fertilità del suolo, del tepore perenne, della debolezza e della cordialità dei nativi entrano in circuito le fabulazioni medioevali sulle Indie, assieme al sogno paganeggiante di una rinnovata età dell’oro, diffusa tra gli umanisti quattrocenteschi (Colombo è contemporaneo di Machiavelli, ma anche di Botticelli).
Il nuovo mondo dà linfa al fiorire dell’utopia: da un lato fornisce modelli esotici, sia di felice anarchismo che di efficiente organizzazione politico-amministrativa, cui attingono da Moro in avanti tutti i propugnatori di società “perfette”; dall’altro offre spazi concreti alla sperimentazione e alla realizzazione di “controsistemi” ispirati a nuovi rapporti con la natura e tra gli uomini. Del sogno utopico modifica comunque sostanzialmente i tratti. Le isole fortunate si moltiplicano, ma esse non vanno più alla deriva sugli oceani del mondo, e i loro colori sono familiari.
Al di là comunque delle fantasie liberate, la realtà dell’impatto procura agli europei più di una delusione. Si attendevano un’organizzazione politica, militare e soprattutto commerciale di alto livello, e si trovano di fronte, almeno inizialmente, ad un mondo primitivo, privo di una qualsivoglia struttura economica che consenta traffici regolari e remunerativi. Gli stessi missionari, aggregatisi sin dalla prima ora ai naviganti e ai conquistadores, nella prospettiva di immense greggi da condurre in seno alla chiesa, debbono constatare che i nativi sono riottosi alla conversione e tendono a dimenticare velocemente gli insegnamenti cristiani per tornare alla pratica dei loro culti tradizionali. I più comprensivi tra i religiosi manifestano l’impressione di trovarsi di fronte ad un popolo fanciullo, che dovrà attendere parecchio prima di giungere alla maturità. Esitano talvolta addirittura ad ammetterli ai sacramenti in cui entri in gioco una maggiore responsabilizzazione personale, come l’eucarestia. Ci sono anche coloro che, disgustati della promiscuità sessuale, delle usanze sacrificali, o semplicemente della impermeabilità dimostrata nei confronti della “vera fede”, rinunciano all’opera di evangelizzazione, affermando che “Dio mai creò gente tanto intrisa di vizi e di bestialità, senza mescolanza di bontà o urbanità”. (Tomaso Ortis).
D’altro canto, i problemi di coscienza e gli entusiasmi per il rinvenimento di una umanità più libera e felice sembrano propri soltanto di coloro che col nuovo mondo hanno rapporti puramente intellettuali o sentimentali. Chi invece ad esso concretamente approda è sospinto in genere da motivazioni che non consentono di apprezzare la “qualità della vita” degli indigeni. Al contrario, forti dell’impressione suscitata dalle armi da fuoco e dall’acciaio, ed anche del fatto che i nativi appaiono ingenui, fiduciosi e poco combattivi, gli europei non tardano a mettere in atto una spogliazione ed uno sfruttamento sistematici, improntati al più bestiale misconoscimento di ogni principio umano di carità o di giustizia. Cosa abbia significato per gli amerindi l’incontro con la “civiltà” europea lo dicono chiaramente le cifre. Nel volgere di un secolo una popolazione calcolata attorno ai venti milioni nella sola America Centrale, si riduce a circa un milione: e quella totale del continente, valutata sui quaranta milioni al momento dell’arrivo di Colombo, è ridotta alla fine del ‘500 a meno di dieci[1]. In questo sterminio hanno una gran parte le malattie, soprattutto quelle polmonari e il vaiolo, diffuse dai bianchi; ma senza dubbio la crudeltà, i massacri, le fatiche inumane imposte dai colonizzatoti rimangono il fattore principale. Nulla meglio della testimonianza di Bartolomeo de Las Casas, strenuo difensore della umanità degli Indios e del loro diritto alla libertà, può darci un’idea di ciò che avviene dopo la scoperta e nel corso della “civilizzazione”. Nella Brevisima relacion de la destruccion de las Indias troviamo descritte atrocità ai limiti del credibile. “I cristiani con cavalli e spade e lance cominciarono ad uccidere e usare indicibili crudeltà nei loro confronti. Entravano nelle terre, sventravano e squartavano senza risparmiare né ragazzi, né vecchi, né donne incinte, come se assaltassero degli agnelletti nelle loro mandrie. Scommettevano a chi con una coltellata fendeva un uomo in due, o gli tagliava lo testa di un colpo, o gli scopriva le viscere. Staccavano i neonati dalle poppe delle madri, prendendoli per i piedi, e li sfracellavano con la testa nelle rupi… I signori e la nobiltà li uccidevano normalmente in questo modo. Costruivano graticole di legno sostenute da forchette, e ve li legavano sopra, e sotto attizzavano un fuoco lento: onde poco a poco, gettando tra quei tormenti urla disperate, davano fuori l’anima […] queste cose e altre assai, che fanno fremere l’umanità, vidi io con questi occhi; ed ora ho appena il coraggio di raccontarle, desiderando io stesso non crederle, e supporre che sia stato un sogno”. Egli attacca violentemente anche gli encomenderos: “Finite le guerre, divisero tra loro gli uomini […] e così ripartiti li davano a ciascun cristiano col pretesto che dovesse ammaestrarli nelle fede cattolica: onde costoro, per lo più uomini ignoranti e crudeli, avidissimi e viziosi, eccoli divenire parrocchiani delle anime. La cura e il pensiero che ne ebbero fu di mandare gli uomini nelle miniere a estrarre oro, che è una fatica intollerabile: e le donne nelle capanne, per dissodare e coltivare il terreno, fatica da uomini molto forti e robusti. Non davano da mangiare né agli uni né alle altre, se non erbe e cose prive di sostanza […] È impossibile riferire le some di cui li caricavano, di tre o quattro arrobe, facendoli camminare cento o duecento leghe… sempre si servivano di loro come bestie da soma […] La tirannia che esercitano gli spagnoli contro gli indiani per cercare o pescare perle è una cose più riprovevoli e crudeli che siano al mondo. Non vi è sulla terra vita così infernale e disperata che possa paragonarsi a questa… li mettono in mare, tre, quattro, cinque braccia al fondo, dalla mattina al tramonto. Stanno sempre nuotando a cercare le ostriche. Vengono a galla con alcune reticelle piene di queste a respirare, e lì vi è un boia spagnolo in una barchetta, e se cercano di riposarsi li percuote coi pugni, e pigliandoli per i capelli li butta nell’acqua, perché tornino a pescare”. Las Casas mostra di avere una esatta percezione delle dimensioni dell’etnocidio, quando afferma: “Daremo per certo e reale che, nei detti quarant’anni, per le tirannie e le infernali sevizie dei cristiani sono morti ingiustamente e tirannicamente più di 12 milioni di persone, uomini, donne e bambini; ed io credo in verità, né penso di ingannarmi, che passino i quindici milioni”.
Le divergenze tra la madrepatria e i coloni sul trattamento da usare nei confronti degli indigeni risalgono già ai primi anni della conquista. I sovrani, Isabella in particolare, sono decisamente contrari all’idea dell’asservimento, caldeggiata tra gli altri da Colombo. A Nicolàs de Ovando, primo governatore inviato alle Indie spagnole, fanno pervenire più di un richiamo a non eccedere nella coercizione degli indigeni al lavoro e a retribuirli “pagando loro il salario giornaliero che sia da voi fissato: e ciò facciano e compiano come persone libere come sono, e non come servi”. L’Ovando risponde che l’unico mezzo per far fruttare le terre scoperte è proprio il lavoro coatto: i nativi, pigri e disordinati per indole, necessitano in ogni attività produttiva di una guida e di uno stimolo costante.
Una soluzione accettabile per entrambe le parti sembra essere rappresentata dall’encomienda, istituita nel 1503 nell’intento da parte dei sovrani di salvaguardare i diritti degli indigeni, senza venire a contrasto con i colonizzatori e senza rinunciare alle entrate che lo sfruttamento delle isole caraibiche prospetta. L’encomienda, come si è visto dalla testimonianza di Las Casas, si rivela una forma di schiavizzazione totale e tra le più disumane. Gli indios non “appartengono” all’encomendero, non costituiscono un suo bene o possesso, anche se costui li utilizza come tali: e ciò rende la loro situazione assai più penosa, perché neppure il senso della proprietà interviene in qualche modo a salvaguardarli. Essi sono sfruttati fino a che possono produrre, e quindi lasciati perire di stenti o di malattia; altri, bisognosi d’essere istruiti nella vera fede e “protetti”, li sostituiscono. Las Casas narra di un ufficiale cui furono affidati trecento indios, e nel giro di pochi mesi li ridusse a trenta; ottenuto un ulteriore affidamento, si ritrovò in breve tempo nella stessa situazione: e cosi continuò, dice il narratore, finché il diavolo se lo portò via.
Le prime voci ad alzarsi in difesa degli indios sono quelle dei missionari, in modo particolare quelle dei domenicani. Un religioso giunto da poco a Santo Domingo, Antonio da Montesinos, indignato per la barbarie di cui si trova ad essere spettatore, inizia nel 1511 a denunciare con violente predicazioni l’ipocrisia e la ferocia degli encomenderos. Ottiene al momento soltanto di venire in odio ai suoi vecchi compatrioti, che ne sollecitano l’allontanamento presso la corte e i superiori. Il germe di una diversa coscienza del problema indiano è comunque gettato. Tornato in patria, Montesinos si fa assertore intrepido all’interno del suo ordine e di fronte al consiglio della corona dei diritti degli indios e del rifiuto di qualsiasi forma di schiavitù; e non lotta invano, se nelle disposizioni date ai missionari domenicani è compreso da allora il rifiuto dell’assoluzione per gli encomenderos indegni. Più tiepidi al riguardo appaiono invece i francescani, che hanno nelle isole particolari concessioni e tendono a salvaguardarle sostenendo la necessità di una “tutela” ampia da esercitarsi sugli indigeni.
Nel 1514 inizia la battaglia di Las Casas. Già encomendero al seguito di Ovando, prende i voti in età matura, a 36 anni, e si trova a parteggiare, al momento dello scompiglio suscitato da Montesinos, per i coloni. Non tarda però a provare disgusto, toccato da quella predicazione, per il comportamento dei suoi compatrioti, e a rilevare Montesinos stesso nella difesa degli amerindi presso il consiglio delle Indie, fino ad ottenere il titolo di Protector de Los Indios.
In seguito alle sue sollecitazioni viene inviata ai Caraibi una commissione d’inchiesta, che constata la veridicità delle denunce, ma arriva a concludere che la soggezione degli indios, sia pure in forme mitigate, è indispensabile per la resa economica di quelle terre. Tutt’altro che domo, Las Casas si impegna allora a dimostrare concretamente il contrario. Ottenuta una concessione imperiale, nel 1520 impianta egli stesso una colonia mista di popolamento a Cumana, sulla costa del continente, fondandola sulla parità di diritti tra le due razze. L’esperimento non ha successo, soprattutto per la scarsa disponibilità alla convivenza egualitaria da parte dei bianchi; esso si risolve addirittura in un massacro, causato dalle provocazioni continue dei coloni, cui fa seguito un’immediata, crudelissima rappresaglia.
Neppure questo fallimento riesce tuttavia a far desistere Las Casas da quella che ormai considera la sua missione particolare. È un momento particolarmente difficile per la causa degli indios. Le remore morali che avevano in qualche modo condizionato il comportamento iniziale dei conquistatori, o lo avevano comunque fatto oggetto di riprovazione, sembrano venute meno. Dopo la morte di Isabella la corona si è mostrata scarsamente sollecita nella difesa della libertà degli indigeni. L’assuefazione all’idea di un loro legittimo asservimento induce un altro assioma, quello della loro inferiorità.
Nel 1524 il francescano Tomaso Ortis presenta al consiglio delle Indie una relazione molto esplicita in questo senso. Gli indios vengono in essa descritti nelle tinte più fosche: “[…] Mangiano carne umana e sono sodomiti più di qualunque altra popolazione… non provano né amore né vergogna, sono bestiali ed incostanti, incapaci di apprendimento e di correzione, traditori, crudeli, vendicativi, ostilissimi alla religione: sono stregoni, negromanti, indovini […]. Non hanno arte né abilità da uomini”. La loro resistenza alla predicazione e all’evangelizzazione è tra le colpe più gravi: “Quando si scordano delle cose della fede che hanno imparato, dicono che esse vanno bene per la Castiglia e non per loro, e che non vogliono mutare né costumi né dei”. Persino le costumanze estetiche sono interpretate come perversioni: “sono senza barba, e se gliene cresce un po’ se la tagliano”. Le accuse di cannibalismo e di sodomia sono le più ricorrenti nelle descrizioni “in negativo” delle popolazioni amerinde. La seconda è di prammatica, in tutto il corso della civiltà occidentale, nei confronti di qualsivoglia diversità o dissenso (soprattutto all’interno dei gruppi religiosi o politici). La presenza effettiva del cannibalismo, invece, pratica attribuita nel medioevo solo alle popolazioni leggendarie, colpisce profondamente l’immaginazione europea, che ingigantisce un fenomeno peraltro sporadico e di significato soprattutto rituale. Già nel 1511 un anonimo inglese dà questa descrizione degli indigeni: “… Non hanno re, né signore, né dio, possiedono tutto in comune e vanno coperti solo di piume, come bestie senza ragione vivono mangiandosi l’un l’altro e appendono le salme per affumicarle come noi la carne di maiale”; dove la mancanza di senso dell’autorità e della proprietà è associata, in un comune significato di depravazione, all’antropofagia.
Nel 1526 Gonzalo Fernandez de Oviedo dà alle stampe il suo Sumario de la natural Istoria de las Indias, nel quale vengono ribadite le tesi di Ortis, nel dichiarato intento di giustificare il comportamento degli encomenderos. Las Casas si sente vieppiù spronato nella sua opera di denuncia e di divulgazione delle atroci realtà della conquista. Continua a presentare memoriali al Consiglio delle Indie, e pubblica nel 1542 la Brevisima relaciòn, dalla quale abbiamo tratto i passi sopra riportati. Nel frattempo la chiesa si è espressa ufficialmente sul problema con la bolla Sublimis Deus, emanata da Paolo III nel 1537, nella quale si sancisce la piena umanità e razionalità degli indigeni, e conseguentemente il divieto di privarli della libertà. È una posizione che a molti riesce assai difficile accettare. Las Casas conduce una disputa quasi ventennale con Juan de Sepulveda, teorizzatore di un diritto delle nazioni “civili” a soggiogare quelle primitive, e a condurre quelle ultime alla civiltà “con qualsiasi mezzo”. Al tempo stesso, però, affianca all’impegno teorico l’azione concreta, svolta nelle terre in questione. Riesce a strappare a Carlo V, proprio con la relazione sulla distruzione delle popolazioni indigene, le Nueuas Leyes de Indias, con le quali viene abolito l’istituto dell’encomienda, lasciando in vigore solo le concessioni esistenti fino alla morte dell’affidatario. È un provvedimento un po’ tardivo per gli indigeni, ormai decimati: così come quello successivo delle Ordenanzas sobre discubrimiento del 1573; inoltre, nella realtà, la situazione muta ben poco.
Nell’ideale dibattito che lungo tutto il Cinquecento ha luogo intorno all’“umanità” degli indiani e al livello della loro civiltà, appaiono emblematici gli atteggiamenti di due tra i maggiori protagonisti della cultura dell’epoca: Montaigne e Shakespeare. Il primo ha una posizione nettamente anticolonialistica, fondata su premesse ben diverse da quelle missionarie di Las Casas. Non gli interessa che gli indiani siano in grado di abbracciare e di praticare la fede “superiore” come e più dei bianchi. La sua idea di umanità è talmente ampia da comprendere le manifestazioni più eterogenee del vivere umano, e da accettarle di per sé, senza rapportarle a paradigmi particolari di civiltà, nella fattispecie a quella europea. “Mi sembra che in quel popolo non vi sia nulla di barbaro e di selvaggio, a quanto me ne hanno riferito, se non che ognuno chiama barbarie quello che non è nei suoi usi: sembra infatti noi non abbiamo altro punto di riferimento per la verità e la ragione che l’esempio e l’idea delle opinioni e degli usi del paese in cui siamo. Ivi è sempre la perfetta religione, il perfetto governo, l’uso perfetto e compiuto di ogni cosa”. La sua amara riflessione sullo snaturamento e l’artificiosità dei rapporti umani lo spinge anzi a scorgere nello “stato di natura” degli amerindi un livello superiore di esistenza. “Quei popoli mi sembrano barbari in quanto sono stati in scarsa misura modellati dallo spirito umano, e sono ancora molto vicini alla loro semplicità originaria. Li governano sempre le leggi naturali, non ancora troppo imbastardite dalle nostre […]. Possiamo dunque ben chiamarli barbari, se li giudichiamo secondo le regole della ragione, ma non confrontiamoli con noi stessi, che li superiamo in ogni sorta di barbarie”. Smantella e ribalta persino le accuse che maggiormente si prestavano a suffragare l’imputazione di barbarie, come quella della pratica cannibalesca: “Non lo fanno, come si può pensare, per nutrirsene, ma per esprimere una superiore vendetta… Penso che ci sia più barbarie nel mangiare un uomo vivo che nel mangiarlo morto, nel lacerare con supplizi e martiri un corpo ancora sensibile, farlo arrostire poco a poco, farlo mordere e dilaniare dai cani e dai porci (come abbiamo non solo letto, ma visto recentemente […] e sotto il pretesto della pietà religiosa)”. Ed esprime il suo rammarico per uno stato di purezza e di tranquillità che nell’incontro con gli europei è andato irrimediabilmente perduto: “Temo molto che avremo assai affrettato il suo declino e la sua rovina col nostro contagio, e che gli avremo venduto a caro prezzo le nostre opinioni e le nostre arti […] Quanto a religione, osservanza delle leggi, bontà, liberalità, franchezza, ci è stato molto utile non averne quanto loro: essi si sono rovinati per tale superiorità e venduti e traditi da soli”.
Nel suo ultimo dramma, La Tempesta, Shakespeare ci offre una metafora ben diversa dei rapporti tra barbarie e civiltà. Se pure all’inizio sembra abbracciare tesi anticolonialistiche (“Se colonizzerò quest’isola, farò tutto al contrario… niente traffici, niente magistrature… né poveri, né ricchi, e tantomeno schiavi… nessuna legge né contratto… niente recinti, né lavoro, ecc…”), l’antitesi tra Calibano (anagramma di cannibale) e Prospero si rivela ben presto come lo scontro tra cultura, nella sua espressione superiore, ovvero europea, bianca, e natura, nel significato deteriore di animalità. Alcune affermazioni sembrano riecheggiare le relazioni di Tomaso Ortis, più ancora che le teorie di Sepulveda: “È un demonio, un demonio nato, sulla cui natura l’educazione non potrà mai fare presa”. C’è una componente nuova, nel disprezzo che i bianchi shakespeariani mostrano nei confronti di Calibano: è qualcosa che odora decisamente di razzismo: “[…] ma la tua bassa natura, per quanto imparassi, era tale che gli onesti non potevano sopportare di avvicinarla”. Shakespeare ha probabilmente letto il saggio di Montaigne: ma l’immagine che ha dell’uomo naturale è tutt’altro che edenica. Per lui l’essere umano è comunque soggetto alla corruzione e alla malvagità. Lo stato di natura è imperfetto, è una condizione subumana, che l’uomo civile deve correggere ed educare. Nel caso specifico poi Calibano, nero di origine africana, “a savage and deformed slave”, personifica la bruttezza, che si contrappone alla bellezza di Miranda, la malvagità bestiale opposta alla gentilezza e alla civiltà, e ciò spiega e legittima la sua condizione di schiavitù.
E tuttavia, anche dietro un ritratto così negativo spuntano alcune consapevolezze che rendono ambigua la posizione di Shakespeare. Calibano si rivela infatti violento e malvagio solo dopo aver subito prevaricazioni e provocazioni, mentre all’inizio appare gentile e ben disposto; il suo cambiamento è quindi anche frutto della corruzione portata dall’uomo civilizzato, la cui bassezza può essere persino peggiore della bestialità del selvaggio. Non tutti i bianchi sono come Prospero: anzi, la gran parte dei protagonisti de La Tempesta è di tutt’altro stampo. La malvagità è comune a entrambi i mondi.
La colpa di Calibano sta soprattutto nel desiderare la fanciulla bianca; e naturalmente, in quanto selvaggio e colorato, il suo desiderio non si esprime nella forma civile dell’“aspirare alla mano”, ma nella bestiale ignominia dello stupro. Dopo che per un secolo gli spagnoli, i portoghesi e da ultimo anche i francesi si sono prodigati a ripopolare il nuovo mondo di meticci, la prospettiva di una mescolanza razziale appare ora, a chi sta per soppiantarli nel dominio coloniale, abominevole. Calibano è in fondo la proiezione di tutte le paure che gli abitanti del vecchio mondo hanno nei confronti del nuovo, e degli stereotipi che inventano per esorcizzarle …
Questa visione anticipa dunque, e condensa, lo spirito nuovo del colonialismo, lascia trapelare una diversa inquietudine: “La tempesta è la formulazione di un giudizio, oltre che storia in forma mitologica; è l’Europa che giudica e rifiuta non solo l’indigeno americano, l’indiano, ma tutti gli americani bianchi futuri, che inevitabilmente si trasformano a immagine dell’indiano. E pure il rifiuto non è totale, in quanto quasi all’ultimo momento il portavoce della cultura europea riconosce che il nuovo uomo nato dalla potenza delle tenebre è in qualche modo derivato anche da lui” (Fielder).
Shakespeare non è nuovo a questa ambiguità. È la stessa che troviamo infatti nella vicenda di Otello, e prima ancora in quella di Shylock.
Nella storia del moro di Venezia il vero protagonista negativo è un bianco, un occidentale. Umanamente il povero Otello ispirerebbe piuttosto simpatia; è innamorato, ed è orgoglioso di essere amato da una donna bianca. Ma proprio qui è il discrimine: fin dove arriva l’amore, e dove invece l’orgoglio? Il tragico finale ci dice che è il secondo a prevalere, e questo in qualche modo avvalora il disagio, il sospetto vero che Shakespeare, attraverso Jago, ma non solo lui, insinua: più che l’amore qui sembra in gioco una rivalsa o un riscatto razziale. Non importa che Otello appaia più moderno e più aperto di tutti i suoi nemici (anche se poi, quando gli viene istillato il sospetto lascia libero corso alla sua natura primitiva). La sua colpa non è di aver commesso qualcosa, ma di essere quello che è. E proprio questo è significativo.
Allo stesso modo, ne Il mercante di Venezia Shylock risponde all’immagine demonizzante dell’ebreo già diffusa a partire dal Basso medioevo in tutta l’Europa, ma rafforzata in età controriformistica sia nei paesi cattolici che in quelli protestanti. E tuttavia, le parole che gli sono messe in bocca, alla fine del ‘500, non possono non lasciarci un sapore amaro in bocca, che guasta il “lieto” fine. “Sono un Ebreo. Non ha occhi un Ebreo? Non ha mani un Ebreo, organi, membra, sentimenti, affetti, passioni? Non si nutre con lo stesso cibo, si ferisce con le stesse armi, è soggetto alle stesse malattie, è curato con gli stessi metodi, non sente freddo d’inverno e caldo d’estate come un Cristiano? Se ci pungete non sanguiniamo? Se ci fate il solletico non ridiamo? Se ci avvelenate non moriamo? E se ci fate un torto non vogliamo vendetta? Se noi siamo come voi in tutto il resto, vi rassomiglieremo anche in questo”.
Buoni e cattivi selvaggi
Nel Settecento non si modifica solo l’immagine fisica che gli europei hanno del globo: cambia anche la percezione delle diverse culture che questo mondo dilatato lo abitano. Dopo lo sconcerto provocato dal primo impatto i popoli “nuovi” sono ora meglio conosciuti e cominciano ad essere inseriti in un quadro che non pretende di trovare corrispondenza letterale nella Bibbia e nella geo-antropologia tradizionale, mentre quelli “antichi” vengono spogliati di tutto il repertorio immaginifico che era loro associato nella classicità e nel medioevo. Una volta conclusa la prima fase della conquista, quella americana, viene anche meno la motivazione più strumentalmente immediata a “demonizzare” le popolazioni indigene, ad accampare la loro presunta barbarie per giustificare la propria. L’immagine che ne risulta è tuttavia mediata da una serie di nuovi filtri, attraverso i quali si attua una rielaborazione del diverso ad uso “interno”. In sostanza, mentre in precedenza la supposizione immaginaria o una conoscenza per la gran parte fantasiosa induceva a proiettare sugli “altri” le paure, le speranze o i rimpianti legati ad una tradizione mitologica o scritturale (e questo vale, come abbiamo visto, ancora per lo stesso Colombo), ora il termine di confronto è costituito dallo stato stesso della civiltà occidentale, con le sue istituzioni, la sua cultura, la sua storia, e gli “altri” fungono da pietra di paragone per esaltarne i pregi o denunciarne i difetti[2].
Su questa trasformazione influiscono quindi tanto le modalità pratiche, motivazionali e psicologiche dell’approccio (ciò che sta fuori non fa più paura – anche perché lo si affronta dall’alto di una superiorità tecnologica e militare – ma incuriosisce e, per i più svariati motivi, attira), quanto il progressivo affermarsi di una “razionalizzazione”, di una concezione convenzionalistica degli istituti sociali, politici e culturali (quella che va da Machiavelli a Hobbes e a Locke per la politica, che passa per la definizione dei “generi” nella letteratura e delle “buone maniere” nel costume quotidiano, che opera attraverso l’adozione di un metodo nella cultura scientifica[3], ecc.). Si è ora disposti a guardare con altri occhi alle culture altre perché non si suppone più un’origine divina dei modelli politici, sociali e culturali propri. Ciò non implica necessariamente una “valorizzazione” del diverso: dal confronto può anche scaturire un sentimento di superiorità, che da culturale tende velocemente a trasformarsi in “razziale”; oppure si può essere indotti a considerare quello in cui vivono gli altri popoli uno stadio più arretrato dello stesso cammino, riconoscendo a tutti una potenzialità di crescita ma avendo chiaro in mente dove questo cammino debba portare. Rimane comunque il fatto che anche in questi casi le differenze di livello vengono imputate alla natura degli uomini, al loro operato, al loro rapporto con le situazioni ambientali, e non alla volontà divina.
La concezione convenzionalistica si traduce pertanto in una considerazione degli altri, dei loro costumi, delle loro credenze e tradizioni, che prescinde da scale di valori precostituite. Solo fino ad un certo punto, però: perché il possibile esito (nella fattispecie, anche il più comune) è il prevalere di una lettura simbolica e strumentale delle diverse esperienze, chiamate in causa non per quello che sono ma per quello che, proprio attraverso il confronto, dicono della cultura occidentale. L’interesse degli europei si concentra infatti sugli elementi più immediatamente funzionali al dibattito politico-filosofico interno: ad esempio, sull’atteggiamento nei confronti della proprietà, che presso i popoli di più recente scoperta o non esiste o è intesa come possesso dei beni clanico o comunitario (il che riduce ad esempio a una normale pratica di scambio ciò che dagli europei è considerato un furto, o addirittura in qualche caso associa a questo comportamento un particolare prestigio); o sulla concezione dell’autorità, e di conseguenza di quella dei limiti e dei modi della libertà individuale; oppure sugli atteggiamenti relativi alla sfera del pudore e della sessualità (dai costumi prematrimoniali alla nudità, all’incesto, ecc…). Spesso queste differenze, vere o semplicemente enfatizzate che siano, vengono giocate a sostegno di una immagine di inferiorità e di barbarie (si pensi al mito del cannibalismo): ma più spesso ancora, e anche a partire da interpretazioni diametralmente opposte, offrono lo spunto per un ripensamento radicale sui fondamenti religiosi, morali e politici su cui si è sviluppata la cultura occidentale. La stessa “barbarie” è sempre meno intesa come la risultante di una degenerazione o di una deviazione dal modello umano originario, e viene letta piuttosto come una particolare condizione storica e sociale all’interno dell’unico percorso possibile verso il modello umano compiuto. Dall’idea del “barbaro” si passa a quella del “selvaggio”.
“Tanto è la gente amorevole, e senza avidità, e trattabile, e mansueta, ch’io giuro alle Altezze Vostre che nel mondo non v’è miglior gente, né miglior terra”. Nel corso del suo quarto viaggio Colombo si convince di essere approdato nel paradiso terrestre, e tenta di convincere anche i suoi finanziatori. Naturalmente è l’unico a crederci[4], perché i navigatori che nel frattempo ne hanno seguita la scia, Vespucci tra i primi, hanno capito subito di essere soltanto al cospetto di una terra e di una umanità diverse e ne hanno data notizia all’Europa. La polemica che si origina da questa coscienza e le motivazioni che la alimentano sono già state trattate in queste pagine: le conseguenze sul piano di una presunzione di superiorità non solo culturale ma biologica lo saranno più oltre. Ciò che preme ora ribadire è che alla fine, malgrado tutto, sarà l’immagine proposta da Colombo a prevalere: è sufficiente sostituire l’Eden con lo “stato di natura” e ci si accorge che il navigatore genovese ha in fondo fornito un modello interpretativo destinato ad una enorme fortuna.
Tuttavia, anche se di fatto è il primo “moderno” a parlare in positivo dei “selvaggi”, Colombo non lo fa nei termini propri della modernità, perché non è pronto a riconoscere agli “indiani” una loro originalità culturale[5]. Questo passaggio sarà reso possibile solo dal clima diffuso attorno alla metà del Cinquecento dal tardo Umanesimo, dalla visione laica del mondo e della storia che Erasmo e i suoi eredi oppongono tanto alla Riforma che alla Controriforma, ribaltando l’idea di un’umanità marchiata dal peccato originale e condizionata dal servo arbitrio. Pur considerandolo uno stadio primordiale quasi animalesco, e argomentando ciascuno in maniera diversa, Grozio e Hobbes prima, e poi Pufendorf e altri, fino a Locke e a Leibnitz, teorizzano uno “stato di natura” che suppone quest’ultima come un ordine autonomamente normato, nel quale l’umanità può svilupparsi al di fuori dei limiti sociali e culturali artificiosamente creati dalla “civilizzazione”. I costumi dei selvaggi ne sono appunto la testimonianza, e anche quando vengano interpretati come segni di inferiorità dimostrano comunque che le fedi e le culture dei popoli civilizzati sono frutto di un artificio, e le istituzioni e le leggi nascono da una convenzione.
In questo quadro teorico, e sulla scorta della documentazione fornita soprattutto dai missionari sul comportamento degli europei nei confronti di questi popoli, sugli eccidi e le nefandezze da essi compiuti, sulla sostanziale innocenza di pratiche volutamente interpretate in negativo al primo incontro, è naturale che nasca una riflessione intorno al senso e al destino della cultura occidentale. Lo ha già fatto con largo anticipo Tommaso Moro, traendone un giudizio tutt’altro che positivo: ma Moro, per quanto probabilmente suggestionato dalle notizie sull’incontro con i “selvaggi”, rimane nella sfera del vecchio mondo, al più spostando oltre l’oceano la localizzazione della sua Utopia. Ci ritorna invece con uno spirito nuovo, come abbiamo già visto, dopo la metà del Cinquecento, Montaigne.
Nel celebre “essai” Des Cannibales Montaigne non usa mai l’espressione “buon selvaggio”, che comincerà a circolare solo un secolo più tardi[6]. Le sue riflessioni si fondano soprattutto su l’Histoire d’un voyage fait en la terre du Brésil, autrement dite Amerique, di Jean de Lery (pubblicato nel 1568), resoconto entusiasta della vita degli indigeni del nuovo mondo, che sfronda tutta una serie di luoghi comuni assurdi e dà un’interpretazione in positivo della poligamia, della nudità, dell’assenza di senso della proprietà, arrivando a concludere che se esistono uomini felici, questi sono gli Americani. Montaigne attinge dunque ad una fonte laica, laddove per quasi tutto il suo secolo e quello successivo saranno soprattutto i religiosi, in primo luogo i Gesuiti, a difendere la causa dei popoli primitivi e a ribaltarne in positivo l’immagine. Questo probabilmente influisce sulle conclusioni che il filosofo ne trae, sull’assunzione di un atteggiamento scettico anziché giusnaturalistico. Non ha infatti la necessità di fare un uso polemico delle notizie cui si affida, perché non deve sostenere l’esistenza di alcuna base, naturale o religiosa, del diritto. Si limita a prendere atto della diversità e ad astenersi dal giudizio (sia pure mostrando simpatia per i “selvaggi”). Quella di Montaigne rimane comunque una posizione isolata, dettata dal buon senso e da una sensibilità che difetteranno, per un verso o per l’altro, ai suoi successori. Non è relativismo, ma la semplice coscienza del fatto che ogni cultura ha una storia propria, e che importante è conoscere e capire questa storia, piuttosto che fare confronti tra realtà per molti aspetti e per ragioni naturali e storiche incommensurabili.
Un contemporaneo di Montaigne, Giovanni Botero, scrive: “[…] danno nome di barbari a quei popoli i cui costumi si dilungano dalla ragione e dalla vita comune. Definizione che, se fosse vera, il nome de’ Barbari converrebbe più a’ Greci e a’ Latini che al resto delle genti: perché se vita comune si deve dire quella che mena la più parte delli huomini e Barbari quelli che se ne allontanano, essendo che i Greci e i Latini vivono differentemente da altri e sono meno degli altri, a loro converrebbe il nome di Barbari”[7]. In pratica risponde con largo anticipo a Grozio, il quale qualche decennio dopo sosterrà che “[…] il diritto naturale è quello che viene ritenuto tale presso tutto i popoli, o tutti quelli con costumi più avanzati. Un effetto universale postula una causa universale […]”[8], e definirà barbari coloro che non seguono la retta ragione e la comune consuetudine degli uomini.
L’argomentazione di Botero è fatta propria a metà Seicento anche da Hobbes: “Non di rado accade che tutti i popoli appaiano perfettamente d’accordo nel tenere comportamenti che quegli scrittori (i giusnaturalisti) ritengono essere contrari alla legge naturale”[9]. Il criterio non può quindi essere quello del consensus omnium, ma quello per cui la legge naturale è il “dettame della giusta ragione”. E in base a questo, ad esempio, è possibile negare la naturalità del patriarcato, o quella della proprietà privata: allo stato di natura, come dimostrano proprio i costumi dei “popoli selvaggi dell’America”, queste istituzioni non esistono. A prescindere dal fatto che per Hobbes lo stato di natura è comunque tutt’altro che edenico[10], affermare che a dispetto dell’esistenza di diversità culturali inoppugnabili e irriducibili esiste un parametro, e questo parametro non è né il consenso universale né quello dei popoli più civilizzati, è un passo fondamentale. Significa muoversi già su un altro binario, quello che attraverso Pufendorf condurrà poi a Leibnitz[11] e all’illuminismo francese.
Al di là comunque delle sfumature, sia pure tutt’altro che trascurabili, ciò che importa è che tanto Montaigne quanto Grozio e Hobbes affermano l’autonomia dell’essenza umana. Ed è questo a fare la differenza rispetto alla concezione pre-moderna. Di qui innanzi, quale che sia il giudizio che di questa essenza si verrà a dare, il dibattito ruoterà attorno all’idea di una “umanità” che esiste anche al netto della civilizzazione, oltre che della rivelazione. Naturalmente, il passaggio è graduale. Nel corso del Seicento il dibattito si svolge ancora, come abbiamo visto, a tre voci: c’è quella dei conquistatori, che procede attraverso l’uso sistematico della connotazione in negativo (i selvaggi non hanno dio, non hanno leggi morali, non indossano abiti, non conoscono la proprietà, non lavorano, non sono monogami, ecc…) ad alzare lo steccato, a sancire la barbarie e a giustificare l’asservimento; c’è quella dei missionari, quando non si accordi e non diventi strumentale alla prima, che mitiga la contrapposizione, perché pur ammettendo i difetti e l’inferiorità culturale degli indigeni riconosce loro anche una buona disposizione e una certa potenzialità di miglioramento, o meglio di “redenzione”, e rivendica l’innocenza dei loro costumi; e c’è infine quella dei “libertini”, che si innesta su un filone ideologico di polemica antispagnola in nazioni come l’Olanda, la Francia e l’Inghilterra, e sostiene la naturalezza di questi costumi, capovolgendo il non privativo in un senza dal significato liberatorio[12] e travalicando quel sistema di valori all’interno del quale l’innocenza ancora si pone.
Nel Settecento il confronto in qualche modo si semplifica. Ormai l’idea dell’esistenza di uno “stato di natura” è acquisita, viene costantemente suffragata da una conoscenza delle culture dei selvaggi scientificamente fondata su un approccio etno-antropologico, ed è divulgata dalla letteratura diaristica, dalle relazioni di viaggio e dalle illustrazioni sempre più realistiche e dettagliate che le accompagnano. Su questa base lo “stato di natura” può essere poi letto, a seconda dei casi, secondo il paradigma del “buon selvaggio” o in chiave negativa. Le scuole di pensiero tendono naturalmente a connotarsi nell’una o nell’altra direzione in ragione delle scelte coloniali delle diverse nazioni, per cui laddove i nativi sono considerati degli interlocutori, nel quadro ad esempio di una politica di alleanze o di scambi commerciali, verranno individuati gli aspetti positivi delle loro culture, mentre dove li si vede come un ostacolo nella prospettiva di un insediamento territoriale, o al più come una risorsa da sfruttare in forma schiavistica, se ne sottolineeranno soprattutto l’arretratezza e la disumanità. È così che il dibattito assume coloriture molto diverse in Francia, in Spagna o in Inghilterra[13]. La semplificazione è comunque legata anche al fatto che, una volta uscito dal chiuso dei salotti libertini o delle relazioni dei gesuiti, il dibattito si allarga ora a coinvolgere un’opinione pubblica ben più vasta, e nel farlo rinuncia sempre più alle argomentazioni sottilmente teologiche o filosofiche per dare spazio alle componenti emozionali o spettacolari. L’immagine dei “selvaggi” che circola nel Settecento è piuttosto quella diffusa dal barone di Lahontan o da De Foe, e più tardi da Bernardin de Saint-Pierre o da Bougainville, che non quella dei giusnaturalisti o degli illuministi.
Se vogliamo in qualche modo datare un inizio del “nuovo corso” possiamo farlo risalire al 1683, quando padre Louis Hennepin, un “recollet” belga già aggregato alla spedizione di La Salle, pubblica la Description de la Louisiane nouvellement decouverte au sud-ouest de la Nouvelle France. Mescolando realtà, fantasia e millanterie il francescano descrive una natura incontaminata e fertile (è il primo occidentale a vedere, o perlomeno a descrivere, le cascate del Niagara), racconta di avventure mirabolanti e di grandi passioni, presenta “selvaggi” che parlano con un’arte oratoria degna di Cicerone e conservano intatta la capacità di un alto e nobile sentire. Hennepin conosce in effetti la vita indiana, per essere stato catturato dai Sioux ed avere vissuto con loro, come prigioniero, per qualche mese (afferma addirittura di essere stato adottato da un capo indiano): ma il valore documentario della sua opera è alquanto discutibile. Indubbio è invece l’effetto: il suo racconto, oltre a ravvivare l’interesse per l’America degli ambienti politici e commerciali francesi, fino a quel momento piuttosto tiepido, accende l’entusiasmo di molti giovani assetati di avventura.
Tra costoro c’è il barone Louis Armand de Lahontan, personaggio decisamente controverso e intrigante, che nel 1683, a soli diciassette anni, si arruola nell’esercito e viene spedito in Canada, dove si trova a vivere l’epopea dell’esplorazione della zona dei grandi laghi e delle guerre tra la nazione urone e quella irochese. Lahontan rimane nella nascente colonia per dieci anni, durante i quali impara perfettamente le lingue algonchine e condivide per lunghi periodi la vita e i costumi delle popolazioni indiane. Alla fine, per contrasti nati con il governatore, diserta e rientra in Europa. Naturalmente non può tornare in Francia (anzi, fornisce esortazioni e suggerimenti al governo inglese su come subentrare ai francesi), e pubblica in Olanda nel 1703 i Nouveaux voyages de M. le baron de La Hontan dans l’Amérique septentrionale, cronaca della sua vita canadese, seguiti dai Mémoires de l’Amérique septentrionale, osservazioni sulla geografia e sulle istituzioni delle tribù indigene, nonché da un Supplément aux Voyages, ou Dialogues curieux entre l’auteur et un sauvage de bon sens qui a voyagé, in cui esalta la vita primitiva attaccando violentemente il cristianesimo e la civiltà europea. Nei suoi scritti racconta le peregrinazioni lungo l’alto corso del Mississippi e la scoperta di altro fiume, la “rivière longue”, probabilmente il Missouri, la sua permanenza per più anni nei villaggi algonchini, gli scontri con gli inglesi e con le tribù avversarie. È un racconto vivace ed incalzante, che appassiona i lettori e divulga un’immagine nuova e diversa del selvaggio americano. Nel Supplemento, in particolare, attraverso il dialogo tra lo stesso Lahontan e un capo urone di nome Adario, viene esaltata la condizione di assoluta libertà e serenità dei popoli nativi. L’idealizzazione dello “stato naturale” è mirata soprattutto a mettere sotto accusa le complicazioni e le restrizioni comportate da una civiltà europea avvelenata dalla religione, dalle leggi e dalla proprietà privata[14]. I “selvaggi” non hanno bisogno di giudici, e quindi di prigioni, perché non conoscono la proprietà e nemmeno l’uso del denaro; non hanno bisogno di preti, perché la loro religione è semplice e la loro vita è esente dai vizi tipici degli europei; non hanno bisogno di capi, di funzionari e di burocrazie perché sono liberi e completamente padroni dei loro corpi, e non conoscono discriminazioni tra ricchi e poveri.
Alla stessa immagine perviene, partendo da esperienze e motivazioni decisamente differenti, Anthony Cooper, terzo conte di Shaftesbury, in un saggio sulle “Caratteristiche di uomini, costumi, opinioni, tempi” pubblicato nel 1711. Shaftesbury non ha mai visto un selvaggio, ma non ne fa un problema: ciò che gli preme è trovare argomenti contro la dottrina del peccato originale. Gli indiani raccontati da Lahontan e da Hennepin gliene offrono a iosa: dimostrano che lo stadio “naturale” è assolutamente positivo e che fino a quando non vengono guastati da una civiltà piena di vizi, di ingiustizie e di corruzione gli uomini sono essenzialmente buoni. In un universo che è armonico e ordinato sono necessariamente tali anche le leggi che governano la sfera morale, e il bene comune si accorda pienamente con quello individuale. Non c’è conflitto tra egoismo e altruismo, dal momento che quando l’individuo opera “scelte razionali” queste tengono conto dell’interesse comune, e il singolo persegue il bene universale mentre realizza il proprio. Shaftesbury parte dal principio che “se in una creatura o in una specie v’è qualche cosa di naturale, è ciò che contribuisce alla conservazione della specie stessa e determina il suo benessere e la sua prosperità”. Pertanto, al contrario di ciò che afferma Hobbes, l’uomo è spontaneamente incline alla società con gli altri uomini, poiché l’istinto sociale è insito nella sua stessa disposizione naturale. “Se devi cercare un modello etico”, consiglia dunque al suo lettore “cercalo nella semplicità dei modi e nel comportamento innocente che era spesso proprio dei puri selvaggi, prima che essi fossero corrotti dai nostri commerci”[15]. Shaftesbury va quindi oltre la posizione libertina, che era soprattutto indirizzata ad una contrapposizione ideologica. Non rifiuta la civiltà cristiana, ma la civiltà tout court. E in questo senso va oltre non solo le posizioni di Hobbes, ma quelle dello stesso Montaigne.
Le avventure di Lahontan esercitano un enorme influsso su un’opinione pubblica che cresce con la diffusione della lettura, cosi come le idee di Shaftesbury lo hanno su tutta la filosofia settecentesca: ma questo vale più sul continente che oltremanica. In Inghilterra lo sguardo sui nativi americani rimane in verità piuttosto disincantato. Colpisce in negativo la loro povertà istituzionale e l’assenza di tecnologia. Il modello del pensiero inglese è perfettamente riassunto dal Robinson Crusoe (1719) di Daniel Defoe. Duecento anni dopo l’isola di Utopia, protagonista è un’altra isola, nella quale però il collettivismo lascia il posto all’individualismo. I selvaggi possono essere buoni, come Venerdì, quando sono disposti a fungere in pratica da schiavi (il fatto stesso che Robinson gli imponga un nome, come fa Adamo con tutte le cose dopo la creazione, invece di chiedergli se ne ha uno, è una chiara presa di possesso), o cattivi, come i cannibali che frequentano l’isola per i loro macabri banchetti, che vanno quindi combattuti e possibilmente sterminati. L’idea di avere qualcosa da imparare da loro non passa a Robinson nemmeno per il capo.
D’altro canto, sia pure con esiti più sfumati, ma adottando comunque un angolo visuale non molto dissimile, il tema del selvaggio americano era già stato trattato da Locke nel secondo dei Due trattati sul Governo (1690). Locke va al sodo. “Mi chiedo se nelle foreste vergini o negli immensi spazi incolti dell’America, abbandonati alla natura senza alcuna bonifica, alcun dissodamento o coltivazione, un migliaio di acri forniranno ai poveri e disgraziati indigeni altrettante comodità di vita quante ne forniscono dieci acri di terra ugualmente fertile nel Devonshire, dove son ben coltivati […]” Poveri e disgraziati: altro che vita beata nella natura. Verrebbe da chiedere a chi i dieci acri fornissero le comodità di vita, stanti le condizioni in cui versavano i contadini inglesi ai primi del Settecento: ma Locke non sta a sottilizzare: “in mancanza dell’incremento apportato dal lavoro, non hanno nemmeno la centesima parte delle comodità di cui godiamo noi”. Il lavoro, la proprietà, il denaro, prima ancora che lo sviluppo delle tecnologie, che era stato uno degli argomenti a favore della superiorità occidentale nel Seicento, costituiscono per Locke il discrimine tra uno stato naturale di miseria ed uno civile di benessere. Da notare che Locke è un sostenitore dello “stato di natura”[16], e che in un altro capitolo dello stesso trattato utilizza in funzione polemica antilegittimista il tema della concordia interna ai gruppi tribali e dell’assenza di dinastie monarchiche, dal momento che i selvaggi eleggono i loro governanti[17], e conferiscono loro poteri limitati ai periodi di belligeranza: “I Re degli indiani sono poco più che generali delle loro armate. Pur avendo un comando assoluto in guerra, tuttavia negli affari interni e in tempo di pace essi esercitano un potere assai esiguo […]”. Ma se la naturale condizione umana non è per Locke la guerra di tutti contro tutti, e ogni uomo ha in sé una naturale predisposizione alla giustizia e alla pace, è solo nello stato di diritto, o stato sociale, che le regole impresse dalla natura nel suo cuore trovano la piena e concorde attuazione. Gli uomini sono stati creati per vivere in società, e non in solitudine.
In Francia e sul continente il filone letterario-filosofico del “buon selvaggio” trova un terreno più consono, ed è declinato nelle sue più diverse sfumature. Il padre gesuita Joseph François Lafitau (scopritore tra l’altro delle virtù del ginseng canadese e considerato uno dei fondatori dell’antropologia) nel 1724 pubblica Moeurs des Suavagés ameriquains, comparées au moeurs des premiers temps. In questo caso l’esperienza è maturata sul campo, con uno studio approfondito delle popolazioni irochesi, ma è fortemente mediata da una intenzione ideologica (Lafitau sostiene il monogenetismo, e di conseguenza il diffusionismo culturale). Nei riti e nelle credenze dei popoli primitivi ritrova la spiegazione dei riti e delle credenze di quelli classici, tanto da arrivare ad affermare che gli indiani americani sono i diretti discendenti dei Lacedemoni, arrivati nel nuovo continente dopo aver attraversato tutta l’Asia e superato lo stretto di Bering. Anche se non crede ad una assoluta eguaglianza degli spiriti (cosa che invece credeva Fontenelle[18]), Lafitau vede la condizione dei “selvaggi” come uno stadio significativo della storia dell’umanità (in linea peraltro con quanto afferma quasi contemporaneamente Giovan Battista Vico nei Principi di una Scienza Nuova, del 1725). Quindi uno stadio primitivo, nel quale sopravvivono però le qualità fondamentali di coraggio, schiettezza e lealtà proprie degli antichi eroi della classicità.
Ludovico Antonio Muratori, dal canto suo, propone nel 1743, con il Cristianesimo felice de’ padri della Compagnia di Gesù nel Paraguai, una storia delle riduzioni gesuitiche compilata in funzione apologetica dell’operato della Compagnia, proprio nel pieno della tempesta che porterà di lì a qualche anno alla sua soppressione. In questo caso lo “stato di natura” è per Muratori quello che rende possibile la riaffermazione della “vera chiesa”, che consente di veder riapparire “lo spirito dei primi cristiani”, nei quali “abita l’umiltà” che la cristianità europea ha dimenticato. Gli intenti possono apparire diametralmente opposti a quelli di Shaftesbury, ma il presupposto è in fondo lo stesso.
Nelle Lettere irochesi (1752) di Jean Henry Maubert de Gouvest, un ex gesuita dal dente avvelenato, l’irochese Igli è un invece un pretesto in puro stile libertino per mettere alla berlina la religione cristiana, e in generale tutte le fedi, ma anche la cultura formalistica e storicistica degli europei: a questa il “selvaggio” contrappone il suo gusto per la vita e per la natura. Lo stesso spirito informa L’ingénu di Voltaire (1767), dove si raccontano le malinconiche vicende di un indigeno americano schietto e innocente, catturato dagli inglesi, finito a vivere in Francia, convertito al cristianesimo e alle maniere civili, solo per trovarsi a constatare quanto immorale e falsa sia la società evoluta. Voltaire ha peraltro già affrontato il tema dei “selvaggi” nell’Essai sur les moeurs, dove li cita a modello, ma anche in questo caso solo per parlare male dei civilizzati[19]. (Salvo poi darne, come vedremo, un giudizio completamente opposto in un’altra occasione).
Persino Benjamin Franklin, rappresentante di una nazione che nasce sulla negazione agli indiani del diritto alla propria terra e alla propria cultura, che li ha combattuti prima e arriverà poi quasi a sterminarli, prende posizione in loro favore nei Remarks concerning the savages of North America (1784). “Selvaggi li chiamiamo noi – scrive – perché le loro maniere sono diverse dalle nostre, e noi pensiamo di aver raggiunto la perfezione della Civiltà: ma essi pensano la stessa cosa di se stessi”. Franklin rivolge questo scritto, nel quale non manca peraltro di fare le punte a certe esagerazioni e ai luoghi comuni del mito, ai coloni suoi connazionali. «Non dovete essere così sicuri che il vostro stile di vita sia l’unico modo di vivere dignitosamente. Gli indiani sono brave persone, con una forte fede. Il fatto che non sia la stessa fede che praticate voi non significa che non sia “buona”. Dovete anzi sforzarvi di essere più simili a loro, in quanto sono persone ospitali». Troverà un uditorio alquanto distratto.
In Europa invece il mito del “buon selvaggio” conosce un’ulteriore definitiva consacrazione presso il grande pubblico (anche quello femminile, che non legge le relazioni di viaggio o i pamphlets polemici) quasi a fine secolo, nel romanzo Paul et Virginie di Bernardin de Saint Pierre (1787). In realtà, qui i selvaggi c’entrano poco, dal momento che i protagonisti sono figli della cultura europea che hanno la ventura di crescere in mezzo all’oceano indiano, in un’isola che pare modellata su quella degli utopiani, dove gli abitanti vivono e lavorano in perfetta armonia, collaborazione ed eguaglianza, e che dovrebbe rappresentare le condizioni esistenti allo “stato di natura”. Ma ci sono tutti gli ingredienti per toccare i cuori ed appagare la voglia di esotismo da cartolina che una nuova forma di sensibilità va diffondendo: una storia d’amore tra adolescenti, lo sfondo di un ambiente da sogno, lontano dalle convenzioni sociali e dalla corruzione della civiltà, il tragico epilogo. Di illuministico c’è solo la formazione dell’autore: per il resto, con Paul et Virginie siamo già in atmosfera preromantica, in una concezione sentimentale della vita e spiritualistica della natura[20]. I passi successivi saranno Les Natchez di Chateaubriand (ma siamo già nel 1801), dove l’idillio scocca tra un europeo e una “selvaggia” figlia della natura, e l’Ultimo dei Mohicani, dove le parti addirittura si rovesciano.
Nel frattempo, però, continua ad essere mostrata anche l’altra faccia della medaglia, quella del “cattivo selvaggio”. Non si tratta necessariamente di rivangare la crudeltà e la brutalità che imperano allo stato primitivo, rappresentazione che anima ad esempio in Inghilterra un acceso dibattito durante la guerra dei sette anni sull’utilizzo di alleati indiani[21]. Anche senza far ricorso ai cannibali o ai sacrifici umani ci si richiama ad una valutazione realistica delle miserabili condizioni, rapportate ai parametri europei, in cui vivono le popolazioni americane: sono condizioni che non sembrano lasciare alcuno spazio a quelle prospettive di costante miglioramento che l’illuminismo pone a significato ultimo dell’uomo.
Il giovane ecclesiastico olandese Cornelius de Pauw pubblica nel 1768 le Recherches philosophiques sur les Américains, un poderoso studio sulla natura delle Americhe e sui loro abitanti. De Pauw ribalta completamente la prospettiva. Sottolinea il ritardo economico, tecnologico e culturale dei selvaggi, e lo spiega da un lato con la natura troppo rigogliosa del continente, che consente di sopravvivere senza impegnarsi molto, dall’altro con la “pusillanimità innata” dei suoi abitanti, la “constitution de la vie sauvage”. In sostanza, la fortuna di un popolo è vivere su una terra che non dia nulla senza la contropartita di uno sforzo, perché induce a produrre più del necessario. Questo è verificabile peraltro anche nei comportamenti dei conquistatori europei: i coloni inglesi stanno “risanando” l’ambiente naturale americano con il loro lavoro, e stanno cercando di trasmettere il loro spirito operoso anche agli aborigeni, mentre quelli spagnoli e portoghesi si sono lasciati ammorbare dall’ambiente e contagiare dalla pigrizia degli indigeni. Come spesso accade, le posizioni più conservatrici o reazionarie si rivelano poi le più lungimiranti. Du Pauw ignora volutamente tutta la letteratura “positiva” delle relazioni gesuitiche e dei pamphlets libertini, ma preconizza un futuro radioso per l’America, sia sul piano economico che su quello culturale, anche se lo pospone di almeno tre secoli (forse per dare il tempo agli aborigeni di estinguersi e agli inglesi di dissodare)[22]. Se si prescinde delle tesi razziste, il suo è in realtà un ritratto dell’America alla metà del Settecento molto più veridico di quelli che circolano nel milieu libertino: ed è anche rimarcabile il fatto che in conclusione l’autore si auguri che non si ripeta in altri continenti quello che è accaduto nel nuovo, dove gli Europei hanno fatto una strage orrenda degli abitanti originari: se non sappiamo far altro che peggiorare la loro situazione, scrive De Pauw, lasciamoli almeno vivere in pace nella loro miseria[23]. Che è già qualcosa di meglio della pretesa di “civilizzarli”, e di più realistico di quella di farne dei modelli.
Uno schivo e misconosciuto frequentatore del gruppo degli enciclopedisti, Nicolas Antoine Boulanger, fa piazza pulita di tutta la mitologia sull’Eden primordiale ne L’Antiquité dévoilée par ses usages, pubblicata nel 1766. Boulanger è un pensatore fuori dal coro, particolarmente ecclettico, precursore di Wittfoghel ma anche di Alfred Wegener, lo scopritore della deriva dei continenti. Parte dall’analisi delle religioni, dei riti e dei miti antichi, ripercorre le fasi dell’imporsi di un dispotismo teocratico originario, fondato sulla paura e sulla debolezza della ragione, e disegna un percorso evolutivo dell’uomo sociale. L’intento è quello di arrivare a smascherare ogni forma di dispotismo politico, che a suo parere altro non è che una teocrazia laica, nella quale le ritualità religiose sono semplicemente sostituite da un cerimoniale politico altrettanto artificioso. Il cammino verso la libertà, intrapreso solo dall’uomo occidentale, perché gli orientali continuano ad essere sottomessi a dispotismi di vario genere, è insieme un percorso sociale e individuale di liberazione dalla natura originaria, tutt’altro che innocente e fiera, di progressiva emancipazione dalle paure e dalla superstizione.
Boulanger non costituisce un’anomalia: testimonia il fatto che nell’ambiente illuminista la naturale bontà dei “selvaggi” e le meraviglie dello stato di natura non sono dei dogmi, ma piuttosto dei pretesti per il dibattito sui modi e sugli esiti del processo di “civilizzazione”. Anche i maggiori esponenti del movimento, primo tra tutti Voltaire, nutrono più di un dubbio. D’Holbach stesso (che peraltro è l’editore delle opere di Boulanger) riporta raccapriccianti episodi delle guerre indiane riferitigli dal barone di Dieskau (quello rappresentato in celebre quadro di Benjamin West mentre sta per essere scalpato da un irochese e viene salvato in extremis dal generale Johnson). Tanto il quadro che il racconto sottolineano il contrasto tra il senso dell’onore e il rispetto dell’avversario degli europei e la vile ferocia dei selvaggi (il barone Dieskau è ferito e indifeso)[24].
La fase americana della guerra dei Sette Anni, combattuta al di fuori di ogni regola militare e di ogni convenzione morale, smorza alquanto gli entusiasmi dei fautori dello stato di natura. Nel frattempo, però, si apre un orizzonte alternativo. Vengono pubblicate in rapida successione le relazioni sui viaggi d’esplorazione nelle terre australi di Byron, di Wallis, di Carteret, di Bougainville e di James Cook, tutti compiuti nel volgere di una manciata di anni, che rivelano l’esistenza di una cultura edenica conservatasi intatta, lontano dalla civiltà e dalla cristianizzazione[25]. Lo specchio nel quale riflettersi non sono più gli indiani americani, ma gli indigeni polinesiani.
I “selvaggi” dei Mari del Sud non sono feroci come gli irochesi né apatici come gli indios sudamericani. Sono allegri, spontanei, ospitali. Non conducono una vita stentata e miserabile[26]. Al momento di ripartire, dopo aver scoperto Tahiti e avervi soggiornato per qualche tempo, Wallis non riesce a trattenere la commozione[27]. Sin dal primo impatto Bougainville è affascinato dalla loro fisicità, gli uomini robusti e tatuati, le donne aggraziate e sensuali: “Le piroghe erano piene di donne che, per l’aspetto gradevole non apparivano di certo inferiori alla maggior parte delle europee, e con queste avrebbero potuto gareggiare con vantaggio”. Il paesaggio stesso suggerisce dolcezza, facilità e felicità del vivere: “Io stesso ho passeggiato diverse volte all’interno dell’isola. Mi credevo trasportato nei giardini dell’Eden[28]”. Ma mentre passeggia nell’Eden lo sta già profanando. Nel corso della prima spedizione Cook scrive nel suo diario: “Stiamo corrompendo la loro integrità morale, già di per sé portata al vizio, e diffondiamo tra loro bisogni e forse anche malanni prima sconosciuti per loro e che servono solo a turbare la tranquilla felicità di cui essi e i loro progenitori hanno sinora goduto”. È trascorso solo un anno dalla partenza di Bougainville.
Il tema del degrado della condizione indigena, della corruzione degli animi e dei costumi indotta dal contatto con gli europei, ricorre nei resoconti di tutti i viaggiatori dell’ultima parte del Settecento e di tutto il secolo successivo. Lo ritroviamo in Georg Forster, che partecipa alla seconda spedizione di Cook, e poi in Humboldt, in Darwin e in Wallace. Costituirà in effetti il leit-motiv di tutta la letteratura etnografica otto-novecentesca, fino a Levi-Strauss e oltre. Riflessioni di questo genere non erano certo mancate anche nei secoli precedenti, rispetto alle civiltà e alle culture americane: ma sono decisamente rafforzate dall’incontro con le popolazioni dei mari del Sud. I motivi, come abbiamo visto, sono essenzialmente due: da un lato la situazione incontrata dai primissimi scopritori, che presenta davvero tutti i requisiti per far pensare all’Eden[29], dall’altro la rapidità con la quale questa situazione si degrada. Tra il racconto di Bougainville e quello di Forster intercorrono dieci anni, e dalla meraviglia si è già passati al rimpianto[30]. È ora di iniziare a tirare qualche somma.
Guillaume Raynal, altro gesuita tornato allo stato laicale, pubblica nel 1770 l’Histoire philosophique et politique des établissements des Européens dans les deux Indes. Nel decennio successivo ne verranno edite altre due successive versioni, ampliate fino a raddoppiarne l’estensione e a conferirle un respiro immenso. Alla fine l’opera viene a costituire quella che può essere considerata la prima storia della globalizzazione, ripercorsa ed interpretata da ogni angolo visuale e con uno sguardo che pone problemi ancora oggi di stretta attualità. L’Hisoire costituisce in effetti il pendant storico dell’Encyclopédie: non a caso dietro ad entrambe c’è il genio di Denis Diderot, non soltanto ispiratore ma materiale estensore e responsabile delle parti più significative. Non si tratta solo della redazione di un bilancio: l’opera è un vero, appassionato manifesto di denuncia di un modello di civilizzazione ferocemente imperialista, che ha esportato in tutto il mondo il dispotismo, le diseguaglianze sociali, l’assenza di libertà e i costumi corrotti tipici della società europea.
Diderot ha una sua particolare posizione sullo “stato di natura”. Pur essendo un apostolo della scienza e più ancora delle sue applicazioni pratiche, delle tecnologie, nelle quali vede lo strumento per un continuo progresso, nel Supplément au voyage de Bougainville, pubblicato nel 1772, sembra non sottrarsi al mito del buon selvaggio. “Noi siamo innocenti, noi siamo felici; e tu non puoi che nuocere alla nostra felicità. Noi seguiamo il puro istinto della natura; e tu hai cercato di cancellarne il carattere dalle nostre anime. Qui tutto appartiene ad ognuno; e tu ci hai insegnato non so quale distinzione tra il tuo e il mio. Noi siamo liberi; ed ecco che tu hai sotterrato nella nostra terra il simbolo della nostra schiavitù futura”. Chi parla in questo modo è un vecchio tahitiano, che descrive a Bougainville gli effetti prodotti tra la sua gente dall’arrivo degli Europei.
Il vecchio risponde a distanza di ottant’anni ai giudizi di Locke: “Noi possediamo tutto ciò che ci è necessario, tutto ciò che è bene per noi. Siamo forse degni di disprezzo per non aver saputo crearci bisogni superflui? Quando abbiamo fame, noi abbiamo di che sfamarci; quando abbiamo freddo, noi abbiamo di che vestirci […] Ricerca fin dove vuoi quelle che tu chiami comodità della vita; ma consenti a esseri forniti di buon senso di arrestarsi quando essi potranno ottenere soltanto, dalla continuazione dei loro sforzi penosi, dei beni immaginari”. La risposta in verità vale anche per il Bougainville reale, che a giustificazione della partenza per il suo giro attorno al mondo aveva scritto: “Si troverà nei mari del sud una sorgente inesauribile di esportazione per i prodotti francesi, a vantaggio delle popolazioni immense che li abitano e che, nell’ignoranza in cui vivono, apprezzeranno infinitamente ciò che la nostra cultura ha reso così comune e ha ridotto da noi a così vil prezzo. Di lì trarremo i beni che la natura offre laggiù”[31].
Il portavoce di Diderot mette persino in questione la superiorità razionale degli europei: “Lasciaci i nostri costumi; essi sono più saggi e più onesti dei tuoi: non vogliamo scambiare ciò che tu definisci la nostra ignoranza con i tuoi lumi inutili”. La conclusione è perfettamente in linea con quelle di Lahontan e di Shaftesbury, e in parte, come vedremo, anche con quelle di Rousseau: “Esisteva un tempo un uomo naturale; all’interno di quest’uomo si è introdotto un uomo artificiale, e nella caverna si è accesa una guerra continua che dura per tutta la vita. Talvolta l’uomo naturale è piú forte, talvolta è invece sconfitto dall’uomo morale e artificiale. […]
Ma allora, si deve civilizzare l’uomo, oppure abbandonarlo al suo istinto? Se si deve rispondere francamente, dirò che dovete civilizzarlo, se avete intenzione di diventarne il tiranno: avvelenatelo quanto piú potete di una morale contraria alla natura; frapponetegli ostacoli di ogni specie; impedite i suoi movimenti in mille modi; ispirategli fantasmi che lo spaventino; perpetuate la guerra nella caverna, di modo che l’uomo naturale sia sempre incatenato ai piedi dell’uomo artificiale. Se invece lo volete felice e libero, non intervenite nelle sue faccende: già troppi incidenti imprevisti lo condurranno alla luce e alla disperazione; e restate pur sempre convinti che non è a vostro profitto, ma per proprio vantaggio, che alcuni saggi legislatori vi hanno costruiti e conformati così come siete”.
Mezzo secolo dopo sembra di sentir ripetere il discorso di Adario a Lahontan. Ma non è la stessa cosa. In mezzo ci sono una militanza illuminista eclettica e perennemente curiosa, fatta di profonde e sincere amicizie e di rispetto intellettuale per le opinioni altrui, i rapporti con il sensismo materialistico di Condillac e D’Holbach, la conoscenza del pensiero di Shaftesbury, del quale Diderot ha tradotto le opere principali e adottate le idee di tolleranza: c’è, soprattutto, una rara capacità di mettere in discussione i propri convincimenti, di fronte alle realtà e alle situazioni che le nuove conoscenze fanno intravvedere. Diderot non pensa affatto che l’uomo debba abbandonarsi ai suoi istinti o lasciarsi determinare dalle forze naturali. La libertà dell’individuo sta per lui proprio nella capacità di dominare gli uni e le altre, o quantomeno di sottrarsi al loro condizionamento, e quindi alla superstizione e ai pregiudizi, attraverso la conoscenza tanto dei fenomeni naturali che della storia umana. È ben lontano dall’idea di uno stato naturale edenico. Ma ci sono degli aspetti del racconto di Bougainville che lo hanno profondamente colpito. Il primo è la sensualità spontanea e innocente dei tahitiani (“La ragazza lasciò cadere negligentemente una stoffa che la copriva e apparve agli occhi di tutti nello stesso modo in cui Venere apparve al pastore frigio”, scriveva Bougainville), che al contatto con gli europei si è degrada immediatamente a lussuria. Diderot fa dire al vecchio: “Le nostre figlie e le nostre donne sono comuni; tu hai condiviso con noi questo privilegio, e hai acceso in esse furori sconosciuti. Esse sono diventate folli nelle tue braccia, e tu sei diventato feroce tra le loro. Esse hanno cominciato a odiarsi; voi vi siete battuti per esse, e ci sono ritornate macchiate del vostro sangue”. La prima lotta per la liberazione dalle paure e dai tabù concerne per Diderot proprio la sfera del corpo (coerentemente col suo sensismo): conoscerlo e viverlo appieno significa riprenderne possesso, dopo l’espropriazione operata per tanti secoli tanto dalla chiesa quanto dai poteri civili.
Il secondo aspetto concerne i rapporti sociali e il loro legame con il regime economico, l’assenza di sperequazioni tra ricchi e poveri. Bougainville aveva scritto: “È probabile che i tahitiani pratichino fra loro una lealtà che non conosce incrinature. Siano essi in casa o no, giorno o notte, le case sono aperte. Ciascuno coglie i frutti nel primo albero che incontra, o ne prende nella casa in cui entra. Parrebbe che, per le cose assolutamente necessarie alla vita, non esista il diritto di proprietà, e tutto appartenga a tutti”. E infatti il vecchio accusa: “Qui tutto appartiene ad ognuno; e tu ci hai insegnato non so quale distinzione tra il tuo e il mio”. Il paradiso perduto, insomma, non è tanto quello esotico dei mari del Sud, ma quello domestico di un’Europa dove la “civilizzazione” ha coinciso con un progressivo asservimento: “Richiamiamoci a tutte le istituzioni politiche, civili e religiose: esaminatele profondamente – e, se non mi inganno, vi vedrete la specie umana piegata di secolo in secolo sotto il giogo che un ristretto numero di imbroglioni si proponeva di imporle. Diffidate di colui che vuol mettere ordine”.
Di questo asservimento mascherato dai vuoti rituali politici e religiosi e dall’ipocrisia delle buone maniere, messo ora a nudo attraverso la brutalità con la quale si è espanso a tutto il globo, l’Histoire di Raynal e Diderot offre una radiografia cruda e indignata. È una lettura delle forme del potere e del nascente imperialismo che lascerà il segno, anche se a prevalere nell’immediato parrà piuttosto la lezione di Rousseau.
Paradossalmente, tra i pensatori illuministi Rousseau è quello meno vicino al mito del buon selvaggio. Mentre il modello giusnaturalista dava dello stato di natura un’interpretazione “realistica”, collocandolo in un periodo storico o in uno stadio particolare del processo di incivilimento, Rousseau lo assume invece come categoria teorica[32]. Con lui lo “stato di natura” diventa in maniera esplicita un criterio di giudizio per sviluppare la critica del presente e condannare le ingiustizie e le disuguaglianze indotte dalla civiltà. Pur essendo un avido lettore di resoconti di viaggio non è particolarmente entusiasta dei costumi delle popolazioni amerindiane (e nemmeno appare commosso dal loro sciagurato destino)[33]. I dati etnografici gli servono soltanto a elaborare il paradigma di una ideale “sauvagerie”. Il selvaggio da lui ipotizzato non è né buono né cattivo, vive in una sorta di limbo di innocenza. Nel Discorso sulle scienze dice: “I selvaggi non sono precisamente cattivi, per-ché non sanno cosa sia essere buoni; poiché non è l’accrescimento dei lumi né il freno della legge, ma la calma delle passioni e l’ignoranza del vizio che impedisce loro di fare il male”. Adeguando esattamente i loro bisogni alle risorse di cui dispongono non necessitano di sviluppare le arti e le tecniche o di creare istituzioni sociali. Allo stadio naturale l’uomo torna ad apparire a Rousseau come un essere “senza”, senza occupazione, senza linguaggio, senza domicilio, senza guerra e senza legami[34]. È evidente che non sta pensando agli Uroni o agli indios amazzonici, ed anche che non auspica un ritorno allo stato “selvatico”.
L’“uomo naturale” possiede in potenza due strumenti fondamentali per uscire da questo torpore: il libero arbitrio e la capacità di perfezionarsi. Stimolato da fattori esterni, ambientali, l’uomo ha utilizzato questi strumenti, ma in maniera sbagliata: ha iniziato a costruirsi una famiglia, ha inventato la metallurgia e l’agricoltura, le quali a loro volta hanno indotto il senso della proprietà e le disuguaglianze, e di conseguenza lo Stato, per difenderle e perpetuarle. L’uscita dallo stato primitivo ha coinciso quindi con il passaggio dall’uguaglianza primitiva alla disuguaglianza propria della società progredita: in questo senso la storia non è che una “deviazione”. Per certi versi l’uomo civile è superiore all’uomo primitivo: ma si tratta di recuperare la bontà e la felicità che furono propri di quest’ultimo, e lo si può fare solo con una diversa educazione, che lo lasci liberamente sviluppare secondo natura.
I buoni selvaggi sono quindi per Rousseau piuttosto i montanari svizzeri (peraltro già portati ad esempio anche da Locke) che gli americani. La prossimità alla natura consiste per lui nella fedeltà a una vita semplice e operosa, rispettosa delle antiche tradizioni di libertà: quella in definitiva che può essere riscontrata, senza tanti esotismi, nella repubblica ginevrina. Non sono tanto i modi della vita, quanto i sentimenti naturali, la contrapposizione ai costumi corrotti degli stati assolutistici, a determinare il grado di libertà.
L’incontro settecentesco con la diversità non riguarda però solo i “selvaggi”. Sono “diverse” anche quelle culture con le quali esiste un’antica consuetudine, ma che vengono ora riscoperte sull’onda di un espansionismo economico (e presto politico e militare) che ingenera necessariamente anche una curiosità culturale. L’immagine dell’Oriente era rimasta per secoli quella trasmessa da Marco Polo e dagli altri viaggiatori nel XIII e XIV secolo, mediata prima dai rapporti con Bisanzio e poi da quelli intrattenuti soprattutto da Venezia con il mondo ottomano, e per suo tramite con la cultura arabo-mussulmana: una mescolanza di mistero, di favola, di crudeltà e di vita intensa dei sensi. Ancora agli inizi del Seicento la letteratura (si pensi al Tasso o a Marino) insiste su questa immagine fortemente sensuale, ripresa e rafforzata negli scritti degli esploratori e dei viaggiatori, che sottolineano sempre gli aspetti “scandalosi” o semplicemente disinvolti della sessualità nelle popolazioni extra-europee: l’idea dei mondi nuovi come luoghi della libidine e dell’eros si riverbera anche su quelli antichi.
La penetrazione dei portoghesi prima e di olandesi, britannici e francesi poi nell’estremo oriente fa conoscere però anche altre realtà: e sono soprattutto i missionari gesuiti affluiti in Cina e in India a strappare il sipario del favoloso e a raccontare agli stupefatti occidentali di società ordinate, laboriose e civili quanto e forse più quella europea. Verso la fine del XVII secolo le relazioni di Matteo Ricci e dei suoi confratelli, le opere di Athanasius Kirkner, insieme all’importazione delle sete, delle ceramiche e del segreto della porcellana, creano una vera e propria mania per le cineserie, ma anche una forte curiosità intellettuale per i costumi di un popolo che sembra aver elaborato leggi perfette, che utilizza amministratori reclutati per concorso ed ha elaborato un sapere filosofico di altissimo livello. La Cina influenza per quasi un secolo il gusto europeo non solo in ambito letterario (Il mandarino meraviglioso di Carlo Gozzi), ma nell’architettura, nell’arredo, nella costruzione dei giardini, sposandosi felicemente con il rococò. Dopo la metà del Settecento, invece, in concomitanza con il tentativo di colonizzazione francese dell’India e la guerra anglo francese che ne consegue, l’interesse si sposta e la sinomania lascia il posto allo studio dei costumi e della religione indiana, aprendo tra l’altro un nuovo fondamentale capitolo negli studi linguistici.
Anche l’oriente arabo conosce un forte ritorno di interesse a partire dai primi anni del sec. XVIII, ma in una direzione diversa. L’edizione francese de Le mille e una notte, del 1704, nella traduzione di Antoine Galland, avvalora l’immagine di luoghi magici e favolosi e incontra un’enorme fortuna tanto in Francia quanto in Inghilterra, dando l’avvio alla moda letteraria del racconto o della fiaba ambientati in un Oriente che è tutto una caverna di Aladino. Gli stereotipi di questa forma di esotismo sono quelli perfettamente riassunti nel Vathek (1786) di William Beckford (autore anche di pregevoli libri di viaggio), dove la magia, e addirittura il demoniaco, si mescolano con l’erotismo, la violenza, la crudeltà, i saperi misteriosi e ogni altro ingrediente capace di solleticare i sensi e la fantasia, piuttosto che la razionalità. Ma la speziatura orientale viene utilizzata, con finalità diverse, anche in altri contesti: per aggiungere sapore al racconto galante (il Sophà di Crébillon fils) o per travestire sotto spoglie esotiche la critica dei costumi e della società occidentali.
Un’utilizzazione satirica dell’esotismo era già stata fatta da Montaigne, che aveva raccontato gli stupori e le perplessità di due cannibali capitati a Rouen. Alla fine del Seicento Giovanni Paolo Marana ne “L’esploratore turco nelle corti dei principi cristiani” (che i francesi traducono “L’espion turc”) fa giudicare gli Europei da un preteso viaggiatore orientale e lancia un nuovo modo di far satira, che di lì a poco conoscerà il suo capolavoro con le Lettres Persanes (1721) di Montesquieu.
Nell’opera di Montesquieu le Lettres stanno a L’Esprit des Lois come in quello di Diderot il Supplément sta all’Histoire. Sono una dichiarazione d’intenti, alla quale seguirà lo studio approfondito dei costumi civili e politici. Montesquieu non può essere iscritto tra i fautori dello stato di natura, anche se nell’opera maggiore indica le società primitive come modelli di virtù e di saggezza[35]. Le culture cui fa riferimento in questo caso sono piuttosto quelle remote nel tempo che quelle lontane geograficamente e, come avviene per Rousseau, la società che lo interessa non è quella naturale, ma quella civile. Non rifiuta lo Stato, ma vuole che sia legittimato dall’equilibrio dei poteri: e non sono certo gli uroni o gli irochesi a potergli fornire dei modelli convincenti. Nemmeno i persiani, a dire il vero: ma questi perlomeno gli offrono lo spunto per criticare le manie, i pregiudizi e gli abusi della civiltà moderna da un pulpito reso credibile da millenni di storia. I suoi due orientali non sono né naturali né ingenui, ma hanno quello sguardo lucido e disincantato che consente di cogliere da “fuori” tutto ciò che risulta oggettivamente ridicolo e assurdo.
I persiani non sono lì per caso. Nel corso della seconda metà del XVII secolo diversi francesi, tra cui Jean Baptiste Tavernier e Jean Chardin, soggiornano a lungo in Persia, attratti soprattutto dal commercio delle pietre preziose, tanto ricercate dalla corte del re sole. Da Versailles vengono inviate anche ambascerie ufficiali, e sono ricambiate. Gli usi e i costumi del paese vengono conosciuti con ricchezza di dettagli, naturalmente anche con qualche esagerazione, e suscitano una impressione positiva, che verrà rafforzata dopo la pubblicazione de Le mille e una notte. La moda persiana è però destinata a tramontare presto. Ad un certo punto, nel secolo successivo, l’influenza francese sulla corte persiana diverrà fastidiosa per la Compagnia inglese delle Indie Orientali, che si mobiliterà per subentrare. I francesi si ritireranno in buon ordine, ma solo per lasciare spazio al nuovo competitore che si affaccia nello scacchiere dell’Asia centrale: la Russia.
Schiavitù, diversità, razza
L’attenzione a modelli di civiltà e di cultura diversa, l’assunzione ad esemplarità di uno stato naturale edenico o l’ipotesi di un possibile progresso culturale coinvolgono i popoli asiatici e gli indigeni americani o polinesiani, ma non i neri africani.
Il parametro del giudizio rimane nei viaggiatori del Sei e del Settecento la prossimità al modello bianco. Bougaiville, dopo aver decantato le delizie della “Nuova Citera” e le virtù dei suoi abitanti arrischia il complimento più grande: “Nulla distingue i loro tratti da quelli degli Europei; e se fossero vestiti, se vivessero meno all’aria aperta e in pieno sole, sarebbero bianchi come noi”. Più avanti conclude: “Per il resto abbiamo osservato, nel corso di questo viaggio, che in generale gli uomini con la pelle nera sono molto più cattivi di coloro il cui colore è vicino al bianco”.
Dumont d’Urville descrive così gli abitanti della nuova Zelanda: “I Maori sono di un colore bruno, un po’ più scuro di quello degli spagnoli. Sono molto alti: i loro lineamenti sono generalmente regolari e piacevoli a vedersi. L’influenza del clima più freddo avvicina la loro fisionomia a quella degli europei; il naso aquilino, lo sguardo pensieroso, la fronte rugosa, manifestano un carattere più virile, dalle passioni più durature, una attività più perseverante. […] I Manga-Manga sono invece più piccoli e più robusti; il loro colore è assai scuro; hanno capelli e barba assai crespi e occhi piccoli… i lineamenti del viso poco espressivi”. Lo stesso vale per gli abitanti delle Fiji: “Il colore della loro pelle è poco scuro, soprattutto tra i capi, e questo fatto dà a molti di loro una somiglianza ancor più marcata con gli europei delle contrade meridionali. Ci sono anche individui che alla taglia più bella, al portamento più nobile, alle forme più perfette uniscono i tratti più delicati e un colore quasi bianco o semplicemente abbronzato”.
Quando si vuole sottolineare in positivo l’umanità e la possibilità di integrazione degli indigeni si ricorre alle sfumature: “Sono di alta statura, ben fatti e proporzionati…il loro colore è bronzino, ma piuttosto chiaro” (John Byron)” oppure si abbinano i caratteri fisici all’industriosità e alle capacità tecniche: “Questi indiani sono di color bronzino […] hanno dei bei e lunghi capelli neri […] i loro lineamenti sono di mediocre statura, ma straordinariamente agili, vigorosi e attivi” che si accompagna a “le loro piroghe sono ben lavorate e con molta destrezza” (Carteret).
Il colore bronzino, possibilmente tendente al chiaro, sembra costituire per gli scopritori dei paradisi del Pacifico il limite ultimo tollerabile nella scala cromatica dell’umanità. Oltre c’è il nero, o il tendente al nero, c’è la diversità assoluta, anziché la differenza. Un’istintiva antipatia e contrapposizione verso tutto ciò che è scuro ha da sempre caratterizzato la cultura e il gusto occidentale, portando ad associare simbolicamente il bianco con ciò che è puro e buono e il nero con ciò che è malvagio ed ha a che fare con la morte o con le tenebre. Ma in questo caso all’istinto[36] si sovrappone un convincimento culturale di recentemente acquisito. Questi viaggiatori, e gli scienziati e i filosofi che ne leggono e ne commentano le relazioni, sono figli di Linneo e del nuovo atteggiamento “scientifico”: hanno indossato gli occhiali di un pregiudizio che non è più fondato su contrapposizioni religiose o etniche, ma su una sistematizzazione delle conoscenze in termini di “razionalità” e “scientificità”. Magari senza averne alcuna coscienza, sono portatori di un germe che si svilupperà proprio in seno alla cultura illuministica della tolleranza etnica e religiosa e dell’universalismo. Il razzismo è dunque un virus nuovo, generato, coltivato e diffuso proprio dalla “modernità”.
“Il concetto delle differenze razziali basate sulla ereditarietà e sulla biologia si sviluppò soltanto tra popoli che da secoli si erano liberati del servaggio e della schiavitù, ma che mantenevano essi stessi degli schiavi. È importante notare che, fino a quando il commercio degli schiavi fu considerato cosa lecita e nessuna voce si alzò contro di esso, gli schiavi, per quanto trattati come bestie, furono sempre ritenuti esseri umani, sotto ogni aspetto, salvo quello dello status sociale” (Montagu).
In effetti, prima del diffondersi della tratta africana la civiltà occidentale non ha mai postulato nessi di fondo tra schiavitù e diversità etnica. È vero che già Aristotele, nella Politica, giustificava l’esistenza della schiavitù affermando che “[…] per natura, alcuni esseri comandano, altri obbediscono, ai fini della reciproca sicurezza […]” e che “[…] colui che è abile soltanto ad eseguire con la fatica del corpo è inferiore, e naturalmente schiavo”: ma le sue argomentazioni non fanno riferimento a caratteri biologici specifici, quanto piuttosto ad una attitudine spirituale, che non ha legami di sorta con i tratti morfologici. È solo il concetto della “superiorità” culturale diffuso nel mondo greco, portato alle estreme conseguenze attraverso la razionalizzazione. Da quel mondo arriva piuttosto, per voce del suo più famoso viaggiatore, la testimonianza di un criterio estetico non etnocentrico che farà difetto ai moderni. Parlando degli Etiopi Erodoto infatti dice: “Vi si trovano gli uomini più alti, più belli e più longevi”. Un atteggiamento altrettanto aperto, e più moderno ancora, troviamo nella cultura romana. Nel De Legibus Cicerone afferma che “gli uomini, diversi quanto a sapere, sono però tutti uguali nella loro attitudine al sapere: non c’è nessuna razza (genus) che guidata dalla ragione non possa raggiungere la virtù”[37]. Ha qualche dubbio, in verità, nei confronti degli ebrei, ma il dato di fondo è l’assenza di qualsiasi discriminazione pregiudiziale. Certo, possiamo trovare altrettanti riscontri di un atteggiamento opposto, in Plinio il Vecchio[38], ad esempio, in Pomponio Mela, in Strabone e in Tacito[39], ma anche questi autori non arrivano mai a mettere in discussione l’unicità di quel genus.
Le cose non cambiano in epoca cristiana. San Paolo sancisce l’unità di tutti i popoli in Cristo[40]. È vero che Agostino, prendendo spunto proprio da Plinio, si pone il problema di una comune discendenza di tutti i popoli della Terra da un solo progenitore, soprattutto di quelli “mostruosi che abitano i confini del mondo”; ma lo risolve con una professione di fede monogenetica[41] e soprattutto, quantunque “africano bianco”, non accenna minimamente ad un problema specifico posto dalla “negritudine”.
La presunzione di una superiorità “latina” e poi “cristiana” rimane certamente viva, e si accentua, in età medioevale: si alimenta però sempre di contrapposizioni culturali o religiose (è il caso degli ebrei) e sottolinea le differenze etniche soltanto in funzione di queste ultime. Si arriva al più a dare credito alle favole su esseri intermedi, su uomini con la coda ed altre straordinarie ibridazioni, confinando comunque queste presenze ai limiti del mondo, in una dimensione che non comporta problemi di valutazione biologica.
Non solo. Nel Medio Evo si può addirittura rintracciare un certo apprezzamento per i “mori”, al contrario di quanto avviene nei confronti degli ebrei. Un primo motivo è verosimilmente legato al fatto che i neri sono comunque lontani, non costituiscono una presenza tangibile e inquietante, mentre gli ebrei sono presenti e pongono quotidianamente con la loro presenza il problema della diversità. Ma esistono anche altre ragioni plausibili. L’ultima delle svariate localizzazioni del mito del prete Gianni, ad esempio, colloca in Africa, nella regione etiope, il favoloso regno dal quale dovrà arrivare soccorso contro gli islamici. E probabilmente si lega a questo mito la comparsa di un nero tra i magi rappresentati nelle Natività. Una condizione di parità sembra vigere persino nel repertorio dei santi, che vede un san Maurizio bianco nelle prime versioni e poi improvvisamente e definitivamente nero, e un san Gregorio il Moro venerato addirittura in Germania. Non viene neppure negata l’appartenenza alla nobiltà ai mulatti generati da nobili con schiave nere e riconosciuti dal genitore (è il caso di Alessandro “il Moro”, della famiglia dei Medici), o a ex schiavi nordafricani adottati da famiglie nobiliari (Leone Africano, anch’egli accolto nella grande famiglia medicea). Solo nella penisola iberica la presenza islamica e il suo retaggio portano precocemente all’associazione tra pelle nera e schiavitù; ciò che spiega peraltro la naturalezza e la disinvoltura con la quale i portoghesi sin dai primi impatti con l’Africa subsahariana hanno dato avvio alla tratta.
Delineare il percorso che dai primi approdi portoghesi nel golfo di Guinea conduce al razzismo “scientifico” del secondo Ottocento è tutt’altro che semplice, soprattutto in un lavoro di sintesi. È sufficiente ad esempio dare un’occhiata alla sterminata produzione storiografica sul razzismo per rendersi conto che la scelta stessa di retrodatare o di posticipare l’apparizione di sintomi evidenti del fenomeno, o di restringere o allargare i criteri per una sua definizione, ne modifica radicalmente la chiave di lettura. Ho scelto pertanto, per praticità e chiarezza, di distinguere nei limiti del possibile e trattare in successione le due angolazioni dalle quali il tema può essere affrontato, quella dello schiavismo moderno e della sua giustificazione e quella conseguente e parallela del razzismo. In parte queste tematiche sono già state sviluppate, almeno per quanto concerne i risvolti pratici, parlando della tratta. In quanto aspetti di uno stesso fenomeno naturalmente si fondono e si incrociano, ma a partire da un certo punto percorrono anche vie autonome. Lo dimostra il fatto stesso che la cessazione della tratta non ha implicato automaticamente la fine dello schiavismo, e che l’abolizione di quest’ultimo non ha affatto coinciso con una ritirata del razzismo (semmai, è avvenuto il contrario).
Stante quello che si è a più riprese affermato nelle pagine precedenti, e cioè che la xenofobia e l’etnocentrismo hanno caratterizzato da sempre, in ogni tempo e cultura, la storia dell’umanità, ma né nell’antichità né nel medioevo e né in Europa né in Oriente hanno mai assunto una vera connotazione “razziale”, resta da capire da quando può essere significativamente documentata la comparsa di quest’ultima tendenza. Credo che la metà del XV secolo possa rappresentare un plausibile spartiacque, per la concomitanza di una serie di eventi che a vario titolo risultano connessi alla nostra direzione d’indagine. Intanto, la caduta di Costantinopoli cambia la percezione della presenza ottomana e del pericolo che rappresenta per l’intera Europa, inducendo la ricerca di rotte commerciali alternative (e quindi aprendo l’epoca delle grandi scoperte geografiche) ma anche una contrapposizione frontale che si alimenta di reciproche demonizzazioni.
Dal lato opposto del Mediterraneo, la “normalizzazione” e la sete di rivincita che seguono la cacciata definitiva degli Arabi dalla Spagna portano ad elaborare, proprio a partire dalla metà del secolo, gli statuti della purezza del sangue (limpieza de sangre). Gli statuti in realtà non fanno che tradurre in uno strumento giuridico codificato dei provvedimenti e un modo di sentire diffuso che erano nati già dieci secoli prima, rivolti specificamente contro gli Ebrei[42]. Ora però tali provvedimenti vengono allargati ai moriscos. Si tratta di una discriminazione su base religiosa, almeno negli intenti: ma diventa invece, visto il clima di sospetto che continuerà a gravare sui conversos, ebrei o arabi che siano, lo strumento per indurre una concezione “ereditaria” della differenza. Per esseri che portano dentro il gene del male non c’è conversione che tenga. Pertanto, una volta “ripulita” la penisola iberica, tutte le immagini negative associate nei secoli precedenti ai moriscos e agli ebrei, soprattutto ai neoconvertiti, verranno in automatico proiettate sugli indigeni americani e sugli schiavi africani.
Negli stessi anni in cui vengono emanati i primi statuti fa la sua comparsa la tratta, e a suo supporto prende avvio il processo di de-umanizzazione dei neri. Gomes Eanes de Zurara sostiene, nella seconda metà del XV secolo, che “i neri sono i discendenti di Cam, la cui razza era destinata a restar sottomessa a tutte le razze del mondo, come afferma Giuseppe nelle ‘Antichità Ebraiche’ […]” Sta facendo appello ad una argomentazione che discendente da una lettura impropria della Bibbia, e che fatta propria dalla cultura islamica è divenuta presto funzionale alla pratica schiavistica diffusa nel mondo arabo: gli abitanti dell’Africana sub-sahariana sono appunto considerati dai musulmani i discendenti di Cam, maledetti e condannati alla schiavitù perpetua.
Sembra non mancare nulla: statuti di purezza del sangue, giustificazione della schiavitù per appartenenza etnica. Tutto parrebbe avere inizio prima ancora della scoperta dei nuovi mondi. In realtà sarà quest’ultima a portare le argomentazioni decisive per la svolta verso il razzismo “moderno”.
Lo strappo è costituito, alla fine dello stesso secolo, dall’incontro con i nativi americani. Il confronto con i “selvaggi” del nuovo mondo non dà luogo ad una vera e propria concezione “razzista”, ma sono proprio questi popoli a mettere in moto quel diverso meccanismo di approccio che ne indurrà i presupposti teorici. Il problema di fondo che essi pongono è quello dell’origine, per la quale non c’è riscontro nella narrazione biblica (a meno di volerli considerare, come qualcuno in effetti subito fa, i discendenti di una delle tribù disperse di Israele). Ci si chiede quindi se si tratti o meno di discendenti di Adamo, e le possibili risposte hanno le implicazioni più diverse, relative al peccato originale, alla possibilità di ricevere il battesimo, ecc…
Il dibattito non rimane comunque circoscritto nei termini dell’esegesi biblica, anche se fino alla metà del XVII secolo il confronto più serrato e significativo si svolgerà proprio su questo piano. L’isolamento plurimillenario induce a pensare che questi popoli non abbiano un’origine comune con quelli da sempre conosciuti, e non basta la bolla papale Sublimis Deus, del 1537, emanata per scongiurare la riduzione degli indigeni in schiavitù[43], a restituire loro la parentela diretta con gli “umani”. Anzi, il pronunciamento ufficiale della Chiesa accelera probabilmente la comparsa e l’affermazione delle teorie poligenetiche, non fosse altro per un automatica presa di distanza da parte del mondo protestante.
Le prime ipotesi in questa direzione cominciano infatti ad essere formulate proprio da posizioni ereticali, come nel caso di Giordano Bruno e di Paracelso. Per quest’ultimo la diversa origine è già sinonimo di inferiorità: gli indigeni sono privi di anima, in quanto creati non da Dio, ma dagli influssi di una particolare congiuntura astrale. Non è un’argomentazione particolarmente pregnante, ma sottintende la possibilità che altre forze, oltre la volontà divina, possano agire o aver agito nella definizione del quadro della vita. Sarà sufficiente sostituire la natura, come agente autonormativo, agli influssi degli astri per entrare nella nuova mentalità scientifica.
Nell’ambito dell’ortodossia prevale invece naturalmente la teoria monogenetica, sostenuta soprattutto dai gesuiti; anticipando di secoli le conclusioni della genetica delle popolazioni essi sostengono per quanto concerne i nativi americani l’ipotesi di una migrazione dall’Asia, anzi, di una serie di migrazioni, che spiegherebbero i differenti livelli di civiltà cui i vari popoli sono pervenuti.
La controversia sull’origine degli indiani si svolge comunque su un terreno nel quale hanno gioco fattori e interessi i più svariati. Lo stesso Colombo passa dal primo entusiasmo ai dubbi appena incontra, già al secondo viaggio, delle resistenze[44]. I conquistadores e gli encomenderos devono giustificare il trattamento inumano riservato agli indigeni. I libertini, nel secolo successivo, usano l’argomento per confutare la narrazione biblica, mentre i gesuiti sostengono l’opinione contraria per giustificare i loro esperimenti di cristianizzazione totale. Altri, come ad esempio il mercante-navigatore George Best, incaricato di redigere il resoconto ufficiale della spedizione di Frobisher, rifiutano la comune discendenza perché questa avvalora l’idea che le differenze fisiche tra gli esseri umani siano da attribuirsi esclusivamente al clima e all’ambiente, idea che può scoraggiare gli europei dal cambiare continente o emisfero. Nella prospettiva di avviare progetti di colonizzazione in tutte le aree del globo, comprese le zone torride o glaciali, è invece necessario fugare nei potenziali coloni ogni timore di una possibile “degenerazione” morfologica, a partire dalla pigmentazione della pelle, affermando che i caratteri sono stati fissati da Dio una volta per tutte e citando a sostegno la solita maledizione di Cam.
Tutto sommato, comunque, la gran parte delle valutazioni espresse sul carattere e sui costumi di questi popoli sono positive, e arrivando quasi sempre da missionari fanno riferimento in particolare alla permeabilità religiosa: le stesse valutazioni verranno poi paradossalmente riprese ed utilizzate nella direzione opposta, della libertà di pensiero e della naturalità dei costumi, dalla cultura libertina. Nell’un caso e nell’altro l’origine comune non è messa in discussione. Meno frequenti sono invece le descrizioni totalmente negative, anche perché le popolazioni americane vengono viste ancora come un insieme unico, nel quale spiccano alcune civiltà che hanno raggiunto un alto livello organizzativo. Non si rende quindi necessario ricorrere a teorie esplicative della differenza culturale e somatica tra i vari popoli della terra su basi biologiche.
Quanto ai neri, il problema si pone in altri termini. Con la loro diversità gli europei hanno convissuto per millenni; non costituisce una sorpresa, non ha mai creato eccessivi interrogativi. Ne hanno dato spiegazioni naturalistiche già gli autori classici, da Erodoto[45] a Plinio, svariando dagli effetti del clima a quelli dell’alimentazione, senza trascurare peraltro anche ipotesi degenerative, ma mai accampando un’origine separata.
L’incontro con le popolazioni della costa subsahariana proietta però la negritudine in una prospettiva nuova, in termini sia economici che psicologici. Il quasi contemporaneo contatto con gli indigeni brasiliani sembra intanto confutare ogni ipotesi di pigmentazione legata al clima e all’ambiente. Sotto il sole dei tropici vivono sulle due sponde dell’oceano uomini dal colore, dai tratti, dalle corporature e dai costumi completamente diversi, difficilmente rapportabili ad un genitore comune. Gli stessi europei, anche dopo lunghe permanenze nelle zone equatoriali, mantengono sotto una momentanea arrossatura il colorito chiaro. Gli africani condividono poi il territorio con specie antropomorfe che suggeriscono una scala dell’essere a gradini distinti: e la contiguità viene facilmente tradotta in una prossimità di “stato”, che relega i neri al fondo della scala. Anche la “protesta” religiosa, soprattutto nella versione luterana, decisamente contraria alla politica di inclusione e di conversione di massa promossa dalla chiesa, porta a cogliere nella diversità il segno di un’esclusione divina: a livello popolare è diffusa, in particolare in Germania, la credenza che il mancato rispetto della Bibbia produca la degenerazione fisica, e che il segno più manifesto sia proprio l’iscurimento della pelle. La responsabilizzazione individuale di fronte al peccato non fa sconti ai popoli “bambini” (nemmeno a quelli più anziani, a giudicare dall’odio di Lutero per gli Ebrei), e non concede loro alcun credito di una crescita futura: esattamente come farà la cultura laico-scientifica.
L’ipotesi poligenetica comincia infatti a diventare dominante verso la fine del Seicento, in una prospettiva ormai sganciata dalle motivazioni religiose, polemiche o apologetiche che siano: il problema della diversità si ripropone ora in termini “scientifici”. Agli inizi essa non comporta un esito necessariamente razzista: uno dei suoi primi sostenitori, Arthur Isaac La Peyrère, nel Pre-Adamitae (1655) afferma che l’origine dei negri è più antica di quella dei bianchi, secondo un’interpretazione che è appunto definita “preadamitica”, dalla quale non trae peraltro alcuna valutazione gerarchica. Ma il preadamitismo compare in un’epoca nella quale l’attenzione si va spostando dal selvaggio americano a quello africano; il primo, buono o cattivo che lo si voglia considerare, del tutto inadatto alla fatica e allo sfruttamento, il secondo al contrario eccezionalmente resistente e utilizzabile in ogni settore lavorativo. Inoltre, si afferma contemporaneamente al maturare di tentativi di interpretazione biologica della diversità orientati verso l’ipotesi di una catena degli esseri.
Già William Petty nel 1677 parla di differenze esistenti tra gli uomini “come tra le diverse razze dei cani”. Nel 1684 poi François Bernier divide gli uomini in cinque razze: europei, negri, americani, lapponi, ottentotti[46], e anche se il suo impiego della categoria di “razza” non implica giudizi morali è automatico che questi scaturiscano dalla suddivisione stessa. È così che verso la fine del ‘600 vi sono autori che possono già intendere il senso riposto di queste elaborazioni dottrinali come un tentativo di giustificazione dello schiavismo. Morgen Goodwin (The Negro’s and Indians advocate, 1680) afferma che sono i proprietari di schiavi a sostenere la teoria preadamitica, in quanto ciò consente loro di evitare di battezzare i propri servi, eludendo così ogni controllo religioso e statale sul trattamento ad essi inflitto. Occorre d’altro canto osservare che si trovano argomentazioni del tutto opposte. Un medico che ha lavorato su navi negriere, John Atkins, sostiene il poligenismo proprio contro le conversioni con le quali i religiosi giustificano la schiavitù.
I due problemi della diversità razziale e della schiavitù cominciano quindi ad essere posti in correlazione. Nel frattempo, le anticipazioni della teoria poligenetica sembrano trovare una conferma scientifica nelle osservazioni di Malpighi e di Ruysch: si comincia a parlare di un “reticolo mucoso” individuato, durante la dissezione di negri, tra lo strato esteriore e quello interno dell’epidermide. Un’argomentazione simile si ha già ne L’Espion Turc del Marana (1686), dove si sostiene espressamente che i bianchi e i negri appartengono a due specie differenti, e si cita la testimonianza di un celebre medico parigino che afferma di aver trovato “una sorta di vascular plexus, che si stendeva per tutto il corpo come una tela”. L’autore ne deduce che “la natura, per distinguerli gli uni dagli altri ha dato dei marchi interni ed esterni per far conoscere la differenza dei loro corpi”. Lo stesso tipo di testimonianza si ritrova in Tyssot de Payot (Voyages ed adventures de Jacques Massé, 1710): “[…] immediatamente sotto l’epidermide trovammo una membrana estremamente delicata, […] ciò diede luogo a ragionamenti sull’origine degli Etiopi, che sembra non essere quella degli altri uomini, vista questa rimarchevole differenza”.
Agli inizi del ‘700 la vecchia interpretazione che attribuiva la differenza di colore agli influssi climatici è ormai in disuso. Anche il linguaggio si adegua. Il termine “razza” compare per la prima volta in un vocabolario francese nel 1690. Il fatto è che quando si trasferisce l’utilizzo di questo termine dalle specie animali a quella umana il fattore di diversità più immediatamente evidente è proprio il colore della pelle. Nelle colonie nordamericane comincia ad essere utilizzato già nel ‘600 l’acronimo Wasp (White Anglo-Saxon Protestant), ad indicare i discendenti dei primi colonizzatori, rigorosamente inglesi, non contaminati con ebrei, afro-americani, slavi o asiatici, appartenenti alle chiese presbiteriane o anglicana. È significativo che la connotazione “cromatica” preceda sia quella etnica che quella dell’appartenenza religiosa. Ma in fondo “Dio è bianco”, e i popoli dell’Europa occidentale, che nel pallore del loro incarnato maggiormente gli si avvicinano, forniscono il parametro sul quale misurare quantitativamente il grado di civiltà le altre culture[47]. Tempo un secolo e in Europa si affermerà il termine ariano, che fa corrispondere ai caratteri morfologici, primo tra tutti naturalmente il colore, un insieme molto più nutrito di peculiarità psicologiche e linguistiche.
Si adegua intanto velocemente anche il mondo scientifico. Le ricerche degli anatomisti sulle cause della diversa pigmentazione dei negri si sono moltiplicate. Oltre alla tesi sul reticulum mucosum ve ne sono altre che parlano di un fermentum nigricans, o individuano l’origine nel sangue e nella bile. Tutte comunque portano ormai allo stesso risultato: la razza nera è separata dalle altre da una barriera biologica. È pur vero che nell’ambito più strettamente scientifico Linneo prende le distanze da una interpretazione forzata del suo Systema naturae (1735): ma in realtà l’opera, anche nella sua neutralità, apre la strada ad una convalida scientifica di quanto era venuto maturando alla fine del XVII secolo[48]. Il fissismo non ammette evoluzioni o salti qualitativi.
La spiegazione “razzista” trova dunque numerosissimi adepti[49], anche se nel mondo scientifico incontra ancora alcuni oppositori. Buffon nelle Varietà della specie umana (1749 e poi 1777) sostiene che a differenziare gli uomini sono solo le sfumature: se vi sono differenze tra questi popoli, esse non concernono che il più o il meno di difformità. Pur parlando di “razza”, e introducendone in pratica il concetto antropologico, non intende assolutamente il termine in senso biologico. Ciò malgrado, riesce ad essere razzista su altri presupposti: sostiene infatti la teoria della degenerazione, in base alla quale tutti gli uomini discendono da un ceppo unico, ma alcuni popoli, per fattori legati al clima e all’ambiente si sono allontanati dalle caratteristiche originarie. Nei confronti della schiavitù non esprime alcuna condanna, limitandosi ad osservare che i maltrattamenti inflitti ai neri non sono degni di bianchi “superiori”.
Tra i più accesi sostenitori del razzismo biologico e gerarchico è invece Voltaire, che desume dalle varietà e dalle differenziazioni “scientificamente sperimentate” dei convinti giudizi di valore. Egli vuole sbarazzare il campo di tutte le nozioni relative a ciò che non è naturale, come quella di “indole” usata da Buffon. Per natura le specie sono fisse, immutabili, al più si possono ottenere degli ibridi infecondi. Le enormi differenze esistenti tra le razze umane sono incontestabili, e poiché hanno dato origine a civiltà di diverso livello, occorre trarne classificazioni gerarchiche: i vari gradi di umanità corrispondono ai vari gradi di civiltà. Così che “ottentotti, samoiedi, lapponi, cafri … sono animali”. Voltaire non ha dubbi, cita anch’egli le testimonianze sul reticolo mucoso, e sembra in definitiva interpretare quella che è l’opinione comune corrente della sua epoca. Il paradosso sta nel fatto che pur disprezzando profondamente i neri (e gli ebrei) attacca lo schiavismo come un prodotto del cristianesimo, mentre gli sta offrendo tutta una serie di giustificazioni laiche e “razionali”.
Verso la fine del secolo James Burnett (Lord Monboddo), autore di Of the origin and progress of language (1792), ritiene che la recente scoperta dell’orangutan nelle isole malesi comprovi l’esistenza di una grande catena dell’essere, che va dall’inorganico sino all’uomo cosciente, e nella quale “il fratello dell’uomo”, così simile ai neri africani, costituisce l’anello superiore animale, mentre i neri sono quello più basso della specie umana. Lo stesso orangutan viene posto dal suo contemporaneo Edward Long, un coltivatore giamaicano impegnato a difendere lo schiavismo attraverso l’ipotesi poligenetica, al livello dei neri, in una specie inferiore, dalle caratteristiche più bestiali che umane[50]. Proprio dalla Giamaica parte, con questa grossolana risposta alla nascita del movimento abolizionista, l’offensiva del razzismo compiutamente “moderno”, quello che lasciando cadere le vecchie argomentazioni testamentarie pretende di fondarsi sulle più avanzate ricerche e acquisizioni scientifiche, e che tanto successo avrà negli Stati Uniti[51].
Anche in Europa comunque la tesi della differenza razziale biologica viene molto presto quasi universalmente accettata, malgrado in autori come Herder[52] e Blumenbach[53] si ritrovi la teoria dell’unicità dell’origine umana. Un collega di Blumenbach a Gottinga, Christoph Meiners, redige addirittura, a pochi anni dalla comparsa della terza edizione dell’Histoire di Raynal e Diderot, una storia universale di segno diametralmente opposto, (Lineamenti di una storia dell’Umanità) basata sulla tesi dello sviluppo separato di razze umane diverse ab origine, con caratteri ereditari non mutabili, valutate sulla base di un criterio estetico-morfologico che naturalmente pone in una sfera superiore gli europei[54]. Meiners anticipa molte delle future teorie di De Gobineau, schierandosi contro ogni mescolanza inter-razziale.
Qualche anno dopo Petrus Camper classifica in una sua Dissertazione[55] (1791) le razza umane in base alle misure anatomiche (è l’inventore dell’angolo facciale), che dovrebbero fornire un criterio estetico basato sull’anatomia comparativa. Questo consente a Charles White, un chirurgo inglese, di affermare che “per la struttura e l’economia corporee, il nero è più vicino alla scimmia dell’europeo”[56]. Da un altro versante, e pur se alieno da ogni ipotesi razzista ed etnocentrica, anche Johann Kaspar Lavater con la Fisiognomica (1778) finisce per supportare le tesi della differenza. Le sue silhouettes forniscono un metodo per la comparazione dei tratti somatici, meno scientifico rispetto all’analisi biometrica ma egualmente soggetto ad interpretazione.
È infine lo stesso Kant, con il trattato “Le differenti razze dell’umanità” a introdurre in Germania l’ipotesi poligenetica e il concetto di razza, anche se non ne dà poi alcuna connotazione morale[57]. Si tratta oramai però di una acquisizione ideologica che si è autonomizzata, perché lo schiavismo ha in realtà fatto la sua epoca.
L’evolversi dell’atteggiamento occidentale nei confronti delle ipotesi genetiche può essere quindi seguito parallelamente allo sviluppo dell’istituto schiavistico nelle colonie. Fino a quando si tratta di popoli coi quali si mantiene un rapporto commerciale, nulla induce a porsi problemi sulla loro appartenenza o meno a pieno diritto al genere umano. Ma allorché si passa ad una forma diversa di colonizzazione, intesa alla produzione diretta, e diventa necessario “usare” intere popolazioni tenendole in uno stato inumano, ecco sorgere il corrispettivo scientifico della loro non umanità. Evidentemente non è un caso che proprio il secolo dei lumi veda l’affermazione del razzismo: e non tanto perché i criteri di omogeneità e di commensurabilità sottesi alla razionalizzazione comportano una valutazione negativa e gerarchizzata del diverso, quanto piuttosto perché questa razionalizzazione si attua all’insegna di un nuovo esperimento produttivo, di cui lo schiavo è soltanto la prima cavia. Per questo, non appena gli orientamenti economici mutano e il sistema schiavista viene superato dall’incalzare della nuova realtà industriale, il pensiero illuminista potrà abbracciare la causa dell’abolizionismo, senza per questo rinnegare le sue acquisizioni “scientifiche” razziste.
[1] Le stime relative alla demografia dell’America precolombiana sono a tutt’oggi assai controverse. Vanno, per l’intero continente, da un minimo di 10/12 milioni a un massimo di oltre 100. Sulle valutazioni pesano fattori legati alla metodologia di ricerca, ma è poi determinante l’atteggiamento ideologico. Per la seconda ipotesi, quella di un continente sovrappopolato (la stessa Europa di fine XV secolo non raggiunge i cento milioni) propende un gruppo di storici terzomondisti, tra i quali il più autorevole è Pierre Chaunu, per ovvie ragioni, mentre la maggioranza degli studiosi valuta ragionevole una consistenza attorno ai trenta milioni. Esiste infine una corrente minimalista, che basandosi sulla relativa povertà di siti archeologici, non è disposta ad ammettere cifre superiori ai dodici milioni.
[2] “Sino ad oggi i moralisti avevano cercato l’origine e i fondamenti della società nelle società che avevano sotto gli occhi. Ma dopo che si è visto che le istituzioni sociali non derivano né dai bisogni della natura né dai dogmi della religione, poiché innumerevoli popoli vivono indipendenti e senza culto, si sono scoperti i vizi sella morale e della legislazione nella formazione stessa delle società” (Denis Diderot, Pensées détachées remis à l’Abbé Raynal)
[3] Un metodo che insegna a dubitare anche del concetto di “consenso universale”. Nel Discours de la méthode Cartesio scrive: Vedendo come molte cose che, malgrado a me sembrino assolu-tamente stravaganti e ridicole, sono tuttavia comunemente riconosciute e approvate da altri grandi popoli, ho imparato a non credere troppo a ciò di cui ero stato persuaso dagli esempi e dal costume diffuso […]”.
[4] Il riferimento all’Eden, o all’età dell’oro, è presente anche nelle Decades de orbe novo di Pietro Martire d’Anghiera, pubblicate qualche anno più tardi: ma in questo caso è la cultura umanistica, e quindi metaforica, a prevalere, piuttosto che quella religiosa.
[5] Gli indigeni gli sembravano, però, appartenere ad una civiltà inferiore, da convertire, ma anche da assoggettare: “devono essere buoni servitori e ingegnosi, perché osservo che ripetono tutto quello che dico loro” annotò.
[6] Per la precisione nel 1672, nell’opera teatrale La conquista di Granada, di John Dryden.
[7] Giovanni Botero, Relazioni Universali, parte IV, Venezia 1596
[8] Ugo Grozio, De jure belli et pacis, 1625
[9] Thomas Hobbes, De Cive, Londra 1642
[10] Per Hobbes nello stato di natura gli uomini vivono in uno stato di guerra perpetuo di ciascuno contro tutti gli altri (“bellum omnium contra omnes”) e la vita è nasty, brutish, and short (spiacevole, grezza, e breve). La conservazione di se stessi è un principio naturale, e proprio il naturale diritto a conservare la propria vita e la propria integrità fisica autorizza l’uomo, nello stato di natura, ad aggredire il suo vicino per difendersi da lui prevenendolo. Per uscire da questa situa-zione e garantire la sicurezza degli individui si deve costituire una società efficiente. Gli individui devono quindi rinunciare ai propri diritti naturali, stringendo un patto con cui li trasferisco-no a una singola persona, che può essere o un monarca, oppure un’assemblea di uomini, che si assume il compito di garantire la pace entro la società.
[11] In una lettera ad Hobbes del 1670 Leibnitz sostiene che quella dello “stato di natura” deve esse-re considerata una pura finzione concettuale, e non una realtà storica. Dio non può aver creato un mondo nel quale non ci siano obblighi morali e diritti individuali. Tuttavia consente con Hobbes sul fatto che la “società civile” nasca per motivi di sicurezza reciproca tra uomini spinti dal timore.
[12] Il senza era stato utilizzato in una valenza negativa da André Thévet, un compagno di De Léry: “L’America è abitata da genti meravigliosamente strane e selvagge, senza fede, senza legge, senza, religione, senza civiltà alcuna, ma che vivono come animali privi di ragione nel modo in cui la natura li ha generati, che mangiano radici e restano sempre nudi sia gli uomini che le donne … (La singularité de la France Anctartique .., 1558). Lahontan scriverà invece: “Ah! Vi-va gli Uroni, che senza leggi, senza prigioni e senza torture passano la vita nella dolcezza, nel-la tranquillità, e godono di una felicità sconosciuta ai francesi”. (Dialogues curieux …, 1703)
[13] Questo avviene anche all’interno della chiesa cattolica. Vedi il dibattito gesuiti-francescani, che si disputano il controllo delle reducciones e la gestione della evangelizzazione degli indigeni. Particolarmente crudo sarà il confronto tra la Compagnia di Gesù e i cosiddetti “recollets”, che sono gli apripista dell’evangelizzazione soprattutto nel Nord-America.
[14] C’è in queste accuse un forte coinvolgimento personale, perché Lahontan si arruola per sfuggi-re ai creditori, e sia in America sia dopo la diserzione verrà sempre a conflitto con ogni autorità costituita, religiosa o laica.
[15] Anthony Shaftesbury Advice to an author (1712)
[16] Anche se è disposto a dar credito ai racconti più assurdi sui “selvaggi”: “Vi sono luoghi dove la gente mangia i propri bambini. Gli abitanti dei Caraibi erano soliti castrare i bambini apposi-tamente per ingrassarli e mangiarli. Garcilaso de la Vegas ci racconta di un popolo nel Perú il quale ingrassava e mangiava i bambini che avevano dalle loro prigioniere, le quali venivano conservate come concubine per quello scopo e quando avevano passato l’età della procrea-zione venivano anch’esse uccise e mangiate” (Saggio sull’intelletto umano).
[17] “Benché essi preferiscano di solito l’erede del loro re defunto, tuttavia, se lo trovano in qual-che modo debole o incapace lo mettono da parte e stabiliscono a loro governatore l’uomo più forte e coraggioso […]”.
[18] Bernard de Fontenelle riteneva che tutti i popoli “civili” fossero passati per uno stato simile a quello dei selvaggi: “I Greci furono un tempo dei selvaggi cosi come lo sono oggi gli America-ni: quando erano un popolo nuovo non pensavano affatto più ragionevolmente di quanto pen-sino i barbari d’America, i quali erano, a quanto pare, un popolo buonissimo, quando furono scoperti dagli spagnoli” (Histoire des oracles, 1686).
[19] “Voi intendete per selvaggi dei villanzoni che vivono nelle capanne con le loro famiglie e qualche animale […] che parlano un dialetto che non si comprende nelle città (…) che hanno poche idee e per conseguenze poche espressioni […], che si riuniscono in una specie di ca-panna per celebrare delle cerimonie di cui non comprendono nulla […]? Il fatto è che vi sono di tali selvaggi in tutta l’Europa. Bisogna convenire che i popoli del Canadà e i Cafri, che noi chiamiamo selvaggi, sono infinitamente superiori ai nostri. L’Urone, l’Algonchino, l’Illinois, il Cafro, l’Ottentotto hanno l’arte di fabbricare essi stessi tutto ciò c di cui hanno bisogno. Le popolazioni dell’America e dell’Africa sono libere, e noi selvaggi non abbiamo nemmeno l’idea di cosa sia la libertà” (Essai sur les Moeurs).
[20] “Voi europei, il cui spirito si riempie sin dall’infanzia di tanti pregiudizi contrari alla felicità, non riuscite a concepire che la natura possa procurare tanti lumi e tanti piaceri. La vostra anima circoscritta in una piccola sfera di conoscenze umane presto attinge il termine dei suoi godimenti artificiali: ma il cuore e la natura sono inesauribili”.
[21] Anche dopo la rivolta delle colonie, in un discorso pronunciato alla Camera dei Lord nel 1777, William Pitt il Vecchio denuncia gli atti di violenza e addirittura di cannibalismo perpe¬trati da-gli ausiliari indiani contro “innocenti”.
[22] “Au bout de trois cent années, l’Amérique rassemblera aussi peu à ce qu’elle est aujourd’hui, qu’elle ressemble aujourd’hui peu à ce qu’elle étoit au temps de la découverte”.
[23] “Ne massacrons pas les Papous pour connaître, au thermomètre de Réaumur, le climat de la Nouvelle Guinée”.
[24] La credibilità del racconto è a dire il vero un po’ inficiata dalla reputazione di Johnson, che era chiamato “il selvaggio bianco” per l’atteggiamento spietato.
[25] Questa immagine viene ulteriormente rafforzata dalla vicenda del Bounty, che ha una larga risonanza sia per lo scandalo dell’ammutinamento che per la scelta dell’equipaggio di rimanere nelle Isole Felici.
[26] “Gli indigeni danno l’impressione di essere felici come nessun altro popolo sotto la cappa del cielo e oltre a tutto il necessario dispongono anche a profusione di quegli agi e voluttà che abbelliscono la vita” scrive Cook nei Diari di bordo.
[27] “Tutti questi nostri amici, e specialmente la Regina, diedero l’ultimo addio ai nostri in una maniera così sensibile, che Mister Wallis avendo il cuore nell’estrema costernazione, non fece altro per lungo tempo che sfogarsi anch’egli a piangere dirottamente”.
[28] Luois Antoine de Bougainville, Voyage autour du mond, 1771
[29] Anche se non mancano le eccezioni. A proposito delle Isole Salomone Carteret scrive: “Se può giudicarsi dello stato di un popolo da quello delle sue abitazioni, questi selvaggi dovevano es-sere certamente negli estremi gradi della vita selvaggia, avendo per dimora le più miserabili che si fossero giammai vedute nel mondo”.
[30] Georg Forster, Viaggio attorno al mondo, 1780. “Purtroppo io temo che la nostra conoscenza sia stata del tutto svantaggiosa per gli abitanti dei Mari del Sud”.
[31] Bougainville, Voyage autour du mond, Lettera introduttiva
[32] “Lo stato di natura non esiste più, forse non è mai esistito, probabilmente non esisterà mai” (Discours sur l’origine de l’inegalité, 1755)
[33] Non si può nemmeno parlare di primitivismo o di culto della barbarie, anche perché Rousseau è ben consapevole dei limiti di quello stadio di vita. “Non vi era né educazione né progresso, le generazioni si moltiplicavano inutilmente e, poiché ognuno partiva sempre dal medesimo punto, i secoli scorrevano e rimaneva inalterata la rozzezza dell’età primitiva, la specie era già vecchia e l’uomo rimaneva sempre bambino”.
[34] Nel Discours sur l’origine de l’inegalité scrive: “Errando nella foresta senza lavoro, senza pa-rola, senza domicilio, senza guerra e senza legami, senza alcun bisogno dei suoi simili, così come senza alcun desiderio di nuocer loro, persino senza mai riconoscerne alcuno individualmente, l’uomo selvaggio, soggetto a poche passioni e bastante a se stesso, non aveva che i sentimenti e i lumi propri a quello stato, non provava che i bisogni veri, non guardava se non quanto aveva interesse di vedere e la sua intelligenza non faceva maggiori progressi della sua vanità”.
[35] Montesquieu, al pari di Locke, non ha una grossa stima dei “selvaggi”. Ne “L’Esprit des Lois” usa a modo di parabola la storia di un popolo che, avendo scelto di vivere allo stato di natura, finisce per degradarsi ed estinguersi. Non è nemmeno un entusiasta delle civiltà orientali: basandosi su una relazione di Dampierre depreca l’uso tonchinese e cinese di affidare le cariche amministrative agli eunuchi, che produce una serie di contraddizioni: “Si affidano a quelle persone le magistrature perché non hanno famiglia; e d’altro lato, si permette loro di sposarsi perché hanno le magistrature […] Nella storia della Cina si trovano un gran numero di leggi per togliere agli eunuchi tutte le cariche civili e militari: ma vi ritornano sempre. Sembra che gli eunuchi in Oriente siano un male necessario”.
[36] Parlo di istinto non perché ritenga che i pregiudizi di gruppo siano geneticamente determinati (come sostengono William Hamilton, Richard Dawkins ed Edward O. Wilson), ma perché so-no comunque universalmente diffusi, sotto le specie dell’etnocentrismo, e agiscono come un automatismo di difesa e di sopravvivenza.
[37] Quaecumque est hominis definitio, una in omnes valet (De Legibus, I, X, 29)
[38] Naturalis Historia, libro VII
[39] Nel De origine et situ Germanorum, soprattutto, insiste sulla non contaminazione dei popoli germanici, dei quali esalta il coraggio, la semplicità, il senso dell’ospitalità e la monogamia, in contrasto con l’immoralità dei costumi romani (non manca però di sottolineare quanto siano pigri e barbari). Negli Annales esprime invece a più riprese un profondo disprezzo per gli ebrei.
[40] Nell’Epistola ai Galati (III, 27): Non c’è più Giudeo né Greco; non c’è più né schiavo né libero; non c’è più uomo né donna, poiché tutti voi siete uno in Gesù Cristo.
[41] Agostino di Ippona, De civitate dei, libro XIX. Agostino sostiene anche, però, che la schiavitù va vista come la sanzione divina di una colpa (che può anche essere collettiva). Una legittimazione della schiavitù arriva nel XIII secolo da Tommaso d’Aquino, aristotelico convinto, che ritiene giustificata la schiavitù se conseguente ad una condanna per un grave delitto, alla cattura in una guerra giusta, alla nascita in stato servile.
[42] Già nel Concilio di Elvira (IV secolo) si proibiva ai cristiani il matrimonio con gli ebrei o addi-rittura di consumare con essi il pasto.
[43] Preceduta peraltro da una legge di Carlo V, del 1539, che perseguiva lo stesso scopo.
[44] A differenza dei Tainos, che gli erano parsi la miglior gente di questo mondo “i Caribi, sono gente fiera e combattiva, ma affrancata da quella loro crudeltà, sarebbero schiavi dei migliori che siano al mondo” scrive nel memoriale ad Antonio de Torres del 1494.
[45] Erodoto, al solito il più moderno, fa risalire le differenze alla sola “tradizione culturale”.
[46] Nouvelle division de la Terre par les différentes éspèces ou races d’homme qui l’habitent.
[47] “Nel Settecento si escludeva che i cinesi fossero ‘bianchi’ in quanto non se ne riconosceva più la pari dignità culturale. La convinzione che esistesse per forza un nesso fra il colore della pel-le da un lato e il carattere di una razza o di un popolo dall’altro, e che vi fosse altresì una gerarchia culturale, nella quale il primo posto spettava ai bianchi europei e l’ultimo ai neri dell’Africa, implicava non solo che una carnagione scura dovesse comunque corrispondere a un’inferiorità di cultura e di carattere, ma anche, per converso, che quanti non erano adeguati allo standard delle ‘nazioni progredite dell’Europa’ non potessero, appunto perciò, essere bianchi”. (Demel, Walter – Come i cinesi divennero gialli – Vita e pensiero 1997).
[48] Lineo distingue tra europei, indiani d’America, asiatici, africani. Utilizza come criterio distinti-vo il colore della pelle (bianchi, rossi, gialli e neri) e descrive i primi come “perspicaci, ottimisti, creativi, governati dalle leggi”, i secondi come “collerici”, i gialli come “apatici”, gli ultimi come “furbi, indolenti, negligenti, malinconici, governati dal capriccio”.
In verità nelle prime edizioni del suo Systema Naturae (ad esempio in quella del 1740), l’uomo asiatico è definito “fuscus” (scuro), ma nel 1756 diventa “luridus” (giallastro).
[49] Tra questi anche David Hume (Essays, 1741), che ritiene i neri “inferiori per natura”, privi di doti razionali e incapaci di sviluppo civile.
[50] History of Jamaica, 1774 – Lang ritiene esistano solo tre specie del genere umano: gli europei e, molto a margine, i gialli e i rossi; i negri e gli orang-utan; le scimmie senza coda.
[51] Una delle eccezioni è costituta da Thomas Jefferson, che nelle Notes on Virginia (1784) sostiene la parità morale dei neri coi bianchi. Un po’ più dubbioso è su quella intellettuale, mentre non ha dubbi sulla superiorità estetica dei secondi.
[52] Johann Gottfried von Herder, Idee per la filosofia della storia dell’umanità (1784-91) – In realtà, anche se combatte lo schiavismo e il colonialismo, Herder inaugura con la sua teoria del Volkgeist, lo spirito del popolo, una sorta di razzismo culturale.
[53] Johann Friedrich Blumenbach De generis humani varietate nativa (1776). – Per lui il significato di razza è quello di tipo ideale, un’astrazione teorica. Suddivide l’umanità in cinque gruppi: caucasici, mongoli, etiopi, americani e malesi, sottolineandone le caratteristiche somatiche, piuttosto che quelle morali. Non ha dubbi che tutti gli esseri umani appartengano alla stessa specie, ma neppure sul fatto che sia quella caucasica la razza umana originaria, quella che presenta gli esemplari più belli be più giusti e che ha la forma del cranio più aggraziata.
[54] Christoph Meiners, Grundiss der Geschichte der Menscheit, 1785
[55] On the Points of Similarity between the Human Species, Quadrupeds, Birds, and Fish.
[56] In An Account of the Regular Gradation in Man, (1799) Charles White sostiene l’esistenza di quattro razze e ne definisce una precisa gerarchia, ponendo gli asiatici subito dopo gli europei in quanto a intelligenza.
[57] Immanuel Kant, Von der verschiendenen Racen der Menschen, 1775 – Kant distingue quattro razze: bianca, nera, mongolica e indù. Afferma che “si possono definire appartenenti ad una ‘razza’ quegli animali che conservano la loro purezza malgrado la migrazioni da una zono all’altra […] così i negri e i bianchi non sono certo due differenti tipi di specie, ma nondimeno due razze differenti”. Definisce i cinesi una “semirazza”, nelle vene della quale però scorre sangue unnico.