con postfazione 2025
di Giuseppe Rinaldi, 12 novembre 2025
Il breve saggio di Beppe Rinaldi che proponiamo non avrebbe bisogno, come del resto gli altri qui comparsi in precedenza, di alcuna presentazione: è già tutto lì. Ma io, che sono incorreggibile, ne approfitto una volta di più per ribadire il concetto che sta alla base dell’esistenza di questo sito: e cioè che l’informazione, la cultura, ogni forma di conoscenza, così come ogni altro mezzo di sopravvivenza, bisogna guadagnarseli. Nella fattispecie, leggendo il testo con la dovuta attenzione, e là dove rispetto a qualche nome, a qualche opera o a qualche movimento non si abbiano i necessari riferimenti, andando a recuperarli. Magari facendo anche un po’ di fatica (la fatica non è una maledizione divina, ma il modo naturale per tutte le specie animali di stare al mondo): che è anche quanto Rinaldi sostiene quale antidoto al nichilismo.
Con questo credo di rispondere a qualche nostro lettore (avete letto bene, qualcuno c’è) che lamenta una marcata discrepanza tra gli argomenti trattati nel sito, nonché nel modo di trattarli. Ora, il concetto è che, si parli di fumetti, di cinema, di scampagnate, di viaggi o di libri di viaggio, oppure si affrontino tematiche più complesse, inerenti la filosofia, la sociologia, la scienza e i suoi derivati tecnologici, a tenere assieme il tutto, e anzi, a spiegare come il tutto si tenga assieme, c’è sempre la volontà di rendere partecipe chi ci segue: intendendo la partecipazione nella valenza più letterale, attiva. Non siamo al ristorante, ma ad una cena tra amici, una volta si sarebbe detto ad un “convivio”, e tutti devono fare del loro meglio: che si traduce nel cercare di farsi capire il più possibile da parte di chi scrive, e nello sforzarsi di capire il più possibile da parte di chi legge. E magari di scrivere a sua volta, se qualcosa non lo convince.
Qui non si dispensa cultura, non si offrono frutti maturi, e neppure si ha la pretesa di insegnare a coltivare l’intelletto: saremmo già felici se riuscissimo a trasmettere lo stimolo a farlo. (P. R.)
1. In un volume[1] collettaneo di Ernesto de Martino, intitolato Furore, simbolo, valore, si trova un breve articolo intitolato Furore in Svezia, che contribuisce al titolo stesso della raccolta. Il furore cui si fa riferimento è un episodio accaduto nel 1956, durante il capodanno, nel centro di Stoccolma: cinquemila adolescenti abbigliati con giubbe di cuoio si erano scatenati e avevano tenuto la strada, molestando i passanti, rovesciando automobili, frantumando le vetrine ed erigendo barricate. Si ebbero scontri violenti con la polizia, si contarono numerosi feriti e molti arresti. Fenomeni analoghi, seppure di minore intensità, si erano ripetuti in quel periodo, nel fine settimana, nel centro di Stoccolma e in altre città svedesi. Il lettore odierno non fa alcuna fatica ad andare con la memoria a episodi analoghi, anche ben più gravi, accaduti nei tempi successivi, fino ad oggi, sia nel nostro paese sia altrove. Si tratta di episodi violenti che si caratterizzano per la loro apparente assoluta mancanza di senso.
2. Già de Martino osservava: «Si tratta di pure e semplici esplosioni di aggressività senza premeditazione e senza organizzazione, senza capo e senza scopo. Gli episodi di violenza non insorgono per qualche cosa e contro qualcuno: inesplicabilmente, come per un richiamo misterioso, gruppi di adolescenti e di giovani, dai quindici ai vent’anni, senza conoscersi tra loro e nulla avendo in comune tranne l’età, formano banda temporanea ed entrano in furore distruttivo. […] Questi ribelli senza causa non si propongono rapina o vendetta nel senso comune di queste parole: sono mossi da un impulso di annientamento delle persone e delle cose, vogliono ridurre in cenere il mondo, far sfoggio della loro potenza di eversione. Nessun legame interpersonale nasce da tali tempestosi assembramenti, da queste orge di furore: le bande temporanee si sciolgono così come si sono formate, senza lasciare traccia di rapporti oltre la scarica distruttiva»[2].
3. Naturalmente già all’epoca in cui scriveva De Martino erano stati avanzati vari tentativi di spiegazione di questi fenomeni. Egli sottolineava tuttavia la non esaustività delle spiegazioni economiche (i giovani in questione non condividevano la stessa condizione sociale, non si trovavano cioè in situazioni sociali ed economiche particolarmente critiche), come pure delle spiegazioni incentrate sull’eccesso di benessere svedese, oppure sulla solitudine delle alte latitudini dovuta ai ritmi naturali della giornata (freddo, mancanza di luce) e invocava l’esigenza di ricorrere al contributo dell’etnologia e della storia delle religioni per comprendere meglio il fenomeno: «Dal punto di vista dell’etnologia e della storia delle religioni il capodanno di Stoccolma e altri episodi affini perdono il loro carattere più preoccupante di assoluta eccezionalità e si manifestano come un pericolo che tutte le epoche e tutte le civiltà hanno dovuto fronteggiare, con maggiore o minore successo. Questo pericolo è l’angoscioso essere afferrati dalla nostalgia del non-umano, è l’impulso a lasciar spegnere il lume della coscienza vigilante e ad annientare quanto, nell’uomo e intorno all’uomo, testimonia a favore dell’umanità e della storia. […] L’etnologia e la storia delle religioni confermano largamente la tesi secondo cui una delle funzioni fondamentali della civiltà consiste nel controllo e nella risoluzione di ciò che Freud chiamò “istinto di morte”, cioè l’abdicazione della persona come centro di decisione e di scelta secondo valori, la tendenza a cancellare dall’esistenza quanto esiste, la cieca tentazione della eversione e del caos, la nostalgia del nulla»[3].
4. Insomma, de Martino ipotizzava una specie di patologia, propria dell’animale culturale, che consiste giusto nel disancoramento dalla propria cultura (che de Martino considerava un artefatto storico) o, se si preferisce, nel disancoramento dal proprio Mondo, e nella conseguente messa in opera di comportamenti distruttivi nei suoi stessi confronti. In seguito al venir meno del legame con la cultura, che dà forma alla storicità delle varie comunità e che dunque così contribuisce a definire i comportamenti e le identità dei singoli, si spalancherebbe l’abisso primordiale dell’assoluto negativo.
Questa condizione, si badi bene, non ha nulla a che fare con l’istinto meccanico dell’animale, regolato e selezionato per secoli dall’evoluzione, che non ha nulla di distruttivo, ma è una situazione potenziale specifica degli umani, nel cui orizzonte culturale può prendere forma qualunque aberrazione distruttiva, contro qualsiasi cosa abbia un significato culturale compiuto, in termini di limitazione, di coerenza, di convenzione, di durata. Ciò può implicare la distruzione di qualsiasi cosa sia comunemente considerata come dotata di valore. Invece di realizzare se stessi in termini costruttivi, attraverso le diverse forme valoriali che la cultura mette a disposizione, si cerca di costruire e mantenere una propria momentanea identità attraverso la distruzione, più o meno sistematica, del prodotto culturale storico che una società è riuscita a mettere insieme.
Non si tratta dunque di una manifestazione culturale nuova, una qualche forma di cultura critica radicale o alternativa, il tentativo di criticare un qualche valore che istituisce un particolare mondo dell’esserci, ma di un gesto distruttivo nei confronti di quello che c’è, di ciò che è condiviso dalla gran parte dei membri di una società. Si tratta di un gesto semplicemente regressivo che evoca modalità infantili e/o primitive di rapporto con l’oggetto e con gli altri.
5. Questa possibilità, insita nell’animale culturale, si scontrava con l’ottimismo storicistico, professato dallo stesso De Martino, secondo il quale, la storia sarebbe il campo della realizzazione costruttiva, o dell’ethos del trascendimento – come egli si esprimeva attraverso il suo linguaggio fenomenologico esistenzialistico. Il furore è dunque un comportamento del tutto possibile per l’animale uomo, un comportamento attraverso il quale l’uomo non riconosce più il proprio stesso patrimonio culturale e lo vandalizza e devasta. Un comportamento determinato da una sorta di affermazione di sé attraverso la produzione del caos, attraverso lo scoperchiamento del nulla, il bisogno di mostrare il nulla che abita sotto la sovrastruttura culturale, di vanificare come illegittimo qualsiasi ordine di valore instaurato. Insomma, la disgregazione al posto della realizzazione costruttiva.
6. De Martino osservava, nel suo articolo, che nelle società arcaiche e nelle civiltà del mondo antico l’abisso primordiale che inevitabilmente si rivela quando viene meno l’identificazione basilare con la propria cultura era ben noto. Esso era considerato come qualcosa di molto pericoloso, tanto che veniva circoscritto e ritualizzato. Egli fa l’esempio del capodanno babilonese, oppure dei Saturnali romani, oppure ancora delle tradizioni carnevalesche.
Così racconta de Martino: «Nel capodanno babilonese il rito disfaceva il tempo trascorso nell’anno spirante, cancellava per così dire la storia che si era accumulata, ed esprimeva un regresso all’epoca mitica delle origini, quando il caos dominava e il cosmo non era ancora stato fondato. In rapporto a questo schema tecnico il rito comportava aspetti di distruzione e di annientamento dell’ordine sociale vigente, come l’umiliazione e l’abbassamento della stessa potenza regale, la simbolica trasformazione degli schiavi in padroni, la violenta eliminazione dei mali fisici e morali contratti nel corso dell’anno spirante, e infine la instaurazione dell’indistinzione originaria del caos. Ma il rito includeva anche l’opposto momento della reintegrazione dell’ordine, e del ripristino dei valori sociali e morali: veniva infatti rappresentata la lotta dell’eroe Marduk contro il mostro marino Tiamat, con la vittoria finale dell’eroe e la fondazione primordiale del cosmo. In tal modo lo schema mitico – rituale del capodanno babilonese consentiva all’impulso di morte di manifestarsi attraverso eversioni e inversioni annientatrici dell’ordine vigente: ma gli impulsi distruttivi non erano fatti valere sul piano realistico, ma su quello simbolico del rito, e soprattutto la vicenda riceveva il suo senso dalla ripetizione del dramma della creazione e della reintegrazione di un ordine nuovo senza macchia, uscito per la prima volta dal caos»[4].
Carattere comune di questi espedienti di manipolazione del nulla e di reintegrazione del significato, di questi artefatti culturali di morte e rinascita, sono la durata circoscritta nel tempo, la cancellazione temporanea dei ruoli e delle barriere sociali, lo scatenamento emozionale, il sacrificio o la distruzione di qualche entità simbolica, la narrazione di miti legati alla questione dell’ordine e del disordine, la reintegrazione dell’ordine. Insomma, si tratta di un modo per evocare l’abisso senza farsene travolgere, un modo per circoscriverlo e per produrre una reintegrazione culturale.
7. In mancanza di una capacità diffusa di reintegrazione, può sopravvenire il fascino del nulla, il nichilismo. Così De Martino aveva interpretato la crisi culturale del periodo del secondo dopoguerra. «È da tempo che una cupa invidia del nulla, una sinistra tentazione da crepuscolo degli dèi dilaga nel mondo moderno come una forza che non trova adeguati modelli di risoluzione culturale, e che non si disciplina in un alveo di deflusso e di arginamento socialmente accettabile e moralmente conciliabile con la coscienza dei valori umani faticosamente conquistata nel corso della millenaria storia di Occidente»[5].
8. De Martino dunque ci avverte che le culture, tutte le culture, anche le più complesse, sono estremamente fragili, che la connessione che si stabilisce tra i corpi biologici e il patrimonio culturale che vien costantemente elaborato e accumulato è estremamente labile, che la cultura, la quale ha il compito di dirigere attraverso i propri valori il comportamento umano, è in fondo un costrutto artificiale, un prodotto non necessario della storia, che avrebbe potuto essere completamente diverso da quello che ci ritroviamo. Si tratta di una forma di rappresentazione o, se si preferisce, addirittura di una illusione, come direbbero volentieri diversi filosofi continentali. Ammesso che così sia, si tratta tuttavia di un’illusione necessaria, poiché quello che siamo in quanto umani è esattamente il costrutto culturale che siamo in grado di produrre e di mantenere, senza farci troppo ammaliare dal fascino dell’abisso.
Postfazione 2025

1. Lo scritto antropologico di Ernesto De Martino, che ho testé presentato e analizzato, ha ben poco a che fare con la tradizione continentale che si è occupata del nichilismo in quanto categoria filosofica. Mi riferisco alla tradizione che ha tra i suoi esponenti principali Nietzsche ed Heidegger, seguiti da una schiera di epigoni. Dato che De Martino, nel suo saggio sul nichilismo, ha preso le mosse dalle manifestazioni del disagio giovanile degli anni Cinquanta, ho pensato di metterlo a confronto con Umberto Galimberti, un rispettabile seguace di Nietzsche e Heidegger, che ha trattato anch’egli della tematica del rapporto tra il nichilismo e i giovani. Credo che il raffronto possa risultare piuttosto utile, anche al fine di chiarire alcuni concetti fondamentali riguardanti il ruolo delle marche emotive e del simbolismo nella costruzione della coscienza collettiva e dell’ordine morale della società. Ciò mi permetterà, indirettamente, di distinguere tra quel che è la teoria sociale, invero oggi piuttosto misconosciuta, e quel che sono certe favole filosofiche che sono invece piuttosto di moda.
2. De L’ospite inquietante[6] – che porta come sottotitolo Il nichilismo e i giovani – di Galimberti mi sono occupato fin dal 2007, quando il volume è uscito. Questo perché lo scritto possiede almeno due livelli di lettura. Il primo è quello dell’instant book sui problemi della condizione giovanile, dove si compiono diverse analisi e considerazioni a partire dai fatti di cronaca e dalla ricognizione di vari elementi empirici relativi al disagio e alla violenza giovanile[7]. A quell’epoca era questo il livello che mi aveva soprattutto interessato, poiché ero allora impegnato in una ricerca sociologica sui giovani. Il secondo livello di lettura, quello più sottile e forse più sfuggente, riguarda invece proprio la questione filosofica del nichilismo. Nell’impianto del saggio di Galimberti, il concetto teorico filosofico del nichilismo – com’è stato elaborato da Nietzsche e Heidegger – viene ampiamente utilizzato in termini esplicativi per dar ragione del disagio giovanile e per proporre addirittura una soluzione che dovrebbe condurre oltre il nichilismo. Qui, indubbiamente, la filosofia si fa antropologia, sociologia, psicologia e soprattutto tecnica terapeutica per curare i mali del mondo. Più volte, nel suo scritto, Galimberti manifesta una certa sufficienza nei confronti delle scienze umane che – in quanto scienze – sarebbero incapaci di fare effettivamente fronte ai problemi dei quali si occupano. Più efficace sarebbe, appunto, la filosofia, almeno quella che intende Galimberti. Questo secondo piano di lettura è quello di cui mi occuperò in questa sede.
3. Non mi occuperò quindi della questione effettiva del disagio giovanile e/o della violenza insita in taluni comportamenti giovanili, argomenti di cui comunque è pervaso il libro di Galimberti, a proposito dei quali va comunque riconosciuto che egli è in grado di fare una miriade di osservazioni senz’altro intelligenti e interessanti. Mi occuperò piuttosto della teoria filosofica sottostante e quindi, indirettamente, dell’annosa questione dell’uso possibile delle teorie filosofiche a fini terapeutici. Vedremo purtroppo come la terapia proposta da Galimberti finisca per costituire essa stessa una delle cause, forse la più importante, della malattia che egli intende curare.
4. Dati i miei scopi, del saggio di Galimberti esaminerò qui soprattutto l’introduzione e le conclusioni. Fin dalle prime battute, Galimberti propone la sua versione del nichilismo: «[…] i giovani, anche se non sempre ne sono consci, stanno male. E non per le solite crisi esistenziali che costellano la giovinezza, ma perché un ospite inquietante, il nichilismo, si aggira tra loro, penetra nei loro sentimenti, confonde i loro pensieri, cancella prospettive ed orizzonti, fiacca la loro anima, intristisce le passioni rendendole esangui»[8].
Galimberti dice con chiarezza che il disagio di cui parla è di natura culturale: «E questo perché se l’uomo, come dice Goethe, è un essere volto alla costruzione di senso (Sinngebung), nel deserto dell’insensatezza che l’atmosfera nichilista del nostro tempo diffonde il disagio non è più psicologico, ma culturale. E allora è sulla cultura collettiva e non sulla sofferenza individuale che bisogna agire, perché questa sofferenza non è la causa, ma la conseguenza di un’implosione culturale di cui i giovani, parcheggiati nelle scuole, nelle università, nei master, nel precariato, sono le prime vittime»[9].
5. Insomma, abbiamo ormai una catastrofe culturale alle spalle e la condizione odierna dei giovani sarebbe soltanto una conseguente manifestazione di quanto è già accaduto. Se questo fosse vero, ogni questione di rimedi sarebbe fuor discussione: «Se il disagio giovanile non ha origine psicologica ma culturale, inefficaci appaiono i rimedi elaborati dalla nostra cultura, sia nella versione religiosa perché Dio è davvero morto, sia nella versione illuminista perché non sembra che la ragione sia oggi il regolatore dei rapporti tra gli uomini, se non in quella formula ridotta della “ragione strumentale” che garantisce il progresso tecnico, ma non un ampliamento dell’orizzonte di senso per la latitanza del pensiero e l’aridità del sentimento. Le pagine di questo libro non indicano un rimedio di facile ed immediata attuazione. E già questa ammissione di impotenza la dice lunga sulla natura del disagio che, lo ripeto, non è esistenziale ma culturale»[10].
Mi permetto di osservare en passant che le teorie che individuano nella storia un qualche peccato originale funzionano tutte più o meno così. Si tratta anzitutto di individuare dove e quando è avvenuto il fattaccio che a tutt’oggi ci condiziona da vicino e ci impedisce di essere quel che vorremmo o dovremmo essere. Dopo avere fatto con sicurezza la diagnosi, si tratterebbe allora di cercare un rimedio, a proposito del quale, tuttavia, si può essere anche piuttosto vaghi e possibilisti. Ci si può anche limitare a evocare vaghe speranze. Ad aspettare qualche forma di salvazione. O a concludere che non c’è più niente da fare.
6. Nel caso di Galimberti e del nichilismo, la diagnosi è piuttosto precisa: in estrema sintesi è tutta colpa della ricerca esasperata di un senso, la quale ricerca è in corso non da ieri, ma fin dagli inizi della tradizione giudaico cristiana. Più o meno, si tratterebbe di un problema che sussiste fin dagli albori della civiltà, o fin dalla creazione biblica, per quelli che la considerano seriamente.
Nonostante il fatto che la questione, messa così, assuma decisamente una prospettiva epocale cosmico storica, Galimberti, con un guizzo creativo, prospetta comunque il suo rimedio: «E se il rimedio fosse altrove? Non nella ricerca esasperata di senso come vuole la tradizione giudaico-cristiana, ma nel riconoscimento di quello che ciascuno di noi propriamente è, quindi della propria virtù, della propria capacità, o, per dirla in greco, del proprio “daimon” che, quando trova la sua realizzazione, approda alla felicità, in greco “eudaimonia”? In questo caso il nichilismo, pur nella desertificazione di senso che porta con sé, può segnalare che a giustificare l’esistenza non è tanto il reperimento di un senso vagheggiato più dal desiderio (talvolta illimitato) che dalle nostre effettive capacità, quanto l’arte del vivere (téchne tou biou) come dicevano i Greci, che consiste nel riconoscere le proprie capacità (gnothi seauton, conosci te stesso) e nell’esplicitarle e vederle fiorire secondo misura (katà métron). Questo spostamento dalla cultura cristiana a quella greca potrebbe indurre nei giovani quella gioiosa curiosità di scoprire se stessi e trovar senso in questa scoperta che, adeguatamente sostenuta e coltivata, può approdare a quell’espansione della vita a cui per natura tende la giovinezza e la sua potenza creativa»[11].
7. Galimberti avanza dunque l’ipotesi (invero piuttosto azzardata) che la ricerca del senso (che secondo lui è caratteristica specifica non degli umani in generale bensì della tradizione culturale giudaico cristiana) potrebbe essere la causa principale stessa del disagio nichilistico, non solo dei giovani attuali, a questo punto, ma dell’intero Occidente. Stiamo male proprio perché siamo costantemente alla ricerca del senso. Il nichilismo che ci attanaglia sarebbe solo la conseguenza estrema della nostra malata ricerca del senso. L’interpretazione di Galimberti qui segue ovviamente Nietzsche più o meno alla lettera.
In alternativa alla prosaica ricerca del senso, destinata a non avere alcuna soddisfazione, destinata anzi a generare proprio il nichilismo, Galimberti propone un ritorno ai Greci. La cosa suona, a prima vista, davvero un poco bizzarra, poiché, per la maggior parte delle persone appena un po’ acculturate, la tradizione giudaico cristiana, è nota proprio per avere incorporato la cultura greca. Dunque la perniciosa “ricerca esasperata di senso” si sarebbe manifestata fin da subito anche e soprattutto presso i Greci. Del resto, la filosofia occidentale, nella comune accezione, si è sempre occupata della ricerca del senso. Fin dai filosofi presocratici.
8. Ma allora, cosa vuol dire Galimberti? Di quali Greci sta parlando? Galimberti è piuttosto ambiguo, poiché parla di un non ben precisato daimon che i giovani dovrebbero imparare a scoprire dentro di sé e a coltivare. Cosa è l’arte del vivere di cui parla? Come dobbiamo intendere lo gnothi seauton? Apparentemente, il discorso di Galimberti sembrerebbe essere di tipo socratico, ma allora non avrebbe senso contrapporlo così decisamente alla cultura giudaico cristiana. In realtà Galimberti ha in mente una ben precisa interpretazione anti cristiana (e antisocratica) della cultura dei Greci, cioè quell’interpretazione alquanto discutibile che ha origine nella romantica Nascita della tragedia di Nietzsche e che poi si è sviluppata, attraverso la filosofia continentale successiva, in Heidegger e nei suoi epigoni[12]. Il recupero del daimon interiore, la pratica dell’arte di vivere, la condanna della ricerca del senso, fanno più che altro riferimento a Dioniso, che per Nietzsche era l’antagonista per eccellenza di Socrate. Il lato alternativo alla cultura greca ufficiale.
9. Solo sotto la luce nera di Dioniso si comprendono, nel fraseggio di Galimberti, “la gioiosa curiosità di scoprire se stessi”, l’ “espansione della vita” e la “potenza creativa” della giovinezza. L’unico elemento, tra quelli citati, che sarebbe estraneo al dionisiaco è il katà métron, che è senz’altro una concessione al socratismo. Qualsiasi misura, infatti, implica, di già, la definizione di un qualche senso. Forse si tratta di un’allusione a quello che, secondo Nietzsche, sarebbe stato il breve momento miracoloso della sintesi tragica tra apollineo e dionisiaco. Galimberti recupererà, nel seguito delle sue argomentazioni, proprio i tratti salienti di una analoga sintesi, o avvento di una condizione di equilibrio instabile, che egli ritrova nelle nozioni da lui proposte del nomadismo e dell’etica del viandante. Cioè, di un pensiero e di un’etica capaci di operare senza alcun punto fisso di riferimento.
Noi nel nostro piccolo avevamo sempre pensato, invece, che coloro che son colpiti dal nichilismo avessero per lo meno bisogno, per uscirne, di qualche punto fisso di riferimento. O al più rimpiangessero di non averne uno. Come ognun vede, quella di Galimberti costituisce un’indicazione piuttosto paradossale, e cioè di procedere a un alleggerimento della cultura, proprio in un’epoca nella quale avremmo decisamente bisogno di più cultura. Un invito a lasciar andare via anche quel poco di senso che c’è rimasto, convinti che l’epoca del senso sia ormai irrimediabilmente finita e, soprattutto, convinti che nel flusso del pensiero e dell’etica nomade staremo tutti senz’altro meglio.
10. Si tratta dunque, secondo Galimberti, di sostituire, alla ricerca considerata ormai vana e superata del senso della vita, una nuova nozione – che a noi parrebbe invero più romantica che greca – della vita come arte totale. Non tuttavia di un’arte meccanica si tratta, e neanche intellettuale, bensì di un’arte intesa come espressione di sé, ove soltanto si potrebbe realizzare il miracoloso equilibrio nomade tra daimon e métron. C’è un punto che a mio modesto avviso va precisato. Tutti coloro che fanno proposte simili, che credono fortemente nella vita come espressione, tendono a dare per scontato di aver dentro una incomparabile ricchezza nascosta, che stia lì, solo ad aspettare di venir fuori. Si tratta solo di togliere via gli impedimenti. In una versione democratica di queste teorie, tutti sarebbero egualmente ricchi di queste mirabili risorse interiori, dunque ci sarebbe abbondanza di speranza per tutti.
Per cui siamo spinti a concludere che la proposta terapeutico – culturale di Galimberti, proprio per i suoi presupposti, non può che risultare del tutto inconsistente. A chi manifesta o denuncia, più o meno consapevolmente, di avere il vuoto dentro, Galimberti sembra prescrivere qualcosa come: «Esprimi quello che hai dentro». O, peggio: «Diventa quello che sei». Quello che hai dentro, oppure quello che sei allo stato originario – a meno che tu non pensi di essere un Dio – altro non è se non il coacervo magmatico delle emozioni, l’istinto di branco dell’animale, il complesso disparato di tutti gli impulsi grezzi, come questi sono prima che siano resi consapevoli ed educati in un contesto culturale qualsiasi. Il risultato di simili prescrizioni, un effetto perverso vero e proprio, non può essere allora altro che proprio il furore di cui parlava De Martino. La terapia culturale proposta da Galimberti potrebbe alimentare e aggravare la malattia culturale stessa che invece egli intenderebbe curare.
11. La strada proposta da Ernesto De Martino è decisamente un’altra. Il nichilismo, lo sprofondamento nel nulla, è un pericolo esistenziale cui è continuamente esposto l’animale culturale umano. Questo accade perché sotto la coperta della cultura – la sola che ci rende quel che siamo – c’è solo la nostra natura animale, positiva e pregevole fin che si vuole, ma pur sempre animale. Quando, per qualche motivo estrinseco, si affloscia l’orizzonte di senso che ci viene dalla cultura – allora perdiamo la storicità, perdiamo cioè il fine, perdiamo il senso dei valori, il senso del nostro impegno nella società e il senso della nostra prassi nella storia. Perdiamo la nostra stessa individualità. Non sappiamo più donde veniamo, chi siamo, dove andiamo. È questo un rischio costante cui l’animale uomo è da sempre sottoposto, poiché esso è – appunto – l’animale culturale per eccellenza. Occorre allora esser consapevoli di questa specifica condizione umana e procedere, di conseguenza, a un’opera costante di reintegrazione, cioè a una opera di manutenzione dei rapporti che intercorrono tra la nostra parte culturale e sociale (quella che è stata definita come l’altro generalizzato[13]) e la nostra parte animale (la natura di cui facciamo indissolubilmente parte).
12. Questa manutenzione dei rapporti tra natura e cultura, dice De Martino, non può limitarsi a essere di tipo meramente individuale, perché andando a scavare nella carne della nostra natura individuale, troveremo sempre e soltanto lo stesso nulla che vi trovano tutti. O, se vogliamo, potremmo trovare quelle poche cose elementari che l’evoluzione ha fatto per noi[14]. La manutenzione del rapporto natura/ cultura non è dunque un fatto privato e personale, deve invece passare necessariamente attraverso i rituali collettivi della cultura stessa. La reintegrazione non può che avvenire attraverso la dimensione simbolica, che è sempre culturale e collettiva, anche quando viene interiorizzata dai singoli. Anche quando ce ne dimentichiamo.
13. L’emersione del vuoto nelle nostre vite, cosa che talvolta ineluttabilmente avviene, non è dovuta all’ospite inquietante di Galimberti, nato dalla tracotanza assiologica giudaico cristiana risalente a svariati secoli or sono. È dovuta alla nostra fortuita e sopravvenuta incapacità nell’uso dei rituali collettivi di reintegrazione a livello simbolico[15]. De Martino, riferendosi alle società semplici, parla in tali casi di cerimonie tribali, parla del carnevale o dei Saturnali. Trasferendo tuttavia l’equivalente di questi rituali nella nostra società occidentale, complessa e tecnologica, i problemi si complicano. Perché cose come il rischio della presenza e la perdita della storicità assumono aspetti del tutto nuovi e imprevisti. E di enorme portata. E così, oggi, l’esigenza dei rituali di reintegrazione si presenta in forma allargata e totalmente nuova. Rispetto alle società primitive, i problemi che abbiamo oggi hanno a che fare in gran parte con l’affievolimento (o la complicazione) dei rituali collettivi in presenza, quelli che chiamiamo face to face. Sono questi i rituali della vita quotidiana di cui ha ampiamente trattato l’interazionismo simbolico. E questi hanno a che fare, anche e soprattutto, con varie forme di sconnessione, nella nostra esperienza, tra le marche simboliche e le marche emotive. È bene ricordare che le marche emotive sono proprio quelle che – dentro di noi – regolano il rapporto tra natura (il corpo) e cultura (il simbolismo collettivo).
14. È da notare che la sconnessione tra l’emotivo e il simbolico si presta a essere molto più frequente in una società complessa piuttosto che in una società semplice. Nelle società semplici difficilmente si sfugge alla mobilitazione delle emozioni intorno al patrimonio simbolico riconosciuto immediatamente da tutti a livello locale. Nelle società complesse, invece, il simbolismo acquista un volume e una autonomia enormi e così può accadere che la dimensione emozionale, collettiva e individuale, venga facilmente sconnessa, oppure possa anche trovare una moltitudine di connessioni improprie.
Basti ricordare come l’isolamento forzato del covid abbia fatto scoprire, a una moltitudine di studenti, solitamente distratti da mille cose, l’essenzialità del rapporto in presenza con gli insegnanti e con la propria classe. Basti ricordare che, di fronte alla crescita degli episodi di violenza tra i giovani, da più parti si richiede l’adozione di una sorta di educazione affettiva, obbligatoria e gestita dalla scuola pubblica. Oppure si ricordi la devastazione operata dagli smartphone, nell’ambito dei rapporti face to face, nei confronti di intere nuove generazioni, come è stato comprovato dagli ormai celebri lavori di Twenge e Haidt. Oppure, ancora, si pensi ai danni colossali per la democrazia causati dal progressivo affievolimento dei rituali formali e informali della partecipazione politica. Ma va notata anche la comparsa di nuovi rituali collettivi decisamente perniciosi – che si servono magari anche delle nuove tecnologie – come quelli del razzismo o del populismo, o di movimenti demenziali come QAnon.
15. Si tratta allora di prendere consapevolezza, di comprendere fino in fondo, anche nel dettaglio delle micro interazioni, come avvenga effettivamente la sempre avventurosa e mai garantita costruzione dei legami sociali e culturali, quei legami che – soltanto loro – sono in grado di tenere a bada il nichilismo, cioè il vuoto di senso. Come avvenga la costituzione stessa della società come entità morale (il termine è di Durkheim). E quali siano invece le forze disgregatrici cui le società vecchie e nuove, sono sottoposte. Le risposte dell’antropologia culturale, della psicologia sociale, della sociologia e della linguistica sono ormai abbastanza chiare e convergenti. Sulla linea di De Martino, disponiamo oggi di una tradizione teorica che comprende figure decisive come Durkheim, Mauss, GH Mead, Merton, Geertz, Goffman, Douglas, Collins, solo per citarne alcune. Abbiamo dunque ormai un’ampia disponibilità di elementi di teoria sociale con cui possiamo effettivamente affrontare i problemi della costruzione del senso, della solidarietà sociale e delle identità collettive. Evitando accuratamente i danni dei deragliamenti nichilisti alla Galimberti. Qui, per esser questa una postfazione, non mi posso dilungare oltre. Se ci sarà qualche interesse, avrò modo eventualmente di tornare su queste tematiche.
OPERE CITATE
1962 De Martino, Ernesto, Furore, simbolo, valore, Feltrinelli, Milano.
2007 Galimberti, Umberto, L’ospite inquietante. Il nichilismo e i giovani, Feltrinelli, Milano.

[1] Il suggerimento di procedere alla pubblicazione di questo saggio è nato nell’ambito di una discussione, presso Città Futura, ove era emersa l’esigenza di meglio comprendere i fenomeni, sempre più dilaganti e preoccupanti, del disagio individuale, della aggressività e della violenza. Spero che, con tutti i suoi limiti, esso possa fornire un qualche utile contributo. Questo saggio è stato da me originariamente pubblicato sul sito Finestre rotte il 14/10/2012, con il titolo de L’illusione necessaria. Ha poi subito alcuni rimaneggiamenti, fino alla versione che qui presento, con una nuova titolazione, meno metaforica e più aderente al contenuto. Alla nuova versione mi è sembrato utile aggiungere una postfazione, relativamente ampia, che ha come principale oggetto il confronto tra la nozione del nichilismo demartiniano con quella, opposta, del nichilismo filosofico, come trattato nell’ambito della tradizione nicciano – heideggeriana. In questo confronto mi sono servito del saggio L’ospite inquietante di Umberto Galimberti. In calce, ho inserito qualche breve considerazione sui rituali collettivi di reintegrazione come sono oggi concepiti e concepibili nell’ambito delle scienze umane. Nella scrittura non ho utilizzato strumenti di AI.
[2] De Martino, 1962: 225-226.
[3] De Martino, 1962: 227.
[4] De Martino, 1962: 228.
[5] De Martino, 1962: 231.
[6] Cfr. Galimberti 2007.
[7] All’epoca, l’opinione pubblica era stata scossa dai famosi lanci di sassi dal cavalcavia, azione altrettanto priva di senso delle devastazioni di Stoccolma di cui parla De Martino.
[8] Cfr. Galimberti 2007: 11.
[9] Cfr. Galimberti 2007: 12.
[10] Cfr. Galimberti 2007: 13.
[11] Cfr. Galimberti 2007: 14. Le traslitterazioni dal greco sono di Galimberti stesso.
[12] Che questo sia esattamente ciò che ha in mente Galimberti è piuttosto inequivocabile. Soltanto per brevità evito di esaminare, per filo e per segno, tutto il testo, del quale peraltro ho prodotto una ampia schedatura. A testimoniare dell’ispirazione nicciana in questo testo sta il fatto – dettaglio curioso ma significativo – che il penultimo capitolo sia dedicato alle emozioni e alla musica.
[13] Si tratta di un concetto elaborato nell’ambito dell’interazionismo simbolico.
[14] L’uomo, proprio perché è destinato evolutivamente ad avere necessariamente una cultura, è solo debolmente determinato e vincolato dal patrimonio istintivo genetico.
[15] Durkheim, nel suo noto saggio sul Suicidio, ha introdotto la nozione di anomia, che non cessa di essere discussa e utilizzata, seppure con modifiche e aggiornamenti.








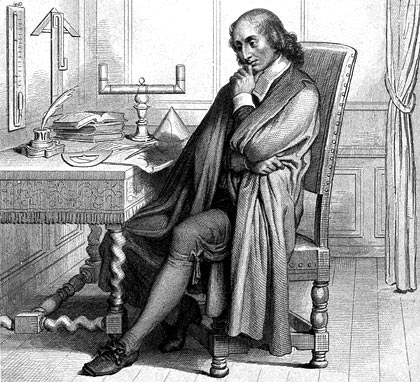
 Del resto, i frutti migliori dell’illuminismo si vedono in Kant, che dimostra di essere pienamente cosciente dei limiti della ragione e per questo non la idolatra. Il mio razionalismo, come il suo, si oppone sia all’iper-razionalismo sia all’irrazionalismo. Ambedue appiattiscono la realtà, negandone la complessità, lo spessore dialettico. In fondo, dimentichiamo che ad ispirare Cartesio era un Angelo, a guidare Socrate un Daimon. Troppo spesso si dimentica il potere creativo, visionario e “immaginario” del nostro cervello, che molti geni, tra gli scienziati e gli inventori del passato, hanno utilizzato in modo proficuo per giungere a formulare le loro conclusioni. Ricordo di aver letto, tempo fa, un articolo di tale Andrea Doria che, a sostegno di ciò portava diversi esempi: tra cui quello del chimico Friedrich August Kékulé von Stradonitz che si era invano affannato a decifrare la struttura della molecola di benzolo; quello, però, che non gli consentì la riflessione cosciente fu un sogno a permettergli di conseguirlo: una notte, addormentatosi di fronte al fuoco, vide in sogno un serpente che si mordeva la coda, ovvero l’archetipica figura dell’Uroboros. Guarda caso, la molecola di benzolo ha una struttura ad anello. Singolare, poi, anche il caso di Niels Bohr, il quale giunse a formulare il suo famoso modello atomico come un sistema planetario in piccolo traendo ispirazione da un sogno: sognò infatti di essere seduto su un sole ardente intorno a cui ruotavano a velocità folle dei pianeti del pari incandescenti.
Del resto, i frutti migliori dell’illuminismo si vedono in Kant, che dimostra di essere pienamente cosciente dei limiti della ragione e per questo non la idolatra. Il mio razionalismo, come il suo, si oppone sia all’iper-razionalismo sia all’irrazionalismo. Ambedue appiattiscono la realtà, negandone la complessità, lo spessore dialettico. In fondo, dimentichiamo che ad ispirare Cartesio era un Angelo, a guidare Socrate un Daimon. Troppo spesso si dimentica il potere creativo, visionario e “immaginario” del nostro cervello, che molti geni, tra gli scienziati e gli inventori del passato, hanno utilizzato in modo proficuo per giungere a formulare le loro conclusioni. Ricordo di aver letto, tempo fa, un articolo di tale Andrea Doria che, a sostegno di ciò portava diversi esempi: tra cui quello del chimico Friedrich August Kékulé von Stradonitz che si era invano affannato a decifrare la struttura della molecola di benzolo; quello, però, che non gli consentì la riflessione cosciente fu un sogno a permettergli di conseguirlo: una notte, addormentatosi di fronte al fuoco, vide in sogno un serpente che si mordeva la coda, ovvero l’archetipica figura dell’Uroboros. Guarda caso, la molecola di benzolo ha una struttura ad anello. Singolare, poi, anche il caso di Niels Bohr, il quale giunse a formulare il suo famoso modello atomico come un sistema planetario in piccolo traendo ispirazione da un sogno: sognò infatti di essere seduto su un sole ardente intorno a cui ruotavano a velocità folle dei pianeti del pari incandescenti.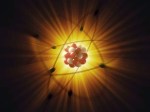 Non sono un irrazionalista nemmeno quando parlo dell’insonnia della ragione. L’insonnia in fondo è una malattia o è, comunque, indizio di malessere. Fa perdere lucidità. Induce stati ossessivi. L’insonnia della ragione è un’aberrazione, del tutto simile a quella – apparentemente opposta – dei massacri perpetrati da sedicenti cristiani. La troppa luce acceca, al punto che illustri illuministi hanno demonizzato il Medioevo come “secoli bui”. Ecco, la demonizzazione non mi appartiene: tanto che anche nei pensatori più lontani dalla mia visione del mondo, anche tra gli illuministi, anche in Marx, so (e amo) ricercare barlumi di verità, pagliuzze d’oro tra le tante scorie. Né presumo di essere infallibile. O di sapere tutto. Al contrario, so bene di sapere ben poco, quasi nulla. Cerco solo di orientarmi, di non perdere la bussola: una volta si diceva la trebisonda. E questo m’induce alla cautela, a comprendere più che a condannare. Quantunque, alla fine, una scelta bisogna pur farla.
Non sono un irrazionalista nemmeno quando parlo dell’insonnia della ragione. L’insonnia in fondo è una malattia o è, comunque, indizio di malessere. Fa perdere lucidità. Induce stati ossessivi. L’insonnia della ragione è un’aberrazione, del tutto simile a quella – apparentemente opposta – dei massacri perpetrati da sedicenti cristiani. La troppa luce acceca, al punto che illustri illuministi hanno demonizzato il Medioevo come “secoli bui”. Ecco, la demonizzazione non mi appartiene: tanto che anche nei pensatori più lontani dalla mia visione del mondo, anche tra gli illuministi, anche in Marx, so (e amo) ricercare barlumi di verità, pagliuzze d’oro tra le tante scorie. Né presumo di essere infallibile. O di sapere tutto. Al contrario, so bene di sapere ben poco, quasi nulla. Cerco solo di orientarmi, di non perdere la bussola: una volta si diceva la trebisonda. E questo m’induce alla cautela, a comprendere più che a condannare. Quantunque, alla fine, una scelta bisogna pur farla. Ha osservato Corrado Ocone: «Il fatto che gli accadimenti e le opere, così come le azioni, siano sempre individue, non significa che in esse, in sede di comprensione, non sia possibile rinvenire un ordine. Solo che quest’ordine, pur essendo opera in ultima istanza delle azioni degli individui empirici, trascende ogni loro intenzionalità, non corrisponde a ciò che gli individui o anche gruppi più o meno ampi di loro, si erano proposti con le loro azioni. È in questo solo e preciso senso, e solo in questo, che Croce può affermare, in senso metaforico, che gli accadimenti o la Storia sono come Dio. Essi, per così dire, se ne vanno per i fatti loro: la libertà è veramente, da questa prospettiva, non degli uomini ma dello Spirito». Analogamente Einstein diceva: «Dio non gioca a dadi». È come se ci fossero due piani: uno empirico, pragmatico (per cui vale l’asserzione di von Mises: «solo l’individuo pensa, solo l’individuo ragiona, solo l’individuo agisce») e uno storico-spirituale (in cui si ordinano, in un «ordine spontaneo», le conseguenze delle azioni individuali. «Gli accadimenti non sono governabili ex ante dagli individui empirici, ma sono da loro riducibili a senso ex post».
Ha osservato Corrado Ocone: «Il fatto che gli accadimenti e le opere, così come le azioni, siano sempre individue, non significa che in esse, in sede di comprensione, non sia possibile rinvenire un ordine. Solo che quest’ordine, pur essendo opera in ultima istanza delle azioni degli individui empirici, trascende ogni loro intenzionalità, non corrisponde a ciò che gli individui o anche gruppi più o meno ampi di loro, si erano proposti con le loro azioni. È in questo solo e preciso senso, e solo in questo, che Croce può affermare, in senso metaforico, che gli accadimenti o la Storia sono come Dio. Essi, per così dire, se ne vanno per i fatti loro: la libertà è veramente, da questa prospettiva, non degli uomini ma dello Spirito». Analogamente Einstein diceva: «Dio non gioca a dadi». È come se ci fossero due piani: uno empirico, pragmatico (per cui vale l’asserzione di von Mises: «solo l’individuo pensa, solo l’individuo ragiona, solo l’individuo agisce») e uno storico-spirituale (in cui si ordinano, in un «ordine spontaneo», le conseguenze delle azioni individuali. «Gli accadimenti non sono governabili ex ante dagli individui empirici, ma sono da loro riducibili a senso ex post».










 Il complottismo è dunque il prodotto di scarto di una normale funzione della nostra mente: e non sarebbe di per sé eccessivamente preoccupante (in ogni processo produttivo ci sono disfunzioni), non fosse che l’errore sta diventando la norma, sta dilagando, e in una società pressapochista come la nostra comincia ad essere omologato per buono. In realtà, anche in un’ottica grettamente “economicistica” non andrebbe condannato solo perché è una “perversione” di un processo mentale corretto, ma anche perché in termini “evolutivi” non funziona affatto (se non per coloro che ci marciano). Offrendo spiegazioni scorrette dei problemi non consente di affrontarli in maniera efficace, e ne crea anzi di ulteriori.
Il complottismo è dunque il prodotto di scarto di una normale funzione della nostra mente: e non sarebbe di per sé eccessivamente preoccupante (in ogni processo produttivo ci sono disfunzioni), non fosse che l’errore sta diventando la norma, sta dilagando, e in una società pressapochista come la nostra comincia ad essere omologato per buono. In realtà, anche in un’ottica grettamente “economicistica” non andrebbe condannato solo perché è una “perversione” di un processo mentale corretto, ma anche perché in termini “evolutivi” non funziona affatto (se non per coloro che ci marciano). Offrendo spiegazioni scorrette dei problemi non consente di affrontarli in maniera efficace, e ne crea anzi di ulteriori. Qui bisogna intenderci. La correttezza è senz’altro una gran bella cosa. Se fosse esercitata da tutti in tutte le funzioni e all’interno di ogni tipo di relazione risolverebbe d’incanto metà dei problemi dell’umanità. Sappiamo però, purtroppo, di non poterci contare, e infatti le cose vanno come vanno. È dunque giusto cercare là dove possibile di salvaguardarla. Ma sappiamo anche che imporla per legge è assurdo, è una attitudine che va educata (e spesso non basta nemmeno questo, prevalgono le disfunzioni caratteriali) e tutto in questo mondo liquido sembra congiurare invece a diseducarla.
Qui bisogna intenderci. La correttezza è senz’altro una gran bella cosa. Se fosse esercitata da tutti in tutte le funzioni e all’interno di ogni tipo di relazione risolverebbe d’incanto metà dei problemi dell’umanità. Sappiamo però, purtroppo, di non poterci contare, e infatti le cose vanno come vanno. È dunque giusto cercare là dove possibile di salvaguardarla. Ma sappiamo anche che imporla per legge è assurdo, è una attitudine che va educata (e spesso non basta nemmeno questo, prevalgono le disfunzioni caratteriali) e tutto in questo mondo liquido sembra congiurare invece a diseducarla.

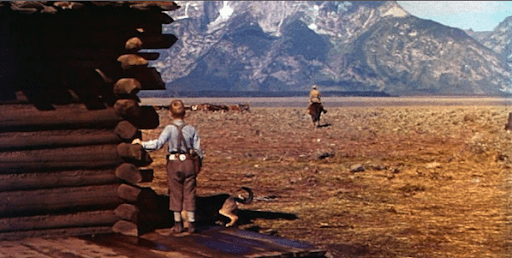
 Dal momento che tratto di senso etico, parlo naturalmente a titolo individuale: ma credo che lo stesso avvenga, in un modo o nell’altro, per tutti. Io ho riconosciuto l’imperativo categorico molto precocemente. Avevo si e no otto anni, e l’ho incontrato sotto le spoglie di Alan Ladd, lo Shane de Il Cavaliere della valle solitaria. Descrivere oggi cosa poteva significare un film negli anni cinquanta per un ragazzino di campagna, e un film western per di più, e quel western in particolare, è impossibile. Infatti non ci provo nemmeno, e mi limito a dire di cosa si trattava.
Dal momento che tratto di senso etico, parlo naturalmente a titolo individuale: ma credo che lo stesso avvenga, in un modo o nell’altro, per tutti. Io ho riconosciuto l’imperativo categorico molto precocemente. Avevo si e no otto anni, e l’ho incontrato sotto le spoglie di Alan Ladd, lo Shane de Il Cavaliere della valle solitaria. Descrivere oggi cosa poteva significare un film negli anni cinquanta per un ragazzino di campagna, e un film western per di più, e quel western in particolare, è impossibile. Infatti non ci provo nemmeno, e mi limito a dire di cosa si trattava.