di Paolo Repetto, da Sottotiro review n. 8, gennaio 1998
Vent’anni. Sembra trascorso un secolo, o addirittura un’era. Rileggo l’articoletto sul goldrakismo e ho l’impressione di fare un salto nella preistoria. Ciò che lì era ironicamente prospettato come futuribile è già il presente, anzi, è già alle nostre spalle. L’incubo si è tradotto in realtà così velocemente che non è stato nemmeno possibile aggiornare i cartoons, adeguarli all’evolvere della situazione. Il vecchio Goldrake continua a sfrecciare sui teleschermi, svenduto alle emittenti minori, ma ha assunto ormai la patina d’epoca dei films di Meliés o della fantascienza d’anteguerra. È maturo per la pensione e per l’antiquariato da fascia notturna di Ghezzi e compagni.
I figli dei nostri pargoletti non girano armati di maglio perforante e non ci ustionano con i laser-giocattolo: semplicemente, inchiodati alla plancia, ci disinseriscono col telecomando, ci smaterializzano staccando la spina o sincronizzandosi altrove. E noi ci aggiriamo raminghi tra i loro paradisi virtuali e il nostro limbo quotidiano, ridotti a ologrammi, muovendoci in scenari a metà strada tra la “normalità” angosciante de “L’invasione degli ultracorpi” e i gironi danteschi di “Blade Runner” o di “Nirvana”.
Tutto è dunque già accaduto; dietro il trascorrere in superficie di prime repubbliche e regimi totalitari, e il permanere di papi viaggiatori, di fedi e costanzi e di massacri integralisti, la vicenda autentica dell’uomo, quella di lungo periodo della sua corporeità e dell’interazione con ciò che lo circonda, è entrata in una nuova fase. Di questa transizione noi siamo stati (siamo) al contempo vittime e protagonisti, ma la repentinità del fenomeno ci ha frastornati, ci ha impedito di averne piena consapevolezza. Attrezzati a gestire il permanente, a misurare il cammino a passi corti e lenti, abbiamo perduto l’equilibrio quando il nastro trasportatore è impazzito e ci ha proiettati violentemente in avanti. Eppure i sintomi di quanto stava avvenendo c’erano. Non ci siamo svegliati scarafaggi all’improvviso, un mattino. La nostra metamorfosi arriva di lontano, ha una storia lunga.
 La storia è quella dell’ambiguo rapporto che da sempre gli uomini hanno intrattenuto con l’universo dei propri manufatti, con gli infiniti prodotti, materiali o immateriali, delle più svariate tecnologie, e di come tale rapporto sia degenerato in sudditanza nel corso dell’età moderna e contemporanea. Di come cioè negli ultimi tre secoli gli oggetti frutto di artificio si siano progressivamente emancipati dal controllo umano, costituendosi in seconda natura, sovrapponendosi alla natura originaria e soppiantandola, al punto che oggi per gran parte dell’umanità questa seconda natura è l’unica percepibile. E di come quella che nel mondo occidentale è da tempo una condizione comune si appresti a diventarlo in tutto il globo. Tradotto in polpettine tutto questo significa che da quando mi sono alzato stamani, anzi, da prima ancora di svegliarmi, ho avuto a che fare solo con case, auto, sanitari, elettrodomestici, asfalto, computer, telefono, ecc… Che ho intravisto – fuggevolmente – prati e boschi soltanto perché abito fuori città: ma che alla maggioranza dei miei simili non è data neppure questa opportunità. Significa che ho ascoltato musica e rumori e voci riprodotte dalla radio, che ho parlato con i colleghi non della pioggia che cadeva ma delle previsioni meteo, che ho discusso con gli studenti non di fatti ma delle interpretazioni che ne hanno dato giornali e televisione, e che affido queste mie considerazioni non ad un uditorio paziente ed amico, ma alla tastiera di un computer. Significa in sostanza che per quanto uno si sforzi di difendersi, di evadere in campagna o in Patagonia, e di sottrarsi al rimbambimento multimediale, non può sfuggire alla pervasività di un sistema che è tutt’uno con il suo ambiente di coltura, che è partito scavandosi una nicchia e ha finito per spianare la montagna. Cose trite e ritrite: ma proprio il fatto che appaiano scontate dimostra quanto sia considerato naturale un modo di vivere che di “naturale” non ha più nulla.
La storia è quella dell’ambiguo rapporto che da sempre gli uomini hanno intrattenuto con l’universo dei propri manufatti, con gli infiniti prodotti, materiali o immateriali, delle più svariate tecnologie, e di come tale rapporto sia degenerato in sudditanza nel corso dell’età moderna e contemporanea. Di come cioè negli ultimi tre secoli gli oggetti frutto di artificio si siano progressivamente emancipati dal controllo umano, costituendosi in seconda natura, sovrapponendosi alla natura originaria e soppiantandola, al punto che oggi per gran parte dell’umanità questa seconda natura è l’unica percepibile. E di come quella che nel mondo occidentale è da tempo una condizione comune si appresti a diventarlo in tutto il globo. Tradotto in polpettine tutto questo significa che da quando mi sono alzato stamani, anzi, da prima ancora di svegliarmi, ho avuto a che fare solo con case, auto, sanitari, elettrodomestici, asfalto, computer, telefono, ecc… Che ho intravisto – fuggevolmente – prati e boschi soltanto perché abito fuori città: ma che alla maggioranza dei miei simili non è data neppure questa opportunità. Significa che ho ascoltato musica e rumori e voci riprodotte dalla radio, che ho parlato con i colleghi non della pioggia che cadeva ma delle previsioni meteo, che ho discusso con gli studenti non di fatti ma delle interpretazioni che ne hanno dato giornali e televisione, e che affido queste mie considerazioni non ad un uditorio paziente ed amico, ma alla tastiera di un computer. Significa in sostanza che per quanto uno si sforzi di difendersi, di evadere in campagna o in Patagonia, e di sottrarsi al rimbambimento multimediale, non può sfuggire alla pervasività di un sistema che è tutt’uno con il suo ambiente di coltura, che è partito scavandosi una nicchia e ha finito per spianare la montagna. Cose trite e ritrite: ma proprio il fatto che appaiano scontate dimostra quanto sia considerato naturale un modo di vivere che di “naturale” non ha più nulla.
 Questa, si dirà, è una storia nota: ma nota, a quanto pare, non vuol dire conseguentemente acquisita, in tutte le sue implicazioni economiche, sociali e culturali, quanto piuttosto tumulata negli scaffali delle biblioteche o banalizzata dalle profezie di celestini vari, e terapeuti new age ed ecologisti patinati. Se davvero fossimo coscienti del senso e della reale portata di questa trasformazione ci renderemmo anche conto che i passi compiuti negli ultimi decenni muovono in una direzione ulteriore, quella che dall’interazione con gli oggetti porta all’ibridazione, e che magari varrebbe la pena pensarci su un attimo. Invece, malgrado gli sviluppi più recenti del rapporto uomo-macchina lascino pochi dubbi su dove si andrà a parare, l’inquietudine per le prospettive che si aprono continua a stimolare solo l’immaginario fantascientifico, mentre dove la riflessione pretende ad una dignità filosofica o scientifica sembra trionfare la più beata incoscienza (quando non la malafede). Ma forse è naturale che ciò accada. Nei confronti di un sistema fondato sul divenire incessante e progressivo l’unica forma di riflessione possibile è proprio l’anticipazione visionaria, quali che ne siano le matrici e gli intenti (sia cioè che nasca dai timori per le scelte presenti e ne prospetti esiti catastrofici o angosciosi, sia che tragga spunto invece da una fede incondizionata nella scienza e ne enfatizzi le risposte “vincenti”), È sempre stato così, in fondo, dalla rivoluzione scientifica in poi. Mentre Kant trovava nella razionalità i presupposti per la pace universale e Robespierre quelli per il trionfo dell’uguaglianza, Goethe sentiva l’odore di zolfo e di negromanzia esalato dalla tecnica moderna, e Frankenstein incarnava l’avvenire dell’Idea molto meglio della filosofia di Hegel. Conviene dunque rivolgerci un’altra volta, come vent’anni fa, alla fantascienza, letteraria o cinematografica, d’autore o di dozzina, per ritrovare le tracce del percorso che ha condotto all’attuale “incoscienza” o, peggio, all’accettazione consapevole del post-umano.
Questa, si dirà, è una storia nota: ma nota, a quanto pare, non vuol dire conseguentemente acquisita, in tutte le sue implicazioni economiche, sociali e culturali, quanto piuttosto tumulata negli scaffali delle biblioteche o banalizzata dalle profezie di celestini vari, e terapeuti new age ed ecologisti patinati. Se davvero fossimo coscienti del senso e della reale portata di questa trasformazione ci renderemmo anche conto che i passi compiuti negli ultimi decenni muovono in una direzione ulteriore, quella che dall’interazione con gli oggetti porta all’ibridazione, e che magari varrebbe la pena pensarci su un attimo. Invece, malgrado gli sviluppi più recenti del rapporto uomo-macchina lascino pochi dubbi su dove si andrà a parare, l’inquietudine per le prospettive che si aprono continua a stimolare solo l’immaginario fantascientifico, mentre dove la riflessione pretende ad una dignità filosofica o scientifica sembra trionfare la più beata incoscienza (quando non la malafede). Ma forse è naturale che ciò accada. Nei confronti di un sistema fondato sul divenire incessante e progressivo l’unica forma di riflessione possibile è proprio l’anticipazione visionaria, quali che ne siano le matrici e gli intenti (sia cioè che nasca dai timori per le scelte presenti e ne prospetti esiti catastrofici o angosciosi, sia che tragga spunto invece da una fede incondizionata nella scienza e ne enfatizzi le risposte “vincenti”), È sempre stato così, in fondo, dalla rivoluzione scientifica in poi. Mentre Kant trovava nella razionalità i presupposti per la pace universale e Robespierre quelli per il trionfo dell’uguaglianza, Goethe sentiva l’odore di zolfo e di negromanzia esalato dalla tecnica moderna, e Frankenstein incarnava l’avvenire dell’Idea molto meglio della filosofia di Hegel. Conviene dunque rivolgerci un’altra volta, come vent’anni fa, alla fantascienza, letteraria o cinematografica, d’autore o di dozzina, per ritrovare le tracce del percorso che ha condotto all’attuale “incoscienza” o, peggio, all’accettazione consapevole del post-umano.
 Se era ancora possibile ironizzare (ma mica poi tanto) sul catechismo biomeccanico predicato da Goldrake e compagni, e ascrivere Hal 9000, il calcolatore paranoico di “Odissea nello spazio”, al filone ormai classico dell’apprendista stregone (mentre in un altro genere ancora rientrano le macchine “animate”, come il “Katerpillar” di Sturgeon o il camion di “Duel”), con lo straordinario “Alien” di Ridley Scott (1979) i termini del problema sono stati spostati decisamente in avanti. L’alieno in questione è un organismo al penultimo stadio del divenire macchina, e quindi perfetto, invincibile e mostruosamente spietato, che si avvale anche della naturale alleanza in funzione anti-uomo di un androide, una macchina a sua volta all’ultimo stadio di evoluzione verso l’organico. Alien, a differenza di Hal 9000, non può essere sconfitto da alcuna superiorità logica o arma tecno-logica o alleanza con il “divino”: sarà battuto solo dal caso, da un comportamento illogico della sua antagonista e, soprattutto, dalla ferrea legge hollywoodiana dell’happy end. Meno sofisticato e metaforico, ma altrettanto indistruttibile e devastante è il cyborg di “Terminator” (1984): ancora un androide (quindi passaggio macchina-uomo) visto in negativo, che ribadisce però la superiorità adattiva, e quindi i rischi di incontrollabilità, del biomeccanico. In “Blade Runner”, però, (1982, ancora di Ridley Scott, da un romanzo di Philip K. Dick) fa già capolino un atteggiamento più possibilista; ai mutanti, androidi umanizzati sino alla composizione cellulare, è concessa in fondo la cittadinanza nel genere umano: Quando poi si tratti di cyborg inversi, cioè di uomini protesizzati, trasformati almeno parzialmente in macchine, i dubbi in genere svaniscono. Dall’uomo bionico al Robocop, cui di organico è rimasto solo il cervello, è tutto un festival di paladini del bene e della giustizia, non più importati da Krypton ma fabbricati in casa, prototipi per una futura commercializzazione in serie.
Se era ancora possibile ironizzare (ma mica poi tanto) sul catechismo biomeccanico predicato da Goldrake e compagni, e ascrivere Hal 9000, il calcolatore paranoico di “Odissea nello spazio”, al filone ormai classico dell’apprendista stregone (mentre in un altro genere ancora rientrano le macchine “animate”, come il “Katerpillar” di Sturgeon o il camion di “Duel”), con lo straordinario “Alien” di Ridley Scott (1979) i termini del problema sono stati spostati decisamente in avanti. L’alieno in questione è un organismo al penultimo stadio del divenire macchina, e quindi perfetto, invincibile e mostruosamente spietato, che si avvale anche della naturale alleanza in funzione anti-uomo di un androide, una macchina a sua volta all’ultimo stadio di evoluzione verso l’organico. Alien, a differenza di Hal 9000, non può essere sconfitto da alcuna superiorità logica o arma tecno-logica o alleanza con il “divino”: sarà battuto solo dal caso, da un comportamento illogico della sua antagonista e, soprattutto, dalla ferrea legge hollywoodiana dell’happy end. Meno sofisticato e metaforico, ma altrettanto indistruttibile e devastante è il cyborg di “Terminator” (1984): ancora un androide (quindi passaggio macchina-uomo) visto in negativo, che ribadisce però la superiorità adattiva, e quindi i rischi di incontrollabilità, del biomeccanico. In “Blade Runner”, però, (1982, ancora di Ridley Scott, da un romanzo di Philip K. Dick) fa già capolino un atteggiamento più possibilista; ai mutanti, androidi umanizzati sino alla composizione cellulare, è concessa in fondo la cittadinanza nel genere umano: Quando poi si tratti di cyborg inversi, cioè di uomini protesizzati, trasformati almeno parzialmente in macchine, i dubbi in genere svaniscono. Dall’uomo bionico al Robocop, cui di organico è rimasto solo il cervello, è tutto un festival di paladini del bene e della giustizia, non più importati da Krypton ma fabbricati in casa, prototipi per una futura commercializzazione in serie.
 Posso aver saltato qualche passaggio, ma credo che la morale di fondo sia comunque chiara: se la macchina si umanizza, qualche problema lo può anche dare (e non si vede come non essere d’accordo), mentre se è l’uomo a farsi macchina non gliene può venire che un gran bene. Che è poi la stessa morale rozzamente espressa a suo tempo dai cartoons giapponesi, e più rozzamente ancora da Romiti, e che negli ultimi anni è stata abbracciata con entusiasmo dalla ex-sinistra tradizionale di tutto l’occidente, in fregola di patti sociali e di standard di competitività. Ma le vie del post-umano, se non infinite, sono senz’altro molteplici: e quella più diretta, più recentemente aperta e già più frequentata passa per la “fantascienza dell’interno”, per il cyberpunk (il cui esponente di spicco è William Gibson). Il più aggiornato immaginario fantascientifico si libera della mediazione – in fondo esorcizzante – di alieni e astronavi interplanetarie, e riconduce l’azione sul vecchio pianeta, trasferendola in un futuro prossimo decisamente verosimile, caratterizzato da dinamiche del tutto o molto simili a quelle che noi tutti quotidianamente viviamo. Ma i suoi personaggi si muovono tra i ghetti di metropoli degradate e ingovernabili e una nuova dimensione definita cyberspazio, lo spazio digitale nel quale navigano le informazioni. All’interno di questa realtà virtuale si gioca il confronto tra i controllori della rete e della merce informatica e i ciberpunk, corsari del cyberspazio che utilizzano le loro conoscenze massmediologiche avanzate per sgusciare tra le maglie del sistema o per aggrovigliarle. Per la prima volta la letteratura del futuribile è cronaca romanzata del presente o addirittura del passato prossimo, epica della gesta degli hakers (i pirati del computer) e delle navigazioni ed esplorazioni informatiche. Ed interpreta l’aspettativa di una mutazione antropologica e mentale che in realtà è già operante e pervasiva, e che proprio per questo comincia ad essere fatta propria anche dalla riflessione sociale e politica.
Posso aver saltato qualche passaggio, ma credo che la morale di fondo sia comunque chiara: se la macchina si umanizza, qualche problema lo può anche dare (e non si vede come non essere d’accordo), mentre se è l’uomo a farsi macchina non gliene può venire che un gran bene. Che è poi la stessa morale rozzamente espressa a suo tempo dai cartoons giapponesi, e più rozzamente ancora da Romiti, e che negli ultimi anni è stata abbracciata con entusiasmo dalla ex-sinistra tradizionale di tutto l’occidente, in fregola di patti sociali e di standard di competitività. Ma le vie del post-umano, se non infinite, sono senz’altro molteplici: e quella più diretta, più recentemente aperta e già più frequentata passa per la “fantascienza dell’interno”, per il cyberpunk (il cui esponente di spicco è William Gibson). Il più aggiornato immaginario fantascientifico si libera della mediazione – in fondo esorcizzante – di alieni e astronavi interplanetarie, e riconduce l’azione sul vecchio pianeta, trasferendola in un futuro prossimo decisamente verosimile, caratterizzato da dinamiche del tutto o molto simili a quelle che noi tutti quotidianamente viviamo. Ma i suoi personaggi si muovono tra i ghetti di metropoli degradate e ingovernabili e una nuova dimensione definita cyberspazio, lo spazio digitale nel quale navigano le informazioni. All’interno di questa realtà virtuale si gioca il confronto tra i controllori della rete e della merce informatica e i ciberpunk, corsari del cyberspazio che utilizzano le loro conoscenze massmediologiche avanzate per sgusciare tra le maglie del sistema o per aggrovigliarle. Per la prima volta la letteratura del futuribile è cronaca romanzata del presente o addirittura del passato prossimo, epica della gesta degli hakers (i pirati del computer) e delle navigazioni ed esplorazioni informatiche. Ed interpreta l’aspettativa di una mutazione antropologica e mentale che in realtà è già operante e pervasiva, e che proprio per questo comincia ad essere fatta propria anche dalla riflessione sociale e politica.
Anche prescindendo dalle farneticanti scorribande tecno-mistiche di scuola statunitense, che non vanno comunque liquidate come espedienti da spettacolo, il cyber-pensiero ha una storia singolare. Affonda paradossalmente le sue radici nella critica di Baudrillard, di Touraine e di altri post-sessantottini alla modernità e al “sistema degli oggetti”, passa per la deriva situazionista dell’appropriazione-smascheramento della tecnica e per le “macchine desideranti” di Deleuze e Guattari, e approda da ultimo alla compiuta teorizzazione del “postumano” come ineludibile e positiva risposta all’avvento della dimensione artificiale. (cfr. Maurizio Terrosi, ne “La filosofia del post-umano”, 1997). Le implicazioni politiche sono immediate. Se in un primo momento l’appropriazione delle abilità informatiche veniva giustificata ai fini di un’azione di disturbo, delle piratesche incursioni in rete degli hakers che consentivano di destrutturare il sistema planetario di informazione-comunicazione e di disvelarne le caratteristiche autoritarie e antidemocratiche, oggi “vi è una speranza, assai diffusa in alcuni settori della nostra società, che le teletecnologie interattive e multimediali possano contribuire ad un drastico spiazzamento del nostro presente modo di intendere e di praticare la democrazia, Si confida che queste tecnologie siano in grado, in sé e per sé, di aprire la strada a una versione diretta, ossia partecipativa, di democrazia”. (Tòmas Maldonado)
 Siamo quindi alla lettura democratica dell’allacciamento in rete di cervelli e volontà, della dilatazione artificiale delle capacità mentali e interattive; lettura che nasce nella “sinistra” dall’ansia di essere più realista del re, dal timore di trovarsi nelle retrovie in un’epoca nella quale sembra scemare l’importanza del dominio sui corpi (che era strategico per la civiltà industriale) e divenire determinante quello sulle menti. Ciò spiega la relativa indifferenza (o anche la benevola curiosità) con la quale viene vissuta l’invasione tecnologica dei corpi. Il corpo umano, che serviva per produrre merci, diviene meno importante, meno sacro, dal momento che il processo produttivo si basa oggi principalmente sulla trasmissione, sulla accumulazione e sulla gestione di dati, e non sulla produzione materiale. Il piccolo particolare che nei cinque sesti del mondo si stia intensificando il dominio e lo sfruttamento dei corpi per produrre merci materiali a costi irrisori viene considerato ininfluente (e fastidioso e anacronistico riesce chi cerca di rammentarlo).
Siamo quindi alla lettura democratica dell’allacciamento in rete di cervelli e volontà, della dilatazione artificiale delle capacità mentali e interattive; lettura che nasce nella “sinistra” dall’ansia di essere più realista del re, dal timore di trovarsi nelle retrovie in un’epoca nella quale sembra scemare l’importanza del dominio sui corpi (che era strategico per la civiltà industriale) e divenire determinante quello sulle menti. Ciò spiega la relativa indifferenza (o anche la benevola curiosità) con la quale viene vissuta l’invasione tecnologica dei corpi. Il corpo umano, che serviva per produrre merci, diviene meno importante, meno sacro, dal momento che il processo produttivo si basa oggi principalmente sulla trasmissione, sulla accumulazione e sulla gestione di dati, e non sulla produzione materiale. Il piccolo particolare che nei cinque sesti del mondo si stia intensificando il dominio e lo sfruttamento dei corpi per produrre merci materiali a costi irrisori viene considerato ininfluente (e fastidioso e anacronistico riesce chi cerca di rammentarlo).
Anche le implicazioni socioculturali del cyber-pensiero sono eclatanti. I nuovi media vengono considerati per loro natura e struttura “egualitari”, a differenza di quelli più antichi (vedi: libro), che avevano una connotazione classista ed esclusiva. La loro “manipolazione” è aperta a tutti, e il problema concerne non gli strumenti in sé, ma chi li usa e a quale scopo. È il vecchio ritornello della tecnologia “neutrale”, né buona né cattiva, pura possibilità imparzialmente offerta a tutti, che si credeva dimenticato e che viene invece riproposto in un nuovo arrangiamento.
Questo è dunque lo stato odierno della “ragione informatica”, e anche da una sintesi confusa e incompleta come quella proposta si può intuire quale sinistra (appunto) piega le cose possano prendere. Vale forse la pena fermarsi un attimo, prendere respiro e cercare di orientarsi tra i fumi turibolari del nuovo credo tecnologico. L’unica cosa su cui non si può non convenire è che è in atto, e in stato già avanzato, una vera e propria mutazione psicofisica dell’uomo, frutto dell’innesto stravolgente del meccanico, o più estesamente, dell’artificiale, sul biologico: è il passaggio dall’umano al post-umano, appunto. Di tale trasformazione noi percepiamo distintamente solo taluni risvolti, di per sé positivi, ma carichi di ambiguità (organi artificiali, protesi, ecc…, intesi per il momento a correggere carenze, malformazioni o mutilazioni, ma passibili domani di ben altro utilizzo); mentre rifiutiamo di cogliere il senso e le implicazioni profonde del fenomeno, e tendiamo a leggerlo come la naturale prosecuzione di un percorso avviatosi migliaia, o forse milioni di anni fa, quando l’uomo ha iniziato a produrre strumenti e manufatti, e a subirne la fascinazione. Ciò che ai più sfugge è che la terza rivoluzione industriale, quella dell’automazione, dell’informatica e della telematica, non si è limitata ad accelerare questo processo, ma ha creato l’humus per l’instaurazione di un rapporto “organico” con gli oggetti, per il salto dal rapporto di utilizzo a quello di simbiosi e, in prospettiva, a quello di sudditanza. Ha creato, cioè, non solo le condizioni ma anche e soprattutto la necessità di un rapido adeguamento dell’essere umano alla trasformazione ambientale.
Ora, il meccanismo delle risposte adattive, quello che i biologi chiamano evoluzione, funziona da quando esiste la vita, e interessa tutte le specie. C’è solo un particolare. Nel caso dell’uomo ha funzionato sin troppo. La specie umana è saltata dal lento carro dell’evoluzione sull’accelerato della civilizzazione, ed ha poi spinto a tavoletta sino a trasformare quest’ultimo in un TGV. Prima si è adattata a tutti gli ambienti, poi ha cominciato ad adattare gli ambienti a sé. E nel fare ciò, nel modificare l’ambiente – inteso nel senso lato dell’insieme di operatività, comunicazione, interrelazione, ecc … – l’uomo è andato talmente oltre da dover ora rimodellare, ri-adattare a quest’ultimo la propria morfologia, intervenendo artificialmente per l’impossibilità di conciliare i tempi lunghissimi del processo evolutivo con quelli frenetici del sistema produttivo (e magari anche per scongiurare esiti imprevisti e non graditi).
Ciò che rende necessaria (e possibile) oggi questa operazione, la chiave che ha aperto le porte del corpo all’invasione tecnologica, è probabilmente da rintracciarsi nell’introduzione di modalità diverse dell’esperienza e dell’uso del tempo. Ogni tecnologia, anche la più semplice o la più primitiva, ha senza dubbio determinato uno sfasamento progressivo tra i ritmi biologici e quelli “culturali”: ma lo stacco decisivo, quello che ha spalancato la forbice, si è verificato allorché alla colonizzazione dello spazio (conquista e trasformazione dell’ambiente) si è sovrapposta quella della dimensione temporale (imprigionamento del tempo in congegni meccanici). L’orologio meccanico ha sostituito la percezione ciclica e naturalmente scandita delle durate (cicli diurni, lunari, stagionali, ecc …) con la loro segmentazione in una sequenza rettilinea, uniforme e ininterrotta Ha trasformato un’esperienza interiore elastica ed individuale, solo occasionalmente intersecata da scadenze collettive (rituali, festività, ecc …) e comunque condivisa, anche in queste occasioni, da gruppi ristretti, in un rigido parametro esterno, misura universale e freddamente oggettiva dell’interagire tra gli umani e del loro rapportarsi produttivo allo spazio e alle cose (cioè degli spostamenti e delle lavorazioni). Ha desacralizzato il tempo, svuotandolo di ogni autonomo significato connesso alla soggettività (quale, ad esempio, il radicamento che consegue all’abitare un luogo per una vita o per generazioni, oppure la traduzione del passato in memoria) per riempirlo di un “valore” assoluto (il tempo-denaro). Lo ha sminuzzato in particelle sempre più infinitesimali per poterne gestire ogni singolo frammento e comprimerne ogni interstizio.
Agli effetti pratici questa coscienza “meccanica” del tempo ha reso possibile l’eliminazione di ogni lasso temporale non produttivo – dai tempi “sacri” del calendario a quelli “morti” nelle lavorazioni – o la riconduzione degli stessi nell’alveo del sistema totalizzante produzione-consumo. Ma ha anche modificato le modalità di percezione e di occupazione dello spazio, nonché la tipologia delle prestazioni richieste all’organismo umano. La corsa al contenimento dei tempi di produzione ha indotto il passaggio alla meccanizzazione e al taylorismo, e successivamente all’automazione. Ne è conseguita una crescita esponenziale del prodotto, che ha portato la progressiva dilatazione dei mercati – sino all’odierna globalità – e la necessità per l’uomo di velocizzare gli spostamenti suoi (anzi, di passare dal viaggio allo spostamento) e delle merci, e di rapportarsi concretamente a distanze sempre più ampie. Ciò ha interessato naturalmente la circolazione di qualsiasi tipo di prodotto, materiale ma anche, e oggi principalmente, culturale.
Le tecnologie della mobilità e quelle della comunicazione hanno dunque ristretto il mondo, comprimendo le prime i tempi di percorrenza dell’intero globo in un arco solare, le seconde riducendoli a zero, consentendo una presenza virtuale in tempo reale. E questi risultati sono gravidi di conseguenze. Per quanto contenuti possano essere infatti i tempi del nostro spostamento, non è possibile occupare fisicamente spazi diversi nello stesso momento: mentre è possibile farlo virtualmente, interagire con essi o controllarli attraverso le protesi comunicative e informazionali. È quanto già quotidianamente accade, ma è soprattutto la nostra condizione futura di “cittadini terminali, handicappati motori superequipaggiati di protesi interattive, di ricettori e sensori” (Paul Virilio) attraverso i quali possono essere controllati contemporaneamente gli spazi esterni della produzione e quelli domestici del consumo. Tale condizione, anche senza necessariamente sfociare nella patologia della perdita di motricità e di coscienza tattile, crea comunque esigenze operative alle quali il vecchio modello naturale non è più in grado di fare fronte: e se in occasione di altre svolte epocali (dalla domesticazione del fuoco e degli animali alla stanzialità, dalla nascita della metallurgia alla rivoluzione agricola, fino alle prime rivoluzioni industriali) l’organismo umano ha potuto trarre da sé le risorse per la risposta, selezionando e potenziando di volta in volta caratteristiche adattive preesistenti, oggi le nuove modalità e le urgenze dell’adeguamento sono tali da indurre una sua capitolazione.
È a questo punto che si pone il discrimine: la linea di confine si fa sempre più sottile e diviene possibile il balzo nel post-umano. Se oggi possiamo scegliere di potenziare o meno le nostre abilità, allacciando i nostri cervelli alle reti telematiche, le nostre voci a quelle telefoniche, i nostri corpi a quelle stradali, o aeree o ferroviarie, il prossimo passo sarà quello dell’allacciamento coatto, della vera e propria in-corporazione dell’apparato tecnologico che medierà i nostri rapporti con gli altri post-umani e con la natura seconda.
Il problema, come si è visto, non concerne nemmeno più la possibilità che ciò avvenga, per certi aspetti è già avvenuto. La prima fase del trasferimento dell’umanità alla dimensione artificiale, quella del condizionamento mediatico, è ormai alle nostre spalle; essa costituisce già il patrimonio culturale di un paio di generazioni, per le quali l’universo delle conoscenze e delle competenze è divenuto meramente virtuale, e la consuetudine con i supporti tecnologici, favorita dai prodigi della miniaturizzazione e quindi dalla portatilità (telefonini, walkmen, computer portatili, ecc…) si è tradotta in dipendenza. Ma anche la seconda fase, quella di attuazione delle biotecnologie e della biomeccanica, è bene avviata: le pionieristiche banche di organi e la fecondazione in vitro sono già rese obsolete dalle potenzialità della clonazione, l’ingegneria genetica consente di selezionare o creare ex-novo caratteri adattivi, la biomeccanica di tradurre in impulsi elettrici gli stimoli nervosi, interfacciando le protesi con i terminali corticali.
Si apre così la strada al terzo stadio, quello che prevede la combinazione delle tecnologie invasive (interventi diretti sul corpo, sostituzione e rigenerazione di organi, potenziatori sensoriali, ecc…) con quelle estensive (che comprendono qualsivoglia protesi, da quelle motorie – dal martello alla macchina utensile computerizzata – a quelle di sussidio alla locomozione e al trasporto, da quelle sensorio-percettive – dagli occhiali al telefono, ai riproduttori di immagini e suoni – fino a quelle intellettive – da ogni forma di linguaggio al computer), e in parallelo, come naturale conseguenza, la totale de-naturalizzazione delle esperienze sensoriali e psichiche, canalizzate verso la natura seconda artificiale o verso la dimensione virtuale non più soltanto dalla persuasione mediatica (esterna) ma da un interfacciamento diretto. Per intanto siamo già al tamagochi, criceto o pesce rosso virtuale, ai caschi per la full immersion nello spazio virtuale, al sesso virtuale, ecc…: non ci vuole molta fantasia per immaginare ulteriori virtualizzazioni). La miniaturizzazione, la concentrazione di energia di lunga durata in microcapsule, la realizzazione o l’utilizzo di materiali sempre più omogenei alle strutture organiche consentirà di inserire direttamente nell’organismo umano protesi di ogni tipo, collegamenti intra-circolatori, recettori e terminali di sensorialità e di sensibilità (e perché no, di sessualità). Per poter rispondere alla moltiplicazione degli stimoli e alla dilatazione degli impegni, ovvero per poter svolgere contemporaneamente attività diverse, i corpi dovranno essere ri-adeguati, attrezzati con artefatti di minimo ingombro e il più possibile celati, per l’appunto in-corporati. È facile ipotizzare, ad esempio, che per ovviare alle restrizioni legislative sull’uso dei telefoni cellulari si arriverà a brevissimo termine all’inserimento di micro-ricevitori permanenti nei padiglioni auricolari, compiendo un ulteriore passo verso la telepatia artificiale. Ed è altrettanto immediato far correre la memoria a certi film fantascientifici anni cinquanta, o al “Mio fratello superuomo” di Bozzetto, che mostravano gli umani collegati attraverso microricettori ad una emittente centrale di controllo.
Non ha più molto senso, dunque, dubitare ancora dell’effettiva comparsa di una mutazione del corpo umano, o meglio del suo declassamento a struttura da controllare e modificare: Si impone invece una riflessione seria sul nostro atteggiamento in proposito. Quello che a me (e spero anche ad altri) parrebbe automatico – anzi, no, naturale –, il rifiuto di ogni invasione protesica non surrogativa o integrativa, ma amplificativa, non limitata cioè a ripristinare la funzionalità corporea ma mirante ad ottimizzare il rapporto di intervento sul o di conoscenza dell’ambiente, non riscuote in generale molte simpatie, e meno che mai, come si è visto, a sinistra. Se il pensiero tradizionale, laico o religioso, è frenato più che dal rispetto del corpo (nei confronti del quale, anzi, la cultura cristiana ha nutrito da sempre un certo disprezzo) dalla connaturata diffidenza per ogni novità o cambiamento (almeno per quelli non riconducibili in qualche modo a ad archetipi), quella progressista non conosce questi timori, né altre reverenze, e preferisce liquidare il rifiuto o la perplessità come patetici atteggiamenti tecnofobi o resistenziali., ai quali va opposta invece un’attitudine aperta e disincantata. Ora, per quanto aperto uno sia non può non rendersi conto che la strategia della liberalizzazione totale dei media e delle reti, quella per intenderci che dovrebbe esaltare i contenuti emancipatori e democratici delle tecnologie informatiche e che viene al momento identificata ad esempio con Internet, è perseguita soprattutto dai grandi monopoli multinazionali, nei quali è difficile sospettare una qualche sollecitudine per il futuro della democrazia. O ancora, che il disincanto nei confronti dell’invasione corporea e mentale non può spingersi sino ad ignorare come le maggiori pressioni in tal senso vengano dall’area del potere economico e politico, che evidentemente ha già messo nel conto le tattiche di gestione del mutamento. Non si tratta qui di riesumare i fantasmi di un complotto capitalistico mondiale, di una diabolica macchinazione ordita da centri di potere occulti; oltre che ridicolo sarebbe anche troppo bello, perché offrirebbe la possibilità di identificare un nemico concreto contro il quale battersi. Si tratta invece di far valere un minimo di buon senso, quello sufficiente a capire che ciò di cui si parla è un fenomeno sfuggito già da tempo al controllo di qualsiasi potentato e ormai autonormativo, un modo di produzione che è diventato sistema globale, nel senso non soltanto che interessa tutto il globo, ma che tende ad inglobare, ad incorporare ogni attività performativa o conoscitiva del reale, e quindi gli organi che la sviluppano, e a rendere il tutto funzionale alla propria perpetuazione. Altro che tecnologia neutrale, da padroneggiare e amare e sottrarre alle voglie dei cattivi. La metafora di Alien qui torna a pennello: il mostro è invincibile, e si alimenta di tutto, anche e principalmente delle nostre abilità e specializzazioni. Ma un buco, un portellone aperto dal quale possa irrompere il caso e risucchiare la minaccia nel vuoto in genere rimane: difendiamolo da noi stessi, dalla nostra presunzione e dalla paura degli spifferi.


 Vedere e fotografare, nell’accezione più pura, significa esser consapevole dell’“unicità” di ciò che si sta guardando, che è tale in un tempo concluso, ovvero in quel preciso momento, scegliere di fermare quell’istante e di fissarlo attraverso il mezzo fotografico. Questo gesto richiede una – seppur mediocre – padronanza tecnica, la capacità di mettere a fuoco e isolare il soggetto all’interno dello spazio che occupa, la percezione istintiva della quantità di luce necessaria ad evidenziare ciò che l’obiettivo inquadra, ma soprattutto una buona dose di lucidità e di distacco: ovvero un coinvolgimento emotivo controllato, almeno un po’. È senz’altro necessaria anche una certa presunzione nel riproporre soggetti che quasi sicuramente sono stati fotografati da altri molto più bravi. Basta fare una ricerca in rete per vedere foto davvero belle che fissano quel paesaggio, quel fiore o quello scorcio che ci apprestiamo a fotografare.
Vedere e fotografare, nell’accezione più pura, significa esser consapevole dell’“unicità” di ciò che si sta guardando, che è tale in un tempo concluso, ovvero in quel preciso momento, scegliere di fermare quell’istante e di fissarlo attraverso il mezzo fotografico. Questo gesto richiede una – seppur mediocre – padronanza tecnica, la capacità di mettere a fuoco e isolare il soggetto all’interno dello spazio che occupa, la percezione istintiva della quantità di luce necessaria ad evidenziare ciò che l’obiettivo inquadra, ma soprattutto una buona dose di lucidità e di distacco: ovvero un coinvolgimento emotivo controllato, almeno un po’. È senz’altro necessaria anche una certa presunzione nel riproporre soggetti che quasi sicuramente sono stati fotografati da altri molto più bravi. Basta fare una ricerca in rete per vedere foto davvero belle che fissano quel paesaggio, quel fiore o quello scorcio che ci apprestiamo a fotografare.



















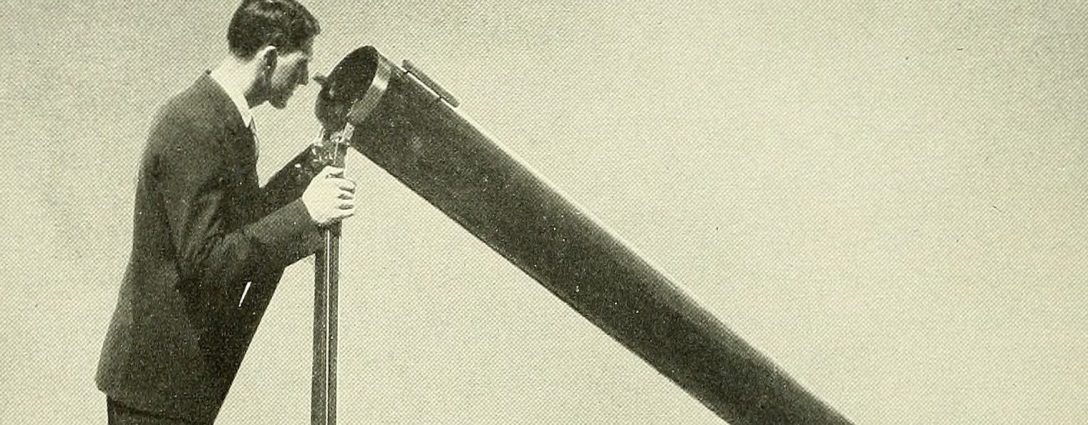


 La storia è quella dell’ambiguo rapporto che da sempre gli uomini hanno intrattenuto con l’universo dei propri manufatti, con gli infiniti prodotti, materiali o immateriali, delle più svariate tecnologie, e di come tale rapporto sia degenerato in sudditanza nel corso dell’età moderna e contemporanea. Di come cioè negli ultimi tre secoli gli oggetti frutto di artificio si siano progressivamente emancipati dal controllo umano, costituendosi in seconda natura, sovrapponendosi alla natura originaria e soppiantandola, al punto che oggi per gran parte dell’umanità questa seconda natura è l’unica percepibile. E di come quella che nel mondo occidentale è da tempo una condizione comune si appresti a diventarlo in tutto il globo. Tradotto in polpettine tutto questo significa che da quando mi sono alzato stamani, anzi, da prima ancora di svegliarmi, ho avuto a che fare solo con case, auto, sanitari, elettrodomestici, asfalto, computer, telefono, ecc… Che ho intravisto – fuggevolmente – prati e boschi soltanto perché abito fuori città: ma che alla maggioranza dei miei simili non è data neppure questa opportunità. Significa che ho ascoltato musica e rumori e voci riprodotte dalla radio, che ho parlato con i colleghi non della pioggia che cadeva ma delle previsioni meteo, che ho discusso con gli studenti non di fatti ma delle interpretazioni che ne hanno dato giornali e televisione, e che affido queste mie considerazioni non ad un uditorio paziente ed amico, ma alla tastiera di un computer. Significa in sostanza che per quanto uno si sforzi di difendersi, di evadere in campagna o in Patagonia, e di sottrarsi al rimbambimento multimediale, non può sfuggire alla pervasività di un sistema che è tutt’uno con il suo ambiente di coltura, che è partito scavandosi una nicchia e ha finito per spianare la montagna. Cose trite e ritrite: ma proprio il fatto che appaiano scontate dimostra quanto sia considerato naturale un modo di vivere che di “naturale” non ha più nulla.
La storia è quella dell’ambiguo rapporto che da sempre gli uomini hanno intrattenuto con l’universo dei propri manufatti, con gli infiniti prodotti, materiali o immateriali, delle più svariate tecnologie, e di come tale rapporto sia degenerato in sudditanza nel corso dell’età moderna e contemporanea. Di come cioè negli ultimi tre secoli gli oggetti frutto di artificio si siano progressivamente emancipati dal controllo umano, costituendosi in seconda natura, sovrapponendosi alla natura originaria e soppiantandola, al punto che oggi per gran parte dell’umanità questa seconda natura è l’unica percepibile. E di come quella che nel mondo occidentale è da tempo una condizione comune si appresti a diventarlo in tutto il globo. Tradotto in polpettine tutto questo significa che da quando mi sono alzato stamani, anzi, da prima ancora di svegliarmi, ho avuto a che fare solo con case, auto, sanitari, elettrodomestici, asfalto, computer, telefono, ecc… Che ho intravisto – fuggevolmente – prati e boschi soltanto perché abito fuori città: ma che alla maggioranza dei miei simili non è data neppure questa opportunità. Significa che ho ascoltato musica e rumori e voci riprodotte dalla radio, che ho parlato con i colleghi non della pioggia che cadeva ma delle previsioni meteo, che ho discusso con gli studenti non di fatti ma delle interpretazioni che ne hanno dato giornali e televisione, e che affido queste mie considerazioni non ad un uditorio paziente ed amico, ma alla tastiera di un computer. Significa in sostanza che per quanto uno si sforzi di difendersi, di evadere in campagna o in Patagonia, e di sottrarsi al rimbambimento multimediale, non può sfuggire alla pervasività di un sistema che è tutt’uno con il suo ambiente di coltura, che è partito scavandosi una nicchia e ha finito per spianare la montagna. Cose trite e ritrite: ma proprio il fatto che appaiano scontate dimostra quanto sia considerato naturale un modo di vivere che di “naturale” non ha più nulla. Questa, si dirà, è una storia nota: ma nota, a quanto pare, non vuol dire conseguentemente acquisita, in tutte le sue implicazioni economiche, sociali e culturali, quanto piuttosto tumulata negli scaffali delle biblioteche o banalizzata dalle profezie di celestini vari, e terapeuti new age ed ecologisti patinati. Se davvero fossimo coscienti del senso e della reale portata di questa trasformazione ci renderemmo anche conto che i passi compiuti negli ultimi decenni muovono in una direzione ulteriore, quella che dall’interazione con gli oggetti porta all’ibridazione, e che magari varrebbe la pena pensarci su un attimo. Invece, malgrado gli sviluppi più recenti del rapporto uomo-macchina lascino pochi dubbi su dove si andrà a parare, l’inquietudine per le prospettive che si aprono continua a stimolare solo l’immaginario fantascientifico, mentre dove la riflessione pretende ad una dignità filosofica o scientifica sembra trionfare la più beata incoscienza (quando non la malafede). Ma forse è naturale che ciò accada. Nei confronti di un sistema fondato sul divenire incessante e progressivo l’unica forma di riflessione possibile è proprio l’anticipazione visionaria, quali che ne siano le matrici e gli intenti (sia cioè che nasca dai timori per le scelte presenti e ne prospetti esiti catastrofici o angosciosi, sia che tragga spunto invece da una fede incondizionata nella scienza e ne enfatizzi le risposte “vincenti”), È sempre stato così, in fondo, dalla rivoluzione scientifica in poi. Mentre Kant trovava nella razionalità i presupposti per la pace universale e Robespierre quelli per il trionfo dell’uguaglianza, Goethe sentiva l’odore di zolfo e di negromanzia esalato dalla tecnica moderna, e Frankenstein incarnava l’avvenire dell’Idea molto meglio della filosofia di Hegel. Conviene dunque rivolgerci un’altra volta, come vent’anni fa, alla fantascienza, letteraria o cinematografica, d’autore o di dozzina, per ritrovare le tracce del percorso che ha condotto all’attuale “incoscienza” o, peggio, all’accettazione consapevole del post-umano.
Questa, si dirà, è una storia nota: ma nota, a quanto pare, non vuol dire conseguentemente acquisita, in tutte le sue implicazioni economiche, sociali e culturali, quanto piuttosto tumulata negli scaffali delle biblioteche o banalizzata dalle profezie di celestini vari, e terapeuti new age ed ecologisti patinati. Se davvero fossimo coscienti del senso e della reale portata di questa trasformazione ci renderemmo anche conto che i passi compiuti negli ultimi decenni muovono in una direzione ulteriore, quella che dall’interazione con gli oggetti porta all’ibridazione, e che magari varrebbe la pena pensarci su un attimo. Invece, malgrado gli sviluppi più recenti del rapporto uomo-macchina lascino pochi dubbi su dove si andrà a parare, l’inquietudine per le prospettive che si aprono continua a stimolare solo l’immaginario fantascientifico, mentre dove la riflessione pretende ad una dignità filosofica o scientifica sembra trionfare la più beata incoscienza (quando non la malafede). Ma forse è naturale che ciò accada. Nei confronti di un sistema fondato sul divenire incessante e progressivo l’unica forma di riflessione possibile è proprio l’anticipazione visionaria, quali che ne siano le matrici e gli intenti (sia cioè che nasca dai timori per le scelte presenti e ne prospetti esiti catastrofici o angosciosi, sia che tragga spunto invece da una fede incondizionata nella scienza e ne enfatizzi le risposte “vincenti”), È sempre stato così, in fondo, dalla rivoluzione scientifica in poi. Mentre Kant trovava nella razionalità i presupposti per la pace universale e Robespierre quelli per il trionfo dell’uguaglianza, Goethe sentiva l’odore di zolfo e di negromanzia esalato dalla tecnica moderna, e Frankenstein incarnava l’avvenire dell’Idea molto meglio della filosofia di Hegel. Conviene dunque rivolgerci un’altra volta, come vent’anni fa, alla fantascienza, letteraria o cinematografica, d’autore o di dozzina, per ritrovare le tracce del percorso che ha condotto all’attuale “incoscienza” o, peggio, all’accettazione consapevole del post-umano. Se era ancora possibile ironizzare (ma mica poi tanto) sul catechismo biomeccanico predicato da Goldrake e compagni, e ascrivere Hal 9000, il calcolatore paranoico di “Odissea nello spazio”, al filone ormai classico dell’apprendista stregone (mentre in un altro genere ancora rientrano le macchine “animate”, come il “Katerpillar” di Sturgeon o il camion di “Duel”), con lo straordinario “Alien” di Ridley Scott (1979) i termini del problema sono stati spostati decisamente in avanti. L’alieno in questione è un organismo al penultimo stadio del divenire macchina, e quindi perfetto, invincibile e mostruosamente spietato, che si avvale anche della naturale alleanza in funzione anti-uomo di un androide, una macchina a sua volta all’ultimo stadio di evoluzione verso l’organico. Alien, a differenza di Hal 9000, non può essere sconfitto da alcuna superiorità logica o arma tecno-logica o alleanza con il “divino”: sarà battuto solo dal caso, da un comportamento illogico della sua antagonista e, soprattutto, dalla ferrea legge hollywoodiana dell’happy end. Meno sofisticato e metaforico, ma altrettanto indistruttibile e devastante è il cyborg di “Terminator” (1984): ancora un androide (quindi passaggio macchina-uomo) visto in negativo, che ribadisce però la superiorità adattiva, e quindi i rischi di incontrollabilità, del biomeccanico. In “Blade Runner”, però, (1982, ancora di Ridley Scott, da un romanzo di Philip K. Dick) fa già capolino un atteggiamento più possibilista; ai mutanti, androidi umanizzati sino alla composizione cellulare, è concessa in fondo la cittadinanza nel genere umano: Quando poi si tratti di cyborg inversi, cioè di uomini protesizzati, trasformati almeno parzialmente in macchine, i dubbi in genere svaniscono. Dall’uomo bionico al Robocop, cui di organico è rimasto solo il cervello, è tutto un festival di paladini del bene e della giustizia, non più importati da Krypton ma fabbricati in casa, prototipi per una futura commercializzazione in serie.
Se era ancora possibile ironizzare (ma mica poi tanto) sul catechismo biomeccanico predicato da Goldrake e compagni, e ascrivere Hal 9000, il calcolatore paranoico di “Odissea nello spazio”, al filone ormai classico dell’apprendista stregone (mentre in un altro genere ancora rientrano le macchine “animate”, come il “Katerpillar” di Sturgeon o il camion di “Duel”), con lo straordinario “Alien” di Ridley Scott (1979) i termini del problema sono stati spostati decisamente in avanti. L’alieno in questione è un organismo al penultimo stadio del divenire macchina, e quindi perfetto, invincibile e mostruosamente spietato, che si avvale anche della naturale alleanza in funzione anti-uomo di un androide, una macchina a sua volta all’ultimo stadio di evoluzione verso l’organico. Alien, a differenza di Hal 9000, non può essere sconfitto da alcuna superiorità logica o arma tecno-logica o alleanza con il “divino”: sarà battuto solo dal caso, da un comportamento illogico della sua antagonista e, soprattutto, dalla ferrea legge hollywoodiana dell’happy end. Meno sofisticato e metaforico, ma altrettanto indistruttibile e devastante è il cyborg di “Terminator” (1984): ancora un androide (quindi passaggio macchina-uomo) visto in negativo, che ribadisce però la superiorità adattiva, e quindi i rischi di incontrollabilità, del biomeccanico. In “Blade Runner”, però, (1982, ancora di Ridley Scott, da un romanzo di Philip K. Dick) fa già capolino un atteggiamento più possibilista; ai mutanti, androidi umanizzati sino alla composizione cellulare, è concessa in fondo la cittadinanza nel genere umano: Quando poi si tratti di cyborg inversi, cioè di uomini protesizzati, trasformati almeno parzialmente in macchine, i dubbi in genere svaniscono. Dall’uomo bionico al Robocop, cui di organico è rimasto solo il cervello, è tutto un festival di paladini del bene e della giustizia, non più importati da Krypton ma fabbricati in casa, prototipi per una futura commercializzazione in serie. Posso aver saltato qualche passaggio, ma credo che la morale di fondo sia comunque chiara: se la macchina si umanizza, qualche problema lo può anche dare (e non si vede come non essere d’accordo), mentre se è l’uomo a farsi macchina non gliene può venire che un gran bene. Che è poi la stessa morale rozzamente espressa a suo tempo dai cartoons giapponesi, e più rozzamente ancora da Romiti, e che negli ultimi anni è stata abbracciata con entusiasmo dalla ex-sinistra tradizionale di tutto l’occidente, in fregola di patti sociali e di standard di competitività. Ma le vie del post-umano, se non infinite, sono senz’altro molteplici: e quella più diretta, più recentemente aperta e già più frequentata passa per la “fantascienza dell’interno”, per il cyberpunk (il cui esponente di spicco è William Gibson). Il più aggiornato immaginario fantascientifico si libera della mediazione – in fondo esorcizzante – di alieni e astronavi interplanetarie, e riconduce l’azione sul vecchio pianeta, trasferendola in un futuro prossimo decisamente verosimile, caratterizzato da dinamiche del tutto o molto simili a quelle che noi tutti quotidianamente viviamo. Ma i suoi personaggi si muovono tra i ghetti di metropoli degradate e ingovernabili e una nuova dimensione definita cyberspazio, lo spazio digitale nel quale navigano le informazioni. All’interno di questa realtà virtuale si gioca il confronto tra i controllori della rete e della merce informatica e i ciberpunk, corsari del cyberspazio che utilizzano le loro conoscenze massmediologiche avanzate per sgusciare tra le maglie del sistema o per aggrovigliarle. Per la prima volta la letteratura del futuribile è cronaca romanzata del presente o addirittura del passato prossimo, epica della gesta degli hakers (i pirati del computer) e delle navigazioni ed esplorazioni informatiche. Ed interpreta l’aspettativa di una mutazione antropologica e mentale che in realtà è già operante e pervasiva, e che proprio per questo comincia ad essere fatta propria anche dalla riflessione sociale e politica.
Posso aver saltato qualche passaggio, ma credo che la morale di fondo sia comunque chiara: se la macchina si umanizza, qualche problema lo può anche dare (e non si vede come non essere d’accordo), mentre se è l’uomo a farsi macchina non gliene può venire che un gran bene. Che è poi la stessa morale rozzamente espressa a suo tempo dai cartoons giapponesi, e più rozzamente ancora da Romiti, e che negli ultimi anni è stata abbracciata con entusiasmo dalla ex-sinistra tradizionale di tutto l’occidente, in fregola di patti sociali e di standard di competitività. Ma le vie del post-umano, se non infinite, sono senz’altro molteplici: e quella più diretta, più recentemente aperta e già più frequentata passa per la “fantascienza dell’interno”, per il cyberpunk (il cui esponente di spicco è William Gibson). Il più aggiornato immaginario fantascientifico si libera della mediazione – in fondo esorcizzante – di alieni e astronavi interplanetarie, e riconduce l’azione sul vecchio pianeta, trasferendola in un futuro prossimo decisamente verosimile, caratterizzato da dinamiche del tutto o molto simili a quelle che noi tutti quotidianamente viviamo. Ma i suoi personaggi si muovono tra i ghetti di metropoli degradate e ingovernabili e una nuova dimensione definita cyberspazio, lo spazio digitale nel quale navigano le informazioni. All’interno di questa realtà virtuale si gioca il confronto tra i controllori della rete e della merce informatica e i ciberpunk, corsari del cyberspazio che utilizzano le loro conoscenze massmediologiche avanzate per sgusciare tra le maglie del sistema o per aggrovigliarle. Per la prima volta la letteratura del futuribile è cronaca romanzata del presente o addirittura del passato prossimo, epica della gesta degli hakers (i pirati del computer) e delle navigazioni ed esplorazioni informatiche. Ed interpreta l’aspettativa di una mutazione antropologica e mentale che in realtà è già operante e pervasiva, e che proprio per questo comincia ad essere fatta propria anche dalla riflessione sociale e politica. Siamo quindi alla lettura democratica dell’allacciamento in rete di cervelli e volontà, della dilatazione artificiale delle capacità mentali e interattive; lettura che nasce nella “sinistra” dall’ansia di essere più realista del re, dal timore di trovarsi nelle retrovie in un’epoca nella quale sembra scemare l’importanza del dominio sui corpi (che era strategico per la civiltà industriale) e divenire determinante quello sulle menti. Ciò spiega la relativa indifferenza (o anche la benevola curiosità) con la quale viene vissuta l’invasione tecnologica dei corpi. Il corpo umano, che serviva per produrre merci, diviene meno importante, meno sacro, dal momento che il processo produttivo si basa oggi principalmente sulla trasmissione, sulla accumulazione e sulla gestione di dati, e non sulla produzione materiale. Il piccolo particolare che nei cinque sesti del mondo si stia intensificando il dominio e lo sfruttamento dei corpi per produrre merci materiali a costi irrisori viene considerato ininfluente (e fastidioso e anacronistico riesce chi cerca di rammentarlo).
Siamo quindi alla lettura democratica dell’allacciamento in rete di cervelli e volontà, della dilatazione artificiale delle capacità mentali e interattive; lettura che nasce nella “sinistra” dall’ansia di essere più realista del re, dal timore di trovarsi nelle retrovie in un’epoca nella quale sembra scemare l’importanza del dominio sui corpi (che era strategico per la civiltà industriale) e divenire determinante quello sulle menti. Ciò spiega la relativa indifferenza (o anche la benevola curiosità) con la quale viene vissuta l’invasione tecnologica dei corpi. Il corpo umano, che serviva per produrre merci, diviene meno importante, meno sacro, dal momento che il processo produttivo si basa oggi principalmente sulla trasmissione, sulla accumulazione e sulla gestione di dati, e non sulla produzione materiale. Il piccolo particolare che nei cinque sesti del mondo si stia intensificando il dominio e lo sfruttamento dei corpi per produrre merci materiali a costi irrisori viene considerato ininfluente (e fastidioso e anacronistico riesce chi cerca di rammentarlo).