di Paolo Repetto, 30 maggio 2013
I pavoni nascondono a volte agli occhi di tutti
la loro ruota – e ciò è la loro superbia.
F. Nietzsche
Immagino che il titolo di questa conversazione susciti qualche perplessità. Vengo a tesservi l’elogio del dilettantismo in un’epoca in cui da ogni parte si fa appello alla professionalità: se non di un’eresia, potrebbe avere il sapore di una provocazione e, quel che è peggio, di una provocazione del tutto gratuita. È meglio quindi sgombrare subito il campo da aspettative o interpretazioni fuori misura. La mia sarà una semplice riflessione ad alta voce, nel corso della quale parlerò di cose in cui credo davvero, e che naturalmente possono essere non condivisibili. Di questo avremo modo, se lo riterrete, di discutere. Se invece dovesse risultare proprio un’eresia, vorrei che apparisse almeno motivata e consapevole.
Come chiede lo spirito di questi incontri, racconterò di una passione, quella della scrittura, che coltivo al di fuori della mia occupazione ufficiale, e che tuttavia con quest’ultima ha naturalmente più di un rapporto. Lo faccio volentieri perché raccontare mi piace, in fondo è stato per anni il mio mestiere, e perché l’impegno a parlare di questa passione mi costringe a riflettere sul significato che attribuisco ad alcuni termini e sui comportamenti che conseguono a tale attribuzione.
Partiamo dunque dalla terminologia.
In questa e nelle precedenti serate sono chiamati in gioco due concetti, quelli di professionismo e dilettantismo. Nel modo comune di sentire a questi concetti corrispondono i due diversi atteggiamenti che possono essere assunti, per scelta o per necessità, rispetto ad attività specifiche, ma oserei dire anche rispetto all’esistenza nel suo assieme. Da essi derivano poi i sostantivati professionista e dilettante e gli aggettivi professionale e dilettantesco. Ora, mentre per i concetti e i sostantivati sopravvive bene o male una distinzione neutra, nel senso che non implicano un giudizio di valore ma indicano solo diverse modalità di approccio (che poi nell’utilizzo corrente dei termini il giudizio di valore entri comunque è un altro discorso), per quanto concerne gli aggettivi questi vanno ormai decisamente a connotare nel primo caso un approccio serio, un impegno continuativo e profondo, una conoscenza robusta, nell’altro un interesse quanto meno non prioritario, un impegno sporadico e superficiale, una conoscenza limitata, quando non lacunosa. A monte c’è una separazione tra professione e diletto che oserei dire tutta e solo moderna, e alla cui origine varrebbe la pena dedicare uno specifico incontro: ma non voglio annoiarvi con un’esegesi storica e semantica nella quale affogherei dopo due bracciate. Mi importava solo mettere sullo sfondo alcune delle sfumature che i concetti di dilettantismo e professionismo possono assumere e delle ambiguità cui possono dare origine.
Definito lo sfondo, torno ad occuparmi del tema specifico della serata: la mia passione per la scrittura. Alcuni giorni fa ho provato a redigere una bibliografia di quel che ho scritto nell’ultimo quarto di secolo. Ho recuperato un centinaio di titoli, per cose che variano in consistenza da una a trecento pagine: mi ci sono volute due ore. Provo ora a riassumere l’elenco, limitandomi agli argomenti e ai temi principali, perché l’insieme mi ha lasciato perplesso. Dunque: per lo scaffale filosofia e storia delle idee ho scritto tra l’altro su Pico e Bacone, sull’etica di Kant, sulle origini dell’idea di progresso, sulle rappresentazioni del male nel medioevo, sul mito del buon selvaggio e sulla nascita del razzismo. Per quello di storia sugli eretici e sugli ebrei nel medioevo, sulle esplorazioni geografiche e sul colonialismo, sulla rivoluzione inglese e sugli utopisti del Settecento. E poi, una storia dell’alpinismo e una del fumetto western, una storia della scuola e una della scrittura al femminile nell’800: e biografie di viaggiatori, esploratori, scienziati, anarchici, uomini politici, avventurieri e filosofi, oltre a quella di mio padre, e implicitamente alla mia. E mi fermo qui, perché avrei fatto prima ad elencare quello che non ho scritto. O almeno, che non ho ancora scritto. Perché non è finita. Esiste anche un elenco di quello che non sono riuscito a scrivere. Non preoccupatevi, ve lo risparmio.
Non vorrei che questo inventario fosse letto come una fiera di erudizione: mi sembra ci si possano scorgere piuttosto i sintomi di un notevole disordine mentale, di un cervello che fa più giri di un frullatore e rischia di ottenere gli stessi risultati, un omogeneizzato di neuroni. Di positivo c’è però un fatto: non ho spacciato in giro questa roba. Il che non vuol dire che le cose che ho scritto non abbiano una circolazione: significa semplicemente che non ne ho “pubblicata”, nel senso di “messa sul mercato”, una sola riga. In compenso provvedo io stesso ad editare dei volumetti artigianali (questi appunto che vedete), in tirature nell’ordine delle unità, fascicolati e pinzati a mano, operazione che mi procura un particolare piacere sia fisico, tattile e visivo, che psicologico. Inoltre gli scritti sono reperibili da qualche tempo, in questo stesso formato, sul sito dei Viandanti delle Nebbie; per cui tutto quello che andrò ora a dire ha senso solo sino ad un certo punto, solo all’interno di una concezione appartenente al secolo scorso, che vedeva nella pubblicazione a stampa la certificazione di una qualità “professionale”, e quindi alta, della scrittura.
In sostanza: queste cose girano, sia pure entro un circuito molto ristretto, ma non sono in vendita, non vengono distribuite ad un euro in più rispetto al costo del quotidiano e neppure sono edite a spese di qualche ente pubblico o fondazione bancaria.
Ora, è chiaro che di per sé la mancata pubblicazione non significa niente: a dispetto di tutto, credo che solo in questo paese gli aspiranti autori siano qualche milione. Ciò che restringe alquanto l’apparentamento è il fatto che la pubblicazione non l’ho mai cercata (ma anche qui, siamo ancora in parecchi), o l’ho semplicemente declinata quando mi è stata proposta (e qui direi che diventiamo invece pochini).
Perché non ho cercata, o ho in alcuni casi rifiutata, la pubblicazione? Un’amica mi ha detto che questo mio “disinteresse” è frutto di un atteggiamento snobistico (accreditandomi peraltro di uno snobismo molto sottile, perché in genere, contrariamente a quanto ora sto facendo, non lo ostento). Dal momento che la mia amica è una persona ironica e intelligente presumo abbia assolutamente ragione, e che la sua non volesse affatto essere una critica. Forte poi del fatto che non ho mai ben capito cosa sia snob, io l’ho preso per un complimento: se vuol dire quello che intendo io, mi iscrivo da subito tra i candidati alla qualifica di snob.
Non sono infatti una persona semplice, come sanno tutti quelli che mi conoscono, ma sono paradossalmente troppo sbrigativo, o forse solo troppo pigro, per complicarmi la vita con calcoli del tipo “mi si noterà di più se pubblico o se non pubblico”. E nemmeno mi si addice l’atteggiamento dell’incompreso che difende orgogliosamente la sua dignità: “meglio primo tra gli inediti (ma qui è una bella lotta) che ultimo tra i pubblicati”. Per la carità! È tutto molto più banale (anche se, a rifletterci bene, il mio modo di vedere la cosa è davvero un po’ complesso – che è comunque diverso da complicato).
Non so se sono uno snob, ma sono certamente sotto alcuni aspetti presuntuoso. Presumo, o meglio, pretendo da me (il “tu devi” kantiano) livelli alti. Le misure naturalmente le detto io. Ora, nella scrittura i livelli sono determinati da due fattori: ciò che hai da dire, e come lo dici. Io non credo di avere da dire nulla di particolare. Per quel che concerne la saggistica, in primis gli interessi storici, non ho raccontato alcunché di nuovo e non ho elaborato teorie o interpretazioni innovative. Le cose che ho scritto sono in fondo ovvie, al più le ho magari messe in fila in maniera un po’ diversa, e presentano un colpo d’occhio differente. Ma nulla per cui valga la pena davvero sbattersi a diffonderle. Se sotto sotto un intento c’era, era quello di divulgare divertendo: ma, come vedremo, un intento del genere cozza almeno in parte con la concezione della cultura che coltivo, questa forse davvero snobistica.
Per la narrativa vale invece un’altra considerazione. Qui la forma è quasi (o senza quasi) più importante del contenuto, perché in fondo quelle che si raccontano da duemila e cinquecento anni a questa parte sono sempre le stesse storie, e quindi ciò che conta sono le varianti nell’insaporitura e nella presentazione del piatto. In questo campo credo di avere almeno un dono: so riconoscere la mano felice, e distinguere tra chi ha la mano felice e chi scrive bene. Chi scrive bene fa dei compiti onesti e corretti, chi ha la mano felice regala coinvolgimenti ed emozioni. Bene, io ho capito, molto presto per fortuna, di essere uno scrivano diligente e ordinato, al più talvolta un po’ bizzarro, ma di non avere “il dono”. È stato intuitivo, ma ne ho avuto poi la conferma in più di una occasione, quando ho letto i libri che avrei voluto scrivere io, o che addirittura in parte avevo già scritto, e ho capito che non avrei mai saputo dire le stesse cose altrettanto bene.
Secondo voi, quando uno ha questa duplice consapevolezza, di non aver nulla di così importante da dire e di non avere le qualità per dire le cose in maniera così affascinante e diversa da valer la pena trasmetterle agli altri, che deve fare? Si lascia morire d’inedia o si iscrive a una scuola di samba? No, se come me ama il cibo ed è goffo nei movimenti continua a scrivere, disgiungendo questa attività dalla prospettiva di essere pubblicato. Continua a scrivere per sé, anche se poi, nel momento stesso in cui scrive, lo fa pensando ad ipotetici lettori. Intanto però si gode il fatto di non dover tenere conto di lettori reali, ma di un pubblico perfetto, di non soggiacere allo stress di adattare il proprio pensiero a quello degli altri, perché i suoi lettori ideali sono tanto sensibili e intelligenti da capire senza problemi ciò che sta dicendo.
Questa libertà non è cosa da poco. Chi scrive per sé immagina di rivolgersi ad un ideale pubblico di lettori, e ciò lo aiuta a decidere come impostare il discorso, che sviluppi dargli, ecc…, ma poi in realtà scrive quello che vuole, quello che gli passa per la testa: solo cerca di metterlo in riga in una forma strutturata, discorsiva, argomentativa, convincente, insomma, vedete un po’ voi. Può suonare come un esercizio sofistico fine a se stesso, e magari lo è, ma alla fin fine anche per rispettarsi un po’ di disciplina ci vuole. Personalmente quando mi metto davanti al foglio a quadretti ho già in testa il succo del discorso, so dove voglio arrivare, ma in genere non ho la minima idea di come farlo. Le cose vengono poi da sole. Scrivo di getto, fino a che non ho tirato fuori tutto. Poi riverso quello che ho scritto sul computer, e magari cambio completamente l’ordine, ma quasi nulla della sostanza.
Questo del passaggio al computer è però un argomento particolare, cui vorrei dedicare qualche minuto. Devo innanzitutto confessare che non è del tutto vero che non ho mai pubblicato nulla. Moltissimi anni fa, quasi quaranta, ho collaborato alla scrittura di un’opera a carattere storico a molte mani, che finì per occupare dieci volumi, pubblicati nel giro di cinque o sei anni, e alla quale contribuirono anche nomi importanti, quasi tutti stranieri (ecco una possibile ulteriore motivazione del mio “disinteresse” attuale per la pubblicazione. Diciamo che ho già dato, ho già avuto e non ho bisogno di provare nuove ebbrezze. Ma in questo momento mi serve per parlare di un’altra cosa). All’epoca scrivevo come oggi a mano, correggevo e riscrivevo, battevo poi su una Olivetti 22 e ricorreggevo ancora; infine trascrivevo il testo risultante in tre copie, con la carta carbone. Sembrano secoli, succedeva invece fino a venticinque anni fa.
Bene, questo procedimento imponeva un ordine mentale completamente diverso. Per ogni capitolo stendevo una scaletta, ordinavo gli eventi e le argomentazioni, li sviluppavo, curavo poi le cuciture, ci tornavo per la lucidatura linguistica definitiva. Un lavoro certosino, che comportava lunghe riflessioni su ogni frase, su ogni rigo, prima di passare alla trascrizione. Ricordo ancora l’emozione che provai nel vedere stampato il mio primo capitolo: non mi sembrava neppure più mio, l’ultima volta che lo avevo riletto era tutto rabberciato dalle correzioni che andavano a sovrapporsi alle battute sbiadite di un nastro usato per dritto e per rovescio. Ora era lì, ordinato e disteso in sedicesimo su fogli di carta levigata, in file ordinate, senza lettere spostate in alto o in basso, senza sbavature o spazi superflui. Aveva acquisito l’autorevolezza della parola stampata, che lasciava supporre dietro ben altre conoscenze e anni di ricerche di quelli che io sapevo esserci in realtà.
Oggi quell’autorevolezza, se uno sa impostare un layout editoriale, cosa che è estremamente semplice, le tue parole ce l’hanno subito: ma paradossalmente il fatto di poterle cancellare o spostare o tagliare e ricucire, ecc …, finisce per togliergliela. Non so se riesco a spiegarmi. Il computer induce a scrivere (e infatti!), ma non induce a ripensare e a meditare molto su ciò che si scrive, e alla fine neppure a crederci. Vedi già l’effetto che fa, e questo ti ruba (almeno, lo ruba ad uno snob come me) il piacere e l’affanno di scoprire quello che potrebbe fare. Inoltre, che la destinazione sia o meno quella della stampa, la facilità e la velocità stesse con cui si arriva ad un’alta definizione “visiva” del testo finiscono per fartelo considerare un prodotto di rapido consumo, e quindi a farti curare piuttosto i dettagli della confezione che non la genuinità degli ingredienti. È sufficiente andare a consultare qualche voce su siti di prestigio, che dovrebbero fornire garanzie di accuratezza (provate quello della Treccani, ad esempio), per averne la prova. Chiusa la parentesi.
Torniamo invece alle motivazioni. Insisto, io scrivo per il piacere di scrivere. Quando scrivo un pezzo cerco di salvaguardare i diritti tanto del respiro mentale quanto di quello fisico, di dargli scorrevolezza; voglio che la superficie risulti liscia come quella di un piatto ben lavato. Mi disturbano le scabrosità, e ripasso più volte la spugnetta. Poi, quando finalmente riesco a staccarmene, di norma molto prima di esserne davvero soddisfatto, lo faccio alla maniera dei lupi. È un figlio che deve andare per la sua strada, ho già in mente altro. In genere non rileggo volentieri le cose che ho scritto, perché ogni volta cambierei e rifarei tutto, ma sostanzialmente perché non mi interessano più. Non che non mi interessi più l’argomento: solo, quel pezzo era una sorta di riassunto mentale di cui avevo bisogno per riordinare le mie idee, utilizzabile magari anche per un confronto ristretto con quelle altrui. È normale che dopo qualche tempo, ci sia stato o meno il confronto, mi appaia superato.
Un’altra motivazione del mio … chiamiamolo riserbo, è che ritengo che le cose che scrivo siano strettamente legate alla mia persona e alla mia storia, forse troppo per poter essere lette da chi non mi conosce. Anche qui, non so se considerare questo come un esito o come un presupposto. Voglio dire che quando scrivo, e mi scelgo il mio pubblico, posso dare per scontate certe conoscenze, relative sia ai fatti, ai personaggi o agli argomenti che tratto, sia a chi li tratta. Dato che in genere mi accosto alle cose con un certo disincanto, che io vorrei fosse ironia, e dato che non sempre sono sicuro che si capisca che sto usando quel metro, mi rassicura poter pensare che chi mi conosce sa che sono così, e che uso quel metro. Tutto ciò mi permette anche di civettare col mio lettore ideale, facendo riferimenti o allusioni a ipotetiche conoscenze o esperienze comuni (ecco, il mio pubblico ideale potrebbe essere quello di una cerchia ristretta cui leggere le mie cose, sul modello di Tolkien e degli Inklings. In questo caso il dominio sulla materia sarebbe totale, perché sarei padrone anche dei toni e delle pause. Lo so, questa è già patologia).
A questo punto si sarà capito quanto autocompiacimento c’è dietro quello che scrivo. E come ciò sia incompatibile con una possibile “mercificazione” delle mie cose, perché la pubblicazione è anche questo. Le cose che scrivo non possono avere un prezzo di copertina: nessuno può acquistare il diritto di leggerle per qualche euro. Entrano in un giro di scambio che suppone l’amicizia e la reciprocità. Soprattutto, voglio mantenere una posizione di forza nel rapporto: se non ti piacciono, non ti sono comunque costate nulla, non puoi lamentare una delusione. Non è però solo una deviazione mentale: io ho davvero questa concezione dello scambio culturale, che vale per tutto, dall’arte alla musica. Non concepisco un “professionismo” culturale che non sia quello connesso ad una attività specifica legata alla cultura: l’insegnamento, la ricerca, l’organizzazione. Il mestiere di scrittore per me non esiste. Sebastiano Timpanaro, una delle figure più eminenti della nostra cultura del secondo novecento, diceva: io faccio il “revisore di bozze” (in realtà faceva ben altro, come curatore editoriale; ma dovendo qualificarsi con un’attività concreta, vedeva giusto quella).
Quindi, certo, c’è un sacco di autocompiacimento. D’altro canto, se non ci fosse non si capisce perché perdere tanto tempo (in verità neanche poi tanto) a scrivere. E comunque, per arrivare a questa conclusione ho avuto bisogno della presente seduta di autoanalisi, perché in realtà non ci avevo mai pensato seriamente prima: e forse mi sono inventato tutto per l’occasione.
No, non è così. Mi spiace di avervi fatto perdere tutto questo tempo per arrivare a dire una cosa tanto semplice, anzi, a ribadirla. Scrivo perché mi diverto, mi diverto un mondo. E badate, non ho una visione ristretta del divertimento. Ho saputo e so divertirmi in tanti modi, anzi, a dispetto del mio disincanto ho avuto la fortuna di trovare sempre la vita, tutto sommato, divertente, o almeno di saperne cogliere gli aspetti divertenti. Mi piace stare solo e stare con gli amici, camminare in montagna e rannicchiarmi nel mio studio: ma soprattutto mi piace leggere, e ancor più mi diverte scrivere (per forza, perché qui ho una parte più attiva nel gioco). Quindi mi riesce difficile immaginare una concezione penitenziale della scrittura, il tormento dello scrittore, il rovello della pagina bianca, tutte quelle cose lì che fanno tanto folklore. Non che non ci creda, per carità: immagino che chi ritiene di aver molto da dire voglia farlo nella maniera più incisiva, più perfetta, più definitiva possibile. È giusto, è serio che sia così. Ma, al di là del fatto che dovrebbe essere il traguardo anche di chi da dire ha poco, tutta questa drammatizzazione non è per me. Non ho mai creduto che Pavese si sia suicidato per impotenza creativa, di qualsiasi tipo. Se uno davvero si sente così stanco, ha mille altri motivi più validi per scendere dal treno.
Questo ci riporta comunque al dilettantismo. Dicevo che il dramma creativo non è il mio caso perché sono un dilettante, nel senso appunto che mi diletto. Davanti ad una pagina bianca non mi assale il tormento dello scrittore, casomai una compulsione a riempirla. Se non so cosa scrivere o come scriverlo, disegno: mi piace molto anche disegnare, e riempio fogli su fogli di paesaggi montani con piccole baite (n.d.r: non ho mai dipinto, né reso pubblico un mio disegno). Davanti al monitor mi diverto a cambiare le parole o la loro disposizione. Quando non mi diverto più, faccio dell’altro. E qui torniamo al discorso iniziale: non ho alcuna urgenza di comunicare alcunché al mondo. Ma si badi, sono cosciente che anche questa è a suo modo presunzione. Voglio dire: credo che mi impegnerei fino in fondo per far arrivare il mio verbo al maggior numero di persone possibile se ritenessi che fosse qualcosa di indispensabile, che potrebbe cambiare in meglio la vita di qualcuno. Oggettivamente so che non è così, quindi non vale la pena affannarmi più di tanto. So anche che se tutti la pensassero a questo modo non esisterebbe, o quasi, la letteratura e sarebbe ridotta al minimo la saggistica, perché la prima esiste anche per offrire divertimento e consolazione, e la seconda per assecondare anche le piccole e private curiosità. Per fortuna non è così, direi anzi che prevale l’idea che tutti abbiano qualcosa di significativo da dire, e godiamo di un’ampia scelta.
Sono infine un dilettante perché ho troppi interessi. L’ho già detto, ma ora vorrei chiarire che non penso che l’avere tanti interessi sia sempre un male, anche se è difficile stabilire il confine tra i tanti e i troppi (e nel mio caso poi lo è in modo particolare). Questa attitudine corrisponde evidentemente ad un modo di concepire la vita. In effetti io sono curioso di quasi tutto, e quindi non riesco a concentrarmi su qualcosa in particolare: non so rinunciare a niente che mi intrighi. Ma, ripeto, non credo che questo significhi per forza essere superficiali, e neppure che crei sempre una inconcludente dispersione. Nei casi positivi può rimandare ad esempio all’idea che sotto sotto tutto si tenga, che tra la storia del fumetto western, quella dell’alpinismo e l’etica di Kant corra un sottile legame. Magari poi l’unico legame sarà proprio il fatto che tutte e tre queste cose mi intrigano: e vorrà dire che se non c’era l’avrò creato io. In definitiva, fatte le debite proporzioni, direi che questo è un atteggiamento “enciclopedico”, sul tipo di quello degli ultimi grandi illuministi, del mitico Humboldt. Per forza mi sono innamorato di quell’uomo. Non conosceva per ragioni anagrafiche il fumetto western, ma l’etica kantiana e l’alpinismo li aveva messi assieme eccome.
Ecco, Humboldt – tanto ormai l’ho giocato e conviene quindi andare fino in fondo – è la dimostrazione che si può essere intrigati da tutto senza per forza essere superficiali e approssimativi. Se le cose che ti interessano fanno parte per te di un “grande disegno” (che non è affatto il disegno intelligente dei creazionisti, ma quello più modesto che hai in mente tu) non è necessario che vada a trovare il particolare o il dettaglio inedito per dare un senso al tuo lavoro, a meno che si tratti di un particolare che cambia tutto il quadro. Diciamo che ti riservi un lavoro di sintesi, mentre quello dell’analisi lo lasci agli altri, ai professionisti. L’importante è che qualsiasi parte ci si riserva venga poi interpretata con serietà. Occorre essere molto seri col proprio dilettantismo, perché il diletto può venire solo dalla coscienza di essere “filologicamente” inappuntabili, come avrebbe detto il solito Timpanaro. Non vedo d’altro canto che piacere si possa trarre dall’approssimazione, o dal millantare conoscenze che non si possiedono: visto che uno può scegliersi i lettori ideali, immagino vorrà sceglierli intelligenti, e voglia offrire loro cose quantomeno precise nei contenuti e corrette e accattivanti nella forma. Sono anzi convinto che il vero dilettante, a differenza del professionista, sia in una condizione che non gli consente assolutamente di barare, se non vuole prendere in giro proprio il primo e il solo lettore veramente ideale, cioè se stesso. Quindi, diletto negli intenti, ma professionalità nei modi e negli strumenti.
A chi destinare poi un lavoro svolto con questi principi è un problema secondario; se si ritiene valga la pena, sia almeno dignitoso o sia decisamente importante, lo si partecipa in qualche modo anche ad altri. Ma in genere chi si dedica a questo tipo di ricerca non lo fa per gli altri. Lo fa per rispondere ad un bisogno proprio, se vogliamo ad una propria presunzione: quella di voler capire (nei casi più gravi, di aver capito) il senso del tutto.
Ammetterete che chi si è preso un impegno simile non ha tempo da perdere con la pubblicazione.







 È il caso della presenza fra gli oltre 100 mila morti italiani per Covid 19 di Ziad Zawaideh, mio medico per 35 anni. Ha contratto il virus pochi mesi dopo essere andato in pensione, e gli si è arreso solo dopo un lungo ricovero. Ho avuto altri amici e conoscenti portati via da questo morbo, ma la sua assenza mi tocca in modo particolare. Non che fossimo amici, ma era la persona sempre sorridente che mi accoglieva durante le rare mie visite nel suo ambulatorio, e con la quale scambiavo qualche battuta sulla disarmante realtà ambientale ovadese o sulla situazione del medio orientale, da dove proveniva. Ho una gran nostalgia di quel riso benevolo e della forte stretta di mano con cui ci accomiatavamo.
È il caso della presenza fra gli oltre 100 mila morti italiani per Covid 19 di Ziad Zawaideh, mio medico per 35 anni. Ha contratto il virus pochi mesi dopo essere andato in pensione, e gli si è arreso solo dopo un lungo ricovero. Ho avuto altri amici e conoscenti portati via da questo morbo, ma la sua assenza mi tocca in modo particolare. Non che fossimo amici, ma era la persona sempre sorridente che mi accoglieva durante le rare mie visite nel suo ambulatorio, e con la quale scambiavo qualche battuta sulla disarmante realtà ambientale ovadese o sulla situazione del medio orientale, da dove proveniva. Ho una gran nostalgia di quel riso benevolo e della forte stretta di mano con cui ci accomiatavamo.
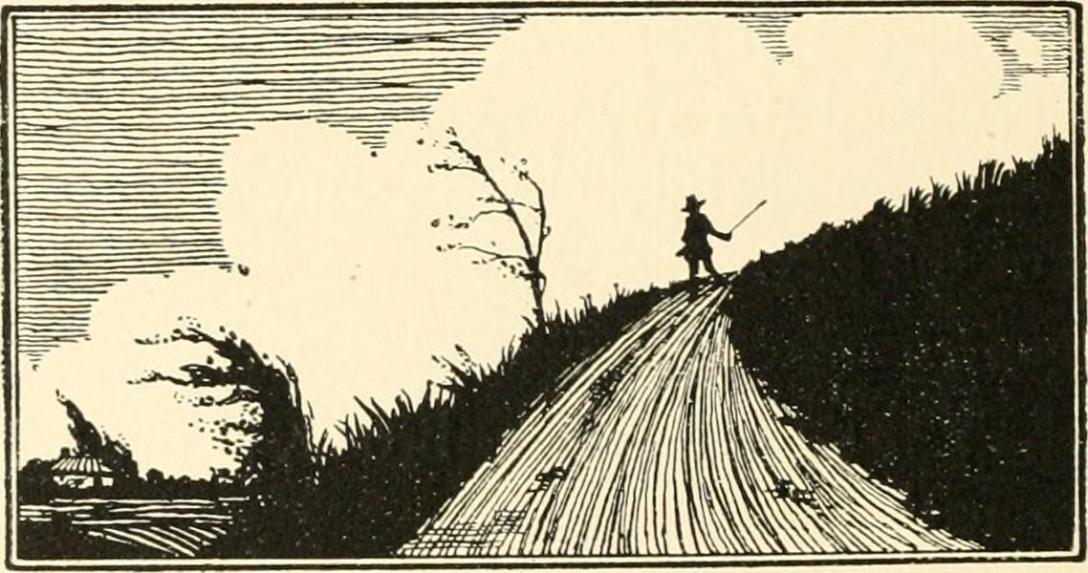



 di Vittorio Righini, 25 marzo 2020
di Vittorio Righini, 25 marzo 2020 Nasce nel 1912 a Jalandhar, in India, a quei tempi ancora colonia inglese, perché il padre, ingegnere ferroviario, sta lavorando alla costruzione della ferrovia. La ferrovia per Darjeeling (che ha fornito il titolo a un film a mio modesto parere mediocre) è un notevole prodotto dell’ingegneria meccanica inglese, e la sua ultima parte, a scartamento ridotto, è un’attrazione turistica per arrivare appunto alla città di Darjeeling, patria del miglior tea al mondo e balcone sotto l’Himalaya, con gran vista del Kangchenjunga, di ben mt. 8586. (Ora, in puro stile Sjoberg, se vuoi divagare e guar-darti la ferrovia di Darjeeling, guarda questo bel video, fino alla fine, però …
Nasce nel 1912 a Jalandhar, in India, a quei tempi ancora colonia inglese, perché il padre, ingegnere ferroviario, sta lavorando alla costruzione della ferrovia. La ferrovia per Darjeeling (che ha fornito il titolo a un film a mio modesto parere mediocre) è un notevole prodotto dell’ingegneria meccanica inglese, e la sua ultima parte, a scartamento ridotto, è un’attrazione turistica per arrivare appunto alla città di Darjeeling, patria del miglior tea al mondo e balcone sotto l’Himalaya, con gran vista del Kangchenjunga, di ben mt. 8586. (Ora, in puro stile Sjoberg, se vuoi divagare e guar-darti la ferrovia di Darjeeling, guarda questo bel video, fino alla fine, però …  Probabilmente Lawrence nasce a Darjeeling, e viene registrato a Jalandhar, parecchio lontana; è chic pensarla così, e sta nel personaggio. Va a scuola dagli undici anni in poi in Inghilterra, a Canterbury prima, a Oxford poi, ma con pessimi risultati; la sua infanzia libera in India e il carattere ribelle lo allontanano dalla severa educazione inglese. A quindici anni è pianista jazz e poeta, qualunque cosa tranne che studente.
Probabilmente Lawrence nasce a Darjeeling, e viene registrato a Jalandhar, parecchio lontana; è chic pensarla così, e sta nel personaggio. Va a scuola dagli undici anni in poi in Inghilterra, a Canterbury prima, a Oxford poi, ma con pessimi risultati; la sua infanzia libera in India e il carattere ribelle lo allontanano dalla severa educazione inglese. A quindici anni è pianista jazz e poeta, qualunque cosa tranne che studente. primo libro del Quartetto di Alessandria, le sue opere più famose e conosciute. Dopo una parentesi in Argentina e poi in Iugoslavia, l’Intelligence lo trasferisce a Cipro, dove vive con la figlia Sappho Jane, ma si separa dalla moglie. Nel 1960, a causa della guerra contro gli inglesi lascia Cipro e si trasferisce in Provenza. Si sposa una terza volta, ma nel 1967 la moglie muore, e nonostante attraversi un periodo di successi (è tra i candidati al Nobel della Letteratura), vive un pessimo momento, compresa una brutta malattia. Si sposa intanto per la quarta volta, un matrimonio che dura solo sei anni. Nel 1985 la figlia Sappho Jane si suicida accusando il padre di incesto psicologico. Il fratello ultimogenito Gerald, famoso naturalista, zoologo e scrittore, lo definisce ‘‘un distruttore di donne’’. Muore nel 1990 per un ictus.
primo libro del Quartetto di Alessandria, le sue opere più famose e conosciute. Dopo una parentesi in Argentina e poi in Iugoslavia, l’Intelligence lo trasferisce a Cipro, dove vive con la figlia Sappho Jane, ma si separa dalla moglie. Nel 1960, a causa della guerra contro gli inglesi lascia Cipro e si trasferisce in Provenza. Si sposa una terza volta, ma nel 1967 la moglie muore, e nonostante attraversi un periodo di successi (è tra i candidati al Nobel della Letteratura), vive un pessimo momento, compresa una brutta malattia. Si sposa intanto per la quarta volta, un matrimonio che dura solo sei anni. Nel 1985 la figlia Sappho Jane si suicida accusando il padre di incesto psicologico. Il fratello ultimogenito Gerald, famoso naturalista, zoologo e scrittore, lo definisce ‘‘un distruttore di donne’’. Muore nel 1990 per un ictus. Ora vediamo la famiglia Durrell: L’ultimogenito è Gerald, l’autore del delizioso e simpaticissimo ‘‘La mia famiglia e altri animali’’, nel quale descrive la vita della sua famiglia a Corfù, dal 1935 fino a quando l’eco della guerra suona troppo vicino alla tranquilla isola greca. Come dicevo sopra la madre, che era di certo una donna originale ma pragmatica, subissata dalle insistenti richieste del primogenito Lawrence e di sua moglie Nancy si era fatta convincere a trasferirsi sull’isola greca insieme a tutti i figli (Lawrence appunto, l’originale fratello Leslie, la stralunata sorella Maggie e Gerald): ufficialmente per motivi di clima e di salute, ma in realtà anche per il modesto costi della vita a cui si sarebbe dovuta rapportare rispetto a quello della fredda (e costosa) Inghilterra.
Ora vediamo la famiglia Durrell: L’ultimogenito è Gerald, l’autore del delizioso e simpaticissimo ‘‘La mia famiglia e altri animali’’, nel quale descrive la vita della sua famiglia a Corfù, dal 1935 fino a quando l’eco della guerra suona troppo vicino alla tranquilla isola greca. Come dicevo sopra la madre, che era di certo una donna originale ma pragmatica, subissata dalle insistenti richieste del primogenito Lawrence e di sua moglie Nancy si era fatta convincere a trasferirsi sull’isola greca insieme a tutti i figli (Lawrence appunto, l’originale fratello Leslie, la stralunata sorella Maggie e Gerald): ufficialmente per motivi di clima e di salute, ma in realtà anche per il modesto costi della vita a cui si sarebbe dovuta rapportare rispetto a quello della fredda (e costosa) Inghilterra. Trascuriamo per un attimo il fatto che Lawrence non è stato il marito o il padre ideale, e guardiamo invece alla sua produzione letteraria. Ho letto il quartetto di Alessandria, cioè quattro libri di storie complicatamente amorose, con intrighi e situazioni sociali e politiche varie, scritti nella seconda metà degli anni ‘50. In ognuno di questi libri si incontrano quattro punti di vista diversi sulla stessa storia, sugli stessi intrighi, perché per l’autore la verità è relativa, e la personalità di ogni personaggio vige solo in funzione del punto di vista del lettore, della sua interpretazione. Durrell ha poi lasciato una vastissima produzione in prosa, molti altri libri che ebbero però minore successo. Ma non di questi ti volevo scrivere, perché per me ben più interessanti sono quelli, sottostimati, che vengono considerati come libri di viaggio o guide, e tali invece non sono affatto.
Trascuriamo per un attimo il fatto che Lawrence non è stato il marito o il padre ideale, e guardiamo invece alla sua produzione letteraria. Ho letto il quartetto di Alessandria, cioè quattro libri di storie complicatamente amorose, con intrighi e situazioni sociali e politiche varie, scritti nella seconda metà degli anni ‘50. In ognuno di questi libri si incontrano quattro punti di vista diversi sulla stessa storia, sugli stessi intrighi, perché per l’autore la verità è relativa, e la personalità di ogni personaggio vige solo in funzione del punto di vista del lettore, della sua interpretazione. Durrell ha poi lasciato una vastissima produzione in prosa, molti altri libri che ebbero però minore successo. Ma non di questi ti volevo scrivere, perché per me ben più interessanti sono quelli, sottostimati, che vengono considerati come libri di viaggio o guide, e tali invece non sono affatto. Poi, venticinque anni più tardi, un editore propone a Lawrence di fare un viaggio spesato per la Sicilia e di raccontare l’isola a modo suo. Durrell coglie l’opportunità al volo, e addirittura si accoda a un Tour ‘‘tutto compreso’’ della Sicilia, dal nome Carosello Siciliano (come poi il titolo del libro stesso). Ispirato dalle lettere che dalla Sicilia la sua amica Martine gli aveva scritto negli anni precedenti (un’amica del periodo di Cipro, trasferitasi poi in Sicilia, che morì prima del viaggio di Durrell e che invitò molte volte l’autore ad andarla a trovare per mostrargli quanto la Sicilia fosse, realmente, l’Attica Occidentale), l’autore, da buon opportunista qual era, ma anche per la fiducia che nutriva verso i consigli che Martine gli scriveva sulla nostra bella isola, accettò l’offerta. Se l’uomo non merita davvero una grande stima, l’autore la merita fino in fondo, perché anche in questo libro (pur mercenario) riesce a presentarci la Sicilia in modo colto, lirico a volte, con una scrittura perfetta, capace di farci comunque scoprire cose nuove e che non avevamo considerato prima, o di farcele immaginare con occhi diversi. Lo trovai anni fa della Bompiani Editore nei Grandi Tascabili, è del 1977.
Poi, venticinque anni più tardi, un editore propone a Lawrence di fare un viaggio spesato per la Sicilia e di raccontare l’isola a modo suo. Durrell coglie l’opportunità al volo, e addirittura si accoda a un Tour ‘‘tutto compreso’’ della Sicilia, dal nome Carosello Siciliano (come poi il titolo del libro stesso). Ispirato dalle lettere che dalla Sicilia la sua amica Martine gli aveva scritto negli anni precedenti (un’amica del periodo di Cipro, trasferitasi poi in Sicilia, che morì prima del viaggio di Durrell e che invitò molte volte l’autore ad andarla a trovare per mostrargli quanto la Sicilia fosse, realmente, l’Attica Occidentale), l’autore, da buon opportunista qual era, ma anche per la fiducia che nutriva verso i consigli che Martine gli scriveva sulla nostra bella isola, accettò l’offerta. Se l’uomo non merita davvero una grande stima, l’autore la merita fino in fondo, perché anche in questo libro (pur mercenario) riesce a presentarci la Sicilia in modo colto, lirico a volte, con una scrittura perfetta, capace di farci comunque scoprire cose nuove e che non avevamo considerato prima, o di farcele immaginare con occhi diversi. Lo trovai anni fa della Bompiani Editore nei Grandi Tascabili, è del 1977.


