Una dieta ricostituente. Ho chiesto a Beppe Rinaldi l’autorizzazione a riportare sul sito dei Viandanti delle Nebbie due suoi recenti saggi, già postati nel blog Finestre rotte. Il link che rimanda a Finestre rotte compare da tempo nella home page dei Viandanti, e a quello avrei potuto semplicemente indirizzare: ma ho ritenuto opportuna in questo caso anche la pubblicazione diretta, per più di una ragione.
In primo luogo perché ritengo che questi scritti abbiano una rilevanza intrinseca assoluta: ultimamente ho letto ben poche cose di questo livello (forse nessuna) e mi pare dunque doveroso pubblicizzarli e renderli disponibili il più possibile. La nostra non sarà una gran tribuna, ma è comunque una “finestra” in più.
In secondo luogo perché ho egoisticamente “calcolato” (eccola la “ragione calcolante” tanto aborrita dai post-moderni) che la loro pubblicazione avrebbe alzato decisamente il tiro e il tono del nostro sito, negli ultimi tempi piuttosto moscio.
Infine perché questi scritti costituiscono una sfida, alla nostra intelligenza e alla nostra capacità di concentrazione: stiamo rammollendo i nostri cervelli, nutrendoli di pappine omogeneizzate e precotte che non richiedono alcuno sforzo nell’assunzione e nella digestione, ma atrofizzano le nostre papille gustative e il vello intestinale. I risultati purtroppo si vedono, non solo in tivù o nell’informazione cartacea, ma nella impossibilità di un qualsivoglia confronto serio nel dibattito “domestico”, conviviale, socratico, chiamatelo un po’ come volete. Questi saggi vanno in una direzione diametralmente opposta: esigono impegno nella lettura e coerenza nella riflessione. Li ho letti una prima volta, mi hanno colpito e li ho riletti, non perché temessi di non aver capito – si capisce tutto benissimo, ogni argomento è spiegato e sviscerato come meglio non si potrebbe – ma per assicurarmi di non aver saltato alcun passaggio. Ora li ripropongo agli amici, appunto come una sfida, come stimolo a rompere un po’ la linea sulla quale si va appiattendo il pensiero.
Gli scritti di Beppe mi sembrano costituire il miglior campo base per ogni eventuale tentativo di risalita. Le sue argomentazioni e le idee ad esse sottese possono essere condivise in toto, com’è nel mio caso, oppure discusse e contestate: ma se si vuole chiudere la ricreazione e tornare allo studio serio non si può prescinderne.
Spero dunque sia evidente che non propongo questi saggi come testi sacri, novelli Atti dei Viandanti, o come manifesti programmatici del sodalizio: li promuovo a titolo personale, me ne assumo ogni responsabilità, e li concepisco come strumenti per tornare a far lavorare un po’ i nostri cervelli. Sono strumenti che vanno dalla pinzetta da orafo al martello pneumatico, per cui ci sarà da divertirsi (e da nutrirsi) per tutti.
Il piano di pubblicazione prevede per i due saggi (che sono piuttosto impegnativi rispetto allo standard dei documenti digitali) momenti separati, un intervallo di qualche settimana l’uno dall’altro, per dare modo ai Viandanti “volenterosi” di digerire e assimilare con calma il loro enorme apporto proteico. Nel frattempo io rimango in attesa, curioso di vedere se la nuova dieta avrà qualche effetto.
Il tema che Beppe tratta in questo primo saggio è quello della pace. Tema scivoloso e controverso, rispetto al quale siamo abituati a prendere posizioni decisamente rozze (cfr. ad esempio il mio Contare a fino a dieci, del 2003) o ambigue e superficiali, oppure assolutamente ipocrite (vedi le manifestazioni pacifiste che finiscono a sassate e manganellate): sempre comunque dettate da una profonda ignoranza rispetto all’argomento. Qui ci è offerta l’occasione, una volta per tutte, di avere almeno chiaro di cosa parliamo quando parliamo di pace. Dopodiché, non ci saranno più alibi all’uso improprio o distorto o strumentale del termine.
di Paolo Repetto, 18 ottobre 2023

Il legno storto
Note di filosofia della pace e della guerra
di Giuseppe Rinaldi, pubblicato su Finestre rotte il 24 novembre 2022
1. Solo quando scoppiano le guerre[1], come quella attuale in Ucraina, tendiamo a porci una serie d’interrogativi sulla pace come fossimo nati ieri. E gli interrogativi tendono a moltiplicarsi, quanto più le prospettive della pace si fanno oscure e incerte e quanto più siamo coinvolti dalla guerra, anche nella nostra vita quotidiana. La riflessione sulla pace e sulla guerra sembra dunque procedere a sbalzi, al ritmo delle guerre che ci colpiscono da vicino. Le due Guerre del Golfo (1990-91 e 2003-11) erano state, in ordine di tempo, l’ultima ormai scordata occasione di riflessione pubblica sull’argomento. Quasi contemporaneamente, analoghi dibattiti si erano tenuti in occasione delle Guerre jugoslave (1991-2001) e in occasione dell’11 settembre 2001. Nessun dibattito ovviamente intorno alle innumerevoli guerre lontane o guerre dimenticate[2], quelle guerre che, abitualmente, appena possiamo, ci scrolliamo di dosso.
La guerra russo ucraina combattuta alle porte dell’Europa ci ha dunque trovati piuttosto impreparati e così abbiamo finito per rispolverare e riportare in auge vecchi luoghi comuni. Si sono avute molte grida ma decisamente poche riflessioni approfondite e argomentate. E si è preferito trascurare l’ampio patrimonio di riflessione sulle questioni della pace e della guerra che si è ormai accumulato nel campo degli studi politologici e filosofici, nonché nel campo storiografico. In questo scritto cercherò di compiere un’esposizione sintetica intorno alle principali questioni teoriche che si pongono da sempre a proposito della pace e della guerra. Niente di particolarmente nuovo dunque, ma una sintesi intorno alle questioni fondamentali. Insomma, quello che a me pare il minimo indispensabile da cui partire.
2. Pace e definizioni. Per mettere un po’ di ordine nelle diverse questioni, è preferibile, come sempre, cominciare dalle definizioni. Cominceremo proprio dalla pace. Si tratta anzitutto, in via preliminare, di mettere da parte certi usi generici della parola “pace”. La pace che ci interessa e sulla quale ci concentreremo è quella connessa all’ambito stretto delle comunità politiche, sia nei loro rapporti esterni, internazionali, sia al proprio interno, come nel caso della guerra civile. Il termine “pace” sta a indicare genericamente, in quest’ambito, un’assenza di conflitto violento[3], quel tipo di conflitto cioè che generalmente è identificato con il termine guerra. Parlare di pace significa necessariamente tirare in ballo il suo rovescio, cioè appunto il conflitto violento e la guerra. Si tratta dunque di una definizione in termini negativi. La pace, a quanto pare, non ha un suo significato autonomo e non può che essere definita in stretta antitesi con la guerra. Pace e guerra sono due diversi alternativi stati possibili. Una familiare dicotomia suggerisce che ci si trovi in pace, oppure ci si trovi in guerra.
Le cose tuttavia non sono così semplici. Se appena facciamo un qualche sforzo di riflessione, ci renderemo conto immediatamente che, all’occorrenza, possiamo individuare diversi stati intermedi compresi tra la pace e la guerra. In certi casi può anche risultare non del tutto chiaro se una certa situazione sia di pace o di guerra. Nel linguaggio comune si esprime qualcosa di simile dicendo: “Siamo sull’orlo di una guerra”, oppure: “Ci sono segnali di pace all’orizzonte”. In taluni casi, un chiarimento definitivo può derivare solo da un’esplicita dichiarazione di guerra o dalla sottoscrizione di una tregua, oppure di un trattato di pace. Ci sono poi delle situazioni che possono essere considerate come guerre anomale o guerre non convenzionali.
Una simile incertezza terminologica e concettuale la stiamo sperimentando proprio in questi mesi. Notoriamente, per i Russi l’aggressione all’Ucraina non è una guerra. È stata denominata operazione militare speciale. I cittadini russi che la chiamassero “guerra” potrebbero essere perseguiti penalmente[4]. Del resto nessuna esplicita dichiarazione di guerra è stata pronunciata da entrambe le parti. Secondo Putin, chi fornisce armi all’Ucraina è già “in guerra” con la Russia. Secondo alcuni pacifisti, gli USA, la UK, l’Europa sarebbero già in guerra con la Russia. Secondo il papa, questa sarebbe la Terza guerra mondiale “a pezzi”. Secondo alcuni altri, poi, la NATO aggressiva era già in guerra con la Russia fin dagli anni Novanta. Come si vede, la definizione dei confini tra pace e guerra è tutt’altro che semplice. I dati di fatto e la propaganda sembrano ormai intrecciarsi in maniera indissolubile.
Ancora più complessa è la situazione nel caso della guerra interna, o guerra civile. È difficile che le guerre civili siano dichiarate (anche se talvolta accade). Ci sono guerre civili de facto che non sono mai state combattute come tali e che sono state riconosciute come tali solo successivamente. È il caso, ad esempio, del riconoscimento, da parte dello storico Claudio Pavone, della Resistenza italiana al nazifascismo come guerra civile. È probabile che nel Donbass, dal 2014 in poi, si sia combattuta una guerra civile, con ogni probabilità fomentata dalla Russia con l’introduzione clandestina di uomini e mezzi. O forse una guerra di secessione.
3. Almeno due tipi di pace. Nella letteratura filosofica e politologica è stato spesso fatto notare come si possano annoverare due tipi di pace, quella negativa, quella più ovvia cui abbiamo già accennato, e quella positiva. La distinzione risale a Johan Galtung 1969. Galtung tratta non tanto della guerra quanto della violenza. La pace negativa è costituita dalla assenza di violenza personale, mentre la pace positiva è costituita dall’assenza della violenza strutturale. Per Galtung la pace positiva coincide dunque con la giustizia sociale. La distinzione tra pace negativa e positiva è stata poi usata ampiamente da Bobbio specificatamente in relazione alla guerra. Si parla comunemente di pace negativa quando il significato che si conferisce al concetto è soprattutto quello di negazione della guerra, cioè negazione del conflitto violento interno o internazionale. Si parla invece di pace positiva quando, oltre alla mera negazione della guerra, si vuol riempire il concetto della pace di una serie di connotazioni positive, che appartengano solo e soltanto alle situazioni di pace. Queste connotazioni dunquesi aggiungono alla pace negativa, cioè all’assenza di guerra. Si può parlare, in tal caso, di cessazione della violenza strutturale, ma anche di tranquillità, felicità, di fioritura umana, di prosperità, di progresso e simili. Oppure anche di armonia, integrazione, aiuto reciproco, cooperazione e scambio. Come ben si vede da questi esempi, se la nozione di pace negativa come assenza di guerra è relativamente precisa, pur con tutti i problemi del caso, la nozione di pace positiva è ancor più vaga, tanto che questa può essere ricondotta al capitolo generico dei benefici della pace – quali che questi possano essere. Oppure anche delle conseguenze positive della pace[5]. Si noti tuttavia che la condizione di pace positiva non si presta a definire un modello preciso di società, come, per esempio, la società cristiana, la società aperta, oppure la democrazia o il socialismo. Cioè, la pace difficilmente si lascia tradurre in un preciso modello di società che sia alternativo ad altri modelli. Sono i diversi modelli di società che possono sperimentare, talvolta, la condizione della pace positiva (o della guerra).
4. La guerra. Se vogliamo sapere cosa è la pace, almeno nella sua forma elementare, dobbiamo dunque come minimo sapere bene cosa sia la guerra. La guerra necessita dunque, a sua volta, di una definizione, che può risultare anch’essa piuttosto difficoltosa. Di solito non basta però definire la guerra come non pace. La guerra ha invece una sua definizione in positivo, cioè dotata di suoi specifici e autonomi contenuti. Vagamente, il termine guerra può significare un conflitto di qualsiasi tipo, ma abbiamo già detto che ci sono conflitti che non sono guerre. Allora abbiamo dovuto introdurre fin da subito la specificazione di “conflitto violento”. La guerra è un conflitto la cui caratteristica precipua è l’uso sistematico della violenza. Secondo una definizione esaustiva proposta da Bobbio, la guerra in senso stretto sarebbe caratterizzata dal conflitto violento entro o tra comunità politiche e/o Stati[6]. Osserva Bobbio: «Va da sé che, una volta definita la pace come non guerra, la definizione di pace dipende dalla definizione di guerra […]. Le più frequenti connotazioni di “guerra” sono queste tre: la guerra è, a) un conflitto, b) tra gruppi politici rispettivamente indipendenti o considerati tali, c) la cui soluzione viene affidata alla violenza organizzata»[7].Si noti che, secondo Bobbio, la guerra rientra nel novero della politica e che la violenza impiegata non ha da essere sporadica o casuale, bensì organizzata.
5. La questione della violenza. La definizione della guerra non poteva che evocare anche la questione della violenza. La violenza è uno dei principali contenuti della guerra. La nozione di violenza, ovviamente, è assai più ampia della nozione della guerra. Non ogni violenza è guerra. Possiamo pensare alla violenza dei fenomeni naturali, a parole violente, alla violenza nei confronti degli animali, oppure alla violenza psicologica. Nel caso della guerra, siamo interessati a un particolare uso della violenza allo scopo di risolvere un conflitto di tipo politico, tra comunità politiche o entro di esse.
Che tipo di violenza è quella della guerra? Secondo Hobbes la guerra era lo stato prepolitico per eccellenza che comportava svariate forme di violenza, la cui massima espressione poteva giungere fino all’estremo dell’uccisione del nemico. La soglia minima che ci interessa in questo caso sembra sia proprio l’ammissibilità dell’uccisione del nemico. Altrimenti anche un incontro di boxe potrebbe essere considerato come una guerra. Per Hobbes, la costituzione dello stato politico attraverso il contratto determinava la fine della guerra di tutti contro tutti e del conseguente rischio di essere ammazzati. La pace negativa (la negazione della guerra) si oppone dunque al conflitto violento entro le comunità politiche e tra gli Stati e, dunque, a quelle forme di violenza che, oltre alla distruzione delle cose, ammettono l’uccisione del nemico.
Fatta questa distinzione fondamentale, tuttavia, fin dai tempi di Hobbes le forme della violenza connesse alla guerra si sono moltiplicate a dismisura, in un museo degli orrori senza fine. Dalla generica uccisione del nemico si è giunti al genocidio, ossia al tentativo di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso. Oppure alla minaccia atomica, la quale implicherebbe la possibile distruzione dell’intera umanità.
Occorre riconoscere che si è fatto uno sforzo per codificare l’uso della violenza in guerra, giungendo alla proibizione di determinate condotte e alla definizione dei crimini di guerra e di tribunali internazionali. Alla messa al bando di determinati tipi di armi. Va tuttavia riconosciuto che lo ius in bello, cioè il diritto bellico, nazionale e internazionale, nonostante i lodevoli sforzi, ha ottenuto scarsi successi nel governo della violenza in guerra. L’attuale guerra russo ucraina fornisce in merito una documentazione impressionante di barbarie. D’altro canto questa guerra mostra anche come non tutti i contendenti sono uguali nell’osservanza del diritto bellico e nel contenimento della barbarie della guerra. Qui mi riferisco precisamente alla guerra contro i civili messa in atto sistematicamente dai Russi in Ucraina. Ciò va detto chiaramente, contro le troppo facili generalizzazioni che corrono. E contro le troppo comode equidistanze.
In generale, abbiamo dunque la possibilità minimale di cercare di controllare l’uso della violenza in guerra, oppure la possibilità di far cessare ogni violenza bellica attraverso la pace. Abbiamo tuttavia anche la possibilità di rifiutare altri tipi di violenza che sono di fatto possibili. Fino al rifiuto di tutti i tipi possibili di violenza – ammesso che ne sia possibile un inventario[8]. In questo caso non possiamo parlare semplicemente di diritto bellico o di pace negativa, ma dovremo parlare proprio di un’altra cosa e cioè della nonviolenza[9]. Questa va oltre la guerra in senso stretto e diventa così un atteggiamento, una predisposizione a comportarsi, da applicare sempre, in tutte le situazioni, in tutti i casi della vita, non solo in contrapposizione alla guerra. L’insieme della nonviolenza è dunque assai più ampio dell’insieme della pace negativa. Anche se la pace negativa non può che essere uno degli aspetti compresi nella nonviolenza.
6. La nonviolenza. Trascrivo qui una definizione generale e generica: “La nonviolenza è una pratica personale che consiste nel non causare offesa ad altri in qualsiasi caso. Essa può derivare dalla credenza che offendere persone, animali e/o l’ambiente non sia necessario per ottenere qualsiasi tipo di scopo. Può avere come riferimento una filosofia complessiva che implichi l’astensione da ogni violenza. Può essere basata su principi morali, religiosi o spirituali, oppure le ragioni per promuoverla possono anche essere di tipo strategico o pragmatico”[10]. La nonviolenza è dunque anzitutto una pratica personale, più che uno strumento di lotta politica, anche se questa è stata talvolta impiegata proprio in questo senso. Si noti che la nonviolenza, secondo Aldo Capitini, non andrebbe intesa semplicemente come negazione della violenza, bensì dovrebbe essere intesa come un valore autonomo, dotato di un proprio contenuto positivo.
Per comprendere la posizione della nonviolenza, che riguarda indubbiamente il nostro discorso e a cui faremo spesso riferimento, può essere utile riandare a Lev Tolstoj (1828-1910). Preferisco rifarmi a Tolstoj, piuttosto che al ben più noto Gandhi, perché la sua posizione mi pare più chiara ed esemplare. Per una considerazione critica di Gandhi, si veda Losurdo 2010. Tra la fine degli anni Settanta e degli anni Ottanta dell’Ottocento, anche in seguito all’ esperienza personale della guerra, Tolstoj visse una profonda crisi[11] e sperimentò un’intensa trasformazione interiore che lo spinse alla fede in Dio, alla semplicità volontaria, al rifiuto di tutte le forme di violenza, alla dieta vegetariana e all’animalismo. In questo ambito elaborò i principi fondamentali della nonviolenza, in un contesto fondamentalmente di tipo religioso. I riferimenti principali da cui aveva attinto sono costituiti dai Vangeli, dal cristianesimo minoritario (ad esempio i Quaccheri), da alcuni testi orientali e da alcune filosofie, tra cui quella di Schopenhauer.
Nell’ambito della nonviolenza, la dottrina centrale di Tolstoj – che si rifà soprattutto al Discorso della montagna evangelico – è quella della non-resistenza al male con il male[12]. Tolstoj ritiene che la non resistenza al male, quando sia perseguita rigorosamente, possa condurre – oltre che alla liberazione interiore – a un’autentica trasformazione sociale e possa provocare il dissolvimento degli ordinamenti sociali oppressivi e disumani. Tutto ciò senza ricorrere ad alcuna forma di violenza. Per questo occorre tuttavia un radicale impegno personale individuale, fino a giungere a praticare la disobbedienza civile, rifiutare il servizio militare e rifiutare il pagamento delle tasse, poiché queste sono usate dagli Stati per finanziare le guerre. In ciò seguendo David Henry Thoreau (1817-1862) come precursore. Il fondamento ultimo della nonviolenza è posto da Tolstoj nel comando divino contenuto nel Vangelo. E in ultima analisi nella fede. Notoriamente fu Tolstoj a influenzare Gandhi, con tutto quel che ne seguirà, circa la dottrina della nonviolenza, dottrina che in Gandhi prende il nome di ahimsa.
Come si può notare, si tratta di un pensiero senz’altro estremamente profondo. È stato tuttavia sempre fatto notare come sia anche piuttosto difficile da praticare, poiché implica, negli eventuali praticanti, un cambiamento radicale di vita e, di fatto, uno scontro radicale con l’esistente, in pressoché tutte le sue manifestazioni. Si noti che la strada proposta dalla nonviolenza implica uno scoglio di gran rilievo in materia di etica, su cui avremo modo di discutere ampiamente, e cioè la possibilità che il male sia lasciato libero di agire senza ostacoli. Questo poiché gli eventuali ostacoli posti al male implicherebbero a loro volta il ricorso alla violenza. E dunque alla riproposizione della violenza stessa. Questa posizione – come vedremo oltre – implica un’irrisolvibile incongruenza dei valori.

7. Bellicisti, pacifisti e nonviolenti. Siamo così giunti a circoscrivere, in termini di prima approssimazione, oggetti concettuali come pace negativa e positiva, guerra, violenza e nonviolenza. Siamo ora in grado di meglio comprendere le dottrine o le elaborazioni teoriche corrispondenti a questi concetti e, conseguentemente, anche una serie di movimenti pratici che vi si ispirano. Avremo dunque le teorie pacifiste (nel senso della pace negativa ed eventualmente della pace positiva), le teorie belliciste (ed eventualmente violentiste, cioè le filosofie della violenza, anche se queste sono state raramente esplicitate e professate[13]) e le teorie della nonviolenza sul modello tolstojano e poi gandhiano. Avremo dunque, di conseguenza, come prima sistemazione, su un continuum, orientamenti e movimenti bellicisti, pacifisti e nonviolenti. Si potrebbero produrre ulteriori distinzioni, ma la cosa andrebbe troppo oltre i nostri scopi.
8. Esistono davvero i bellicisti? Dei tre punti di vista, il bellicismo è oggi l’orientamento meno caratterizzato, meno teorizzato, meno organizzato. Si tratta di un “–ismo”, il che comporterebbe, in senso proprio, una sorta di esaltazione della guerra, una sua promozione fino alla sua massima realizzazione, che corrisponderebbe al perseguimento di una sorta di guerra perfetta o di guerra perpetua[14]. Sicuramente, guardando al passato, possiamo trovare in merito numerosi casi storici. Molte società del passato si sono costituite avendo la guerra come fulcro. O, per lo meno, avendo al proprio interno gruppi sociali interamente devoti alla pratica della guerra. I quali spesso, proprio per questa loro attività connessa all’esercizio della forza, finivano per ricoprire una posizione sociale centrale e dominante. Oggi, in generale, nelle più diverse società, la centralità della guerra sembra in via di superamento. Anche molti di coloro che oggi sono impegnati settore della guerra, nel settore militare, ritengono auspicabile non doversi mai ricorrere effettivamente alla guerra. Il termine “bellicismo” oggi – almeno in Occidente – viene applicato in forma residuale soprattutto per designare coloro che ritengono possibile l’uso della guerra in determinate situazioni, oppure che, pur non esaltando la guerra, la accettano come necessaria, oppure ancora coloro che, una volta scoppiata una guerra, non vi si oppongano con la dovuta risolutezza. Talvolta si tratta di un termine che ha abbandonato la connotazione descrittiva e ha assunto connotazione retorica e dispregiativa, come il ben più noto termine guerrafondaio.
La domanda che ci dobbiamo porre allora è se oggi esistano realmente i bellicisti in senso proprio, o se questi non siano soltanto dei pacifisti deboli. Oppure pacifisti minimali, pacifisti moderati, o anche pacifisti imperfetti. In talune situazioni retoriche coloro che, pur non desiderandola, accettano la guerra come una necessità sono stati considerati come dei bellicisti. Si ponga mente al dibattito occorso in Italia alla vigilia della Grande guerra. Bellicisti autentici erano sicuramente gli interventisti, ma oggi sarebbero considerati bellicisti anche coloro che avevano come motto “Né aderire, né sabotare”, oppure i cattolici che, pur disapprovando la “inutile strage”, la ritenevano comunque doverosa in termini di obbedienza alle leggi vigenti dello Stato. Ancora diversa la posizione di taluni interventisti democratici, che volevano unicamente quella guerra per porre fine a tutte le guerre.
Come si vede, anche in questo caso, la distinzione tra bellicismo e pacifismo sembra piuttosto evocare un continuum, piuttosto che una secca dicotomia, come sembra invece emergere invece dal dibattito superficiale dei giorni nostri. Può essere anche comprensibile il fatto che nello scontro politico si sia indotti a dicotomizzare, ma è sufficiente un minimo di riflessione per concludere che la dicotomia tra pacifismo e bellicismo costituisce una ben povera rappresentazione della realtà. Soprattutto una rappresentazione di fatto priva di utilità. Tratteremo più in là della teoria della guerra giusta, che è un caso esemplare di situazione di continuità tra i due opposti.
9. Militaristi. Abbiamo visto che la guerra è una forma di violenza organizzata. Nelle società a elevata divisione del lavoro, i militari sono i professionisti della guerra. La questione degli armamenti, degli eserciti e più in generale della tecnica militare, è una conseguenza delle distinzioni precedenti. Armi, eserciti e tecniche militari sono impiegati per produrre i conflitti violenti e organizzati tra le comunità politiche ed entro gli Stati, cioè le guerre. La posizione attribuita all’organizzazione militare nell’ambito della società diventa dunque fondamentale. Quando la sfera strumentale della guerra tende a prevalere e a sopravanzare le altre sfere della società, si parla di militarismo e di società e/o Stati militaristi. Possiamo parlare più correttamente, in generale, di società a trazione militare. Si tratta di società la cui attività fondamentale ruota attorno alla guerra e dove i militari giocano un ruolo centrale nelle principali decisioni. E dove consumano nella loro attività le principali risorse economiche e finanziarie accumulate dalla società stessa. Nel corso dei secoli, in Occidente siamo stati testimoni del passaggio progressivo da società a trazione militare verso società a trazione commerciale, o a trazione industriale, tecnologica e finanziaria. Queste ultime tendono ad attribuire al settore militare un ruolo sempre più strumentale e marginale. Questa tendenza si è accentuata dopo la fine della Seconda guerra mondiale. Il caso degli USA è esemplare: pur essendo una potenza militare, la sua trazione fondamentale è di tipo tecnologico, industriale e finanziario. Oggi è di moda trascurare questo punto, a causa dell’anti americanismo pregiudiziale assai diffuso nel nostro Paese. Sul piano del militarismo, gli USA e la Russia non sono proprio la stessa cosa. La Russia di Putin, insieme a pochi altri esempi, è invece effettivamente una potenza a trazione militare (o si illude di esserlo, viste le scarse prestazioni sul campo).
Dunque, armamenti, eserciti e tecnica militare costituiscono dei mezzi che rendono possibile l’esercizio della guerra. Secondo un certo senso comune diffuso, il semplice possesso di armamenti ed eserciti sarebbe un indice certo di militarismo. Si trascura tuttavia il fatto che oggi, nella maggioranza dei casi, il possesso di armamenti ed eserciti ha la funzione di provvedere alla difesa. Questo per garantire un bene pubblico indubbio che si chiama sicurezza. Si è discusso a lungo su come ottenere la sicurezza senza disporre tuttavia di apparati di difesa ma una soluzione efficace non pare sia stata ancora trovata. Se comunque nel mondo tutti gli eserciti servissero solo per la difesa, non ci sarebbero più guerre. Forse è vero che in determinate circostanze i mezzi militari rendono anche più probabile l’esercizio della guerra. Ma è anche del tutto possibile pensare ad armi, eserciti e tecniche militari che siano perfettamente approntate, ma mai adoperate. L’idea che se hai un’arma prima o poi la usi è un’idea stupida e superficiale. Anche gli svizzeri tengono lo schioppo sotto il letto, ma è difficile pensarli come pericolosi aggressori e guerrafondai. Secondo la teoria della deterrenza, le atomiche sarebbero armi prodotte proprio per non essere mai usate.

C’è ancora indubbiamente, da qualche parte nel mondo, un militarismo aggressivo. Ci sono ancora imperialismi a trazione militare, com’è proprio il caso della Russia. Ma oggi nel mondo c’è anche un realistico impiego di eserciti e armamenti per la mera difesa. O anche per gli interventi umanitari nelle situazioni di crisi. L’esigenza di finanziare con risorse pubbliche una forza di difesa non può che dipendere dalla valutazione razionale di quanto pericoloso sia l’ambiente internazionale in cui ci si trova. I recenti avvenimenti dell’aggressione della Russia all’Ucraina hanno indubbiamente reso più pericoloso l’ambiente internazionale, determinando così – a parere di molti – l’esigenza di maggiori investimenti nella sicurezza[15]. Dunque, anche nell’ambito del militarismo, sarebbe il caso di introdurre delle distinzioni. Anche il povero Enrico Letta è stato rappresentato con l’elmetto. Non tutti i militarismi sono uguali. Dovrebbe essere evidente che il militarismo della NATO non è esattamente uguale al militarismo della Russia di Putin. Le semplificazioni eccessive precludono la comprensione della realtà e impediscono un’azione efficace nel mondo.
Può ben essere che il superamento e infine l’abolizione dell’apparato militare possa essere in futuro una conseguenza desiderabilissima dell’affermazione universale di una situazione di pace positiva. Magari connessa anche all’accettazione universale della prospettiva filosofica e religiosa della nonviolenza. Al giorno d’oggi però un simile obiettivo non sembra essere alla nostra portata. Può al più costituire al più una idea regolativa, nel senso kantiano del termine.
10. La pace si dice in molti modi. Gli elementi definitori che abbiamo fin qui introdotto hanno mostrato la complessità delle questioni affrontate, tale da afflosciare la sicumera di molti protagonisti dell’odierno dibattito pubblico. La prima acquisizione inevitabile, per chi frequenti ancorché saltuariamente questo campo, è proprio quella per cui la pace “si dice in molti modi”. Questo vuol dire che, a dispetto del senso comune, non c’è un concetto unico di pace. Si tratta piuttosto – come dicono i filosofi – di una “somiglianza di famiglia”, cioè di una rete di concetti interconnessi e di relativi usi linguistici. Dunque chi dice di essere per la pace non ha ancora detto niente: dovrebbe sforzarsi di esplicitare chiaramente cosa intende per pace. Altrimenti, bisognerebbe concludere inevitabilmente che tutti vogliono la pace. Ma una volta affermato il punto, tutti si scontrerebbero immediatamente intorno alle questioni che hanno appena evitato di chiarire. Nella letteratura filosofica e politologica si fa riferimento ad almeno quattro tipi di pace[16]. Molto diversi tra loro. Abbiamo dunque: a) la pace come resa incondizionata; b) la pace come tregua; c) la pace come trattato; d) la pace positiva. Potremmo aggiungere un quinto tipo: e) la pace come conseguenza della nonviolenza, che sarebbe poi un tipo particolare di pace positiva, alla quale abbiamo tuttavia già accennato.
11. La pace come resa incondizionata. È questo un tipo di pace che sopravviene quando uno dei contendenti (o più di uno) è talmente coartato che non può neanche decidere di scendere in guerra. Di solito si cita in proposito un famoso esempio da Rousseau. Il filosofo, all’inizio del suo Contratto sociale[17], scrive contro Hobbes: “Si vive tranquilli anche nelle carceri: basta questo per trovarcisi bene? I Greci rinchiusi nell’antro del Ciclope ci vivevano tranquilli, aspettando che venisse il loro turno di essere divorati”. Si trovavano dunque certo in pace i marinai di Ulisse, chiusi nella prigione del ciclope, in attesa di essere divorati. È questa una condizione di pace (senz’altro assenza di guerra e di violenza nell’immediato!) che deriva dalla totale passività, dalla totale costrizione, cioè dalla resa incondizionata al nemico.
La storia è piena di casi in cui una comunità politica avrebbe sicuramente scelto di combattere, solo se appena avesse potuto farlo. Possiamo pensare a situazioni nelle quali l’oppressione è così forte che i soggetti non hanno neppure la possibilità di scegliere eventualmente la via delle armi. L’attuale Afghanistan gode senz’altro di una situazione di pace in seguito alla resa incondizionata ai talebani. L’attuale Iran, che godeva senz’altro della pace interna, sta mostrando che quella pace si fondava sostanzialmente sull’oppressione (in particolare delle donne) e sta precipitando verso una situazione di guerra civile. Spesso ci si dimentica che per decidere di scendere in guerra occorre perlomeno disporre di un minimo di libertà d’azione. Rispetto a una situazione di totale dominazione, checché ne pensasse Tolstoj, la possibilità di combattere una guerra può anche essere considerata, in taluni casi, come una sorta di miglioramento della propria posizione, un auspicabile avanzamento. Solo la determinazione assoluta di non opporsi al male può sconsigliare di ricorrere alla guerra nelle situazioni più estreme di oppressione.

12. La pace come non libertà. Coloro che sono nella situazione descritta da Rousseau hanno sicuramente la pace (ammesso che così si possa chiamare), ma non hanno alcuna libertà. Non si tratta di un caso tanto raro. Assomiglia questa alla situazione hobbesiana post contrattuale, dopo che i cittadini hanno ceduto tutti i loro poteri al Leviatano (lo stato assolutistico) e sono così diventati sudditi. Hanno la pace ma sono sottomessi in tutto e per tutto al potere assoluto. Per di più l’hanno fatto per propria scelta e volontà. Si ricorderà che quella situazione, secondo Hobbes, in un solo caso si sarebbe potuta risolvere in una guerra civile: qualora il Leviatano avesse attentato alla vita dei cittadini. I sudditi sottomessi nel patto hobbesiano sarebbero dunque appena più fortunati dei marinai di Ulisse nella prigione del ciclope. Questo tipo paradossale di pace, intesa come resa incondizionata e totale sottomissione all’arbitrio, è stata ampiamente teorizzata e praticata. Ad esempio, nel caso di certi martiri cristiani. O nel caso della nonviolenza tolstojana già citata. È tuttavia davvero singolare – dovrebbe indurre a qualche riflessione coloro che in questa materia mostrano grandi certezze – che il tipo più infimo di pace, la pace come resa incondizionata, finisca con il coincidere con quella che taluni presumono essere il tipo più nobile di pace e cioè quello derivante dalla applicazione integrale della nonviolenza.
13. Una digressione nell’attualità: forse la pace non è tutto. Più recentemente, e assai più ignobilmente, nel dibattito nostrano seguente alla guerra in Ucraina, il noto opinionista prof. Orsini ha teorizzato l’opportunità della resa incondizionata di fronte all’aggressore russo, pur di avere salva la vita. Così, secondo il professore, avrebbero dovuto fare gli Ucraini di fronte all’invasione russa. In uno dei tanti talk-show, il prof. Orsini ci ha ricordato anche che: “Anche sotto il fascismo i bambini potevano vivere felici”. Poiché Putin non avrebbe probabilmente divorato gli Ucraini come il ciclope – anche se avrebbe potuto far ammazzare il loro presidente – dunque gli Ucraini, se si fossero subito arresi, avrebbero certo perso totalmente la libertà ma avrebbero guadagnato comunque la pace. Almeno per la popolazione civile e per i bambini. Dunque, ne conseguirebbe che i morti che la resistenza degli Ucraini ha indirettamente provocato (militari, civili e i bambini) sarebbero tutti da mettere sulla coscienza di Zelens’kyj, del suo bellicoso governo, con tutti i suoi alleati, che non si sono prontamente arresi. E sulla coscienza di tutti quelli che hanno dato ragione a Zelens’kyj e lo hanno aiutato. Si tratta ovviamente, questa di Orsini, non della conseguenza di una professione di fede nonviolenta, ma di una davvero singolare applicazione dell’etica della responsabilità (vedi oltre). Al professor Orsini non viene neppure in mente il punto problematico fondamentale e cioè il fatto che forse la pace non è tutto.
14. Scoglio: la pace e l’incongruenza dei valori. La situazione della pace come resa incondizionata ci fornisce l’occasione per affrontare uno scoglio teorico di notevole interesse. Ci costringe a domandarci se la pace (la pace prima di tutto, a qualunque costo) possa essere davvero considerata come il bene supremo. Se possa cioè essere considerata indipendentemente dalla situazione nella quale essa si realizza. Se possa cioè essere valutata in piena autonomia da ogni altra considerazione, se sia davvero un valore in sé, incomparabile rispetto ad altri valori. Appena la pace viene tolta dal suo carattere assoluto e viene considerata in termini situazionali, viene cioè confrontata con altri valori, o altri beni, nascono molte questioni inaspettate. Per avere in cambio la pace, possiamo rinunciare completamente alla nostra libertà? Cos’è una pace senza libertà? Anche la giustizia può essere tirata in causa. Una pace ingiusta è una vera pace?
Molti autorevoli intellettuali nostrani, soprattutto di sinistra, negli infiniti talk-show che si sono susseguiti dopo il 24 febbraio, seguendo più o meno consapevolmente il prof. Orsini, consigliavano senz’altro agli Ucraini di non resistere. Che deponessero le armi. Qualcuno si affannava addirittura a negare con argomentazioni fantasiose che quella messa in atto dagli Ucraini fosse una resistenza. Addirittura, si sentivano di decidere che non si dovessero mandare armi agli Ucraini, perché questi si arrendessero prima, dunque con meno danni per loro. Qualcuno, beato lui, s’inventò anche le “armi non offensive”. Possiamo qui parlare di altruismo? Se gli Ucraini avessero subito obbedito a questi desiderata, oggi sarebbero senz’altro in pace, sarebbero cioè sotto la pace di Putin (dove senz’altro anche i bambini potrebbero vivere felici!). Qualcuno ha pensato di mettere a confronto il bene di una simile pace con i beni della libertà e della giustizia? Qualcuno di questi “altruisti” ha pensato almeno di chiedere il parere degli Ucraini? Cioè dei diretti interessati. Purtroppo nell’epoca del pensiero incontinente nessuno si ferma ad approfondire le questioni.
Credo abbia colto nel segno il filosofo Alexandr Dugin (un filosofo russo euroasiatista e nazibolscevico, per chi non lo conoscesse) quando dice che gli Occidentali si sono rammolliti, sono in piena decadenza, perché non sono neanche più in grado di pensare di poter morire per la propria causa. Del resto Heidegger era dello stesso parere. Fa davvero pena, oggi, vedere coloro che hanno imbracciato le armi per difendere il proprio Paese, o chi per essi, negare ad altri di fare la stessa cosa, in nome della pace.
Queste considerazioni (e questi esempi) ci pongono di fronte a un problema ben noto nell’ambito dell’etica. Normalmente si pensa che i valori e/o i beni siano semplicemente di carattere additivo, che possano cioè essere sempre assommati tra loro a piacere. Per questo tutti i valori e/o i beni dovrebbero sempre essere tra loro compatibili. In realtà è noto fin dalla filosofia antica che i valori o i beni possono non essere compatibili tra loro. Perseguire determinati valori può implicare necessariamente la rinuncia ad altri. I due tipi aristotelici di giustizia, la giustizia distributiva e la giustizia commutativa, ad esempio, non sono affatto compatibili. Per avere l’uno si deve necessariamente sacrificare l’altro. In generale, è poi noto come sia molto difficile essere giusti e buoni contemporaneamente. In campo teologico, se Dio è giusto, non può essere buono, e viceversa. Nel caso del contratto hobbesiano, accade che per avere la pace si debba sacrificare la libertà. Questa spiacevole situazione è nota come incongruenza dei valori[18]. Dunque – spiace per taluni pacifisti puri – la pace deve scendere dal piedistallo del bene assoluto o per lo meno deve accettare di essere messa a confronto con altri possibili valori o beni. Come minimo con la libertà e la giustizia. Ma anche con beni assai più prosaici. Come ad esempio la sopravvivenza materiale, cioè la vita[19]. Per Orsini, la vita dei bambini vale la capitolazione e dunque la pace come resa incondizionata. Per altri tuttavia la guerra può significare una possibilità di vita. I poveri buriati (una delle etnie asiatiche prevalenti nell’esercito Russo attuale che combatte in Ucraina – la Repubblica di Buriazia è una repubblica della Federazione Russa) sono spinti ad arruolarsi e a combattere perché è pressoché l’unico lavoro che è messo loro a disposizione. Non possono permettersi di fare i pacifisti più di tanto. Poiché l’incongruenza dei valori è una questione fondamentale, ce ne occuperemo oltre.
15. La pace come tregua o “situazione di pace”. È questa la pace che corrisponde all’interruzione temporanea delle ostilità. Se vogliamo, corrisponde alla nozione della tregua. I contendenti sono ostili tra loro. Sono liberi di decidere se continuare o meno a combattersi. Decidono tuttavia di sospendere le ostilità. Siamo cioè in una situazione di ostilità non belligerata.
È questa una situazione ben nota, poiché l’abbiamo sperimentata nel corso della lunga Guerra fredda. Anche se la Guerra fredda è stata in realtà belligerata indirettamente, attraverso una serie notevole di proxy war, le guerre indirette o guerre per procura. È questa anche la situazione descritta dalla locuzione della pace armata. È anche la situazione descritta dall’equilibrio del terrore, o dall’equilibrio della deterrenza. Non si combatte più, cioè ci si è messi in una situazione di tregua, per il fatto che la prosecuzione dei combattimenti produrrebbe esiti non desiderati o temuti da entrambe le parti. Dunque, ci si mette in uno stato di tregua per la paura degli effetti di una continuazione dello stato di guerra belligerata. Si accetta di smettere di combattere perché si è sottoposti a una minaccia (o a uno svantaggio) più grande (sia da parte dell’altro contendente, sia da parte di un Terzo che sia intervenuto). Tuttavia perdura l’inimicizia e la minaccia reciproca, e resta alta la probabilità di riprendere il conflitto.

16. Scoglio: si può imporre la pace? Un caso filosofico interessante, un vero e proprio scoglio etico, è quello dell’imposizione della pace (nel senso della tregua o del trattato). Affinché si dia il caso, occorrono minimamente due contendenti e un Terzo, il mediatore, il pacificatore, che costringa i due a deporre le armi. Usando magari la persuasione, l’influenza, distribuendo garanzie e vantaggi di qualche tipo. Ma è possibile anche pensare che il Terzo possa provvedere all’imposizione della pace attraverso l’uso della forza.
Non sarà sfuggito al lettore che, in un certo senso, la possibilità di imporre la pace, cosa spesso effettivamente successa nella storia, ha in sé qualcosa di contradditorio. In una visione completamente irenica, la pace dovrebbe in un certo senso imporsi da sé. Tuttavia purtroppo la guerra, una volta iniziata, tende ad auto alimentarsi, tende addirittura a intensificarsi. Il Terzo allora è posto di fronte al dilemma di lasciare che la guerra continui oppure di imporre la pace. Se tuttavia sceglie di imporre la pace, si troverà a usare una guerra per imporre la pace. I pacifisti si scandalizzeranno, ma questo è un altro problema legato all’incongruenza dei valori. Per avere la pace si finisce per accettare che si apra una nuova guerra tra il Terzo pacificatore e i due contendenti. Non affrontiamo qui quali possano essere gli eventuali interessi del Terzo nello scendere in guerra per imporre la pace. In generale, dall’intervento del Terzo non si ha alcuna garanzia preventiva; potrebbe certo scaturire anche una pace senza libertà e/o senza giustizia.
L’idea di un Terzo pacificatore attraverso l’uso della forza non dovrebbe tuttavia risultare così peregrina. Si tenga conto che l’ONU dovrebbe, in teoria, proprio agire come un Terzo virtuoso, capace di sedare i conflitti internazionali eventualmente anche con la forza, come sta scritto nella sua Carta. Si noti tuttavia di sfuggita che, se appena si accetta la prospettiva che il Terzo possa (o sia tenuto a) intervenire con la forza per riportare la pace, allora si dovrà come minimo ammettere che non tutte le guerre sono uguali. Alcune sarebbero guerre comuni destinate a continuare o a finire con la sopraffazione dell’uno da parte dell’altro. Altre sarebbero invece guerre determinate dall’intervento del Terzo che avrebbe tuttavia come scopo il ristabilimento della tregua o della pace.
Dovrebbe suscitare un certo stupore il fatto che – in concomitanza con la attuale guerra russo ucraina – a livello mondiale non si sia aperto per lo meno un acceso dibattito circa la riforma dell’ONU, organizzazione oggi pesantemente screditata dal fatto che lo Stato palesemente aggressore, la Russia, siede nel Consiglio di Sicurezza dell’ONU, con il diritto di veto. Questo significa che la Russia, con la sua aggressione, ha di fatto privato il mondo intero di quel minimo di organizzazione internazionale abilitata a fungere da Terzo virtuoso nelle controversie. È come pretendere da ora in avanti che – ove sia violata – la pace si ristabilisca da sola. Perché questa reticenza ad affrontare la questione della riforma dell’ONU? Evidentemente l’idea di una forza militare internazionale capace di fare interventi di pacificazione anche con le armi non è così popolare, in parte per una forma di pacifismo estremista ma in parte anche per malcelato bellicismo: qualora ci si trovasse nella situazione di fare la guerra è preferibile avere le mani libere.
Così avviene che si stia togliendo di mezzo proprio il Terzo virtuoso che sarebbe in grado di intervenire con la forza e di “rendere il male con il male” all’aggressore. Ciò paradossalmente potrebbe anche essere in linea con i migliori auspici dei nonviolenti. Quel che seguirà tuttavia a questa nuova situazione non sarà il regno della pace positiva ma il regno dell’anarchia internazionale, dove ognuno farà quello che vuole, o quello che si potrà permettere, grazie magari alle sue bombe atomiche. Così gli Stati deboli cercheranno la protezione degli Stati forti, di coloro che sono in grado di vendere protezione nel più puro stile mafioso.
17. La pace come ordine privo di ostilità. È la condizione che si configura quando cessano tutte le ostilità. Solitamente questa è la condizione che si consegue sul piano del diritto attraverso la stipulazione di un trattato di pace e, in termini fattuali, attraverso la cessazione delle violenze, il ritiro delle forze e il disarmo. È quella che Bobbio, sulle orme di Aron, chiamava la pace di soddisfazione. Perché è così difficile la pace di soddisfazione? La difficoltà è dovuta al fatto che la condizione di pacificazione, una volta raggiunta, non garantisce il mantenimento della pace stessa. Detto in altri termini, la pace non si auto rigenera, la pace non è in grado di garantire il mantenimento della pace stessa. Poiché i trattati di pace possono sempre essere violati, la condizione pacifica guadagnata è sempre reversibile. La pace non ha alcuna autonomia, è comunque instabile e può tendere a precipitare verso la guerra.
Si tratterebbe allora di comprendere quali siano le condizioni, che non dipendono dalla pace stessa, che possono favorire (o addirittura garantire) il mantenimento della pace. Ad esempio, secondo un famoso assunto del politologo Michael W. Doyle, gli Stati democratici di solito non si fanno la guerra tra loro. Dunque la democratizzazione globale degli Stati costituirebbe una delle precondizioni per il mantenimento di una pace priva di ostilità. Anche un ONU riformato e funzionante (non quello attuale) potrebbe dare un contributo. È chiaro che le condizioni che potrebbero mantenere la pace potrebbero essere le più varie. Non posso entrare nel merito. C’è un’intera disciplina dedicata a questo tipo di questioni e cioè i peace studies, o anche peace and conflict studies.
In generale, possiamo però dire con relativa certezza che una delle cause principali della fine della pace è il sopravvenire dell’ingiustizia, sia all’interno delle nazioni sia tra di loro. Il mantenimento di un ordine privo di ostilità, il mantenimento di una pace di soddisfazione conseguita, implica evidentemente la giustizia. La pace senza giustizia percorre poca strada. Chi voglia mantenere una pace ordinata senza ostilità dovrebbe dunque contemporaneamente procurare la giustizia. È chiaro che una condizione di ingiustizia può spingere al ricorso alla violenza, determinando una catena causale che può portare alla guerra, interna o esterna. Sappiamo bene tuttavia che la pace di per sé non è senz’altro in grado di procurare la giustizia. D’altro canto, lo scopo di procurare la giustizia può implicare anche la rottura della pace. Per questo la pace è sempre a rischio. Ovviamente, la giustizia sussistente in una data situazione viene sempre giudicata dal punto di vista dei soggetti coinvolti, i quali potrebbero non essere affatto concordi sulla natura giusta o ingiusta della pace in questione. Anche in questo caso si presenta l’opportunità di ricorrere all’intervento di un Terzo, capace di intervenire nel merito delle ingiustizie rivendicate. Ma il Terzo come si è visto non è sempre un ospite gradito.
Queste semplici considerazioni stanno a significare che gli sforzi per realizzare e mantenere la pace non possono avere mai fine. Una volta stipulato il trattato di pace c’è sempre il rischio che l’ingiustizia, sopravvenuta o latente, rovini la pace. Allora al pacifista consapevole non resterebbe altro che reinterpretarsi come politico impegnato indefinitamente per l’implementazione della giustizia. Impegnarsi solo per la pace è indice davvero di corte prospettive sulla natura della pace stessa.
18. Pace positiva. I filosofi hanno spesso anche trattato della pace positiva, della quale abbiamo già accennato in apertura, per circoscrivere la pace negativa. Questa non è soltanto un effetto del diritto, attraverso un trattato di pace, che come abbiamo visto può però sempre essere violato. È piuttosto la condizione che la società nazionale e la comunità internazionale assumono dopo che si sia instaurata una pace giusta e sia stata instaurata la giustizia. Un caso tipico è costituito dalla teoria di Galtung, cui abbiamo già accennato.
Spesso questo concetto è stato tacciato di essere un concetto assai vago e di fatto utopico. Esso implica l’esistenza di società pacifiche e giuste e la contestuale trasformazione spirituale degli individui in modo da diventare essi stessi pacifici e giusti. Quando si pensa alla pace positiva non si può fare a meno di evocare la kantiana pace perpetua[20]. La quale tuttavia – Kant era un pessimista cronico – assomigliava più a una pace trattata che non a una pace positiva universale. Sul piano filosofico si può disquisire se una pace positiva fondata sulla giustizia sia possibile, sia effettivamente alla portata della natura umana o se non sia piuttosto incompatibile con questa. Per qualificare la inemendabilità della natura umana Kant ha usato la nota metafora del legno storto: “Dal legno storto dell’umanità non si potrà mai cavare alcuna cosa dritta”[21]. Non posso addentrami in questa problematica del rapporto tra la guerra e la natura umana ma la segnalo al lettore come stimolo per la riflessione.
Tutto ciò ha comunque una conseguenza importante, cui ho già accennato ma che vale la pena di ribadire in forma più estesa. La realizzazione della pace positiva non può essere conseguita restando all’interno dell’esclusivo dominio della pace stessa (e dei relativi pacifismi). La pace da sola non è sufficiente. Non pare bastevole alla sua compiuta realizzazione positiva. Questo significa che l’impegno per la pace non può essere disgiunto dall’impegno politico per la realizzazione di una società giusta. L’impegno per la pace non può dunque essere single issue. Raramente tuttavia i movimenti pacifisti mostrano esser consapevoli dell’esigenza, per la costruzione e il mantenimento della pace, di connettere strettamente la difesa della pace con la realizzazione della giustizia. Questa miopia dei pacifisti si spiega col fatto che ammettere di doversi impegnare per la giustizia finirebbe per sporcare le mani alla purezza apparente dell’impegno per la pace. Queste considerazioni mostrano anche i limiti della nonviolenza. La quale azzarda a ritenere che sia sufficiente la diffusione della nonviolenza per la realizzazione della giustizia. Una società con una maggioranza di nonviolenti praticanti sarebbe presumibilmente comunque sempre ostaggio di una minoranza di violenti praticanti. Anche a Paperopoli c’era la Banda Bassotti.
19. Un’altra classificazione. I diversi tipi di pace di cui abbiamo discusso rappresentano solo una delle tante classificazioni delle situazioni di pace[22]. Un’altra classificazione della pace, che riprende alcuni aspetti della precedente, è stata fornita da Raymond Aron[23].Egli distingue tre tipi di pace. A) Anzitutto la pace di potenza. È la pace che si ottiene grazie al sopravvenire di un potere forte che impone l’ordine e, dunque, la pace. Può essere di tre tipi, di equilibrio, di egemonia o di imperio. B) Abbiamo poi la pace di impotenza, che era quella fondata – all’epoca di Aron – sull’equilibrio del terrore tra le potenze atomiche. Queste erano costrette a non farsi la guerra poiché la guerra avrebbe implicato la mutua distruzione assicurata. C) In ultimo, abbiamo la pace di soddisfazione. È la pace che sopravviene quando ciascuno è in sé soddisfatto della propria situazione, per cui non cerca in nessun modo l’aggressione. Spiega Bobbio che: “La pace di soddisfazione ha luogo quando in un gruppo di stati nessuno ha pretese territoriali o d’altro genere verso gli altri, e i loro rapporti sono fondati sulla fiducia reciproca (che è proprio l’opposto del timore reciproco); pace di soddisfazione è quella che vige dopo la seconda guerra mondiale fra gli stati dell’Europa occidentale”[24].
La classificazione di Aron ha il merito di mettere in luce la dimensione di potere (e di disuguaglianza) che comunque è spesso connessa anche alle situazioni di pace (come nel caso estremo dell’antro del ciclope) e che contribuisce drammaticamente a privare la pace di quel manto idealistico che spesso i pacifisti le attribuiscono. La pace non elimina il potere e questo può sempre riprodurre l’ingiustizia.
20. Dai tipi di pace ai tipi di pacifismo. Visti i diversi tipi di pace, si possono anche dare per definiti i principali obiettivi possibili dei diversi movimenti pacifisti, cui – come dicevamo – possiamo aggiungere anche i movimenti nonviolenti. Per la chiarezza del discorso pubblico, e per l’efficacia del dibattito, questi movimenti dovrebbero però dichiarare esplicitamente quale tipo di pace vorrebbero raggiungere, nelle diverse specifiche situazioni. E dovrebbero evitare di contrabbandare un tipo di pace per un altro, come invece amano fare abitualmente, quasi senza accorgersene.

21. Intermezzo. Nell’intento di capitalizzare i dubbi del lettore volenteroso che sia giunto fino a questo punto, propongo un esercizio di riflessione su un caso concreto[25]. Vediamo con qualche dettaglio la narrazione di quel che accadde a Srebrenica tra il 6 e il 25 luglio 1995. Siamo in Bosnia-Erzegovina, pochi mesi prima della firma dell’accordo di Dayton sulla spartizione interna del Paese tra la Repubblica serba (RepublikaSrpska) e quella croato bosniaca. Srebrenica era una delle tre enclave bosniache in territorio serbo (Srebrenica, Žepa e Goražde). Di qui la forte pressione dell’esercito serbo nei confronti delle poche enclave rimaste. L’intento era quello di effettuare una pulizia etnica dell’enclave che sarebbe in prospettiva divenuta territorio serbo. Srebrenica era presidiata da un contingente di alcune centinaia di caschi blu olandesi dell’UNPROFOR, cioè dell’ONU. Avrebbero dovuto difendere gli abitanti locali da eventuali aggressioni dei serbi. Tra il 6 e il 25 luglio le forze soverchianti dei serbi, comandati dal generale Mladich, circondarono l’enclave, la conquistarono senza difficoltà e, sotto la minaccia delle armi, ridussero all’impotenza il contingente dei caschi blu olandesi. Nei giorni successivi perpetrarono sistematicamente il massacro di più di 8000 civili bosniaci. La Corte internazionale di giustizia ha successivamente definito il massacro come genocidio.
Nonostante vari processi e inchieste, la posizione del battaglione olandese dell’UNPROFOR non è stata ancora del tutto chiarita. Gli olandesi avevano solo armi leggere ed erano sicuramente inferiori di forze rispetto ai serbi. Per cui non furono in grado di intervenire e di assolvere al loro compito di proteggere la popolazione[26]. In un quadro di disorganizzazione della catena di comando, non ci fu alcun significativo aiuto o intervento aereo dall’esterno in difesa dall’enclave, nonostante fosse stato più volte richiesto dal comandante del contingente, questo perché a quanto si disse non sarebbe stato conforme alle regole di ingaggio della missione. Ai caschi blu non restò che riparare nella loro base e cercare di intavolare qualche timida trattativa con Mladich. Una moltitudine di bosniaci sfollati si radunò nei pressi della base ma gli olandesi non furono in grado né di ospitarli né di difenderli. Gli uomini di Mladich li prelevarono con il pretesto della identificazione, separarono gli uomini, li caricarono su mezzi e li portarono via e procedettero al massacro che infuriò nei giorni successivi.
Quando si resero conto di quel che stava accadendo, gli olandesi non furono comunque in grado di intervenire. Le inchieste e i processi che ci furono, a vari livelli, non hanno portato a nulla di definitivo. Circolano diverse versioni interpretative, da chi dice che, praticamente abbandonati dal Comando centrale della missione, i caschi blu non abbiano potuto fare altro che stare a guardare. Qualcuno li accusa addirittura di avere anche, per certi aspetti, collaborato con i Serbi, avendo consentito il prelevamento di coloro che si erano rifugiati nei pressi o addirittura dentro alla base. È stato accertato che, in alcuni specifici casi, i caschi blu non abbiano dato rifugio ad alcuni bosniaci che lo richiedevano espressamente e che poi sono stati massacrati. Per alcune specifiche omissioni processualmente accertate alcuni ufficiali sono stati condannati. Comunque, nonostante la situazione imbarazzante della loro posizione, forse per una sorta di riparazione, i soldati del contingente hanno anche ricevuto un’onorificenza dal governo olandese.
Il caso dei caschi blu olandesi nella sua complessità resta insoluto. A parte la responsabilità penale, gli olandesi del contingente UNPROFOR restano a tutt’oggi nel limbo indistinto di una non accertata responsabilità morale. In una posizione che può essere definita come “al di là del bene e del male”. Ecco allora qualche motivo di riflessione circa la filosofia della pace e della guerra. Qualcuno può sostenere che l’ONU, come pacificatore armato, non dovesse neppure trovarsi nella ex Jugoslavia, lasciando così che i diversi contendenti di quella guerra si pacificassero da soli. Qualche sincero umanitario può sostenere che, pur essendo inferiori in termini di forze, i caschi blu dovevano comunque intervenire per tentare di proteggere la popolazione; avrebbero cioè dovuto fare il loro dovere morale comunque, eventualmente anche sacrificando la propria vita. Oppure si può sostenere che l’ONU abbia peccato di omissione: doveva intervenire con regole di ingaggio più dure, con maggiori forze e più efficacemente, costringendo i Serbi a stare al loro posto. Anche con la minaccia o l’uso delle armi. Ma c’è anche un altro interessante punto di vista: i caschi blu olandesi non hanno fatto altro che tenere un comportamento del tutto consono con le prescrizioni nonviolente tolstojane di non rispondere al male con il male.Meglio dunque sarebbe stato in questo caso che non si fossero neanche presentati in Jugoslavia.
22. Un po’ di metaetica. Dopo il nostro intermezzo, passiamo ora a proseguire il nostro ragionamento. Finora ci siamo accontentati di individuare diversi tipi di pace, mostrando svariati problemi ad essi connessi. Ci siamo cioè occupati principalmente dei diversi obiettivi che possiamo avere in mente quando dichiariamo di essere per la pace. Dovrebbe essere emerso come minimo che la pace è un obiettivo di per sé assai problematico. Ma la pace non è solo problematica in quanto obiettivo. È anche decisamente problematica se consideriamo il modo con cui la vogliamo. Ebbene sì, la pace non solo si dice ma anche si vuole in diversi modi. Prenderemo in considerazione due modi principali. Ce ne sarebbero anche altri, ma questi due sono i più importanti. In termini di metaetica[27], la pace può essere considerata in due modi diametralmente opposti: dal punto di vista deontologico oppure da quello consequenzialista. Si tratta di una distinzione del tutto analoga a quella forse più nota di Max Weber tra l’etica dell’intenzione (o convinzione) e l’etica della responsabilità. Il primo punto di vista tende a considerare la pace come principio in sé. Il secondo punto di vista tende a considerare la pace in base alle sue conseguenze. Detto in sintesi, se assumiamo la pace come un principio universalmente valido, e dunque moralmente doveroso, saremo portati a disinteressarci delle sue conseguenze, le quali però, come s’è visto, possono anche non essere sempre buone. Se consideriamo invece primieramente le conseguenze della pace, non saremo più in grado di trattare la pace come un principio universale, valido sempre e comunque. Potremmo anche mettere in conto, in certi casi, di dover rinunciare alla pace, per evitare certe sue conseguenze negative e/o per conseguire altri beni che siano ritenuti preferibili o prioritari.
23. Deontologi. Vediamo meglio. Chi adotta la prospettiva deontologica ritiene in generale che ci siano dei principi, proprio come la pace, che sono buoni o cattivi in sé. Questi principi sarebbero dunque dotati di un loro valore intrinseco. Questa convinzione si traduce in un dovere, in un comandamento morale al quale si deve soltanto obbedire. Chi non obbedisce si rende colpevole e si colloca ipso facto dalla parte del male. Il principio della pace è dunque considerato una cosa buona di per sé e dovrebbe sempre essere realizzato senza discutere, a tutti i costi: etsipereat mundus.
Resta allora solo il problema di definire come si giunga a stabilire un principio come quello della pace, quale ne sia il fondamento o la giustificazione. I fondamenti che possono essere individuati sono molteplici e curiosamente possono anche essere in contrasto tra loro. Tuttavia mirano tutti a conferire alla pace il suo valore intrinseco. Qui può essere utile, a scopo meramente illustrativo della problematica, rammentare la vecchia classificazione kantiana delle etiche eteronome, formulata a seconda del carattere internoo esternorispetto all’individuo del principio che le guida. In termini esterni, il dovere della pace può derivare da un comando divino, oppure da un’abitudine sociale trasmessa (la tradizione e l’educazione) oppure ancora da una legge degli uomini. In termini interni può derivare invece da un impulso socievole, fornitoci dalla natura, oppure da un sentimento morale, oppure ancora dalla spinta verso la perfezione derivante dalla nostra coscienza razionale. Se si vuol essere kantiani fino in fondo, si può poi invocare anche l’imperativo categorico, come caso di etica dell’autonomia[28].
Quale che sia il fondamento posto alla sua base, è opportuno notare che, in ambito deontologico, il principio della pace viene in tal modo assolutizzato. Ciò indubbiamente lo mette al riparo da qualsiasi dubbio e da qualsiasi eccezione. Questa strategia può tuttavia essere controproducente. Già Kant aveva avvertito come l’assolutizzazione di un principio possa costituire l’anticamera del perfezionismo morale, del ritualismo e financo del fanatismomorale. In fin dei conti le cose dai tempi di Kant non sono cambiate molto. L’impressione è che coloro che si auto proclamano pacifisti in senso deontologico non siano gran che consapevoli di questi rischi. Se il principio così individuato è considerato come un assoluto allora non può mai essere confrontato e messo in concorrenza con altri valori. Gli eventuali insuccessi pratici derivanti dall’applicazione del principio (la prova dei fatti) non scalfiscono minimamente il valore che è stato assunto. Il tutto in linea con la convinzione che le conseguenze non interessino più di tanto: “Il mio dovere l’ho fatto, accada ciò che vuole”.
24. Qualche esempio particolare. Discutiamo più concretamente qualche caso. Almeno i casi principali. Chi è religioso è facile che, per fondare la pace, invochi la legge divina. Spesso in ambito cristiano si cita il Vangelo come legge suprema. Tuttavia ciò non sempre sembra bastare. Il caso di Tolstoj mostra come ci si possa trovare in disaccordo anche a partire dal Vangelo. Tolstoj riteneva che il vangelo predicasse una forma radicale di nonviolenza e ciò lo portò allo scontro con la sua Chiesa. Il moscovita patriarca Kirill oggi benedice la guerra di Putin. Il Catechismo della Chiesa cattolica sostiene invece la teoria della “guerra giusta” discostandosi dalla prospettiva deontologica (vedi oltre). Non ci potrebbero essere interpretazioni più divergenti dello stesso principio.
Secondariamente, tra i deontologisti c’è chi preferisce fondare il principio della pace sulla legge umana, sulle prescrizioni del diritto. In Italia, ad esempio, c’è chi sostiene che la nostra Costituzione proibirebbe la guerra in tutte le sue forme. Secondo i pacifisti che fondano la pace sulla Costituzione, poiché la Costituzione proibisce la guerra, il nostro Paese non dovrebbe neppure partecipare alle missioni internazionali di pacificazione, non dovrebbe produrre e vendere armi. Non dovrebbe stare nella NATO. In teoria non dovrebbe neppure possedere un esercito e (forse) non dovrebbe neppure difendersi in caso di aggressione. È evidente che una simile interpretazione della Costituzione istituirebbe la Pace non solo come obbligo morale o politico individuale ma anche come obbligo legale per tutti i cittadini italiani e le loro istituzioni. In realtà sappiamo che la questione è piuttosto controversa. Secondo autorevoli giuristi, sembra che la Costituzione proibisca certamente le guerre di aggressione. Tuttavia non è certo che proibisca le guerre di difesa e/o di resistenza. Altrimenti non sarebbe stato neanche previsto un Ministero della Difesa.
In terzo luogo è stata spesso indicata come fondamento della pace una convinzione della coscienza, intima e individuale, che imporrebbe all’ individuo di non indossare divise, di non portare armi, di non fare il servizio militare, di rifiutare dunque la guerra, o anche tutte le forme di violenza. Si tratta della cosiddetta obiezione di coscienza. Si tratta questo di un principio che non è fatto valere per tutte le coscienze o per le istituzioni ma limitato alla coscienza individuale. L’obiettore, insomma, ammette che gli altri eventualmente facciano la guerra, tuttavia rivendica per sé la prerogativa di seguire la propria coscienza e di rifiutarsi di farla. Il principio dell’obiezione di coscienza è stato accolto – com’è noto – dalla legge italiana dopo molte controversie (è appena il caso di ricordare in merito la figura di Don Milani[29] e la sua polemica con i cappellani militari). Naturalmente anche in questo caso la convinzione intima può derivare da una pluralità di fonti, dall’adesione a qualche religione, dall’adozione di un qualche imperativo morale, o simili, da un sentimento di amore verso tutti gli umani o addirittura verso tutti gli esseri viventi. Molte delle argomentazioni individuali addotte per l’obiezione di coscienza possono essere legate non solo al rifiuto della guerra ma anche al rifiuto di ogni violenza.
25. Consequenzialisti. Vediamo ora l’altra posizione metaetica. Secondo la prospettiva consequenzialista, o dell’etica della responsabilità, non accade mai che un’azione sia buona o cattiva in sé, ma va sempre valutata in base ai suoi effetti o conseguenze. Una scelta è buona solo se produce conseguenze buone, anche e soprattutto nel caso specifico. Unico criterio normativo che deve stare alla base della scelta sono dunque le conseguenze. Questo orientamento si richiama alla responsabilità di colui che sceglie la linea di condotta. L’eventuale ossequio a principi a-priori implicherebbe invece laderesponsabilizzazioneindividuale e una universalizzazione irrealistica. Per comprendere questa posizione ci si può rifare dibattito intorno alla questione dell’obbedienza assoluta alle leggi. Se n’è discusso alquanto a proposito del caso Eichmann. Se obbedire alla Legge o allo Stato è sempre un atto dovuto, allora non si sarà mai responsabili delle eventuali conseguenze dannose. Deontologicamente, in senso stretto, Eichmann avrebbe avuto perfettamente ragione. La sentenza di condanna contro Eichmann – piaccia o no – è stata pronunciata in un quadro consequenzialista.
Mentre sul piano deontologico, il principio della pace è considerato come universale, sul piano del consequenzialismo invece non può mai essere considerato come universale, deve sempre essere messo in relazione alle specifiche situazioni. Dipende, in altri termini, dalle circostanze. Questo significa che il principio della pace, come ogni altro principio, viene considerato come contingente. Poiché le conseguenze di una scelta possono essere diverse da caso a caso, nella prospettiva consequenzialista è ammesso dare valutazioni diverse a seconda dei casi. In certi casi si può decidere per la pace, in altri per la guerra. Dato quest’approccio per così dire minimalista, i consequenzialisti tendono a non assolutizzare le loro scelte e così rischiano assai meno di incorrere nel perfezionismo morale o nel fanatismo.
26. Obiezioni. Un’obiezione al consequenzialismo è che non possiamo conoscere tutte le conseguenze delle nostre scelte, per cui il processo decisionale per essere corretto dovrebbe essere infinito. Inoltre tutti i principi sarebbero relativizzati alle singole situazioni esaminate. Ogni decisione sarebbe unica e diversa da ogni altra. In questo modo il mondo dei valori diverrebbe altamente instabile, sottoposto all’arbitrio valutativo di ciascun singolo e di ciascuna situazione. Un’altra obiezione è che possiamo non trovarci d’accordo sull’analisi delle conseguenze, poiché, in quanto umani, ragioniamo sempre in condizioni di incertezza o di relativa ignoranza. Oppure siamo sempre sottoposti ai condizionamenti più diversi. Il consequenzialista dunque non avrebbe alcuna garanzia di essere nel giusto, non potrebbe mai rifarsi ad alcun fondamento consolidato. I consequenzialisti risponderebbero che è proprio così, che queste sono le autentiche condizioni di ogni scelta morale.
27. Qualche implicazione. Vediamo qualche concreta implicazione. Nello specifico della guerra russo-ucraina, i pacifisti deontologici anche più soggettivamente sinceri si stupiscono di essere considerati spesso come “amici di Putin”. In realtà essi, adottando deontologicamente il principio della pace, facendo dunque il loro “dovere”, non si faranno mai carico delle specifiche conseguenze delle loro azioni, anche quando siano abbastanza prevedibili. Ad esempio, è fattualmente abbastanza chiaro che se si togliessero gli aiuti militari all’Ucraina, questa sarebbe facilmente sopraffatta. I deontologisti tuttavia non si sentono minimamente imbarazzati da simili conseguenze, perché le conseguenze non li riguardano affatto. Se tutti ragionassero come loro, Putin avrebbe già vinto. Ma questo, appunto, non li riguarda proprio. E così si stupiscono di essere considerati “alleati oggettivi” di Putin.
Anche gli interventisti consequenzialisti (si noti che i consequenzialisti possono anche essere non interventisti) hanno un dilemma da risolvere. Accettando la guerra, anche dopo articolata riflessione, non possono che accettarne anche le gravose conseguenze, le quali si manifesteranno però solo dopo la scelta. Essi, al momento della scelta avevano ritenuto che le conseguenze sarebbero state tutto sommato accettabili se messe a confronto con un male peggiore che sarebbe derivato se avessero deciso altrimenti. Tuttavia costoro si espongono alla confutazione da parte della realtà. La posizione dei deontologi resta invece inconfutabile. Il consequenzialista interventista può essere comunque accusato di avere scelto il male minore della guerra, perché è comunque un male. Ma potrebbe anche essere ancor più accusato qualora il male minore si riveli essere in realtà un male peggiore. Il consequenzialista non può mai avere la coscienza del tutto tranquilla, finisce sempre per avere in qualche modo le mani sporche. E questo può sempre essergli rimproverato dal deontologo (il quale può sempre comodamente dire “Non in mio nome!”). In altri termini, i consequenzialisti sono indotti, in ogni situazione, a cercare di calcolare e prevedere i risultati (di cui saranno comunque responsabili, nel bene e nel male) e a scegliere di conseguenza. Ai deontologi invece non importa dei risultati specifici, dei quali non si sentono responsabili. Per loro conta solo l’aderenza al principio assoluto.

28. Dell’incompatibilità delle due posizioni. Possiamo domandarci a questo punto se sia possibile conciliare queste due prospettive. Ebbene, no, non è possibile. Si può solo stare da una parte o dall’altra. Si può, volendo, argomentare a favore dell’uno o dell’altro punto di vista, in maniera più o meno convincente, ma mai in termini risolutivi. Per questi due mondi, “fare la cosa giusta” può significare cose completamente diverse.
Che fare allora? Di fronte a questi due orientamenti incompatibili si finisce spesso per scegliere una modalità o l’altra a seconda dei casi. Diciamo pure a seconda della convenienza del momento. Si finisce per formulare delle argomentazioni miste che possono essere anche abbastanza ridicole. Ci sono tuttavia dei soggetti che sono invece più costanti e tendono più o meno a essere sempre deontologi oppure sempre consequenzialisti, in base a un atteggiamento personale spesso poco consapevole. Una specie di predisposizione.
Mi permetto qui di suggerire una scappatoia. Di porre all’attenzione la possibilità di adottare un criterio di tipo decisamente pragmatico, un criterio piuttosto “a spanne”, anche se si tratta di un criterio piuttosto vicino al modo di pensare consequenzialista. Si tratta di far ricorso alla casistica empirica nota, all’esperienza passata. Nella storia passata hanno avuto migliori risultati (cioè, hanno fatto meno disastri) coloro che hanno applicato ciecamente i loro valori o principi, oppure coloro che hanno esaminato attentamente e prudentemente le possibili conseguenze delle loro scelte? Cosa convien fare in generale, sulla base del senno di poi? È chiaro che ciascuno formulerà la propria risposta. Dal mio punto di vista, da un esame spassionato, emerge come i consequenzialisti siano meglio adattati alla democrazia. Le ragioni dovrebbero essere facilmente ricavabili da chiunque conosca appena un po’ le regole elementari della democrazia. Propongo al lettore questo compito come esercizio. Sono disposto a correggere gli elaborati.
29. La teoria della guerra giusta. Il caso più celebre di consequenzialismo è senz’altro quello della teoria della guerra giusta[30] alla quale val la pena di riservare uno spazio particolare. È una teoria che risale addirittura ad Agostino e a Tommaso d’Aquino[31]. Prima ancora si trova, ad esempio, in Cicerone. È stata ripresa nell’ambito del giusnaturalismo moderno e, per suo tramite, è giunta fino a noi. A tutt’oggi è una teoria che ha molti sostenitori ed è ancora ampiamente dibattuta. C’è una letteratura immensa sull’argomento. In campo filosofico, tra i sostenitori contemporanei della teoria della guerra giusta possiamo annoverare i filosofi Michael Walzer[32] e Norberto Bobbio[33].
La premessa minimale della teoria è che le guerre non sono tutte uguali. Ci sono guerre inique e guerre giuste. Le guerre giuste si distinguono per essere tali sia nelle motivazioni che le hanno scatenate (jus ad bellum) sia nella condotta sul campo (jus in bello). Per quel che concerne lo jus ad bellum, la sola guerra giusta tendenzialmente è quella che è messa in atto per difendersi da una aggressione. La guerra di offesa non è mai giusta. Nel corso della complessa storia di questa teoria sono state dettate precise condizioni affinché si possa parlare di guerra giusta. Abbiamo, nell’ordine: 1) La giusta causa. 2) La retta intenzione. 3) L’autorità appropriata (legale) e la dichiarazione pubblica. 4) La guerra come ultima risorsa. 5) La probabilità di successo. 6) La proporzionalità. Entrare nel merito dei punti precedenti esula dalle finalità di questo scritto. Il lettore che fosse interessato non farà fatica a trovare un’adeguata documentazione. Va segnalato che l’epiteto di “guerra giusta” non ha in questo caso alcun significato morale, bensì ha un significato giuridico. È definita giusta la guerra che abbia determinati requisiti accertabili in base alla tecnica giuridica. La teoria permette dunque di esprimere un giudizio di tipo giuridico sulla guerra. Il giudizio ovviamente, come tutti i giudizi, potrebbe anche essere errato. Potrebbe anche essere riconsiderato nel caso del sopravvenire di nuovi dati.
Non manca chi ha fatto notare come la teoria della guerra giusta sia del tutto corretta ma che nessuna delle guerre passate sarebbe in grado di passare la prova, se questa fosse condotta in maniera rigorosa. Questa teoria si presta soprattutto a essere impiegata quando in sede internazionale un consesso di nazioni (ad esempio in sede ONU) deve decidere se operare o meno un intervento. Come accade facilmente nelle faccende umane, la teoria è tuttavia stata anche usata strumentalmente dai bellicisti. L’aggressione americana all’Iraq nel 2003, ad esempio, è stata giustificata anche col pretesto che fosse una guerra giusta[34]. In quell’occasione fu anche elaborata una assai discutibile dottrina della guerra preventiva. Occorre dunque tener conto di un possibile uso ideologico e propagandistico della teoria della guerra giusta. Le strumentalizzazioni non bastano tuttavia a invalidarla e, come si diceva, è ancora ampiamente dibattuta.
Taluni hanno sostenuto – lo riporto per imparzialità affinché siano chiare tutte le posizioni – che la teoria della guerra giusta poteva valere per le guerre convenzionali. Non varrebbe più ora che c’è la possibilità della guerra atomica. Norberto Bobbio ha discusso ampiamente su questo punto. Il problema è che la possibilità della guerra atomica non ha messo fuori mercato le altre guerre convenzionali. E su queste, che sono di fatto le uniche a essere praticate, è comunque il caso di pronunciarsi. In effetti l’arma atomica ha una funzione di deterrenza ed è poco probabile che venga mai più usata (dopo il caso del Giappone) poiché con la tecnologia odierna l’uso dell’arma atomica implicherebbe la mutua distruzione assicurata. Le guerre convenzionali hanno invece molta più probabilità di essere utilizzate e di fatto lo sono. Abbiamo dunque bisogno anche di ragionare circa il da farsi relativamente alle guerre non atomiche.
Ma avremmo anche bisogno di ragionare rispetto alle armi atomiche. Negli ultimi decenni l’arsenale atomico mondiale è rimasto congelato dal TNP (Trattato di non proliferazione nucleare) e l’opinione pubblica non pare si sia mai preoccupata più di tanto circa la questione dello smantellamento. Solo nel 2017 è stato proposto da un ristretto gruppo di Paesi il TPNW (Trattato per la proibizione delle armi nucleari) cui però non hanno aderito gli Stati possessori delle bombe o aspiranti tali. Certi pacifisti si rifiutano di mandare qualche cartuccia e qualche obice agli Ucraini che stanno facendo la loro resistenza, un caso cioè che sarebbe generalmente riconosciuto come guerra giusta, ma non dedicano neanche un tweet alla causa della messa al bando delle armi nucleari. Meno male che ci ha pensato Putin a riproporre la questione.
30. L’ambiguo caso della Chiesa cattolica. Come ho spiegato ampiamente in un mio saggio precedente[35], da sempre la Chiesa cattolica sostiene esplicitamente la dottrina della guerra giusta, fin da Agostino e Tommaso d’Aquino. Nel mio saggio ho mostrato dettagliatamente come il Catechismo della Chiesa cattolica sia totalmente incentrato intorno alla teoria della Guerra giusta. Ciò significa l’adesione piena a una prospettiva consequenzialista. Ciononostante, il Papa nel suo attuale pubblico insegnamento mostra di condividere una prospettiva deontologica talvolta assai estrema, fino quasi alla nonviolenza tolstojana, cioè alla proibizione di rendere il male con il male. Questo soprattutto quando sono in questione gli aiuti militari e le spese per la difesa. Ma poi il Papa non trae tutte le conseguenze dalla sua adesione alla nonviolenza. Il messaggio è dunque piuttosto ambiguo. Nel Catechismo si teorizza il diritto alla difesa e alla resistenza da parte di chi è aggredito e invece nelle piazze la Chiesa tuona contro l’invio delle armi in Ucraina e contro gli investimenti nella sicurezza. Si tratta di una palese contraddizione che, nel mio saggio, ho sintetizzato nella formula del peace populism. Intendendo con ciò che questa contraddizione sia dovuta principalmente allo scopo più o meno consapevole della Chiesa di ottenere una qualche popolarità a buon mercato. Un pacifismo deontologico e fondamentalista è senz’altro più popolare di un consequenzialismo responsabile.
Va notato che la teoria consequenzialista della guerra giusta della Chiesa cattolica (almeno quella contenuta nel Catechismo) si espone alle critiche deontologistiche di coloro che professano rigorosamente la teoria della nonviolenza. Per rendersene conto, basta mettere a confronto il Catechismo della Chiesa cattolica con Tolstoj[36]. Agli occhi di Tolstoj, il Catechismo cattolico sarebbe da considerarsi come una mera manifestazione di eresia, un vero e proprio tradimento dell’insegnamento di Cristo. Se stiamo alla lettera, è probabile che Tolstoj abbia ragione. Solo la plateale ignoranza dilagante presso il grande pubblico permette oggi alla Chiesa cattolica di sostenere e insegnare la guerra giusta nel Catechismo e, contemporaneamente, di presentarsi come sostenitrice di un pacifismo deontologico nonviolento, senza che nessuno ne ravvisi le incongruenze.
31. Di che pacifismo sei? Da quanto detto, dovrebbe risultare chiaro fin qui che i problemi che questa materia comporta sono davvero complessi e che ciascuno dovrebbe essere attentamente impegnato nel costruire la propria posizione personale. Una posizione comunque che, per la natura stessa della cosa, non sarà alla fine esente da lati oscuri, incongruenze, conseguenze non desiderate. Sarà dunque una posizione che avrà punti forti, ma anche punti di debolezza. Sarà una simile posizione che sarà poi utilizzata per formulare gli opportuni cauti giudizi sui casi concreti. Dovrebbe dunque risultare chiaro che non ci si può accontentare di superficialità e banalità. Se il ragionamento fin qui sviluppato sarà sembrato eccessivo, ebbene pensi il nostro coraggioso lettore che quel che qui è stato fornito è solo un approccio del tutto elementare. La complessità delle questioni è ben maggiore. In altri termini, non c’è via di scampo, bisogna studiare! Vediamo allora in sintesi, ad usumdelphini, quali sono le principali posizioni possibili.
32. Nonviolenti. Abbiamo anzitutto i nonviolenti. Pare questo il caso relativamente più chiaro, sebbene sia il più difficile da mettere in pratica. Riteniamo di doverli collocare in una loro categoria a parte per il fatto che essi hanno, come obiettivo, non tanto la eliminazione della guerra bensì l’eliminazione della violenza in generale. Se poi intendono – come fa Galtung – per violenza anche la violenza sociale (cioè le disuguaglianze, lo sfruttamento, l’impedimento allo sviluppo delle potenzialità umane di ciascuno, la discriminazione e simili) essi sarebbero impegnati nella impresa di costruire, senza fare uso della violenza, una società completamente nuova, in una vera e propria rivoluzione, sia sul piano istituzionale sia sul piano degli individui. Dal punto di vista metaetico, l’approccio dei nonviolenti è generalmente di tipo deontologico, con tutti i suoi pregi ma anche con i difetti che abbiamo ampiamente discusso in precedenza. I nonviolenti, posti di fronte alla guerra, si troveranno comunque a dover affrontare e risolvere la molteplicità dei dilemmi circa la pace e la guerra che abbiamo segnalato. In particolare, potranno facilmente trovarsi di fronte alla incongruenza dei valori e ai paradossi derivanti dal “non opporsi al male con il male”. E al rischio del fanatismo. Un problema particolare poi è quello della efficacia effettiva in termini pratici della metodologia nonviolenta.
33. Pacifisti assoluti. Abbiamo poi i pacifisti deontologici. Sono coloro che – per i principi più diversi – scelgono sempre la pace, “senza se e senza ma”. Costoro potrebbero essere definiti come pacifisti assoluti. Diciamo pure che costoro, per quanto ampiamente variegati al loro interno, costituiscono un blocco relativamente monolitico. Questa posizione deve comunque risolvere il problema (che non hanno i nonviolenti) di identificare cosa si debba intendere per guerra, cioè di identificare l’oggetto della loro opposizione. Abbiamo visto che l’oggetto guerra è piuttosto fuzzy e, a seconda di quel che si intende, può produrre comunque già delle differenziazioni interne assai marcate nello schieramento. Ci possono essere posizioni assai radicali ove si vietino la produzione e il commercio di armi, ove si chieda lo smantellamento degli eserciti, ma anche ove si vietino i cosiddetti interventi umanitari, le varie forme di interposizione, oppure gli interventi dell’ONU. Ove si condannino nel passato e nel futuro tutte le forme di resistenza armata e ove si condanni anche la guerra passata al nazifascismo. C’è poi anche chi intende la pace solo come obiezione di coscienza individuale (la riserva solo per sé e non la impone agli altri) e chi la intende invece come norma legale da imporre a tutti attraverso una Costituzione. Anche i pacifisti deontologici possono facilmente trovarsi di fronte alla incongruenza dei valori e al paradosso di “non opporsi al male con il male”. E al rischio del fanatismo. Il pacifismo assoluto sembrerebbe dunque la posizione più facile ma al proprio interno, osservando un minimo di rigore, può riservare molti problemi piuttosto difficili da risolvere.
34. Pacifisti relativi. Ma l’elenco non è finito. L’approccio metaeticoconsequenzialista pone più di un problema, per quel che riguarda il da farsi rispetto alla pace (e alla guerra). Se i pacifisti deontologici sceglieranno pressoché sempre la pace, senza badare alle conseguenze, i consequenzialisti invece potranno essere indotti a scegliere, in casi specifici diversi, sia la pace sia la guerra. Ma allora, i consequenzialisti sono da considerare come pacifisti o non piuttosto come bellicisti? Oppure vanno considerati di volta in volta, solo sulla base della loro scelta del momento? Risultando così come dei ballerini morali che transitano troppo facilmente da una posizione all’altra?
 Facciamo un esempio per capirci. Bertrand Russell (1872-1970) è ritenuto generalmente un’importante figura di filosofo e attivista pacifista. È famoso per essersi impegnato per la messa al bando delle armi atomiche. Si è opposto alla partecipazione della Gran Bretagna alla Prima guerra mondiale. Per questo fu privato della cattedra e fu perfino incarcerato. Eppure Russell, dopo un notevole impegno per prevenire il conflitto, giunse ad approvare la guerra contro la Germania nazista. Come dovremmo considerare la sua posizione? Siamo in presenza di un pacifista eroico, oppure di un bellicista guerrafondaio? Oppure di un voltagabbana? Russell ha chiarito la sua posizione in un famoso articolo del 1943[37] nel quale egli si considera non un pacifista assoluto ma “pacifista politico relativo”[38]. Ben al di là di essere un altalenante, egli si considera dunque un pacifista perfettamente coerente. Ma come tale, e proprio in quanto tale, ammette che talune guerre vadano appoggiate. Va da sé che i nonviolenti e i pacifisti assoluti difficilmente accetterebbero Russell in loro compagnia.
Facciamo un esempio per capirci. Bertrand Russell (1872-1970) è ritenuto generalmente un’importante figura di filosofo e attivista pacifista. È famoso per essersi impegnato per la messa al bando delle armi atomiche. Si è opposto alla partecipazione della Gran Bretagna alla Prima guerra mondiale. Per questo fu privato della cattedra e fu perfino incarcerato. Eppure Russell, dopo un notevole impegno per prevenire il conflitto, giunse ad approvare la guerra contro la Germania nazista. Come dovremmo considerare la sua posizione? Siamo in presenza di un pacifista eroico, oppure di un bellicista guerrafondaio? Oppure di un voltagabbana? Russell ha chiarito la sua posizione in un famoso articolo del 1943[37] nel quale egli si considera non un pacifista assoluto ma “pacifista politico relativo”[38]. Ben al di là di essere un altalenante, egli si considera dunque un pacifista perfettamente coerente. Ma come tale, e proprio in quanto tale, ammette che talune guerre vadano appoggiate. Va da sé che i nonviolenti e i pacifisti assoluti difficilmente accetterebbero Russell in loro compagnia.
Se non vogliamo trattare anche Russell come un guerrafondaio allora non possiamo fare altro che accettare la sua argomentazione e ampliare la nostra classificazione dei pacifisti. Avremo allora, da un lato, i pacifisti assoluti che deontologicamente scelgono sempre la pace e poi avremo, d’altro canto, anche i pacifisti non assoluti, pacifisti “relativi”, che non scelgono sempre la pace e si riservano di giudicare caso per caso. Dovrebbe essere abbastanza chiaro, almeno a partire dall’esempio di Russell, che i pacifisti relativi non possono essere assimilati tout court ai bellicisti (i quali sceglierebbero pressoché sempre la guerra). Assumiamo dunque che non basta dare un appoggio circostanziato a una certa guerra, per essere considerati tout court bellicisti o guerrafondai. Si può combattere Hitler anche in nome della causa della pace. Anche qui, le distinzioni sono importanti, non si tratta della stessa cosa! Nella recente letteratura anglosassone sulla pace e sulla guerra si parla tranquillamente di relative pacifism, di contingentpacifism, oppure di conditionalpacifism. Se non si accetta questa soluzione si corre il rischio di screditare una categoria di pacifisti sicuramente numerosa e ben impegnata. Facendo un cattivo servizio alla causa della pace. Si tratterebbe dunque di ammettere una buona volta che i pacifisti relativi siano comunque dei pacifisti a pieno titolo e che un pacifista in certi casi possa anche stare dalla parte della guerra. Pazza idea! Ancora una volta, questa non è una questione che può essere affrontata in maniera schematica. Il pericolo del fanatismo è sempre alle porte.
35. Pacifisti relativi insufficienti. I pacifisti relativi (che non possono che essere consequenzialisti) costituiscono tuttavia un gruppo davvero composito, spesso diviso al proprio interno in base alle diverse analisi condotte circa l’opportunità o i costi e i benefici delle diverse scelte di pace o di guerra. È il caso di ricordare che molti pacifisti relativi (forse la maggioranza!) sembra che, nel caso del conflitto russo – ucraino, abbiano optato proprio per la pace (cioè, di fatto, per la resa incondizionata dell’Ucraina). Sembra tuttavia che i pacifisti relativi facciano notizia solo quando scelgono di appoggiare la guerra. Nel caso della guerra russo – ucraina, diversi di loro hanno appoggiato la resistenza ucraina, fino ad approvare le sanzioni, l’invio di armi, guadagnandosi così l’appellativo dispregiativo di pacifisti con l’elmetto. Ugualmente hanno approvato l’aumento delle spese militari per la sicurezza, beccandosi l’accusa di essere dei guerrafondai e di voler togliere risorse alla sanità, all’istruzione e a una miriade di altre buone cause.
Il livello decisamente poco elevato dell’attuale dibattito italiano sulla guerra in Ucraina suggerisce, ahimè, una pessimistica considerazione circa i molti pacifisti relativi che sono in circolazione. Tra i quali può essere anche collocato il già citato prof. Orsini. Nonostante il parere autorevole di Ockham[39],per tutti costoro mi verrebbe di suggerire una nuova categoria, quella dei pacifisti relativi insufficienti. Se non piace questo termine, si potrebbe anche parlare di pacifisti relativi deboli. Come diceva Viano: “di quelli che non ce la fanno”. O, ancora, di pacifisti relativi opportunisti. Che abbiano optato per la pace o per la guerra, costoro, come consequenzialisti, mostrano abbastanza palesemente di avere operato la loro scelta in base ad analisi assai discutibili delle conseguenze. Purtroppo, l’analisi delle conseguenze non sempre è caratterizzata da onestà e imparzialità, da considerazioni approfondite e di ampio respiro. Talvolta può essere caratterizzata da basse e ciniche convenienze, da abietti e futili motivi. Non tutti si chiamano Bertrand Russell. Non tutti si chiamano Albert Einstein (il quale sulla guerra a Hitler ha sostenuto posizioni analoghe a quelle di Russell). L’analisi delle conseguenze poi può non sempre essere caratterizzata dall’impiego di dati fondati e deduzioni logicamente corrette. Dunque, bisogna purtroppo riconoscerlo, il consequenzialismo è in fin dei conti fin troppo democratico. Ce n’è davvero per tutti i gusti, e anche gli imbecilli sono comunque sempre autorizzati a fare la loro brava analisi delle conseguenze. Del resto in una democrazia è senz’altro giusto che sia così. La democrazia dovrebbe essere così robusta da scoraggiare gli imbecilli e invece li subisce continuamente. E forse li alimenta.
36. Utilitarismo e verità. I pacifisti relativi insufficienti, che sono una legione, non sono purtroppo una sorpresa poiché abbiamo già sottolineato la possibile parentela del consequenzialismo con le etiche utilitaristiche. L’utilitarismo tradotto in pratica purtroppo spesso dimentica il principio cardine che lo dovrebbe improntare, il principio della “maggior felicità per il maggior numero”[40],e tende a scadere in mero opportunismo individualistico. Questo è il motivo per cui, in ambito consequenzialistico occorre sempre esercitare una grande vigilanza affinché l’analisi delle conseguenze non sia viziata dagli innumerevoli bias in cui ci si può imbattere. Mentre in campo deontologico il dibattito non può che vertere intorno ai valori universali (i quali però per lo più si assumono a torto o a ragione senza gran ché dibattere), in campo consequenzialista invece il dibattito è essenziale.Dovrebbe sempre essere approfondito, ampio, documentato, e soprattutto pubblico, per permettere la formazione di un’opinione pubblica matura e consapevole. In altri termini, per fare bene i consequenzialistibisogna studiare. Mi permetto in proposito di richiamare una considerazione recentemente espressa da Emanuele Parsi[41], e cioè che le democrazie non possono proprio funzionare al di sotto di una certa soglia di circolazione della verità. A maggior ragione, ciò dovrebbe valere di fronte a questioni gravi come quelle della pace e della guerra. Occorrerebbe dunque un forte commitment per la verità. È invece un dato fatto che il pubblico medio attuale non si occupa di politica e men che mai di politica internazionale. E le informazioni che circolano sono quelle che corrono sui social media e sui media nazionali. E, soprattutto, i nostri pacifisti relativi insufficienti tendono a decidere piuttosto irresponsabilmente con un tweet o con un Like, magari in base a un bel corredo di fake.
37. Per concludere. Lo scopo di questo saggio, divenuto ormai fin troppo lungo, era quello di fornire alcuni strumenti elementari di analisi a chi volesse condurre una riflessione indipendente e non banale sulle questioni della guerra e della pace. Lo scopo era anche di esercitare un’opera minima di chiarificazione del linguaggio che, su questo tema, è oggi davvero molto inquinato. Spero di avere mostrato ancora una volta come la filosofia possa disseminare dubbi piuttosto che propinare certezze e come possa rappresentare tuttavia uno strumento critico nei confronti per lo meno delle forme più crasse di superficialità. Ho cercato di essere il più obiettivo possibile, non rinunciando ovviamente di volta in volta a esprimere le mie opinioni. Per rispetto nei confronti del lettore, mi sono tuttavia sforzato di rendere sempre ben distinguibili le mie analisi argomentate dalle mie opinioni e valutazioni. Ringrazio i pochi lettori che siano giunti fin qui, sperando di avere fatto loro un qualche buon servizio. Disponibilissimo a ricevere critiche e osservazioni. E a ricevere, qualora fosse il caso, anche qualche ringraziamento. In ossequio al motivo kantiano del “legno storto”, non mi faccio comunque nessuna illusione che tutto ciò possa servire a migliorare anche di un solo millimetro la nostra etica pubblica.
Opere citate
2021 AA. VV., (a cura di), Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo. Decima edizione, Terra Nuova Edizioni.
1962 Aron, Raymond, Paix et guerre entrelesnations, Calmann-Lévy, Paris.Tr. it.: Pace e guerra tra le nazioni, Edizioni di Comunità, Milano, 1970.
1990 Berlin, Isaiah, “Alla ricerca dell’ideale”, in AA., VV. (a cura di), Etica ed economia, La Stampa, Torino. [1988]
1984 Bobbio, Norberto, Il problema della guerra e le vie della pace, Il Mulino, Bologna.
1989 Bobbio, Norberto, Il terzo assente. Saggi e discorsi sulla pace e sulla guerra, Edizioni Sonda, Torino.
1991 Bobbio, Norberto, Una guerra giusta? Sul conflitto del Golfo, Marsilio, Venezia.
2010 Losurdo, Domenico, La non-violenza. Una storia fuori dal mito, Laterza, Bari.
1967 Erasmo, da Rotterdam, Il lamento della Pace (a cura di Luigi Firpo), UTET, Torino. [1517]
1969 Galtung, Johan, “Violence, Peace, and Peace Research”, in Journal of Peace Research, Vol. 6, No. 3 (1969), pp. 167-191.
1995 Kant, Immanuel, Idea per una storia universale dal punto di vista cosmopolitico, in Kant, Immanuel, Scritti di storia, politica e diritto (a cura di Filippo Gonnelli), Laterza, Bari. [1784]
1965 Milani, Lorenzo (Don), L’obbedienza non è più una virtù, Libreria Editrice Fiorentina, Firenze.
1991 Kant, Immanuel, Per la pace perpetua (a cura di salvatore Veca), Feltrinelli, Milano. [1795]
2022 Parsi, Vittorio Emanuele, Il posto della guerra e il costo della libertà, Bompiani, Milano.
1992 Rousseau, Jean-Jacques, Il contratto sociale (a cura di Tito Magri), Laterza, Bari. [1762]
1943-44 Russell, Bertrand, “The Future of Pacifism”, in The American Scholar, Vol. 13, No. 1 (Winter 1943-44), pp. 7-13.
2009 Tolstoj, Lev, La confessione, Feltrinelli, Milano. [1882]
1988 Tolstoj, Lev Nikolàevič, La mia fede, Editoriale Giorgio Mondadori. [1884-1892]
1894 Tolstoi, Leone, Il Regno di Dio è in voi, Fratelli Bocca, Roma.
1997 Walzer, Michael, Just and Unjust Wars, Basic Books, Harper Collins Publishers. Tr. it.: Guerre giuste e ingiuste. Un discorso morale con esemplificazioni storiche, Liguori, Napoli, 1990.
[1]Ho iniziato a scrivere questo saggio pochi giorni dopo il 24 febbraio 2022, data dell’aggressione all’Ucraina da parte della Russia. Per questo sono andato a ripescare materiali relativi alla mia attività di insegnamento, insieme a una gran quantità di vecchi appunti e scritti risalenti al periodo delle guerre jugoslave e al periodo della occupazione dell’Afghanistan. Ricordo in proposito di avere dato un mio perdurato contributo alla Campagna contro le mine antiuomo in Afghanistan, condotta dall’ICS. La stesura del saggio è durata per tutti questi lunghi mesi di guerra, nel corso dei quali ho potuto tuttavia assistere al pressapochismo sia del dibattito mediatico sia delle prese di posizione delle diverse forze politiche, pacifisti compresi. Ho potuto assistere anche alle incertezze, alle ambiguità e al tradimento della causa dei resistenti ucraini da parte di molti degli appartenenti alla mia stessa parte politica, fattori questi spesso uniti all’ignoranza e allo stravolgimento della verità storica. Ho pensato più volte di lasciar perdere. Che non ne valesse proprio la pena. Ho trovato la motivazione minima per condurre a termine questo lavoro dopo la liberazione di Kherson. Slava Ukraini!
[2]Cfr. AA. VV. 2021.
[3]Si noti che possono ben sussistere conflitti d’altro tipo, considerati come accettabili o addirittura utili e indispensabili. Come, ad esempio, il conflitto tra i candidati in una democrazia.
[4] Putin dichiara che la sua è un’operazione militare speciale, ma poi dichiara la mobilitazione “parziale” come se fosse in guerra. D’altro canto, l’Ucraina non ha mai dichiarato guerra alla Russia. Si è trovata in guerra suo malgrado.
[5]Si veda il noto saggio di Erasmo da Rotterdam: Il lamento della pace. Cfr. Erasmo da Rotterdam 1967[1517].
[6] È il caso di far notare che perché si possa parlare di guerra occorre che ci siano delle comunità politiche. La nozione di guerra dunque ha poco a che vedere con la questione dell’aggressività umana, com’è stata trattata dagli etologi, o dagli psicologi. Certo, l’aggressività rappresenta uno dei substrati biologici della guerra. Ma si può dire la stessa cosa anche del pollice opponibile.
[7] Cfr. Bobbio 1984: 124.
[8] La definizione di ciò che è considerato violento è senz’altro di tipo storico e culturale. Certi rituali primitivi erano – e sono talvolta tuttora – violenti. Violenti i sacrifici, animali ma anche umani, previsti da talune religioni. Violenti certi metodi educativi, o certe modalità nel rapporto tra uomo e donna. Taluni considerano violento il cibarsi di carne animale o di certi prodotti animali. Qualcuno considera violento anche l’uso di certi aggettivi o espressioni linguistiche. Ma violenza è anche quella legale, esercitata dallo Stato. È nozione comune il fatto che lo Stato moderno abbia il “monopolio della violenza”.
[9] Scrivo “nonviolenza” senza il trattino seguendo un’indicazione di Aldo Capitini.
[10]La definizione è tratta da Wikipedia, versione in lingua inglese. La traduzione è mia.
[11]Di questa crisi è dato conto nello scritto La confessione. Cfr. Tolstoj 2009.
[12] Trascrivo per comodità del lettore quello che secondo Tolstoj costituirebbe l’autentico comandamento del Discorso della Montagna. Il testo è banalmente tratto da Wikipedia:
“Primo precetto (Matteo, V, 21-26). L’uomo non solo non deve uccidere l’uomo, ma nemmeno adirarsi contro di lui, suo fratello; non deve disprezzarlo né considerarlo “stupido”. Se avrà questionato con qualcuno dovrà riconciliarsi con lui prima di offrire i suoi doni al Signore, vale a dire prima di accostarsi a Dio con la preghiera.
Secondo precetto (Matteo, V, 27-32). L’uomo non solo non deve commettere adulterio, ma neppure servirsi della bellezza della donna per il proprio piacere; e se sposa una donna, deve restarle fedele per tutta la vita (nella tradizione cattolica corrente sono qui unificate la seconda e terza antitesi).
Terzo precetto (Matteo, V, 33-37). L’uomo non deve impegnarsi in niente, sotto giuramento.
Quarto precetto (Matteo, V, 38-42). L’uomo non solo non deve rendere occhio per occhio, ma quando qualcuno lo percuote su una guancia, deve porgergli l’altra; deve perdonare le offese, sopportarle con rassegnazione e non rifiutare nulla di ciò che gli venga chiesto.
Quinto precetto (Matteo, V, 43-48). L’uomo non solo non deve odiare i suoi nemici e combatterli, ma deve amarli, aiutarli e servirli”.
[13] Nella filosofia di Hobbes, lo stato di natura è descritto come una lotta violenta di tutti contro tutti, dove è contemplata l’uccisione del nemico. In Hegel la violenza è generatrice della Storia. Si ricordi la sua metafora del bancone del “macellaio della storia”. La volontà schopenhaueriana è eminentemente conflittuale e violenta. In alcuni aspetti della filosofia di Nietzsche la violenza è contemplata come fondamento stesso della realtà. La teoria darwiniana – che è teoria scientifica – implica, di fatto, la predazione che rappresenta comunque una forma di violenza. Ma una vera e propria filosofia della violenza è contenuta nel darwinismo sociale che è uno stravolgimento della teoria darwiniana. Molte filosofie della razza si fondano sul conflitto razziale inteso come motore della storia. Nonostante molte ragguardevoli filosofie abbiano posto come fondamento la violenza, nella storiografia filosofica si esita a riconoscere l’esistenza di una corrente sotterranea che potremmo chiamare violentismo. Quando si vuol dire qualcosa del genere di solito si ricorre al realismo politico. Ma non è la stessa cosa.
[14]Osserva Bobbio che, mentre si può pensare a una pace perpetua, assai più raramente è stato elaborato il pensiero di una guerra perpetua. I bellicisti che ammettono la guerra normalmente la considerano come un elemento temporaneo, da concludersi con una pace. Sorge dunque il dubbio che i bellicisti possano, in qualche misura, essere considerati minimamente pacifisti.
[15]Coloro che sono contrari alle spese militari di solito lo sono per principio. E tendono a non considerare se la situazione attuale internazionale sia o meno una situazione di insicurezza. Il problema sembra non li riguardi. Posto che si ammetta di essere in una situazione di insicurezza, non spiegano se in tal caso si debba ugualmente procedere con un disarmo unilaterale.
[16]Faccio qui riferimento all’articolo di Andrew Fiala contenuto nella Enciclopedia Stanford. Vedi: Fiala, Andrew, “Pacifism”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2021 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = https://plato.stanford.edu/archives/fall2021/entries/pacifism/.Fiala è uno tra i più importanti studiosi anglosassoni della materia.
[17] Cfr. Rousseau Capitolo IV, Della schiavitù.
[18]Per un orientamento sulla questione si può vedere: Hsieh, Nien-hê and Henrik Andersson, “IncommensurableValues”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2021 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = https://plato.stanford.edu/archives/fall2021/entries/value-incommensurable.
[19]Si noti si può sostenere che anche la vita non sia un valore assoluto. E che vada comunque sempre commisurato con altri beni materiali o immateriali altrettanto importanti. È noto che gli umani, essendo animali culturali, sono in grado di sacrificare volontariamente la propria vita, in determinate condizioni. Giusta o sbagliata che sia la decisione. Una riflessione articolata sulla questione si trova nel mio saggio: Durkheim e i “suicide bombers”. Cfr. Finestre rotte: Durkheim e i “suicide bombers”.
[20]Cfr. Kant 1991 [1795].
[21]Cfr. Kant 1995[1784]. La traduzione che propongo qui si trova in Berlin 1990.
[22]Ci siamo rifatti particolarmente ad Andrew Fiala, uno dei più importanti studiosi anglosassoni di queste questioni.
[23] Cfr. Aron 1962.
[24]Cfr. Bobbio :137
[25]Il resto di questo paragrafo è tratto da un mio saggio precedente.
[26]Cfr. Pirjevec 2001: 469 e segg..
[27]La pace può essere trattata anche sul piano della metaetica, cioè attraverso quella disciplina dell’etica che riflette sui metodi dell’etica stessa.
[28]Non posso qui dilungarmi su questa classificazione. Chi fosse interessato troverà ampi ragguagli in merito su un qualsiasi manuale di storia della filosofia o in qualsiasi monografia su Kant.
[29] Cfr. Milani (Don) 1965.
[30] Si noti che il consequenzialismo ha prodotto molte altre argomentazioni a proposito della pace e della guerra.
[31] Cfr. Tommaso d’Aquino, Summa Theologica, II-II, Questione 40.
[32]Cfr. Walzer 1997.
[33]Cfr. Bobbio 1984, Bobbio 1989, Bobbio 1991
[34]Detta anche Seconda Guerra del Golfo, fu combattuta nel 2003 anche se gli eventi possono essere datati tra 2003 e 2011. La guerra fu condotta dagli USA (allora presidente era George W. Bush) e da una coalizione dei cosiddetti Volenterosi. Si tratto di una cosiddetta “guerra preventiva”. Le analisi e le inchieste successive dimostrarono che non sussistevano le motivazioni per considerare questa guerra come una “guerra giusta”.
[35]Cfr. il mio saggio Catechismo, guerra e resistenza. Finestre rotte: Catechismo, guerra e resistenza.
[36]Si veda Tolstoj 1988 e Tolstoi 1894.
[37]Cfr. Russell 1943-44.
[38]La qualificazione di “politico” Russell intende distinguere la sua posizione da quella degli obiettori di coscienza.
[39]Il quale sosteneva che le entità (i concetti) non dovrebbero essere moltiplicate se non per estrema necessità.
[40]Il principio benthamiano costituisce un nobile tentativo di universalizzare in qualche modo l’utilitarismo.
[41]Cfr. il recente Parsi 2022.




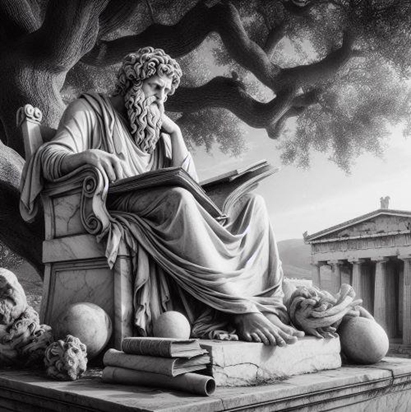













 Facciamo un esempio per capirci. Bertrand Russell (1872-1970) è ritenuto generalmente un’importante figura di filosofo e attivista pacifista. È famoso per essersi impegnato per la messa al bando delle armi atomiche. Si è opposto alla partecipazione della Gran Bretagna alla Prima guerra mondiale. Per questo fu privato della cattedra e fu perfino incarcerato. Eppure Russell, dopo un notevole impegno per prevenire il conflitto, giunse ad approvare la guerra contro la Germania nazista. Come dovremmo considerare la sua posizione? Siamo in presenza di un pacifista eroico, oppure di un bellicista guerrafondaio? Oppure di un voltagabbana? Russell ha chiarito la sua posizione in un famoso articolo del 1943
Facciamo un esempio per capirci. Bertrand Russell (1872-1970) è ritenuto generalmente un’importante figura di filosofo e attivista pacifista. È famoso per essersi impegnato per la messa al bando delle armi atomiche. Si è opposto alla partecipazione della Gran Bretagna alla Prima guerra mondiale. Per questo fu privato della cattedra e fu perfino incarcerato. Eppure Russell, dopo un notevole impegno per prevenire il conflitto, giunse ad approvare la guerra contro la Germania nazista. Come dovremmo considerare la sua posizione? Siamo in presenza di un pacifista eroico, oppure di un bellicista guerrafondaio? Oppure di un voltagabbana? Russell ha chiarito la sua posizione in un famoso articolo del 1943





 Ieri mattina ho rimesso in funzione il vecchio Pasquali. Per molti il Pasquali sarà un perfetto sconosciuto, qualcuno magari assocerà il nome all’eccezionale filologo che fu maestro di Timpanaro: per me invece è il trattorino con carrello che per quasi vent’anni ha costituito una sorta di mia appendice, e che da sei o sette giaceva inattivo nel magazzino del capanno. È andato in moto al secondo colpo, roba che solo una Mercedes, senza che nemmeno avessi sostituito la nafta rimasta nel serbatoio. Mi sono congratulato con lui.
Ieri mattina ho rimesso in funzione il vecchio Pasquali. Per molti il Pasquali sarà un perfetto sconosciuto, qualcuno magari assocerà il nome all’eccezionale filologo che fu maestro di Timpanaro: per me invece è il trattorino con carrello che per quasi vent’anni ha costituito una sorta di mia appendice, e che da sei o sette giaceva inattivo nel magazzino del capanno. È andato in moto al secondo colpo, roba che solo una Mercedes, senza che nemmeno avessi sostituito la nafta rimasta nel serbatoio. Mi sono congratulato con lui. Mentre andavo su e giù per il prato carico di ramaglia scorgevo il Pasquali là in alto, sulla strada: sembrava commiserarmi ironico, come il cavallo di Lucky Luke. Cercavo di giustificare la mia esitazione scaricandola un po’ anche su di lui, dicendomi che dopo tanto tempo non potevo essere sicuro delle sue reali condizioni, di quelle dei freni soprattutto. Ma sapevo che non era affatto quello il problema, meno che mai dopo quella fulminea partenza. Mi dicevo anche, e questo ha già più senso, che è questione di confidenza: accade come in montagna, se stai un po’ senza frequentarla le pendenze diventano subito più ripide e le creste più strette ed esposte. Insomma, ho stentato parecchio ad ammettere che semplicemente avevo paura; e anche allora mi sono ripetuto che era giusto così, e che semmai ero un incosciente prima, quando mi buttavo senza riflettere (questo almeno in parte è vero, e a dispetto dell’essere stato un incosciente fortunato ho cicatrici su tutto il corpo a testimoniarlo).
Mentre andavo su e giù per il prato carico di ramaglia scorgevo il Pasquali là in alto, sulla strada: sembrava commiserarmi ironico, come il cavallo di Lucky Luke. Cercavo di giustificare la mia esitazione scaricandola un po’ anche su di lui, dicendomi che dopo tanto tempo non potevo essere sicuro delle sue reali condizioni, di quelle dei freni soprattutto. Ma sapevo che non era affatto quello il problema, meno che mai dopo quella fulminea partenza. Mi dicevo anche, e questo ha già più senso, che è questione di confidenza: accade come in montagna, se stai un po’ senza frequentarla le pendenze diventano subito più ripide e le creste più strette ed esposte. Insomma, ho stentato parecchio ad ammettere che semplicemente avevo paura; e anche allora mi sono ripetuto che era giusto così, e che semmai ero un incosciente prima, quando mi buttavo senza riflettere (questo almeno in parte è vero, e a dispetto dell’essere stato un incosciente fortunato ho cicatrici su tutto il corpo a testimoniarlo). La differenza è maggiore di quanto possa sembrare, perché la vecchiaia è una condizione, che si vive e si percepisce dall’interno, sapendo che in un modo o nell’altro va gestita: mentre il secondo è un processo che subiamo nella piena consapevolezza della sua inarrestabilità, ma rimanendo ancora aggrappati a quello che eravamo ieri. Essere vecchi è insomma una questione anagrafica, la cui soglia può variare da una cultura all’altra (per i latini ad esempio era quella dei sessant’anni: “Ogni uomo di sessant’anni, sposato o anche, per tutti i diavoli, celibe, del quale si sappia che corre dietro alle ragazze, sarà perseguito e in virtù della detta legge, sarà giudicato uno scimunito” dice Plauto), ma al di là di questa sei out per la gran parte delle normali attività, che tu lo voglia o meno: diventare vecchi dipende invece solo in parte dall’anagrafe, è una questione fisica e mentale, rispetto alla quale si ha l’illusione di essere noi a decidere la soglia. In sostanza, si accetta di essere vecchi, ma non di diventarlo.
La differenza è maggiore di quanto possa sembrare, perché la vecchiaia è una condizione, che si vive e si percepisce dall’interno, sapendo che in un modo o nell’altro va gestita: mentre il secondo è un processo che subiamo nella piena consapevolezza della sua inarrestabilità, ma rimanendo ancora aggrappati a quello che eravamo ieri. Essere vecchi è insomma una questione anagrafica, la cui soglia può variare da una cultura all’altra (per i latini ad esempio era quella dei sessant’anni: “Ogni uomo di sessant’anni, sposato o anche, per tutti i diavoli, celibe, del quale si sappia che corre dietro alle ragazze, sarà perseguito e in virtù della detta legge, sarà giudicato uno scimunito” dice Plauto), ma al di là di questa sei out per la gran parte delle normali attività, che tu lo voglia o meno: diventare vecchi dipende invece solo in parte dall’anagrafe, è una questione fisica e mentale, rispetto alla quale si ha l’illusione di essere noi a decidere la soglia. In sostanza, si accetta di essere vecchi, ma non di diventarlo.