di Paolo Repetto, 4 novembre 2020
“Tutti gli uomini hanno una segreta attrazione per le rovine”
Chateaubriand, Il genio del Cristianesimo
“La storia futura non produrrà più rovine”
Marc Augé, Rovine e macerie. Il senso del tempo
Cammino con Stefano sulla cresta di una collina, nel cuneo di terra che separa ancora per un breve tratto Tanaro e Po, a nord-ovest di Alessandria. Davvero non te lo aspetti un posto così bello, a pochi chilometri da una città tanto piatta e grigia. Queste colline non hanno nulla di selvaggio, sono dolci e ordinate, completamente addomesticate dal lavoro umano lungo i secoli, e non susciteranno mai l’emozione del sublime: ma trasmettono l’idea di un rapporto armonioso con la terra. A me la natura piace anche così, mi piace vederci impressa l’impronta dell’uomo, quando è delicata, leggera.
Ma non sono qui per scoprire il paesaggio, negli ultimi tempi ho già imparato a conoscerlo bene. Cammino invece sulla scia della passione più recente di Stefano, quello per la fotografia di luoghi in rovina o abbandonati (che ha anche un nome, urbex, da urban exploration: inglese naturalmente). Mi incuriosisce. Sono quindi a rimorchio, è lui a guidare, perché ha in testa una meta. Conoscendolo, è probabile che questa meta sia a pochi passi da dove abbiamo lasciato l’auto, ma senz’altro ci arriveremo facendo il giro più lungo possibile e percorrendo l’itinerario più ondulato.
Infatti. Viaggiamo per tre o quattro chilometri su stradine o sentieri fangosi che corrono lungo i campi, fino ad arrivare ad una macchia di verde del tutto inselvatichito e apparentemente impenetrabile. Nel verde si apre però ad un certo punto un piccolo varco, impercettibile al passante distratto. Ci inoltriamo nel folto e all’improvviso, quasi magicamente, siamo di fronte all’edificio.

 È una costruzione imponente, tre piani che vanno calcolati con le misure di un tempo, quindi alta ad occhio e croce almeno una dozzina di metri. Ma non è facile farsi un’idea globale delle dimensioni, perché l’edificio non è mai visibile da una sufficiente distanza. Dall’esterno della macchia risulta totalmente nascosto, malgrado l’altezza, dalle piante secolari che lo circondano. Quando si è dentro lo si può guardare solo dal basso. Non riesco a valutare lo stato del tetto, ma i muri perimetrali sono tutti ancora in piedi, e non si vedono crepe. Persino l’intonaco regge, tranne in qualche punto sulla facciata che guarda a settentrione e nel cornicione che aggetta. Tutto il resto, naturalmente, le cornici in muratura degli infissi e i fregi e gli infissi stessi, è in totale rovina. La costruzione è forse databile agli inizi del secolo scorso, magari anche alla fine di quello precedente: lo stile sta tra il Liberty e l’Art Dèco.
È una costruzione imponente, tre piani che vanno calcolati con le misure di un tempo, quindi alta ad occhio e croce almeno una dozzina di metri. Ma non è facile farsi un’idea globale delle dimensioni, perché l’edificio non è mai visibile da una sufficiente distanza. Dall’esterno della macchia risulta totalmente nascosto, malgrado l’altezza, dalle piante secolari che lo circondano. Quando si è dentro lo si può guardare solo dal basso. Non riesco a valutare lo stato del tetto, ma i muri perimetrali sono tutti ancora in piedi, e non si vedono crepe. Persino l’intonaco regge, tranne in qualche punto sulla facciata che guarda a settentrione e nel cornicione che aggetta. Tutto il resto, naturalmente, le cornici in muratura degli infissi e i fregi e gli infissi stessi, è in totale rovina. La costruzione è forse databile agli inizi del secolo scorso, magari anche alla fine di quello precedente: lo stile sta tra il Liberty e l’Art Dèco.
Entriamo con cautela, e all’interno lo stato di degrado è ancora più evidente. Calcinacci e vetri ovunque, l’intero soffitto di una sala crollato, tappezzerie a brandelli, vecchie stufe, sedie e tavoli disfatti. Rimane però ancora percettibile quella che doveva essere l’originaria ricchezza e bellezza degli ambienti: nei pavimenti alla genovese, nelle volte affrescate, nelle lunette che offrivano scorci montani o lacustri, in quel che rimane degli armadi a muro, ecc… Mi viene in mente per un attimo la Vill’Amarena di Gozzano:  Bell’edificio triste inabitato!
Bell’edificio triste inabitato!
Grate panciute, logore, contorte!
Silenzio! Fuga delle stanze morte!
Odore d’ombra! Odore di passato!
Odore d’abbandono desolato!
Fiabe defunte delle sovrapporte!
Il riferimento non è del tutto appropriato, ma lascia intravvedere quella che ha potuto essere la fase iniziale dell’abbandono (in verità mi viene in mente perché è una delle poche poesie che ancora ricordo, e mi ci aggrappo prima che la memoria sia ridotta come questa casa).
 Non ci avventuriamo ai piani superiori perché anche le scale sono fatiscenti, una grossa crepa taglia a metà il primo pianerottolo. Meno che mai osiamo scendere in un buio piano interrato, dove non arriva luce da nessuna apertura. In realtà non credo sia poi così pericoloso, ma l’impressione è che ci si debba muovere con tutta la delicatezza possibile, per non contribuire ad accelerare lo sfascio. È una casa che incute un certo rispetto.
Non ci avventuriamo ai piani superiori perché anche le scale sono fatiscenti, una grossa crepa taglia a metà il primo pianerottolo. Meno che mai osiamo scendere in un buio piano interrato, dove non arriva luce da nessuna apertura. In realtà non credo sia poi così pericoloso, ma l’impressione è che ci si debba muovere con tutta la delicatezza possibile, per non contribuire ad accelerare lo sfascio. È una casa che incute un certo rispetto.
Stefano comincia sparare fotografie, è affascinato dalla rovina, che i raggi filtranti attraverso quel che resta delle persiane ammantano davvero di una malinconica poeticità. Io, dopo il primo momento di sorpresa, e dopo aver appagato la curiosità iniziale, sento invece montare dentro un sentimento che conosco bene. A differenza di Stefano, che è un positivista professo ma sotto sotto subisce un po’ il fascino della decadenza, io di fronte a queste cose sto male. Non accetto alcun tipo di degrado che non sia quello iscritto nei cicli naturali, perché quello non è degrado, è trasformazione. Questo edificio è invece una testimonianza culturale, è cultura che va a pezzi, e allora sento l’urgenza di intervenire, di impedire alla rovina di avanzare. È una  vera e propria sindrome, che rasenta l’autismo: ovunque vada sono immediatamente colpito da quel che è fuori posto, che potrebbe essere migliorato, sistemato, recuperato (così come mi irrita profondamente, nelle persone, ogni comportamento caciarone e scomposto). Una volta a casa di un amico ho rimesso in piedi tutta una serie di anfore abbattute sparse per il giardino, per poi scoprire che erano state messe così ad arte (il senso devo ancora capirlo oggi). Dopo aver restaurato e ridipinto i settanta metri di staccionata che chiudono il giardino di mia figlia a Bournemouth, mi aggiravo per la città a verificare quante altre staccionate avrebbero avuto bisogno di un sano intervento (e sarei stato disposto ad operarlo gratis). Insomma, è una malattia, che però non si limita a un decorso passivo, ma a modo suo mi rende immediatamente operativo.
vera e propria sindrome, che rasenta l’autismo: ovunque vada sono immediatamente colpito da quel che è fuori posto, che potrebbe essere migliorato, sistemato, recuperato (così come mi irrita profondamente, nelle persone, ogni comportamento caciarone e scomposto). Una volta a casa di un amico ho rimesso in piedi tutta una serie di anfore abbattute sparse per il giardino, per poi scoprire che erano state messe così ad arte (il senso devo ancora capirlo oggi). Dopo aver restaurato e ridipinto i settanta metri di staccionata che chiudono il giardino di mia figlia a Bournemouth, mi aggiravo per la città a verificare quante altre staccionate avrebbero avuto bisogno di un sano intervento (e sarei stato disposto ad operarlo gratis). Insomma, è una malattia, che però non si limita a un decorso passivo, ma a modo suo mi rende immediatamente operativo.
 Anche in questo caso finisco subito a realizzare che si potrebbe intervenire qui, rinforzare là, recuperare materiali, ripristinare. Cerco di figurarmi come potrebbero essere i locali una volta restaurati, e come sarebbe possibile farlo con interventi minimi, puramente conservativi. Mentre Stefano continua a raccogliere immagini, ogni tanto coinvolgendomi anche, comincio a fare mentalmente i conti: un tot a metro per il tetto e per gli intonaci, un calcolo approssimativo per le decorazioni esterne e per gli infissi, una bella botta per il ripristino degli interni. Siamo, molto all’ingrosso, nell’ordine del milione di euro. E questo a condizione di mettere all’opera gente seria, ad esempio i muratori con i quali ho lavorato, fino a pochissimi anni fa, per recuperare la mia casa. Altrimenti la cifra raddoppierebbe, e il risultato sarebbe disastroso. Il tutto naturalmente evitando ogni intromissione delle varie sovrintendenze e degli svariati e altrettanto inutili altri organismi di controllo, oggi tranquillamente indifferenti davanti al fatto che un edifico del genere vada allo sfascio, ma che domani, casomai un folle decidesse di metterci mano, interverrebbero di corsa a imporgli i vincoli più stupidi e le direttive più insensate.
Anche in questo caso finisco subito a realizzare che si potrebbe intervenire qui, rinforzare là, recuperare materiali, ripristinare. Cerco di figurarmi come potrebbero essere i locali una volta restaurati, e come sarebbe possibile farlo con interventi minimi, puramente conservativi. Mentre Stefano continua a raccogliere immagini, ogni tanto coinvolgendomi anche, comincio a fare mentalmente i conti: un tot a metro per il tetto e per gli intonaci, un calcolo approssimativo per le decorazioni esterne e per gli infissi, una bella botta per il ripristino degli interni. Siamo, molto all’ingrosso, nell’ordine del milione di euro. E questo a condizione di mettere all’opera gente seria, ad esempio i muratori con i quali ho lavorato, fino a pochissimi anni fa, per recuperare la mia casa. Altrimenti la cifra raddoppierebbe, e il risultato sarebbe disastroso. Il tutto naturalmente evitando ogni intromissione delle varie sovrintendenze e degli svariati e altrettanto inutili altri organismi di controllo, oggi tranquillamente indifferenti davanti al fatto che un edifico del genere vada allo sfascio, ma che domani, casomai un folle decidesse di metterci mano, interverrebbero di corsa a imporgli i vincoli più stupidi e le direttive più insensate.
Lascio Stefano a finire il suo servizio e mi aggiro nei dintorni della casa: solo per scoprire che le sorprese non sono affatto finite. Come avrei dovuto immaginare, a pochi metri, ma assolutamente invisibile se non ci si avventura in un altro varco nella boscaglia, c’è un secondo edificio, molto più basso e meno elegante, alle spalle del quale è stato appoggiato in epoca relativamente recente un enorme porticato. Dal porticato si ha accesso diretto ad una cantina. Evidentemente era la residenza dei mezzadri, e deve essere stata abitata o utilizzata ancora per qualche tempo dopo l’abbandono della casa padronale: almeno sino a una quarantina d’anni fa, come testimoniano le botti in cemento e lo stato del tetto. Dalla piccola radura antistante la casa individuo poi quello che probabilmente era l’accesso principale alla villa: un vialone un tempo inghiaiato, fiancheggiato da platani enormi, che scende con dolce pendenza e perfettamente rettilineo per almeno duecento metri, sino ad immettersi nella strada comunale. Ho il sospetto che Stefano lo sapesse, e che saremmo potuti arrivare sin lì tranquillamente in macchina. Ma in fondo sono contento di essermi guadagnato almeno un po’ la gioia della scoperta. Che non cessa di rinnovarsi: dal lato opposto, dando le spalle alla casa, intravvedo un altro edificio ancora. Era la stalla-fienile. Dentro, in mezzo a cumuli di cianfrusaglie d’ogni tipo, ci sono ancora delle vecchie attrezzature per l’aratura con gli animali. Devo aggiornare i preventivi per il restauro, ma rispetto a quanto previsto per il corpo centrale qui sono bazzecole.

Ora la topografia del luogo si ricompone. Si accedeva alla villa dal basso, e la si scopriva mano a mano che si risaliva il viale, mentre i due edifici “di servizio” rimanevano nascosti sino all’ultimo. Il viale si interrompeva in uno slargo alla loro altezza, dal quale con due dolci rampe laterali si guadagnava il terrapieno su cui sorgeva la dimora padronale. L’effetto doveva essere di imponenza e di eleganza assieme.
Continuando a girovagare mi rendo conto che il parco alberato è molto più ampio di quanto immaginassi. In serata poi, tornato a casa, scopro sulla mappa satellitare di Google che in basso, proprio al confine del parco, c’è ancora un quarto edificio, del quale né io né Stefano ci siamo accorti. Tra l’altro, nella visione dal satellite l’assieme appare come un’isola verde in mezzo ai diversi toni del marrone dei campi che la circondano.
Bene, non ho dettagliato questa piccola esplorazione domestica per puro amore di racconto, ma perché mi ha spinto a riflettere molto e perché ancora oggi, il giorno dopo, non riesco a smettere di pensarci. E mi chiedo innanzitutto se, al di là della mia specifica sindrome da dio riordinatore, progetti di recupero come quello su cui fantasticavo ieri sarebbero poi davvero così insensati, anche prescindendo da tutti i fattori emotivi, valutandoli su un piano prettamente economico.
Dunque. Proviamo ad immaginare come potrebbero andare le cose in un paese normale. È difficile, perché intanto in un paese normale un edificio del genere non sarebbe in quelle condizioni, sarebbe già intervenuto qualcuno, qualche ente, qualche istituzione, per impedirne la rovina. Se da noi questo non avviene non è perché la cosa sia impossibile, ma perché siamo un popolo di idioti. E certamente, se ogni progetto lo parametriamo a quest’ultimo dato di fatto, allora possiamo abbandonare in partenza. Io sto ragionando per assurdo, ma in questo caso non è assurdo il ragionamento, quanto piuttosto il fatto che in questo paese non lo si possa nemmeno fare.
Allora, rimaniamo nella fanta-utopia (mi ci sono affezionato) del “paese normale”. Se fossi io il legislatore dopo un massimo di dieci anni di abbandono metterei i proprietari di fronte ad un aut aut: o lo tenete in piedi voi o lo cedete (per una cifra simbolica) alla comunità, che provvederà a farlo. Non ci sarebbe nemmeno bisogno di espropriare: basterebbe tassare in maniera esponenzialmente salata gli edifici oltre un certo periodo di non utilizzo. Mi si obietterà che il problema sarebbe a questo punto che fare della miriade di edifici di cui lo stato si troverebbe ad essere proprietario, visto che non riesce nemmeno a manutenere le strutture pubbliche di sua pertinenza. È vero: ma io sto parlando di uno stato normale, il che esclude in partenza situazioni come quella italiana.
Comunque, continuando così non si va da nessuna parte. Devo confrontarmi con la realtà: proviamo a rimanere in Italia. Assumendo quello che ho calcolato per la “mia” villa come costo medio di ogni intervento (e credo di essermi tenuto largo, perché per almeno due terzi gli interventi potrebbero essere meno dispendiosi), per recuperare diecimila edifici o luoghi di un certo pregio sarebbero necessari dieci miliardi di euro. Può sembrare una bella cifra, un investimento colossale: e in effetti lo è, lo sarebbe in qualsiasi momento e lo è tanto più in questa nefasta congiuntura di pandemie e di crisi strutturali.
Ma guardiamo a ciò che abbiamo di fronte. Teoricamente l’Italia dovrebbe ricevere nei prossimi mesi un soccorso finanziario nell’ordine di oltre duecento miliardi (il famoso recovery fund). Il condizionale è d’obbligo, perché il soccorso è subordinato alla presentazione di un piano di investimenti credibile e concreto, cosa di cui si hanno mille ragioni per dubitare (detto tra noi, fossi l’Olanda o la Svezia o l’Austria non farei credito di un solo centesimo al nostro paese). Il rischio è che tutto ciò che saremo in grado di proporre si riduca a una serie di interventi di “tamponamento” a pioggia, vale a dire ad elargire soldi destinati a tacitare le proteste, legittime o meno, ma non certo a normalizzare il respiro della nostra economia. Al tempo stesso abbiamo milioni di persone inattive, in parte per una crisi che era già strisciante prima del Covid e che con la pandemia è esplosa, in parte perché l’idea di poter contare su un salario, che sia di cittadinanza o assuma la forma di qualsivoglia altra assistenza, dissuade molti dal cercarsi o dall’accettare un lavoro. E non mi si venga a dire che è un ragionamento “di destra”, perché è solo una fotografia realistica della situazione.
Il lavoro infatti, a volerlo vedere e organizzare seriamente dagli uni e a volerlo fare senza troppe scene dagli altri, ci sarebbe. Basti pensare a tutti gli interventi urgenti di risanamento ambientale, che quantomeno ci metterebbero in sicurezza rispetto agli eventi catastrofici che ad ogni stormir di pioggia devastano il nostro territorio. Sarebbe un investimento ripagato da un riscontro immediato, di tipo occupazionale e non solo, perché smuoverebbe la produzione e avrebbe una ricaduta contributiva sulle casse statali: ma la sua maggior resa verrebbe col tempo dai risparmi sullo stillicidio continuo di interventi d’emergenza. A questo naturalmente andrebbe data la priorità.
 Anche quello che ipotizzo io è però un investimento che dà risposte concrete e immediate, oltre ad aprire a quelle a lungo termine. Attivando cantieri per diecimila interventi di recupero di questo tipo si creerebbero come minimo centomila posti di lavoro nel settore edilizio e si metterebbe in moto indirettamente un indotto che ne vale altrettanti. Una volta chiusi i cantieri, rimarrebbero attivi almeno ventimila posti per le attività di manutenzione e valorizzazione di quanto già recuperato, mentre potrebbero partire ulteriori progetti di risanamento “culturale”. Queste attività, se minimamente coordinate e inserite in circuito con altre forme di “offerta” (da quelle gastronomiche a quelle enologiche, dall’escursionismo alle più svariate pratiche di fitness, ci sta di tutto), una volta avviate potrebbero raggiungere facilmente l’autonomia finanziaria. A dispetto della nostra colpevole negligenza siamo ancora un paese ad altissima attrattiva turistica anche nel campo della cultura, e con uno sforzo intelligentemente mirato potremmo offrire quei percorsi alternativi ai grandi eventi, alle mostre-monstre, agli intruppamenti obbligati, che vengono invocati ogni volta che le nostre città d’arte arrivano al collasso, ma per i quali non è mai stato pensato alcun progetto serio.
Anche quello che ipotizzo io è però un investimento che dà risposte concrete e immediate, oltre ad aprire a quelle a lungo termine. Attivando cantieri per diecimila interventi di recupero di questo tipo si creerebbero come minimo centomila posti di lavoro nel settore edilizio e si metterebbe in moto indirettamente un indotto che ne vale altrettanti. Una volta chiusi i cantieri, rimarrebbero attivi almeno ventimila posti per le attività di manutenzione e valorizzazione di quanto già recuperato, mentre potrebbero partire ulteriori progetti di risanamento “culturale”. Queste attività, se minimamente coordinate e inserite in circuito con altre forme di “offerta” (da quelle gastronomiche a quelle enologiche, dall’escursionismo alle più svariate pratiche di fitness, ci sta di tutto), una volta avviate potrebbero raggiungere facilmente l’autonomia finanziaria. A dispetto della nostra colpevole negligenza siamo ancora un paese ad altissima attrattiva turistica anche nel campo della cultura, e con uno sforzo intelligentemente mirato potremmo offrire quei percorsi alternativi ai grandi eventi, alle mostre-monstre, agli intruppamenti obbligati, che vengono invocati ogni volta che le nostre città d’arte arrivano al collasso, ma per i quali non è mai stato pensato alcun progetto serio.
 Ora, mi si farà notare, tutta questa gente va comunque da subito pagata. Appunto. Ricordo che stiamo parlando di un settore nel quale da molto prima del covid una buona metà degli addetti stazionava in cassa integrazione, e la quota è aumentata con la pandemia; quindi si tratta in realtà di gente già pagata con soldi pubblici, e senza alcuna contropartita. Lo stesso vale naturalmente per i percettori del reddito di cittadinanza. Ci sono poi anche le spese per i materiali: ma teniamo presenti le sovvenzioni “di ristoro” che lo stato elargisce alle aziende messe in crisi dalla pandemia e dalle misure restrittive: con le stesse cifre si potrebbe acquisire già gran parte del fabbisogno. Anche in questo caso, sarebbero soldi destinati in parte a rientrare nelle casse dello stato e dell’ente previdenziale, sotto forma di imposte e di contributi. Rimane il tema scottante del tipo di occupazione offerta. Ma mi sembra sia giunta l’ora di mettere in chiaro come girano le cose. Non siamo in grado di creare “posti di lavoro” rispondenti a tutte le aspettative, siamo solo in grado di creare occasioni di lavoro, e dovremmo semmai poi assicurarci che questo si svolga in sicurezza, che sia adeguatamente retribuito, che crei a sua volta professionalità e conferisca quindi dignità. Non ha senso opporre che i nostri giovani, o anche i meno giovani, non sono “preparati” per questi tipi di attività. Nemmeno chi sbarca sulle nostre coste o arriva dall’est nel nostro paese è preparato, ma non tarda ad adeguarsi. Impareranno, e questo sarà per loro un valore aggiunto, oltre al fatto di guadagnarsi uno stipendio e poter fare progetti per il futuro. Se invece per quei duecentomila posti dovremo reclutare polacchi o senegalesi, ben venga allora anche l’immigrazione clandestina.
Ora, mi si farà notare, tutta questa gente va comunque da subito pagata. Appunto. Ricordo che stiamo parlando di un settore nel quale da molto prima del covid una buona metà degli addetti stazionava in cassa integrazione, e la quota è aumentata con la pandemia; quindi si tratta in realtà di gente già pagata con soldi pubblici, e senza alcuna contropartita. Lo stesso vale naturalmente per i percettori del reddito di cittadinanza. Ci sono poi anche le spese per i materiali: ma teniamo presenti le sovvenzioni “di ristoro” che lo stato elargisce alle aziende messe in crisi dalla pandemia e dalle misure restrittive: con le stesse cifre si potrebbe acquisire già gran parte del fabbisogno. Anche in questo caso, sarebbero soldi destinati in parte a rientrare nelle casse dello stato e dell’ente previdenziale, sotto forma di imposte e di contributi. Rimane il tema scottante del tipo di occupazione offerta. Ma mi sembra sia giunta l’ora di mettere in chiaro come girano le cose. Non siamo in grado di creare “posti di lavoro” rispondenti a tutte le aspettative, siamo solo in grado di creare occasioni di lavoro, e dovremmo semmai poi assicurarci che questo si svolga in sicurezza, che sia adeguatamente retribuito, che crei a sua volta professionalità e conferisca quindi dignità. Non ha senso opporre che i nostri giovani, o anche i meno giovani, non sono “preparati” per questi tipi di attività. Nemmeno chi sbarca sulle nostre coste o arriva dall’est nel nostro paese è preparato, ma non tarda ad adeguarsi. Impareranno, e questo sarà per loro un valore aggiunto, oltre al fatto di guadagnarsi uno stipendio e poter fare progetti per il futuro. Se invece per quei duecentomila posti dovremo reclutare polacchi o senegalesi, ben venga allora anche l’immigrazione clandestina.
Sono scaduto nello sproloquio da allenatore da bar, di quelli che non saprebbero gonfiare un football ma disquisiscono dei moduli di gioco. Io però non voglio fare l’allenatore, altrimenti mi sarei dato alla politica. Voglio semplicemente dimostrare che una scelta del genere in Italia non si farà mai non perché impossibile, o insensata, ma perché ogni cosa, ogni idea, ogni progetto deve confrontarsi da noi con la vischiosità degli apparati, l’inossidabilità dei privilegi, le gelosie e le ripicche tra i vari enti, lo scaricabarile tra le diverse istituzioni, e non ultimo con una malintesa, ipocrita ed egoista concezione della libertà. Non ci vuole una gran fantasia ad immaginare il balletto dei bandi e degli appalti truccati e dei ricorsi, la sequela delle lungaggini e delle assurdità burocratiche, il gioco delle tangenti e degli interventi della magistratura, il veto a prescindere dei sindacati e degli ispettorati e delle associazioni di difesa dei chirotteri o delle piante spontanee, il traffico dei subappalti, tutta la polvere e la sporcizia insomma che un qualsiasi progetto qui da noi va a sollevare. Ma le cose sono complicate solo perché rese tali da una assoluta mancanza di senso dello stato, di onestà, di competenze, di buona volontà, ecc…: tutti vizi che non attengono al naturale ordine del mondo, ma solo a una particolare disposizione negativa che ci portiamo dietro. Non possiamo imputare il nostro perenne stato di emergenza al fato o ai complotti orditi alle nostre spalle dai poteri forti, ma solo alla nostra riluttanza ad assumerci, a qualsiasi livello, una qualsivoglia responsabilità, dalla nostra tendenza a sentirci sempre creditori nei confronti di tutti, della nostra meschina corsa a scovarci alibi per non fare nulla.
Con queste premesse è evidente che uno i progetti non dovrebbe nemmeno immaginarli. Forse farei meglio a restarmene nell’utopia del paese normale. O forse ci sono rimasto davvero, perché da ieri non faccio che parlare con gli amici di questa cosa, e oggi ne ho già sguinzagliati un paio in cerca di informazioni sulla proprietà. Avessi trent’anni di meno, e quattro soci armati di buona volontà, altro che recovery fund! Accoglierei in cima al viale la delegazione olandese, e si toglierebbero tanto di cappello.

***
“Le allegorie sono nel regno del pensiero
quel che le rovine sono nel regno delle cose”
Walter Benjamin
Dopo la visita alla villa abbandonata, sopiti un po’ gli entusiasmi restaurativi, mi sono trovato a riflettere su un tema di ordine più generale, che meriterebbe dunque un approccio più serio e ponderato: infatti ho qualche esitazione a trattarlo in questo contesto. Ma non sapendo se e quando potrò tornarci su, colgo almeno l’occasione per anticiparlo.
Constatavo, anche in rapporto alla nuova passione di Stefano, che stiamo tornando ad una “estetica delle rovine”, ciò che ci rimanda a quanto accaduto nella sensibilità occidentale un paio di secoli fa, verso la fine del XVIII secolo. Erano stati infatti Winckelmann e poi Goethe ad elaborare questa particolare teoria del sentimento del bello, ispirati non a caso proprio dai loro soggiorni in Italia (e sempre non a caso Winckelmann in Italia era stato ammazzato). Il riferimento era naturalmente alle rovine dell’antichità (stava nascendo l’archeologia classica, erano state da poco riscoperte Pompei ed Ercolano), che si rivelavano essenziali per ri-educare il gusto moderno alla bellezza: da esse si poteva inferire la forma originaria e pura delle opere greche e romane, e ciò, al di là dell’appagamento “sensoriale”, emotivo, doveva indurre alla ricerca, all’imitazione e alla riproduzione di quella bellezza. Non solo di quella artistica: quel mondo poteva darci lezioni sul piano giuridico, legislativo, sociale. Il neoclassicismo non era un moto di reazione agli sconvolgimenti rivoluzionari. Era figlio legittimo dell’Illuminismo. (“Le idee che le rovine suscitano in me sono grandiose”, scriveva Diderot , uno dei Maestri del mio personalissimo pantheon: e, nel mio piccolo, sembrano sortire anche su di me lo stesso effetto).
Ma quel figlio non era l’unigenito. La stessa antichità che alimentava il sogno neoclassico poteva ispirare anche altre fantasie, meno serene; il passato nel quale i classicisti identificavano un modello riproponibile per il presente poteva apparire come un mondo splendido e maestoso, ma irrimediabilmente perduto (si pensi a Piranesi: nelle acqueforti sulle antichità romane esprime la nostalgia per un mondo ideale, per un’epoca incomparabile, ma ormai chiusa e irripetibile: di fronte ai resti colossali dei Fori imperiali non si abbandona a una pacata contemplazione, è scosso da una forte emozione) e suscitare nell’artista moderno un senso di impotenza e di frustrazione (mi viene in mente L’artista commosso dalla grandezza delle rovine antiche, di Füssli. In quella sanguigna c’è davvero tutto il conflitto degli opposti sentimenti, commozione per la grandezza delle opere classiche e frustrazione per l’insostenibilità del confronto).
Del resto, anche gli illuministi non si sottraevano alla riflessione malinconica. Lo stesso Diderot aggiungeva: “Percorriamo le devastazioni del tempo, e la nostra immaginazione disperde sulla terra gli edifici stessi che abitiamo. Sull’istante, la solitudine e il silenzio regnano intorno a noi. Restiamo soli di tutta una nazione che non c’è più: ecco l’abc della poetica delle rovine. […] Tutto passa, tutto perisce. Soltanto il mondo resiste. Soltanto il tempo continua a durare. Io cammino tra due eternità. Ovunque io guardi, gli oggetti che mi circondano mi annunciano la fine, e mi mettono in guardia rispetto a ciò che mi attende”. Si riferiva soprattutto agli aspetti naturali (la roccia che sprofonda nella terra o la valle che si frantuma), ma anche, naturalmente, ai ruderi dei sogni umani.

Col Romanticismo si afferma, soprattutto nei paesi nordeuropei, il gusto per le architetture gotiche: si recupera insomma il passato di casa, un passato che si presenta, rispetto a quello classico, più irregolare e informe, e produce una fascinazione d’altro tipo, nella quale diventa dominante la sensazione di angoscia. Le rovine non sono più un raccordo tra passato e futuro. Raccontano qualcosa che non tornerà, che sta lentamente svanendo anche dalla memoria, e costringono a meditare sulla fragilità umana. I segni del tempo, la vegetazione e i muschi che le ricoprono parlano di una natura che si prende la rivincita sulla civiltà e la cultura. Shelley scrive nell’Adonais:
Su, vai a Roma, — che è insieme il Paradiso, la tomba,
e la città e il deserto; e passa dove le rovine s’ergono
come montagne frantumate, e le gramigne
fiorenti e le piccole selve profumate
vestono l’ossa nude della Desolazione …
Magari oggi la sua esortazione sarebbe più tiepida, anche se le gramigne a Roma fioriscono ancora. Le uniche montagne accanto alle quali si passa sono quelle dei rifiuti, e le piccole selve che crescono sui marciapiedi sono tutt’altro che profumate.
Nella pittura di questo periodo è Friedrich a esprimere perfettamente, in dipinti come L’abbazia nel querceto, l’estetica del fascino malinconico e dolente delle rovine. Altro che ponte sul futuro! Il futuro è plumbeo come il cielo contro il quale le mura e gli alberi tutti spogli e rinsecchiti si stagliano. E la processione che appena si intravvede nella fascia più bassa è diretta a un cimitero. Nel suo caso è una forte connotazione religiosa, e per di più luterana, a indurlo a usare le rovine come simbolo e come monito. Ma quel tipo di fascino, secolarizzandosi, tenderà facilmente a scadere, alla lunga, nel gusto per il fatiscente e il macabro: quello che caratterizzerà il decadentismo (e il cui prototipo potrebbe essere La rovina della casa Usher, di Poe)
E si arriva all’oggi, passando per il Novecento. Il secolo scorso ha prodotto in realtà molte più macerie che rovine, e la sensibilità nei confronti di queste ultime è ancora una volta mutata. Ho sottomano Rovine e macerie. Il senso del tempo, un libretto esile e densissimo, nel quale Marc Augé scrive: “Le macerie accumulate dalla storia recente e le rovine nate dal passato non si assomigliano. Vi è un grande scarto fra il tempo storico della distruzione, che rivela la follia della storia (le vie di Kabul o di Beirut), e il tempo puro, il tempo in rovina, le rovine del tempo che ha perduto la storia o che la storia ha perduto”. Credo voglia intendere che il cumularsi delle macerie prefigura un mondo senza rovine, nel quale il tempo sarà azzerato e che, per tale ragione, non avrà più storia. Per Augé il senso delle rovine non è storico né estetico, ma puramente temporale. La rovina è un frammento del passato ancora presente, e sottratto alla temporalità delle appartenenze, dell’uso, dei significati. Quindi “contemplare rovine non equivale a fare un viaggio nella storia, ma a fare esperienza del tempo, del tempo puro”.
Ma questo cosa significa? Significa che per Augé, illuministicamente, là dove c’è rovina c’è una possibilità, una indicazione di ripartenza: mentre là dove ci sono macerie il tempo viene non solo azzerato, ma abolito. Le rovine tendiamo a conservarle, le macerie possiamo solo rimuoverle, dobbiamo sbarazzarcene. Sottoscrivo in toto, anche dove dice: “Sulle macerie nate dagli scontri che inevitabilmente la storia futura susciterà, si apriranno nondimeno dei cantieri, e insieme ad essi, chissà, una possibilità di costruire qualche altra cosa, di ritrovare il senso del tempo”. A dispetto della mia disposizione congenitamente scettica, non mi sembra un ottimismo forzato e consolatorio: ricordo una immagine, credo sia della biblioteca di Sarajevo, incendiata e semidistrutta nel 1992 (con perdita dell’ottanta per cento del patrimonio librario), nella quale un ragazzo, in mezzo a tanta devastazione e desolazione, sfoglia un libro: e ho davanti quella odierna dell’edificio rimesso in piedi (e in funzione) seguendo esattamente le linee del vecchio progetto. Per quelle macerie, e attraverso quel ragazzo, la storia in qualche modo è ripartita.

A tornare ripetutamente, direi quasi ossessivamente, sul tema delle rovine, nella prima metà del ‘900, è stato Walter Benjamin. Benjamin scrive in un periodo che di macerie ne ha prodotte parecchie, tra le due guerre, ed è comprensibile che vi faccia costante riferimento. In un frammento che è diventato una delle pagine più citate (e abusate) della recente letteratura filosofica scrive (e così lo cito anch’io): “C’è un quadro di Klee che s’intitola Angelus Novus. Vi si trova un angelo che sembra in atto di allontanarsi da qualcosa su cui fissa lo sguardo. Ha gli occhi spalancati, la bocca aperta, le ali distese. L’angelo della storia deve avere questo aspetto. Ha il viso rivolto al passato. Dove ci appare una catena di eventi, egli vede una sola catastrofe, che accumula senza tregua rovine su rovine e le rovescia ai suoi piedi. Egli vorrebbe ben trattenersi, destare i morti e ricomporre l’infranto. Ma una tempesta che spira dal paradiso, che si è impigliata nelle sue ali, ed è così forte che egli non può più chiuderle. Questa tempesta lo spinge irresistibilmente nel futuro, a cui volge le spalle, mentre il cumulo delle rovine sale davanti a lui al cielo. Ciò che chiamiamo progresso è questa tempesta”.
 Confesso che non mi ero mai soffermato a decrittare l’allegoria racchiusa in questa immagine, mi accontentavo dell’interpretazione più immediata e superficiale. La verità è che non riuscivo affatto a scorgerci tutto quello che Benjamin sembra vedere, e non mi rendevo conto che era lui quello da decrittare, e non Paul Klee. Anche perché il quadro era suo, l’aveva voluto fortissimamente e acquistato, l’ha portato con sé in tutte le sue peregrinazioni, sino all’ultimo, e aveva tutti i diritti di leggerlo come voleva. Forse la passeggiata di ieri mi ha chiarito le idee, e riesco anch’io a guardarlo con occhi nuovi.
Confesso che non mi ero mai soffermato a decrittare l’allegoria racchiusa in questa immagine, mi accontentavo dell’interpretazione più immediata e superficiale. La verità è che non riuscivo affatto a scorgerci tutto quello che Benjamin sembra vedere, e non mi rendevo conto che era lui quello da decrittare, e non Paul Klee. Anche perché il quadro era suo, l’aveva voluto fortissimamente e acquistato, l’ha portato con sé in tutte le sue peregrinazioni, sino all’ultimo, e aveva tutti i diritti di leggerlo come voleva. Forse la passeggiata di ieri mi ha chiarito le idee, e riesco anch’io a guardarlo con occhi nuovi.
La storia si allontana, sia pure camminando a ritroso, da ciò su cui fissa lo sguardo, dal passato. Questo passato può essere percepito come un ammasso di detriti, di macerie, e quindi come qualcosa da rimuovere, magari in maniera soft, diluendolo in tante diverse memorie, come sta accadendo oggi, oppure in modo violento e radicale, cancellandone ogni traccia (penso ad esempio ai roghi dei libri, da Qin Shi Huang a Hitler e all’ISIS, o ai calendari “rivoluzionari” che ripartono dall’anno zero). Per Benjamin invece l’angelo, ovvero il vero senso della storia, “vorrebbe ben trattenersi, destare i morti e ricomporre l’infranto”. Qui il significato è ambiguo, e credo ciò dipenda dal fatto che una prima versione di questo brano era incentrata sulla vicenda personale di Benjamin, su un amore finito e rimpianto. Comunque, è verissimo. Per ciascuno di noi ad un certo punto della vita, quello in cui ci si volge indietro perché davanti rimane ben poco da vedere, le rovine della storia sono i fallimenti, le incertezze e le decisioni non prese, le cose non dette e non fatte, che avrebbero potuto cambiare il nostro destino, il nostro presente e il nostro futuro. Vorremmo poter tornare indietro e riscrivere tutto il libro. Ma il vento, che in questo caso è semplicemente l’inesorabile, naturale scorrere del tempo, volta le pagine che rimangono, e il cumulo che abbiamo alle spalle si innalza.
Se interpretata invece nel suo significato più esteso, quello poi scelto da Benjamin, l’immagine ci dice che in realtà l’unica via d’uscita, per non lasciarci trascinare dalla tempesta che chiamiamo “progresso”, è proprio quella di fermarci, tornare sui nostri passi e “risanare” il passato. Quando dice che la tempesta del progresso spira dal paradiso, Benjamin non intende che è suscitata da una volontà divina o da un fantomatico Spirito hegeliano: il paradiso di cui parla è quello terrestre – sta quindi alle spalle rispetto alla marcia del “progresso”, e non davanti –, e il vento soffia dalle porte che l’uomo ha lasciate aperte uscendone. Quel vento, quella tempesta nascono dalla colpa originaria, dalle scelte errate che l’umanità ha compiuto, che ha cumulato e sparso lungo il suo cammino (le rovine, le macerie) senza averle poi ricomposte. Gli occhi spalancati, la bocca aperta dell’angelo sembrano i tratti tipici di chi all’improvviso si è voltato indietro e si sta rendendo conto, pieno di sgomento, della catastrofe che sta lasciando alle sue spalle (e del fatto che la sua marcia lo allontana dal paradiso).
Quello che l’angelo vede non sono però macerie, ma rovine. Non è tentato di rimuoverle per correre incontro al futuro, ma di ricomporle, per costruire su di esse un futuro che dia senso anche al passato. Esattamente il contrario di quella idea di “progresso” che si fonda sul consumo rapido delle cose e delle idee, sulla rincorsa costante del “nuovo” e sulla forma più efficace di eliminazione delle scorie, che è quella di sotterrarle nell’oblio. L’angelo è fermo. Si è fermato per riflettere e per decidere, malgrado la tempesta lo spinga e non gli consenta di chiudere le ali. E già questo gesto di fermarsi è significativo: vuol dire che il “progresso” così irresistibile forse non è, irresistibile è solo la marcia del tempo, ma la direzione e il posso che vogliamo tenere possiamo ancora deciderli noi.
Per capire meglio la complessa interpretazione che Benjamin dà di questa allegoria riesce illuminante, a mio giudizio, un aspetto del suo carattere che di solito è considerato marginale, e che parrebbe avere poco a che vedere col tema delle rovine. Benjamin era un collezionista. Ma di quelli duri, per i quali la passione diventa quasi (o senza quasi) un’ossessione. Collezionava vecchi libri per bambini, quelli impreziositi dalle immagini di illustratori del calibro di Dulac e di Rackam, ma anche più antichi: e quanto il piacere del possesso fosse vera bibliomania lo dice il fatto che un elenco recentemente pubblicato di questi libri consta di trentasette pagine di titoli. Essendo io stesso un bibliomane patologico non posso che sentirlo vicino, e posso anche immaginare quanto debba essergli costato separarsene quando fu costretto all’esilio. La mania con-divisa mi aiuta però a comprendere anche qualcosa di più. I libri per l’infanzia, e le soprattutto immagini che li adornano, sono il primo (in qualche caso anche l’ultimo) tramite per accedere all’esperienza di una dimensione diversa, più “autentica” di quella reale, che si vive attraverso il gioco. Il bambino fa coi con i suoi giochi “un esercizio dell’inutile”. Parte dalla realtà e dalla concretezza di quei fogli di carta, delle parole e delle immagini che vi sono impresse, e ricombina il tutto a suo modo e a suo piacere, avventurandosi in mondi nuovi, nei quali non valgono regole e logiche e tempistiche prevedibili. (Benjamin era molto polemico con la pedagogia della sua epoca – e lo sarebbe anche con quella attuale – che voleva trasformare i libri per bambini in strumenti di indottrinamento etico e di irreggimentazione disciplinare. Non posso che essere d’accordo: se c’è qualcosa di insopportabile e di ipocrita sono i libri per l’infanzia “educativi” – non parliamo poi del tentativo di piegare all’istruzione i fumetti).
Ma giocare è in fondo anche quanto il collezionista fa con i suoi reperti: “toglie alle cose, mediante il possesso di esse, il loro carattere di merce …. e si trasferisce idealmente, non solo in mondo remoto nello spazio e nel tempo, ma anche in un mondo migliore, dove gli uomini, è vero, sono altrettanto poco provvisti del necessario che in quello di tutti i giorni, ma dove le cose sono libere dalla schiavitù di essere utili.” Aggiungerei che redime il mondo dal disordine, disponendo gli oggetti della sua collezione in un ordine spaziale e mentale che conferisce loro un valore diverso da quello d’uso o da quello di scambio. Cancellandone idealmente il prezzo conferisce loro una dignità. Benjamin scrive anche: “Materia in rovina: è l’innalzamento della merce allo stato di allegoria.” Che è perfettamente applicabile tra l’altro al mio modo di collezionare libri, pescandoli là dove già sono rovina, sui banchi dell’usato a un tanto al chilo, e facendoli rifiorire a nuova vita in un orizzonte di senso assolutamente fuori mercato. Con questo il cerchio si chiude.
Adesso mi riconosco perfettamente in questa immagine. Mi sembra rappresenti e riassuma nella maniera più nitida il mio modo di concepire la storia e il nostro essere nella storia. Mi riusciva difficile conciliare le due pulsioni apparentemente contrastanti che mi agitano dentro, quella verso il passato e quella verso il futuro. Pensavo di essere sulla strada giusta, ma mi mancava il conforto di un segnavia riconoscibile. Ora so che quelle due pulsioni possono coincidere, anzi sono un unico moto.
In sostanza, io voglio un futuro che in qualche modo riscatti, dia un senso al passato. Sento una responsabilità, un debito, non solo nei confronti di coloro che verranno, ma anche di coloro che mi hanno preceduto. Per questo, malgrado gli acciacchi, e a dispetto del senso di frustrazione che troppo frequentemente mi tenta, continuo a stare per aria. Ho trovato una corrente ascensionale che mi consente di librarmi senza sbattere le ali (non ne avrei più la forza) e di guardare indietro: le rovine che vedo, quelle che reggono all’erosione del tempo, sono la testimonianza degli sforzi che miliardi di altri, centinaia di generazioni, hanno compiuto guardando a me. Non riuscirò a destare i morti, non ricomporrò i cocci di ciò che stato infranto, ma ricordarli, quello almeno lo posso e lo devo fare. E credo che sino a quando qualcuno lo farà rimarrà aperta la strada per sfuggire alla tempesta abrasiva del “progresso”.
Il mio non è allora un comportamento autistico, ma un impegno etico. In parte ereditato, da una cultura contadina che non buttava nemmeno le unghie del maiale, in parte coltivato, mano a mano che ho cominciato a leggere la storia, anziché come una squallida e assurda tabella di massacri, come un diario della resistenza dell’umanità alla tragica e assieme straordinaria condizione che la natura le ha regalato.
E l’estetica? Me la sono persa per strada? No, semplicemente per me etica ed estetica coincidono. Il comportamento etico non può essere dettato che dalla percezione e dal riconoscimento del bello, in questo caso delle sue vestigia. Una emozione estetica altro non è che il segnale, la luce che si accende su qualcosa che vale, che ha e che dà senso, e va quindi preservato, difeso. Ma anche rispetto a questo atteggiamento vanno fatte delle distinzioni.
Oggi le rovine non sono più consumate solo dal tempo e dall’incuria o dall’indifferenza degli uomini, ma al contrario, dal soffocamento del turismo globalizzato. In un brevissimo saggio scritto a inizio Novecento, che si intitola proprio “La rovina”, e che senz’altro era conosciuto da Benjamin, George Simmel equiparava la rovina alla moda, nel senso che entrambe sarebbero caratterizzate dalla distruzione di ogni contenuto precedente per accedere a una nuova unità. Non sto a raccontare come ci arriva (peraltro, con un percorso un po’ ostico ma illuminante), mi intriga solo l’accostamento, perché in effetti l’interesse per le rovine è stato sempre condizionato, dai giorni del Gran Tour ad oggi, dal fenomeno delle mode. Un tempo era riservato ai rampolli delle famiglie nobili del continente settentrionale e d’oltremanica, poi è entrato a far parte dei consumi di masse sempre più allargate, e motivate sempre più da una necessità di omologazione. Non è nemmeno il caso che stia a ripetere ciò che è sotto gli occhi di tutti e aggiunga la mia ad un coro di geremiadi che fanno ormai parte anch’esse del gioco. Le rovine, così come le bellezze naturali, sono ridotte a elemento scenografico del grande spettacolo non-stop al quale siamo persuasi più o meno velatamente o sfacciatamente ad assistere e/o a partecipare.
Ma qui, nel caso specifico dell’esperienza da cui ho tratto pretesto per queste righe, non di rovine si parla, ma di macerie, e del tipo di fascino, e conseguentemente di disposizione, che inducono. Questo è un fenomeno relativamente nuovo. È già stato fagocitato dalla moda, oggi si direbbe che è diventato virale, e quindi è destinato alla transitorietà: ma non lo liquiderei così frettolosamente. Presenta infatti delle caratteristiche emblematiche dell’ambiguità sottesa ad ogni nostra modalità e finalità di conoscenza. Intanto è una forma di esplorazione, mirata non tanto alla scoperta quanto alla riscoperta. In questo senso, la pulsione esplorativa sarebbe in linea con l’atteggiamento etico di cui parlavo sopra. Cercare qualcosa che si sottrarrebbe, in quanto scarto, alla logica dell’utilità e della mercificazione, e ripartire da quello per immaginare la possibilità di altri mondi. “La rovina innalza le cose allo stato di allegoria”. Ogni scoperta però reca con sé un germe infettivo: produce contaminazione, modifica o addirittura distrugge l’oggetto stesso che l’ha motivata. Gli antropologi ne sanno qualcosa.
Nel nostro caso, di fronte alle macerie della villa, due diversi atteggiamenti possono indurre a fermarle nell’immagine fotografica: quell’immagine può diventare un ulteriore momento dello spettacolo, oppure può documentare qualcosa che non funziona e a cui occorre ovviare. In entrambi i casi quelle macerie diventano funzionali ad altro rispetto a ciò che realmente rappresentano. Ma qui si pone il discrimine tra una scelta estetica, che è di per sé etica, perché orienta il nostro agire, ed una estetizzante, che banalizza nella “spettacolarizzazione” ciò che si è fotografato. L’una ci dice di una volontà di continuità nel tempo, di lettura e recupero del passato in funzione del futuro, l’altra di una plastificazione museale destinata solo al presente, e a un presente esteso, puramente orizzontale, privo di profondità.
Naturalmente queste generalizzazioni hanno senso solo all’interno di una trattazione teorica. La mia esperienza con Stefano, ad esempio, le contraddice. Le sue emozioni, il suo entusiasmo sono assolutamente genuini: e li manifesta attraverso un mezzo che ama altrettanto genuinamente, e col quale riesce a mediare e a ricondurre ad unità quelli che parrebbero interessi sparsi. È anche lui un collezionista di immagini, tratte non dai libri ma dalle tante realtà ambientali e culturali che ha incontrato (l’altra sua passione sono i viaggi). L’elemento unificante è dato dalla costante ricerca della bellezza, intesa come la risultante del lavoro del tempo sui volti, sulle montagne, sui suk arabi, sugli animali africani o sui templi tibetani: di una bellezza che va sottratta alla svendita e al consumo in confezioni cellofanate, con tanto di bollino di conformità, e partecipata invece come condivisione emozionale attiva.
Lo stesso vale per le macerie. Anche nei loro confronti lo sguardo fotografico può essere caldo e partecipe, se a orientarlo c’è dietro un’intenzionalità etica. E questa non è necessario indossarla o metterla nello zaino quando si esce di casa come per partire in missione. Se c’è, se ci è congenita o se l’abbiamo maturata e coltivata, al momento giusto vien fuori. E magari riesce anche a far sì che le macerie diventino rovine, “si presentino – come scrive Augé – a chi le percorre come un passato che egli avrebbe perduto di vista, dimenticato, e che tuttavia gli direbbe ancora qualcosa.
Un passato al quale egli sopravvive”.




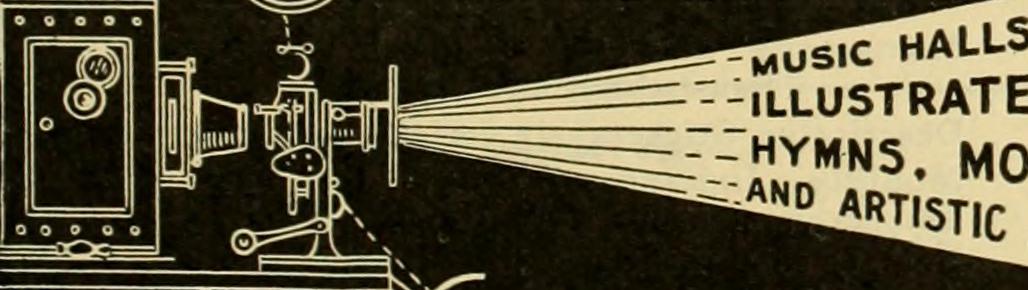
 Massimo era un fotografo “professionista”, nel senso più pieno del termine: non era mai del tutto soddisfatto della riuscita dei suoi lavori, cercava la perfezione, le luci, le ombre, le esposizioni, le angolature: l’attenzione minore andava al risvolto economico. Credo che il suo capolavoro possa essere considerato il “documentario” “
Massimo era un fotografo “professionista”, nel senso più pieno del termine: non era mai del tutto soddisfatto della riuscita dei suoi lavori, cercava la perfezione, le luci, le ombre, le esposizioni, le angolature: l’attenzione minore andava al risvolto economico. Credo che il suo capolavoro possa essere considerato il “documentario” “


 C’era sempre una presenza discreta nelle gite, nelle feste e nelle ricorrenze: una macchina fotografica al collo di mio padre. Negli anni Settanta lo ricordo sempre con quella reflex mentre scattava foto ai familiari.
C’era sempre una presenza discreta nelle gite, nelle feste e nelle ricorrenze: una macchina fotografica al collo di mio padre. Negli anni Settanta lo ricordo sempre con quella reflex mentre scattava foto ai familiari. Il pezzo di Fabrizio sulla fotografia ha casualmente incrociato lungo il mio percorso di letture un breve saggio di Pietro Bellasi comparso trentacinque anni fa su Prometeo (rivista che ancora esiste, o almeno esisteva sino ad un paio d’anni fa) …
Il pezzo di Fabrizio sulla fotografia ha casualmente incrociato lungo il mio percorso di letture un breve saggio di Pietro Bellasi comparso trentacinque anni fa su Prometeo (rivista che ancora esiste, o almeno esisteva sino ad un paio d’anni fa) … Dobbiamo muoverci e pensare ad una velocità sempre maggiore: questo ci chiedono i ritmi imposti dalla modernità. In realtà la nostra mente non è evolutivamente preparata alla brusca accelerazione impressa negli ultimi cento anni, pochissimi se paragonati all’intero arco della storia antropica …
Dobbiamo muoverci e pensare ad una velocità sempre maggiore: questo ci chiedono i ritmi imposti dalla modernità. In realtà la nostra mente non è evolutivamente preparata alla brusca accelerazione impressa negli ultimi cento anni, pochissimi se paragonati all’intero arco della storia antropica … I bambini ospitati a turni settimanali nella struttura educativa dove lavoro vivono un altro modo di fare scuola. Sperimentano attività e fanno esperienze (le escursioni naturalistiche, ad esempio) che non sono previste nel contesto scolastico abituale …
I bambini ospitati a turni settimanali nella struttura educativa dove lavoro vivono un altro modo di fare scuola. Sperimentano attività e fanno esperienze (le escursioni naturalistiche, ad esempio) che non sono previste nel contesto scolastico abituale … L’applicazione della tecnologia digitale alle macchine fotografiche e l’uso diffuso di software di fotoritocco hanno semplificato il gesto del fotografare fino a generare una polluzione incontrollata di immagini, per lo più ordinarie, che ci sorbiamo nostro malgrado e che rispondono a un artificioso bisogno indotto dalla modernità: quello della “spettacolarizzazione di sé” e della condivisione in rete della propria squallida quotidianità…
L’applicazione della tecnologia digitale alle macchine fotografiche e l’uso diffuso di software di fotoritocco hanno semplificato il gesto del fotografare fino a generare una polluzione incontrollata di immagini, per lo più ordinarie, che ci sorbiamo nostro malgrado e che rispondono a un artificioso bisogno indotto dalla modernità: quello della “spettacolarizzazione di sé” e della condivisione in rete della propria squallida quotidianità…

 Vedere e fotografare, nell’accezione più pura, significa esser consapevole dell’“unicità” di ciò che si sta guardando, che è tale in un tempo concluso, ovvero in quel preciso momento, scegliere di fermare quell’istante e di fissarlo attraverso il mezzo fotografico. Questo gesto richiede una – seppur mediocre – padronanza tecnica, la capacità di mettere a fuoco e isolare il soggetto all’interno dello spazio che occupa, la percezione istintiva della quantità di luce necessaria ad evidenziare ciò che l’obiettivo inquadra, ma soprattutto una buona dose di lucidità e di distacco: ovvero un coinvolgimento emotivo controllato, almeno un po’. È senz’altro necessaria anche una certa presunzione nel riproporre soggetti che quasi sicuramente sono stati fotografati da altri molto più bravi. Basta fare una ricerca in rete per vedere foto davvero belle che fissano quel paesaggio, quel fiore o quello scorcio che ci apprestiamo a fotografare.
Vedere e fotografare, nell’accezione più pura, significa esser consapevole dell’“unicità” di ciò che si sta guardando, che è tale in un tempo concluso, ovvero in quel preciso momento, scegliere di fermare quell’istante e di fissarlo attraverso il mezzo fotografico. Questo gesto richiede una – seppur mediocre – padronanza tecnica, la capacità di mettere a fuoco e isolare il soggetto all’interno dello spazio che occupa, la percezione istintiva della quantità di luce necessaria ad evidenziare ciò che l’obiettivo inquadra, ma soprattutto una buona dose di lucidità e di distacco: ovvero un coinvolgimento emotivo controllato, almeno un po’. È senz’altro necessaria anche una certa presunzione nel riproporre soggetti che quasi sicuramente sono stati fotografati da altri molto più bravi. Basta fare una ricerca in rete per vedere foto davvero belle che fissano quel paesaggio, quel fiore o quello scorcio che ci apprestiamo a fotografare.

















 Sedersi sul divano, o attorno ad un tavolo, a guardare e riguardare le foto di noi bambini, dei genitori giovani o delle gite al fiume e al mare, e rievocare aneddoti e personaggi, era un vero e proprio rito, esclusivamente familiare. Si evitava di tirare fuori gli album quando c’erano ospiti, per non incorrere nell’imbarazzo di vedere volti annoiati di persone per le quali quelle immagini non significavano nulla. A casa mia non vi sarebbe accaduto di imbattervi in quei “protagonisti dell’assoluto” che propinano le loro raccolte di foto, adeguandole via via alle diverse modalità, prima l’album cartaceo, poi la sequenza di diapositive, oggi la visualizzazione virtuale. Non avreste desiderato cominciare a starnutire violentemente per indurre il torturatore a richiudere terrorizzato gli album. Non avreste visto nemmeno le copertine.
Sedersi sul divano, o attorno ad un tavolo, a guardare e riguardare le foto di noi bambini, dei genitori giovani o delle gite al fiume e al mare, e rievocare aneddoti e personaggi, era un vero e proprio rito, esclusivamente familiare. Si evitava di tirare fuori gli album quando c’erano ospiti, per non incorrere nell’imbarazzo di vedere volti annoiati di persone per le quali quelle immagini non significavano nulla. A casa mia non vi sarebbe accaduto di imbattervi in quei “protagonisti dell’assoluto” che propinano le loro raccolte di foto, adeguandole via via alle diverse modalità, prima l’album cartaceo, poi la sequenza di diapositive, oggi la visualizzazione virtuale. Non avreste desiderato cominciare a starnutire violentemente per indurre il torturatore a richiudere terrorizzato gli album. Non avreste visto nemmeno le copertine.

 Il risultato “tecnico” della foto può dare certamente soddisfazione, ma ai fini della “narrazione” a volte è poco rilevante. Una fotografia è riconosciuta come “artistica” non per la perfezione degli aspetti formali, ma in relazione alla sua attualità sociale: non conosco esempi di foto che, per quanto belle, siano state avvalorate come “opere d’arte” anni dopo la loro realizzazione. Forse c’è solo il caso di Vivian Maier, ma credo ci sia dietro una grossa operazione di mercato. È difficile che possa accadere ciò che è invece avvenuto per molti pittori, come Van Gogh, che sono entrati nel pantheon degli artisti riconosciuti solamente anni dopo l’effettiva realizzazione dei quadri, addirittura dopo la morte. La fotografia è forse l’unica espressione artistica strettamente connessa al momento dello scatto, alla realtà che documenta e alle attrezzature per realizzarla.
Il risultato “tecnico” della foto può dare certamente soddisfazione, ma ai fini della “narrazione” a volte è poco rilevante. Una fotografia è riconosciuta come “artistica” non per la perfezione degli aspetti formali, ma in relazione alla sua attualità sociale: non conosco esempi di foto che, per quanto belle, siano state avvalorate come “opere d’arte” anni dopo la loro realizzazione. Forse c’è solo il caso di Vivian Maier, ma credo ci sia dietro una grossa operazione di mercato. È difficile che possa accadere ciò che è invece avvenuto per molti pittori, come Van Gogh, che sono entrati nel pantheon degli artisti riconosciuti solamente anni dopo l’effettiva realizzazione dei quadri, addirittura dopo la morte. La fotografia è forse l’unica espressione artistica strettamente connessa al momento dello scatto, alla realtà che documenta e alle attrezzature per realizzarla.
 Invece sono in moltissimi coloro che pubblicano su Facebook o altri social le foto di feste di compleanno, le pietanze che stanno per essere divorate, i volti dei figli o i musi di cani e gatti. In realtà non “raccontano” nulla, ma anche quel nulla ha da essere avvalorato attraverso la visione, l’approvazione e la condivisione di persone che stanno per lo più al di fuori della cerchia familiare. L’immagine deve ricevere dei “like” per soddisfare il nostro bisogno di lasciar traccia, al di là del senso che ha: non importa ciò che dico e sono, solo che per un attimo si sappia che esisto.
Invece sono in moltissimi coloro che pubblicano su Facebook o altri social le foto di feste di compleanno, le pietanze che stanno per essere divorate, i volti dei figli o i musi di cani e gatti. In realtà non “raccontano” nulla, ma anche quel nulla ha da essere avvalorato attraverso la visione, l’approvazione e la condivisione di persone che stanno per lo più al di fuori della cerchia familiare. L’immagine deve ricevere dei “like” per soddisfare il nostro bisogno di lasciar traccia, al di là del senso che ha: non importa ciò che dico e sono, solo che per un attimo si sappia che esisto.

 Intanto hanno cominciato col costruirsi, con l’aiuto delle educatrici Alessandra e Paola, le loro macchine fotografiche, utilizzando barattoli da caffè e scatole di patatine Pringles. Dopo averle costruite, e aver appreso l’importanza della giusta quantità di luce nell’ambiente che dovevano fotografare e del tempo necessario per far imprimere la carta fotosensibile, hanno usato le loro scatolette per realizzare la loro prima fotografia stenopeica.
Intanto hanno cominciato col costruirsi, con l’aiuto delle educatrici Alessandra e Paola, le loro macchine fotografiche, utilizzando barattoli da caffè e scatole di patatine Pringles. Dopo averle costruite, e aver appreso l’importanza della giusta quantità di luce nell’ambiente che dovevano fotografare e del tempo necessario per far imprimere la carta fotosensibile, hanno usato le loro scatolette per realizzare la loro prima fotografia stenopeica. Abituati ad un consumo di immagini molto rapido e distratto, (internet, cartoni e film sempre più veloci, ecc …), faceva tenerezza vederli attendere trepidanti che comparisse una figura assolutamente non paragonabile per qualità di definizione e di cromatismo a quelle digitali: ma proprio questo era l’obiettivo di chi ha creduto in questo piccolo esperimento.
Abituati ad un consumo di immagini molto rapido e distratto, (internet, cartoni e film sempre più veloci, ecc …), faceva tenerezza vederli attendere trepidanti che comparisse una figura assolutamente non paragonabile per qualità di definizione e di cromatismo a quelle digitali: ma proprio questo era l’obiettivo di chi ha creduto in questo piccolo esperimento. L’esperienza di fermare un’immagine concedendosi il tempo necessario per scegliere il soggetto, valutare la luce corretta e impostare conseguentemente il tempo di apertura del diaframma, ha permesso loro di capire che ci possono essere delle alternative alle modalità utilizzate oggi per realizzare fotografie, ma anche per fare un sacco di altre cose: e che queste alternative aprono sentieri fantastici tutti da esplorare.
L’esperienza di fermare un’immagine concedendosi il tempo necessario per scegliere il soggetto, valutare la luce corretta e impostare conseguentemente il tempo di apertura del diaframma, ha permesso loro di capire che ci possono essere delle alternative alle modalità utilizzate oggi per realizzare fotografie, ma anche per fare un sacco di altre cose: e che queste alternative aprono sentieri fantastici tutti da esplorare.