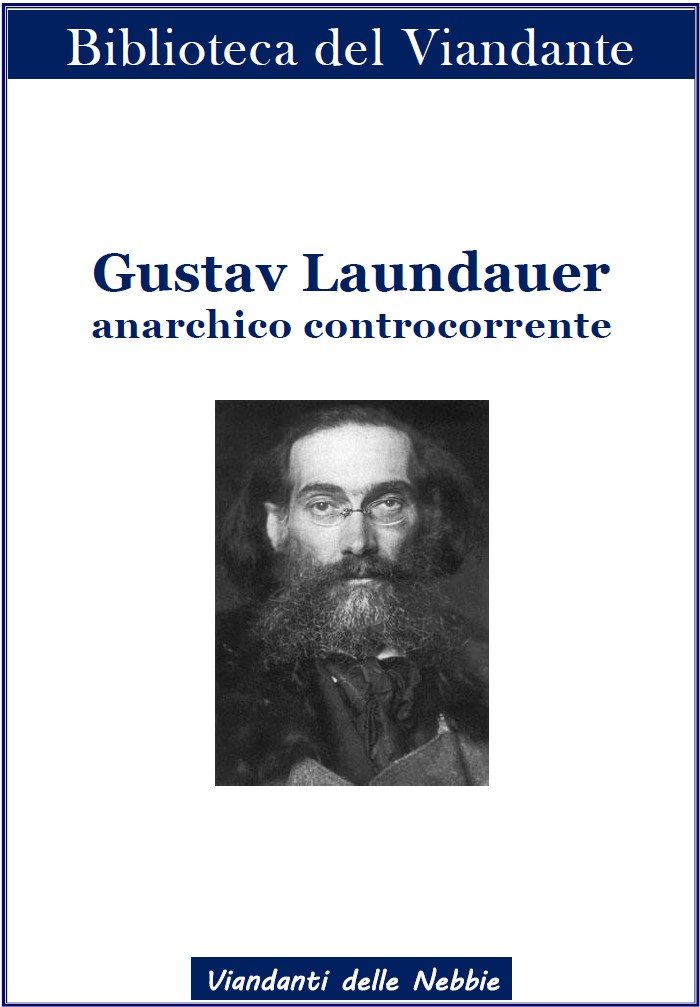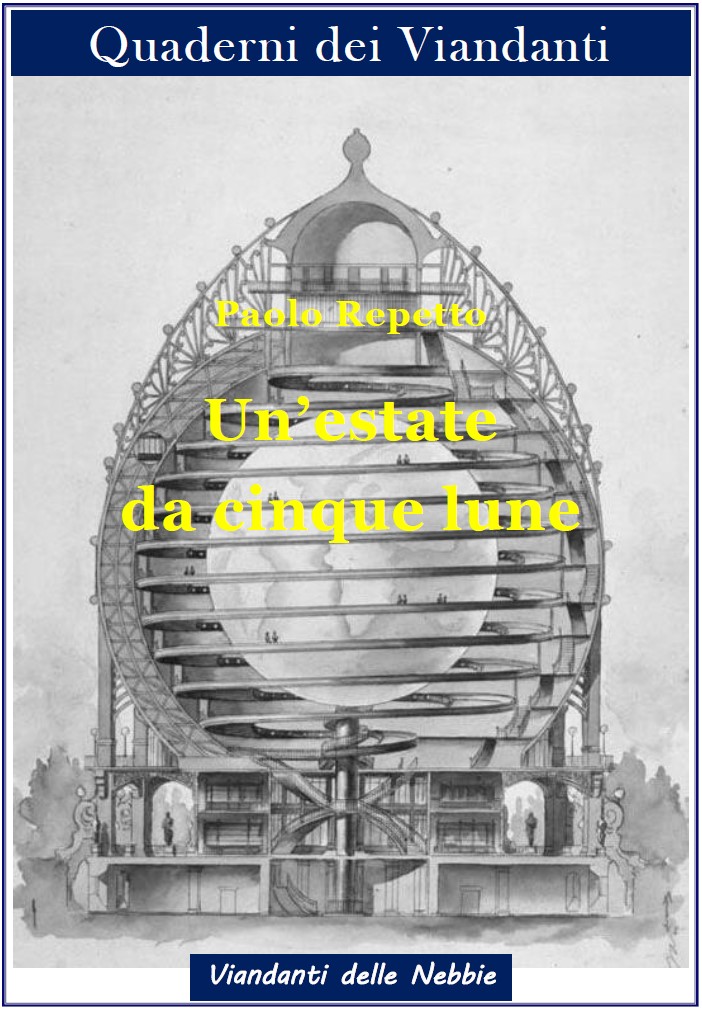(dalla Rappresentanza alla Rappresentazione)
di Paolo Repetto, 15 febbraio 2025
Ho avuto la percezione netta dello smottamento alla fine degli anni Settanta. Non che prima le cose andassero meglio, le tivù private erano nate a metà decennio e stavano già imponendo un nuovo “stile”, al quale la Rai era corsa immediatamente ad adeguarsi: ma tutto sommato la novità erano ancora i comici demenziali usciti del Bagaglino e un po’ di tette che davano fastidio a nessuno. Qualche avvisaglia c’era certamente già stata, ma all’epoca non avevo tempo da dedicare alla televisione, se non per gli incontri di boxe: quindi fui colto quasi alla sprovvista, e posso quasi citare anche la data della rivelazione.
Dell’accelerazione rovinosa mi accorsi assistendo a una delle prime puntate de Il processo del lunedì della gestione Biscardi, tra l’altro trasmessa su Rai3, l’emittente in forza alla sinistra. Ero allibito. Aldo Biscardi, che già di suo parlava un italiano a dir poco approssimativo e capiva una mazza di qualsivoglia argomento, aveva messo assieme una vera corte dei miracoli, nella quale tra pseudo-giornalisti ed ex-calciatori in bolletta gigioneggiavano personaggi assurdi come Maurizio Mosca, uno che su un campo di calcio non avrebbe avuto un ruolo nemmeno come raccattapalle. Non mi scandalizzava l’incompetenza, perché avendoci giocato sino a cinquant’anni sapevo benissimo che sul calcio non c’è nulla da sapere, da capire o da discutere, si tratta solo di mettere un pallone in rete o di non lasciarcelo finire, ma ero disgustato dalla beceraggine di tutto l’assieme, dai toni, dagli argomenti e dalle atmosfere da bettola d’angiporto, proposti su un medium nel quale un attimo primo erano passate notizie di guerre o di catastrofi, oppure rubriche di arte o di letteratura, o anche semplicemente qualche bel film o qualche documentario a tema storico. La cosa peggiore era che in quella trasmissione non circolava un filo di ironia, si prendevano tutti sul serio (come sogliono fare notoriamente gli imbecilli) e, ma questo l’ho scoperto dopo, venivano presi sul serio anche dalla sinistra più accorta, quella sempre un po’ più avanti, che plaudiva al fatto che finalmente si desse voce anche al più genuino “sentire popolare”, confondendo l’idiozia e la sguaiataggine con l’autenticità e la freschezza. In fondo, pensava, quei quattro bagonghi rompevano gli schemi seriosi e ingessati della televisione di regime, erano una ventata d’aria, magari puzzolente ma nuova.
Fu un tutt’uno: compresi allora che l’elogio di Franti tessuto da Umberto Eco e Fantozzi e il gossip confidenziale di Maurizio Costanzo non erano passati invano, c’era una logica che li legava, erano tanti cunei ribattuti nelle crepe della cultura occidentale aperte da due guerre e da tutto quel che c’era stato in mezzo. E compresi anche che quelle martellate non preludevano a una ripulitura e a un restauro (che non è una “restaurazione”, ma il riportare in vita quei motivi, quei colori, in definitiva quei valori originari che il tempo e le nequizie della storia hanno sporcato e deturpato), ma annunciavano la demolizione.
Da allora il degrado dell’etica, del gusto, del semplice buon senso non ha più avuto sosta: ogni volta che ho pensato si fosse toccato il fondo ho dovuto immediatamente ricredermi. Negli ultimi quarant’anni abbiamo visto di tutto: gabibbi chiamati a raddrizzare i torti e inviati “sul campo” bardati come mentecatti: filosofi di grido e indagatori della psiche ridotti a cumulare marchette nei talk show, senza il minimo pudore; intellettuali, artisti, politici, magistrati, sportivi, persino religiosi, in corsa a mendicare un passaggio televisivo per promuovere “eventi” o paccottiglia “d’ingegno”; uomini e donne di ogni età e condizione ansiosi di sputtanarsi in trasmissioni per cerebrolesi, in cambio di trenta secondi di visibilità.
I risultati li abbiamo di fronte: non è nemmeno più il caso di accendere la tivù per farsi un’idea del degrado. Basta girare per strada, origliare le conversazioni, quelle dal vivo e peggio quelle telefoniche, che vengono fatte condividere per un raggio di cinquanta metri, entrare in una scuola, sfogliare un quotidiano. Certamente però i media di massa rimangono il sensore più attendibile, non nel senso che ci raccontino il vero, ma, al contrario, perché del degrado sono il principale veicolo. Una trasmissione radiofonica come La Zanzara, ad esempio, giusto per fare riferimento alla manifestazione più recente di idiozia perversa nella quale mi sono imbattuto, dovrebbe essere usata come argomento di studio nelle facoltà di psicologia, di antropologia, di sociologia, per dare un taglio all’eterno dibattito sulla natura umana. Io non so se allo stato brado questa sia buona o cattiva, ma per certo è facilmente plasmabile da ogni input negativo, mentre non lo è altrettanto da quelli positivi. Se siamo stati modellati con la polvere, c’era qualcosa che non funzionava nell’impasto.
Comunque sia, credo valga la pena cercare di capire come milioni di anni di evoluzione ci abbiano regalato uno che si chiama come Paperino e ne ha la stessa consistenza cerebrale, ma si trova tra le mani le sorti del mondo. E che non ci è arrivato per via ereditaria, come accadeva un tempo, ma attraverso una ufficialmente libera competizione elettorale. È dura da spiegare, ma voglio provarci lo stesso, almeno a grandi linee e almeno per quanto riguarda la parte di cui sono stato un sempre più sconcertato spettatore.
Per parlare dell’oggi prendo spunto da un libro scritto sessanta anni fa, che fotografava la realtà sociale dell’epoca col teleobiettivo, ne coglieva gli sviluppi futuri e la incorniciava in una efficacissima definizione. Lo rispolvero non tanto per verificarne i riscontri, quanto piuttosto per constatare come nel frattempo l’interpretazione di quella (e quindi anche dell’attuale) realtà sia andata radicalmente cambiando. Devo dunque partire di lontano, sperando di non perdermi per strada.

Come è stata raccontata – Nel 1967 Guy Debord pubblicava La société du spectacle, (in italiano: La società dello spettacolo, De Donato, 1968, successivamente ritradotto e ristampato da Vallecchi, 1979, e ultimamente da Massari, 2002 e da Baldini-Castoldi, 2017). Debord era stato uno dei fondatori, dieci anni prima, dell’Internazionale Situazionista. (Per chi non conoscesse la vicenda del situazionismo, fornirò qualche riferimento in calce a questo intervento, allegando anche uno dei documenti di fondazione. Comunque anticipo che il situazionismo come inteso da Debord, da Asgen Jorn e da Raul Vaneigem aveva nulla a che vedere con i patetici sciamannati che da allora hanno nascosto dietro quella fortunata etichetta la propria presuntuosa inconsistenza).
Il libro arrivava al momento giusto – si era alla vigilia del Sessantotto. Conobbe anche una qualche notorietà (sia pure di seconda mano, perché era molto citato ma molto meno letto – in effetti era piuttosto noioso) e in particolare esercitò un forte influsso sul linguaggio immaginifico della contestazione. Debord vi sviluppava un’analisi della trasformazione che era in atto all’epoca nei rapporti sociali e nelle forme del dominio, ovvero della loro sempre più accentuata “spettacolarizzazione”: uno slittamento che aveva conosciuto un’accelerazione esponenziale con la comparsa della televisione, ma aveva preso avvio già nella prima metà del Novecento, con il cinema e con la radio. Non si limitava però a scandagliare il passato e il presente, profetizzava per questa trasformazione uno sbocco rivoluzionario: e lì la lucidità dell’analisi veniva meno, anche se non si può negare che in parte, almeno per quanto concerneva la deriva più immediata, quella precedente la rivoluzione informatica degli anni Novanta, i suoi pronostici fossero azzeccati.
Il testo di Debord si articola in una lunghissima sequenza di “tesi” (addirittura 221), e ha come modello formale quello del Manifesto del 1848. Esordisce così: “Tutta la vita delle società nelle quali predominano le condizioni moderne di produzione si presenta come un’immensa accumulazione di spettacoli”. Enunciazione che rimane quanto mai vera oggi, anche se io farei risalire la tendenza a tradurre la vita in spettacolo molto più addietro, a tempi precedenti la cosiddetta “modernità”: direi piuttosto che il moderno “modo di produzione” l’ha solo spinta alle estreme conseguenze, ad un esito per il quale Debord può scrivere che “le necessità della produzione capitalistica si sono staccate dalla vita, al punto che lo spettacolo è considerato come l’inversione della vita”.
Il nuovo manifesto prende l’avvio da dove Marx era arrivato, ovvero dall’alienazione prodotta dal capitalismo classico, che aveva indotto un passaggio di senso dell’esistenza “dall’essere all’avere”, e descrive l’ulteriore transizione ad un “capitalismo spettacolare”, quello che produce il passaggio “dall’avere all’apparire”. “La prima fase del dominio dell’economia sulla vita sociale aveva determinato nella definizione di ogni realizzazione umana un’evidente degradazione dell’essere in avere. La fase presente dell’occupazione totale della vita sociale da parte dei risultati accumulati dell’economia conduce a uno slittamento generalizzato dell’avere nell’apparire, da cui ogni avere effettivo deve trarre il suo prestigio immediato e la sua funzione ultima”.
È accaduto insomma che la progressiva razionalizzazione dello sfruttamento, quella che il capitalismo moderno ha operato per esercitare un sempre maggiore controllo e mantenere gli sfruttati a margine del processo produttivo, nel ruolo di pura forza-lavoro, ha determinato una sovrabbondanza di beni (almeno nel mondo occidentale): ma questo non ha liberato né i popoli né gli individui dalla necessità, perché la sovrabbondanza è finalizzata al nuovo modello di accumulazione capitalistica, e non certo a venire incontro ai loro bisogni. Ha creato al contrario una necessità apparentemente meno immediata, ma più subdola, perché non potrà mai essere pienamente soddisfatta: la coazione al consumo. Il ciclo del controllo è stato quindi portato a compimento dal capitalismo contemporaneo sfruttando le masse non solo nella fase della produzione ma anche in quella del consumo, determinandone e falsificandone bisogni, aspettative, rapporti: penetrando insomma ogni aspetto dell’esistenza. (Come poi funzioni questa faccenda, perché insomma il capitale per accrescersi debba operare una sia pur molto contenuta redistribuzione, è apparentemente ovvio, ma i modi sono poi complessi da spiegare: ci hanno provato moltissimi economisti, arrivando a conclusioni diametralmente diverse. Io credo dipenda soprattutto da due fenomeni: la finanziarizzazione sempre più spinta – il prevalere del capitale finanziario su quello produttivo – e l’autonomizzazione della tecnica: cose di cui su questo sito si è già parlato, e sulle quali avrò ancora qui modo di tornare).
La totale dipendenza del produttore-consumatore è indotta dalla rappresentazione spettacolare che il capitale elabora di se stesso. I progressi tecnologici nel campo della produzione vanno infatti di conserva con quelli nella comunicazione – ma in questo caso sarebbe forse più corretto dire nella “persuasione”. Tanto meno un prodotto risponde ad una reale necessità, tanto più avrà bisogno di essere caricato di significati esterni che lo rendano desiderabile. I costi della sua promozione vengono naturalmente scaricati a valle, entrano quindi a far parte integrante del costo totale di produzione, mentre il marchio, la certificazione di qualità, promette al consumatore una ostentazione di esclusività e di capacità economiche. La comunicazione a questo punto non è più solo un mezzo, diventa un fine, e avviene in base a codici che sono elaborati tutti dall’offerente, e che vanno a ridisegnare le modalità dei rapporti tra gli individui. Nei paesi capitalisti si sta dunque configurando un modello sociale all’interno del quale gli individui sono ridotti a meri spettatori passivi di un flusso di immagini scelte dal potere. Queste immagini giustificano l’assetto di potere istituito e si sostituiscono completamente alla realtà. “Le nuove tecnologie della comunicazione spingono all’estremo il feticismo delle merci, la coazione al consumo, e soprattutto rimodulano il rapporto sociale fra gli individui, mediato dalle immagini”.
Il nuovo rapporto sociale è in realtà, secondo Debord, un non-rapporto. La messa in scena dello spettacolo presuppone, infatti, l’assenza di dialogo tra gli spettatori. Al consumatore non resta altro che ammirare, rimanendo nella passività assoluta, le immagini che altri hanno scelto per lui. L’individuo ha dunque esclusivamente il ruolo di “pubblico”, ossia di chi sta a guardare, e non interviene. A parlare deve essere solo il potere. Gli individui risultano sempre più isolati nella folla atomizzata. “Il sistema economico fondato sull’isolamento è una produzione circolare di isolamento”.
In questo isolamento lo spettatore finisce per essere dominato dal flusso delle immagini, immerso in un mondo virtuale nel quale la distinzione tra vero e falso ha perso ogni significato. O meglio: nel quale è vero ciò che chi governa lo spettacolo ha interesse a mostrare, mentre tutto ciò che non è stato creato o selezionato dal potere è falso, o non esiste.
Pertanto, nella misura in cui l’immagine si sostituisce alla realtà, la visione dello spettacolo si sostituisce alla vita. Il consumatore non vive più esperienze dirette, ma si accontenta dei surrogati che lo spettacolo gli offre, e cerca di soddisfare quei bisogni, sia materiali che emozionali, che gli vengono artificialmente indotti. Diventa un consumatore di illusioni. Lo spettacolo è dunque il contrario della vita. Debord scrive “Più egli contempla, meno vive; più accetta di riconoscersi nelle immagini dominanti del bisogno, meno comprende la sua propria esistenza e il suo proprio desiderio”.
Molto all’ingrosso, questo è il succo della prima parte del saggio, quella dell’analisi: e direi che sin qui il discorso non fa una piega. D’altro canto, questa chiave di lettura della modernità e dei suoi esiti ultimi non arrivava del tutto nuova, e Debord stesso riconosce i suoi debiti. Si pone infatti come abbiamo visto in diretta continuità col marxismo (sia pure con un Marx liberato dai dogmatismi delle letture “ortodosse”, a partire da quella di Lenin), ma tra i suoi riferimenti vi sono anche Max Stirner, George Lucàks e i francofortesi (e io includerei Thornstein Weblen e Vance Packard, che tuttavia nel Sessantotto erano considerati “organici” al pensiero borghese, quindi poco spendibili – infatti non li cita mai). Il merito del libretto sta nell’aver raccolto e sistemato in una trama coerente tutti questi spunti, di averli attualizzati. E magari anche di avere intravisto le origini più remote del fenomeno, le cui prime avvisaglie fa risalire sino a Cervantes (e anche su questo tornerò).
Ciò che Debord metteva a fuoco sessant’anni fa oggi lo diamo per scontato, perché nella spettacolarizzazione viviamo immersi, è la nostra quotidianità: sul suo libro si è già depositata la patina del tempo, senza peraltro farne un piccolo classico del pensiero, ma al più un reperto documentale da esibire in occasione di future celebrazioni anniversarie o di festival del situazionismo. All’epoca invece l’analisi appariva, oltre che estremamente lucida, anche tempestiva, sviluppata in tempo utile per immaginare delle contromosse, per esorcizzare in qualche modo il fenomeno. Ed è proprio qui che Debord risulta datato: nell’idea che da questa coscienza potesse scaturire una qualche positiva reazione.
La seconda parte del nuovo manifesto è infatti dedicata alle strategie che Debord suggerisce per sottrarsi agli allettamenti della spettacolarizzazione. Non è il caso di elencarle tutte, ma direi che possono essere riassunte ed esemplificate nella pratica del détournement: ovvero del cambiamento di senso di tutto ciò che è espressione del potere, dell’inversione dei meccanismi della ricezione culturale, specialmente se legati alla comunicazione di massa, come la pubblicità o il fumetto, ma anche della modifica e della dissacrazione di oggetti estetici che da sempre orientano o dettano i canoni del gusto: “La libertà per esempio di trasformare la cattedrale di Chartres in luna-park, in labirinto, in campo di tiro, ecc.”.
Di primo acchito verrebbe da pensare che il suo invito sia stato raccolto. In fondo lo stravolgimento dei canoni estetici e dei messaggi, lo snaturamento di luoghi sacri o edifici storici, l’irrisione dei rituali, la falsificazione delle tradizioni, gli sberleffi alle istituzioni, tutto questo è già in atto da tempo. Il problema è che, appunto, lo “spiazzamento”, la “decostruzione”, il “disincanto” sono diventati la nuova normalità. Questa presunta “rivoluzione” continua ad essere gestita dal sistema stesso. Si può discutere se l’abbia anche innescata, senz’altro comunque se ne è appropriato, come è accaduto del resto per tutte le rivoluzioni dell’età moderna, da quella inglese a quella francese, da quelle “nazionali” dell’Ottocento a quelle “sociali” del primo Novecento. È accaduto nel Sessantotto, quando la contestazione giovanile è stata pilotata a svecchiare il sistema e a reclutare nuove fasce di utenti al consumo; è accaduto l’altro ieri, col femminismo, continua ad accadere oggi coi vari movimenti di rivendicazione di identità sessuale.
Insomma, il rinnovato protagonismo auspicato da Debord si risolve in una provocazione sterile, totalmente autoreferenziale, quando non addirittura funzionale al sistema che professa di voler combattere. In linea con la presunzione di épater les bourgeois che dal Romanticismo in poi ha sempre animato ogni “avanguardia” intellettuale. D’altro canto il situazionismo nasce proprio nell’ambiente delle avanguardie artistiche, che con la prosa della realtà hanno in genere un rapporto piuttosto conflittuale, e alla spettacolarizzazione sono predisposte già di per sé. Debord non fa che riproporre in chiave più esplicitamente politica il “sabotaggio” predicato mezzo secolo prima dai surrealisti, da operarsi con gli spostamenti di senso e gli accostamenti paradossali. Ma un orinatoio esposto in un museo o i baffi sul volto della Gioconda non smuovono le coscienze: semmai le anestetizzano, irridono dei valori, decostruiscono dei codici, ma non ne propongono di alternativi. Debord sembra non aver capito che il sistema è un muro di spugna. Fagocita tutto quello che gli butti contro e te lo rigetta in forma di merce. Non a caso i surrealisti più famosi sono Magritte e Dalì, quelli che hanno disatteso i dettami “internazionalisti” di André Breton, mentre nessuno legge più le poesie di quest’ultimo. E non a caso le “avanguardie” del secolo scorso, dai futuristi appunto ai surrealisti, rivelano poi una inquietante consonanza coi totalitarismi.

Com’era –Il discorso a questo punto potrebbe sembrare chiuso: liquidati ormai tutti i sogni di una palingenesi che passi per la presa di coscienza collettiva, rimane solo l’illusione di un protagonismo individuale, sia pure effimero. E invece, proprio di qui potrebbe partire una riflessione non oziosa. Non so infatti se Debord fosse del tutto inconsapevole di quanto onnivoro sia il sistema: di quanto cioè egli stesso, con la fondazione del movimento situazionista, e tanto più con la pubblicazione del libro, si prestasse ad essere risucchiato nei meccanismi di quella rappresentazione sociale che voleva smascherare. Forse consapevole lo era, dal momento che già immediatamente dopo la contestazione sessantottina, durante la quale il movimento aveva conosciuto una particolare popolarità, disgustato dalla massa di aspiranti che professavano la loro adesione all’Internazionale senza averne minimamente capito il senso, dichiarò quest’ultima disciolta (definiva sprezzantemente i neo-adepti “i pro-situ”: lascio immaginare cosa potrebbe pensare degli odierni “post-situ”): ma rifiutava di accettarne le conseguenze, e si trastullava con l’idea che portando scompiglio nei modi della trasmissione culturale, mostrando “di che lacrime grondi e di che sangue” e di che trucchi e menzogne si nutra, si sarebbe aperta la strada ad un ribaltamento dell’assetto sociale.
Lungo tutto il saggio è fortissima la critica alla contemplazione: “Solo nell’attività l’uomo realizza se stesso, nel caso contrario non può esserci che alienazione”. Ma non è ben chiaro di quale attività si stia parlando: “Poiché tutti diventeranno artisti ad uno stadio superiore, cioè in modo inseparabile produttori-consumatori di una creazione culturale totale, si assisterà alla rapida dissoluzione del criterio lineare di novità. Poiché tutti diventeranno, per così dire, situazionisti, si assisterà ad un’inflazione multidimensionale di tendenze, esperienze, di scuole, radicalmente differenti, e tutto questo non più successivamente, ma simultaneamente.” Appunto, un gran casino. Ma non del tipo che Debord si sforzava di immaginare.
Se infatti l’analisi era centrata, non lo erano le prospettive future che l’autore ne inferiva. Certo, come abbiamo visto la “spettacolarizzazione” si è realizzata compiutamente, addirittura al di là di quanto ci si potesse attendere. Tutti sono diventati “produttori-consumatori”, in una filiera nella quale sotto molteplici spoglie il capitale tecno-finanziario gestisce i luoghi, i tempi e i mezzi di produzione delle merci, gli apparati per il loro spostamento, le cattedrali del loro consumo e i rituali per la loro consacrazione. E all’individuo continua ad essere riservato un ruolo passivo di contemplazione (quello dal quale il situazionismo avrebbe voluto riscattarlo), di consumatore delle merci e di una cultura e di una politica “spettacolarizzate”, ridotte a merce anch’esse.
Ma è accaduto anche qualcosa che Debord non aveva messo in conto. Non solo non c’è stata affatto quella reazione liberatoria che secondo il filosofo belga le masse e i singoli individui, una volta acquistata consapevolezza, avrebbero prodotto, ma al contrario le une e gli altri si sono totalmente integrati nella messa in scena, e hanno accolto l’invito all’azione e al ritorno al protagonismo in un senso esattamente contrario a quello da lui atteso. Hanno scelto di essere, ma non di essere consapevoli, quanto piuttosto di essere visibili. Di esserci, di essere riconosciuti (che è cosa ben diversa dall’essere conosciuti), e quindi di rappresentarsi. Si sono arresi ad un surrogato di protagonismo, ad una smodata e malata coazione ad apparire che rientra perfettamente nel disegno del sistema spettacolare.
Va detto onestamente che un detournement di questo tipo non era prevedibile. Nel ‘67 internet e gli smartphone e i social network erano di là da venire, la frontiera tecnologica più avanzata della comunicazione scritta erano la Lettera 22 e il ciclostile. Ma ora che abbiamo imparato a conoscere i media di ultima generazione, a usarli, ad avvertirne le dipendenze, dobbiamo prendere atto che hanno completamente stravolto il quadro. Con le nuove tecnologie l’inflazione multidimensionale di cui Debord parla si è tradotta in una polluzione multimediale, entro la quale tendenze, esperienze, “scuole” non si esprimono, ma si appiattiscono, si svuotano di senso e si perdono dentro un rumore di fondo indistinto.
Provo a riassumere. Nelle aspettative della sinistra movimentista la rete telematica avrebbe dovuto fornire a ciascuno un megafono, essere lo strumento di una partecipazione attiva all’esercizio della democrazia diretta, del controllo dal basso, della trasparenza, e consentire un libero accesso alla conoscenza. Nella realtà si è rivelata un ulteriore formidabile strumento di manipolazione e ha dato la stura al manifestarsi di un individualismo narcisistico e presuntuoso, che si nutre di like e dell’illusione di protagonismo, Se nella fase precedente non c’era alcun dialogo e gli occhi degli spettatori-consumatori erano puntati solo sul cinema messo in piedi dal sistema, ora l’isolamento è ancor più totale, perché il dialogo è in realtà solo un chiacchiericcio unidirezionale e l’attenzione si concentra soprattutto sulle immagini autoprodotte e su una patetica ricerca di “consenso”, che dia l’illusione di una qualche eco e di una qualche visibilità. Tutto ciò che transita sulla rete viene banalizzato, e anche i messaggi e gli inviti al risveglio lanciati in buona fede, persino quelli che sembrano momentaneamente conoscere un certo successo, sono risucchiati velocemente nel vuoto. Ne è riprova il caso delle proteste di massa dello scorso decennio, degli indignati e dei girotondini, delle primavere arabe e non, delle rivolte popolari che non si sono non mai tradotte in rivoluzioni durature, nonché dei passaggi nostrani di banchi di Sardine: milioni di persone hanno risposto simultaneamente, come si augurava Debord, agli appelli al cambiamento diffusi attraverso i network, ma una volta in piazza non sapevano più cosa dire e cosa fare, e nei casi più seri hanno finito per scatenare risposte ferocemente reazionarie.
Per capire come si sia arrivati a questa situazione è necessario comunque fare un passo indietro. Non è liquidabile come un rincoglionimento generalizzato (anche se ha tutte le caratteristiche), frutto di un qualche avvelenamento da piombo come si ipotizzava un tempo per la fine dell’impero romano, o dell’inquinamento atmosferico. Il fatto è che i nuovi media sono stati colonizzati immediatamente dal sistema, così come del resto era accaduto per quelli del passato, ma con effetti più diluiti e meno traumatici. Negli anni Novanta l’alleanza tra il neo-capitalismo digitale e quello finanziario ha prodotto un vero sconvolgimento, in primo luogo nell’economia, accelerando la globalizzazione e la concentrazione monopolistica. Le innovazioni portate dall’ industria high tech sono state sospinte ed enfatizzate con enormi iniezioni di capitali da una finanza in cerca costante di nuove opportunità di investimento. A loro volta le nuove tecnologie hanno velocizzato in maniera esponenziale le transazioni, creando di fatto un mercato finanziario unico, legittimandone le operazioni speculative più ardite e cancellando le regole e i contrappesi che sino a ieri lo avevano regolamentato. E soprattutto hanno “smaterializzato” il concetto stesso di capitale, un tempo legato ai frutti di imprese produttive, oggi a quelli di una attività puramente speculativa. La gran parte dei dirigenti delle grandi multinazionali non ha la minima idea di cosa producano le aziende di cui hanno il controllo, mentre è sintonizzata costantemente sugli algoritmi che ne monitorano le fluttuazioni di valore.
Gli effetti di questa trasformazione sono stati immediati. Intanto il ridimensionamento, in termini di occupati, degli apparati produttivi. In un mercato aperto e senza regole la competitività può essere mantenuta soltanto abbattendo i costi fissi di produzione: e dal momento che sulle altre componenti, materie prime ed energia, non ha il pieno controllo, il capitale interviene comprimendo l’occupazione, esternalizzando il più possibile le attività, spostandole in paesi nei quali il costo del lavoro è più basso o appaltandole ad aziende più piccole, nelle quali la forza contrattuale dei lavoratori è minima; o addirittura individualizzandole, tramite l’affidamento a lavoratori “indipendenti” che operano in regime di “libero mercato”. In quest’ultimo caso soprattutto, ma anche negli altri, sono appunto le tecnologie digitali a consentire un controllo costante e istantaneo.
Ma questa è una storia risaputa. Mi interessano piuttosto gli affetti sociali più eclatanti che questo terremoto economico ha prodotto.
Intanto la precarizzazione del lavoro, quindi il venir meno di quel riferimento fisso che nel bene o nel male informava le esistenze delle generazioni precedenti. Con conseguente insicurezza e perdita di ogni stimolo a progettarsi un futuro. Poi la dissoluzione di quei legami di solidarietà che il lavoro dipendente creava, e che diventavano anche occasioni di amicizie, di rapporti interpersonali effettivi, concreti. Quindi il progressivo isolamento dei singoli nel guscio individuale e il disinteresse nei confronti dei problemi collettivi.
Nel mentre procedeva a questa azione distruttiva l’alleanza tecno-finanziaria si premurava anche di fornirne una giustificazione. Il lavoro precarizzato e individualizzato è stato presentato come un’opportunità di democratizzazione dei nuovi modelli produttivi. In sostanza, il lavoratore verrebbe a godere di margini di libertà più ampi di quelli di cui godevano coloro che operavano nelle imprese fordiste.
A sostituire i rapporti sociali concreti maturati lavorando in azienda provvederebbe la stessa rete, ampliando a dismisura la possibilità di contatto con interlocutori sparsi in tutto il mondo, e consentendo di scegliere e selezionare entro uno spetto molto più ampio.
A questo tipo di rappresentazione fornito dal sistema corrisponde però una realtà molto diversa. L’autonomia di cui dovrebbero godere i nuovi produttori è smentita proprio dal controllo più stretto che le tecnologie digitali consentono, oltre che dalla dipendenza costante dai flussi verso i quali il capitale dirige i consumi. D’altra parte, l’isolamento degli individui non è affatto superabile attraverso un surrogato tecnologico di rapporto che di per sé, per quelli che sono gli aspetti essenziali della sua natura (velocità, appiattimento dei livelli, la modalità stessa della fruizione), prescinde da ogni effetto emozionale e al tempo stesso non si presta affatto a reggere un discorso ponderato e organizzato.
Ciò che effettivamente vediamo scaricato e circolante in rete sono piuttosto sfoghi insensati, urlati, patetici, quando va bene solo sterili; ed è tutto materiale funzionale allo spettacolo. Creano da un lato l’illusione di una appartenenza identitaria, di far parte di una comunità che sia pure solo virtualmente ti riconosce e sia pure solo attraverso gli emoji ti prende in considerazione, dall’altro quella di affermare una autonomia di pensiero e di giudizio all’interno del delirio di voci collettivo. Tutti si influenzano vicendevolmente, tutti parlano e straparlano, ma nessuno in realtà ascolta l’altro. Un brevissimo tour nell’inferno dei social ci offre una fotografia allucinante e allarmante della solitudine, del livore e dell’avvilimento che regnano in platea.
Ma non è tutto: utilizzando i dati forniti dalla coazione ad autorappresentarsi, il sistema è ormai in grado di andare oltre le proposte di consumo generalizzate, di elaborare per ciascuno delle risposte mirate. Non si fa a tempo ad esprimere un’opinione, una preferenza, un interesse o un dubbio che si è immediatamente inondati di offerte e proposte da parte del mercato (e di risposte o di insulti da parte degli altri utenti). È in fondo il modello Toyota, applicato ad ogni forma di produzione di merce.
Questo ci si doveva attendere. Il fatto che Debord non l’abbia previsto è comprensibile, mentre lo è molto meno l’ostinazione odierna della sinistra superstite a non prenderne atto.
Vorrei precisare che il difetto stava comunque già a monte, ben prima della comparsa dei social. Stava intanto nel continuare da parte della sinistra ad adottare criteri di analisi obsoleti; nel fare riferimento a categorie sociali, il proletariato in primis, assunte come se nulla fosse cambiato dai tempi della redazione del Capitale; nel continuare a leggere Marx come un profeta, e non come un economista che ragionava sui dati e sulla realtà del suo tempo; nel credere infine che il sistema sarebbe comunque rimasto ancorato al modello fordista. Debord almeno questo ultimo cambiamento lo aveva intuito.
C’era naturalmente anche l’abbaglio di fondo che ha condizionato tutti i messianismi, religiosi o secolari che fossero, e le utopie: il postulare una natura umana originariamente positiva, corrotta poi ed espulsa dall’Eden per la sua presunzione di dominio sulla natura, bisognosa soltanto di essere riscoperta e redenta. Paradossalmente, questa riappropriazione del sé dovrebbe passare attraverso un contradditorio iter di “rieducazione” alla libertà, di rifiuto di ogni condizionamento politico e sociale (che in occidente si esprime innanzitutto attraverso la critica della democrazia). Di fatto, si risolve nello scivolamento progressivo verso una centralità dei diritti individuali rispetto a quelli collettivi.

Com’è – È ora però di arrivare al dunque. Che non significa tirare delle conclusioni, perché la trasformazione sociale è velocissima e imprevedibile, e riserva ogni giorno nuove sorprese: si possono però fare almeno un paio di considerazioni.
Intanto penso di dover chiarire ulteriormente a cosa mi riferisco quando uso il termine “sistema”, perché dal significato che gli si dà dipende l’interpretazione di tutto quanto ho scritto finora. Io lo intendo come il risultato di un processo, sempre in divenire, messo in moto sin dai primordi dell’evoluzione della specie umana, quando quest’ultima si è trovata nella necessità di ricorrere al soccorso di tecniche per garantirsi la sopravvivenza (e per “tecniche” intendo tutto, secondo l’originale valenza etimologica, dall’uso di protesi e di strumenti materiali – per la difesa, per gli spostamenti, per la domesticazione della natura, ecc. – a quello di un pensiero e di un linguaggio complesso, e dei supporti – scrittura, stampa, ecc. – destinati a trasmetterlo). Col tempo quel supporto che era nato in funzione difensiva si è sviluppato in una direzione offensiva, ed è stato monopolizzato o comunque posto al proprio servizio da una piccola parte dell’umanità per soggiogare e sfruttare non solo la natura, ma la restante maggioranza di una popolazione o di intere altre popolazioni. Di qui la formazione delle classi sociali (sacerdoti, cavalieri, scribi, ecc.) e la sua cristallizzazione in dominanti e dominati, secondo un modello che ha continuato a funzionare così, pur con tutte le possibili varianti, per millenni. Poi sono arrivate la rivoluzione scientifica, e appresso quella industriale, e al seguito di questa quelle sociali, che hanno aperto in quel modello delle crepe.
Ma la rivoluzione profonda, quella che ha sparigliato del tutto le carte, è stata indotta dall’autonomizzazione della tecnica. Voglio dire che ad un certo punto il controllo di quest’ultima è sfuggito dalle mani delle stesse classi dominanti, perché si è innescato un meccanismo in base al quale l’innovazione tecnologica non è più governata in funzione della produzione o dell’accumulazione di capitale, ma è forzata da un processo “necessario” e autoreferenziale di accrescimento. Lo sviluppo della tecnica non è più finalizzato a scopi esterni, ma ad alimentare la capacità tecnica stessa. Un po’ quello che sembra destinato ad accadere in maniera eclatante con l’intelligenza artificiale, ma che già è accaduto ad esempio quasi tacitamente con la progressiva finanziarizzazione del capitale. Il sistema a questo punto non è più rappresentato dai colossi dell’industria o della finanza o del network, tutti protagonisti intercambiabili, e meno che mai dagli apparati politici al loro servizio: è come un enorme e complesso quadro elettrico dove si sono cumulati e intrecciati nel corso della storia innumerevoli fili di colore e diametro diverso, e interruttori e relè e inverter e altre apparecchiature e pulsantiere, che assorbe e distribuisce energia, ma del quale nessuno più è in grado né di individuare i dispositivi di accensione o di spegnimento né di ricordare le finalità del funzionamento.
Tutto questo ha potuto accadere per via della parcellizzazione e della specializzazione delle competenze e dei ruoli tecnici, a sua volta indotta dalle esigenze di strumenti e di modalità produttive (o accumulative) sempre più performanti. Per costruire una carriola erano sufficienti le competenze di mio nonno, per un’auto elettrica si assemblano quelle di migliaia di operatori, nessuno dei quali possiede un’idea complessiva del prodotto finale e a ciascuno dei quali si chiede solo di garantire e aumentare l’efficienza del proprio segmento. Ciascuno aggiunge un filo o un interruttore, e si preoccupa che all’interno di quello passi o si interrompa la corrente. La finalità unica del quadro pare ormai essere proprio quella di funzionare.
Il termine più adatto per definire questa situazione potrebbe essere “tecnocrazia”: ma anche qui, occorre intenderci sull’accezione in cui viene usato. Nel mio caso non mi riferisco a un “governo dei tecnici”, perché questa accezione suppone una “autonomia” di questi ultimi che di fatto non esiste, in quanto al momento è ancora il capitale finanziario a orientare e decidere le direzioni della ricerca e dello sviluppo, e i tecnici semmai rappresentano la componentistica più avanzata, ma sono essi stessi dei cavi o degli strumenti di trasmissione. Penso invece ad un “governo della tecnica”. Sono due cose decisamente diverse: un governo dei tecnici ha una dimensione ancora “umana”, è comunque uno strumento, che può essere piegato a finalità di sfruttamento o di egemonia, ma teoricamente potrebbe anche perseguire altre strade; un governo della tecnica, come dicevo sopra, prescinde da qualsiasi altra finalità che non sia la propria perpetuazione e il proprio sviluppo.
Può sembrare quindi prematuro definire quella attuale una “tecnocrazia”, perché ancora il processo non si è compiuto: ma siamo già molto avanti su questa strada, sulla via della totale autoreferenzialità tecnologica.
Su questo discorso si innesta quello della spettacolarizzazione. Il quadro-sistema è il teatro in cui tutti recitano una parte, alcuni da protagonisti, la maggioranza come semplici comparse, ma nessuno è insostituibile e nessuno ha davvero in mano la regia. A decidere su chi o su cosa puntare o spegnere i riflettori è il tecnico delle luci, come in questo caso potremmo definire la tecnica autoconsapevole, quello che fa sì che il tutto continui a funzionare, che le spie rimangano accese. Qualcuno, non ricordo chi, ha scritto che oggi la scienza (e quindi la tecnica, che ne è l’applicazione) non guarda più a ciò che è utile fare, ma a tutto ciò che è possibile fare: che non è dunque più al servizio dell’uomo, ma di se stessa. Sembra stia parlando della saga di Terminator, ma se sostituiamo l’intelligenza artificiale guerriera che lì prende possesso del mondo in maniera violenta e crudele, e la sostituiamo con un’invadenza tecnologica strisciante, apparentemente ancora strumento e in realtà altrettanto determinata a diventare il fine, ci siamo già dentro. Fisicamente (io stesso ho già dovuto ricorrere a “ricambi” artificiali), ma soprattutto intellettualmente (la rete è già diventata un’indispensabile protesi della nostra memoria).
Non è un’immagine confortante, soprattutto se connessa a quella abusatissima (anche da me) di Kierkegaard, del teatro che sta andando in fiamme e degli spettatori che applaudono e se la ridono, ma è forse quella che meglio fotografa la realtà attuale.
Come se ne esce? Sinceramente, non ne ho la minima idea. Altri le idee le hanno, ma mi sembrano piuttosto confuse e contraddittorie, Per alcuni la soluzione verrà dalla tecnica stessa, che ad un certo punto, a sua stessa salvaguardia, attiverà un riduttore o un salvavita e rimetterà in ordine i fili. Altri prevedono un’operazione di autodifesa del capitale, che ha sensori acutissimi, e che davanti alla prospettiva di un generale collasso vorrà riformarsi secondo modalità più “sostenibili”. I nostalgici del marxismo continuano a sperare in un risveglio collettivo degli ultimi, che è improbabile quanto quello del capitale ed apre a scenari altrettanto foschi, e comunque nebulosi. Altri ancora, al contrario dei primi, ritengono che l’incombere della catastrofe ambientale stia già facendo maturare un rifiuto integrale della tecnica, e dunque del consumismo, e propugnano il ritorno ad una economia “a misura d’uomo”. Magari auspicando anche una drastica riduzione numerica della nostra specie, operata in questo caso dalla natura stessa coi suoi mezzi (dagli asteroidi alle epidemie). Insomma, l’impressione è che chi si pone il problema in termini realistici non possa augurarsi altro che un rallentamento della corsa al disastro, anziché una sospensione, e che negli animi si stia sottilmente insinuando la rassegnazione di fronte a ciò che appare ineluttabile. Non in tutti, per fortuna.
Non rassegnarsi non significa per me progettare migrazioni su Marte o continuare a vagheggiare rivolgimenti sociali sulla Terra, oppure ritirarsi a pascolar capre in montagna: significa molto più semplicemente continuare a fare quello che bene o male ho cercato di fare fino ad oggi: pensare, indagare, capire almeno come siamo arrivati alla condizione attuale, per vedere casomai una delle strade non scelte in passato potesse offrire qualche via di fuga. E lo scritto presente, nel suo piccolo, imponendomi di riflettere risponde a questo assunto.

Come sarà? – Cerco dunque di venirne a una, tornando finalmente al tema che avrebbe dovuto essere centrale. Ho parlato sin qui di due modalità di autorappresentazione, quella proposta dal sistema sul grande schermo del mondo e quella concessa nel formato selfie ai rimanenti otto miliardi di individui umani. Ora vorrei cercare di chiarire qual è il rapporto tra il trionfo della rappresentazione e il crescente rifiuto dell’istituto della rappresentanza. Che a questo punto mi sembra scontato. Ma andiamo con ordine.
La rappresentanza è uno dei cardini della democrazia occidentale, e di fronte all’attuale crisi di credibilità del sistema democratico è il primo ad essere messo in discussione. Lo si elenca tra i trucchi illusionistici imputati alla “modernità” per mascherare l’azione sempre più pervasiva del potere, anche se a ben vedere non è affatto un portato dell’età moderna. Delle modalità di delega erano già presenti infatti, per i ruoli più diversi e in ambiti di partecipazione più o meno ristretti, sin dalla nascita delle comunità umane (a dispetto di quanto sostenuto dai nostalgici dell’eden paleolitico, delle società “orizzontali” dei cacciatori-raccoglitori). E duemilacinquecento anni fa ad Atene erano già regolamentate secondo il modello vigente ancora oggi. Col tempo, con la crescita di istituzioni politiche di grandi dimensioni (per intenderci, con lo stato moderno), e soprattutto con i rivolgimenti sociali prodotti dal modo di produzione industriale, le forme della rappresentanza sono state più o meno uniformemente definite e universalmente accettate. Questo soprattutto in Occidente, e almeno fino a ieri.
Oggi non è più così. Nei confronti della democrazia rappresentativa crescono i dubbi e la disaffezione. E dal momento che non si conoscono modelli alternativi che abbiano funzionato meglio, la critica investe tutto il sistema di princìpi, valori, regole e procedure che caratterizzano le istituzioni democratiche nel loro complesso. Anche questi attacchi non sono una novità: nei secoli scorsi erano uno sport praticato principalmente dalle destre, legittimiste, populiste o tradizionaliste che fossero, e questo è comprensibile. Ma non meno ostile era l’atteggiamento delle sinistre più radicali, nelle loro svariate sfumature, ortodossamente marxiste, operaiste, consigliari, leniniste, anarchiche, che nel mirino hanno sempre avuto la “democrazia borghese”
La differenza sta nel fatto che quelle proponevano bene o male delle alternative, (anche se dove hanno potuto sperimentarle sono andate incontro a risultati tragici), dei progetti sociali definiti e strutturati, mentre il rifiuto espresso dal nuovo corso “movimentista” è tutto all’insegna dello spontaneismo, del culturalismo (le appartenenze identitarie non sono più quelle di classe, ma quelle di cultura o di genere), dell’“orizzontalismo” (quello che avrebbe dovuto passare per Internet). Ciò spiega l’incapacità di questi movimenti di coordinarsi e di adottare obiettivi, programmi e forme organizzative comuni. Si tratta in sostanza di un velleitario miscuglio di ideologie ferocemente antigerarchiche e antistataliste, genericamente antiautoritarie, orientate alla rivendicazione di diritti individuali o di gruppi specifici, che finisce poi paradossalmente per essere espressione più o meno cosciente della globalizzazione e per aggregare masse disorientate, il “volgo disperso che nome non ha”, attorno a leader carismatici.
Tutto questo meriterebbe però una trattazione specifica, che rimando a una prossima volta. Qui mi interessa invece mettere in luce come la narrazione in negativo della politica che prevale oggi non sia solo trasversale ai due vecchi schieramenti, ma li superi, perché è orchestrata appunto da quel “sistema post-politico” che ho identificato sopra. I temi, le argomentazioni e i modi della critica tradizionale sono ripresi e riproposti in una confezione patinata, che sfrutta la potenza e la duttilità dei nuovi strumenti mediatici lasciando parlare, per così dire, le evidenze. Quelle, naturalmente, che si prestano a screditare il modello democratico. Cosa ci raccontano infatti i notiziari, i talk show, le inchieste scandalistiche, ma anche i film, le serie televisive, gli spettacoli di satira, se non che il mondo della politica è un letamaio, che quello politico è uno sporco lavoro, che non c’è verso a giocare puliti e che occorre averci il minor contatto possibile se non vogliamo a nostra volta insozzarci?
Questa narrazione ha senz’altro buon gioco, perché per un funzionamento corretto della rappresentanza la delega dovrebbe essere conferita ad individui in possesso dei giusti requisiti, e nella realtà politica queste condizioni ideali non si verificano quasi mai – non è un problema di oggi, è sempre stato così. Sulle scelte influiscono infatti logiche di partito, condizionamenti economici, interessi più o meno occulti, che alla lunga falsano completamente le regole del gioco. Basti pensare ad esempio a ciò che accade negli Stati Uniti, dove l’enorme aumento dei costi delle campagne elettorali ha finito per riservare ai ricchi la competizione elettorale, tagliando fuori dalla possibilità di vedere rappresentati i propri interessi non solo le classi lavoratrici, ma anche le classi medie (per cui a questo punto è praticamente indifferente che vinca l’uno o l’altro candidato). Lì la cosa è più eclatante per le cifre spropositate che entrano in gioco, ma anche in Europa, pur senza arrivare a questi eccessi, la democrazia non sta molto meglio. Ciò parrebbe in parte spiegare la disaffezione nei confronti della rappresentanza: in realtà spiega però solo quella nei confronti di coloro che deputiamo a rappresentarci, mentre oggi ad essere messo sotto accusa è proprio l’istituto politico.
Va altresì aggiunto che anche laddove una parvenza di senso le elezioni sembrano mantenerla, coloro che per onestà e competenza potrebbero essere più adeguati tendono a sottrarsi alla responsabilità, e non sempre per una scelta di comodo. In molti casi questo atteggiamento nasce dalle delusioni maturate nelle esperienze dirette, che inducono i più sensibili a ritirarsi nel loro guicciardiniano “particolare”.
Tutto, insomma, congiura a far prevalere l’idea che chi vuole preservare la sua dignità dovrà limitarsi alla resistenza passiva, alla difesa delle sue private libertà. E lasciare libero campo all’azione del sistema, rassegnandosi a vivere in una società post-democratica.
Questo avviene infatti mentre dietro le quinte dello spettacolo, nel mondo reale, aumenta in maniera esponenziale la distanza tra l’esigua minoranza dominante e il resto della popolazione, mentre è in atto lo smantellamento dello stato sociale, con la privatizzazione di una quota crescente di attività di assistenza, di cura, di controllo dell’ordine, di gestione del territorio e delle infrastrutture, tutte cose che prima rientravano nelle sfere delle relazioni private, famigliari e comunitarie. Quelle che erano le competenze degli stati sono trasferite ad agenzie transnazionali o a grandi aziende private che operano su scala planetaria, e le vecchie istituzioni politiche sopravvivono solo come facciate della gestione locale del capitale globale. E tutto ciò accade nella quasi totale indifferenza dei “sudditi”, la cui attenzione è stata frammentata e dirottata sui diritti individuali e sulle rivendicazioni identitarie, che sono impegnati a rappresentarsi e a gratificarsi reciprocamente sui social, e ai quali, disponendo di una tribuna teoricamente aperta sul mondo intero, di avere dei portavoce non importa più per niente. D’altro canto, che istanze dovrebbero rappresentare i delegati? quelle femministe, quelle ambientaliste, quelle pacifiste, quelle delle identità di genere o di cultura, e con quale tipo di mandato, e soprattutto, di fronte a chi?
Qui volevo arrivare. Il nuovo assetto sociale fa sì che venga meno anche la necessità di una finzione democratica, di un’ammortizzazione politica: democrazia e mercato, che bene o male avevano convissuto sino al secolo scorso, non viaggiano più di concerto. La prima non funziona nemmeno più da paravento, ha ceduto campo totalmente al secondo. Gli interessi del tecno-capitalismo globale, la sua nuova configurazione e gli strumenti di persuasione di cui dispone, gli consentono di governare direttamente le nostre vite, senza più bisogno di mediazioni politiche.
Questo, lo si voglia o no, è lo stato delle cose. Come si sarà capito, mi è difficile stabilire quanto sia frutto di un ben preciso progetto e quanto invece di un effetto a valanga, prodotto come dicevo sopra dall’autonomizzazione della tecnica, da una corsa di quest’ultima all’autorealizzazione che riesce per il momento perfettamente funzionale al capitale. Nel primo caso un’azione di contrasto dovrebbe essere eminentemente politica, e forse può essere ancora pensabile, nel secondo si tratta di mettere in discussione tutto un modello esistenziale, e qui davvero temo che le probabilità di sovvertire i pronostici infausti siano nulle. Rimanendo comunque al primo caso, sono convinto che l’azione politica non possa prescindere da una difesa e da una rivitalizzazione della democrazia. E che questa sia attuabile solo attraverso l’istituto della rappresentanza, senz’altro rivisto, purgato delle tante criticità, ridisegnato nei modi e nelle finalità: ma non ci sono alternative. Per come gli stati moderni sono configurati non si può pensare di saltare la rappresentanza per attuare una democrazia diretta: lo hanno dimostrato le recenti esperienze politiche dei “nuovi movimenti” che avevano come unico collante “l’indignazione”, l’insofferenza per i doveri, lo sprezzo per ogni tipo di istituzione – segnatamente di quelli che hanno avuto momentaneamente accesso al potere, come è accaduto in Italia per i grillini. Il rifiuto di un’organizzazione politica strutturata, la partecipazione digitale praticata con un click, ha creato in alcuni l’illusione che la democrazia potesse essere rivitalizzata semplicemente cambiandone le regole, in molti la presunzione di essere finalmente protagonisti e di farsi interpreti dei problemi del “paese reale”. Col risultato di consegnare il paese nelle mani di una combriccola incompetente e inconcludente, rissaiola, altrettanto disonesta e compromessa di quelle che avrebbe dovuto spazzare via, e di disamorare ulteriormente dalla partecipazione gli incerti e i delusi. Ha fatto cioè esattamente il gioco del sistema, ha recitato nel suo spettacolo.
Preferirei non assistere alle repliche.

Due postille

1) Non vorrei che il mio approccio al tema della tecnica fosse confuso con quello dei vari Severino, Galimberti e, giù per li rami, Heidegger e Nietzsche. La differenza sta nel fatto che da costoro la tecnica è intesa come un male assoluto, il peccato originale che ha strappato l’umanità dal suo edenico rapporto con la natura, e ha indotto la nostra specie a contrapporsi alla natura stessa e a volerla dominare.
Ora, non c’è dubbio che la risposta adattiva della nostra specie alla propria particolare condizione di debolezza biologica sia finita sopra le righe, ma a mio giudizio questo rientra pienamente nella sua particolare natura. Si può anche pensare che l’uomo sia un tragico errore dell’evoluzione, ma è pur sempre frutto di un processo evolutivo, che nel suo caso ne è la continuazione “con altri mezzi”. La tecnica non è “innaturale” in sé, lo diventa semmai quando il suo controllo è volto a finalità che secondo il nostro metro morale risultano sbagliate. Non è espressione della pura “volontà di potenza” come pensa Heidegger, sulla scia di Nietzsche, o una fuga di fronte angoscia del divenire, del destino della mortalità, come la considera Severino. È una “necessità” evolutiva.
Insomma, dobbiamo capirci. L’uomo per sopravvivere ha bisogno della tecnica: su questo non ci piove. È una scimmia nuda: non ha una pelliccia né una corazza, non ha dentature potenti come le tigri o i coccodrilli, non ha zanne né artigli, non si difende e non attacca coi veleni. Non è attrezzato come tutti gli altri animali alla vita di natura, almeno a partire dal momento in cui lo consideriamo una specie separata dalle sue più affini. Quando questa separazione sia avvenuta più o meno l’abbiamo stabilito, ma non sappiamo né come né perché. Probabilmente i cambiamenti climatici hanno costretto una parte dei nostri cugini scimpanzé a uscire dalle foreste e li hanno gettati allo sbaraglio nelle savane. Comunque sia, per non sopravvivere precariamente solo come prede, gli esuli da quel momento hanno dovuto riadattare il loro fisico alla nuova situazione, e là dove la selezione non provvedeva hanno dovuto ingegnarsi con quello che l’ambiente offriva, pietre, ossa, bastoni, pelli degli animali uccisi. Farne delle protesi dei loro corpi. Sono diventati “umani”, e hanno cominciato a modificare con le loro attività l’ambiente stesso (caccia, raccolta, agricoltura, allevamento) e a plasmarlo progressivamente in un crescendo inarrestabile, a creare nuove forme di società e di rapporti, moltiplicandosi fino ad arrivare a coprire con la loro presenza ogni angolo della terra.
Tutto questo ad un certo punto ha travalicato la pura volontà di sopravvivenza. E qui sposo completamente la tesi esposta da Ortega y Gasset nella Meditación de la técnica (1939): “Senza la tecnica l’uomo non esisterebbe e non sarebbe mai esistito”. L’uomo, dice Ortega, sviluppa, proprio per le circostanze che deve affrontare, una “intelligenza tecnica”, idonea a individuare le relazioni tra i fenomeni che lo circondano. Oltre a fornirgli la basilare possibilità di sopravvivere, questa gli permette di immaginare molteplici possibilità esistenziali e di scegliere tra esse per costruirsi un programma di vita. La sua condotta non è quindi più casuale, ma intenzionale. Per poter realizzare questo programma, per poter “essere insomma quello che vorrebbe essere”, e quindi vivere bene, usa la sua ingegnosità tecnica per creare artifici e procurarsi strumenti che gli consentano di superare le difficoltà e gli allevino le fatiche. Compie delle azioni “tecniche” volte a modificare e a migliorare la natura che lo circonda, generando in tal modo una sovranatura, e adattando l’ambiente a se stesso. La tecnica non è infatti soltanto adeguamento dell’uomo alla Natura ma, viceversa, tende progressivamente a diventare adattamento del secondo termine al primo. “L’esistenza dell’uomo, il suo stare al mondo, non è uno stare passivo ma egli deve, necessariamente e costantemente, lottare contro le difficoltà che si oppongono a che il suo essere abiti nel mondo.”
Bene. Anzi, male. Perché tutto questo funziona fino a quando l’uomo ha chiaro l’essere che vuole diventare: ma in caso contrario non può che maturare angoscia e disorientamento. E questa è la sua condizione attuale.
Cos’è accaduto allora (cosa è accaduto soprattutto nel frattempo, da quando quasi un secolo fa Ortega esponeva le sue Meditaciones: ma va ammesso che ciò che ancora non era così evidente il filosofo spagnolo ha saputo presagirlo)? È accaduto che gli sviluppi tecnologici hanno creato nell’uomo la sensazione di poter “essere tutto”: hanno moltiplicato esponenzialmente le sue possibili esistenze, ma proprio questa potenziale mancanza di limiti ha generato smarrimento, ha complicato sia l’individuazione che l’attuazione di un proprio progetto di vita, sino ad indurre all’assenza del desiderio o a perdersi dietro “pseudo-desideri, spettri di appetiti privi di sincerità e vigore”. L’uomo ha cominciato a riporre fiducia esclusivamente nella tecnica in quanto tale, addossandole anche la responsabilità creargli un senso. Dal canto suo il dominio della tecnica e della strumentazione scientifica, che orienta le nostre vite, quel senso invece lo nega, frammentandolo nella specializzazione e riducendo quei comportamenti che sono le caratteristiche costitutive della nostra identità a reazioni chimiche, elettriche o meccaniche (e questo per Ortega era uno dei prodomi della massificazione). “All’uomo è data l’astratta possibilità di esistere ma non gli è data la realtà. Questa se la deve conquistare, minuto dopo minuto: l’uomo, non solo economicamente ma anche metafisicamente, deve guadagnarsi da vivere”. Questo perché «l’essere umano e l’essere della natura non coincidono totalmente: dal “lato naturale” l’uomo risulta essere immerso nella natura circostanziale in cui i suoi processi naturali si attivano spontaneamente; la sua “parte extra-naturale” che “pretende di essere” ossia la sua personalità, il proprio io, necessita di costruzione, di cura ininterrotta e di attenzione».
Quindi: la tecnica è un beneficio nella misura in cui risponde alla sua funzione principale, ovvero, cambiamento ma soprattutto miglioramento della nostra situazione esistenziale. Il maggior rischio insito nella tecnica non è la produzione sterminata delle possibilità di vita che può offrirci; questa è una complicanza (il che non significa male assoluto) direttamente proporzionale alla sua grandezza. È invece l’uso improprio, il ricorso esasperato al suo aiuto per semplificarci la vita, che ce la semplifica ma solo nel senso che l’appiattisce, la omologa, la rende simile a tutte le altre, annichilendo la nostra identità. L’avanzamento tecnico, conclude Ortega, se fuori controllo, «indebolisce la forza dei centri riflessivi, semplifica e organizza razionalmente i rapporti umani. Potremmo essere vittime di un sistema tecnico che a sua volta corre un grave pericolo, quello “di sfuggirci dalle mani e scomparire in molto meno tempo di quanto potessimo immaginare”».
Riassumendo. La tecnica ha permesso all’essere umano di superare la sua ancestrale situazione di bisogno, di conquistare una libertà nei confronti delle determinazioni naturali della quale prima non godeva. Gli uomini hanno creato delle macchine moltiplicatrici della potenza, della velocità, della memoria, della conoscenza, le hanno usate per produrre o per distruggersi vicendevolmente, le hanno automatizzate e oggi con le nanotecnologie le hanno rese compatibili col nostro organismo, addirittura incorporabili. Tutto questo non l’hanno fatto le protesi, gli utensili, le strumentazioni, le macchine, lo hanno fatto gli uomini, e la tecnica è rimasta al loro servizio. Che poi ne abbiano fatto un buon uso o meno, è un altro discorso. Guardiamo al risultato: siamo più di otto miliardi. Dal punto di vista evolutivo, un incontestabile successo.
Fino ad oggi. L’evoluzione prevede infatti anche situazioni recessive. Anche queste le vanno messe in conto. Le specie che hanno esercitato sulla terra una eccessiva pressione si sono ridimensionate, o sono addirittura scomparse, e a questo non hanno provveduto solo i cataclismi o l’azione umana. I segni di una recessione di quella umana ci arrivano già dalle proiezioni sul calo demografico naturale a partire dalla metà di questo secolo (che potrebbe essere accelerato dalla natura stessa – epidemie, cambiamenti climatici – o dalla dissennatezza degli uomini – conflitti, carestie indotte). E sappiamo che anche là dove l’uomo ha inciso più profondamente e distruttivamente le tracce del suo passaggio la natura non impiega secoli per riprendere il sopravvento, ma pochi decenni.
C’è però un altro punto di vista da considerare: quello della essenza “umana”. Gli uomini non hanno bisogno della tecnica solo per sopravvivere. Hanno si trasformato il mondo per adeguarlo alle proprie aspirazioni, alla propria interiorità, per raggiungere i propri scopi, ma lo hanno fatto a costo di arrivare a dipendere totalmente dalle risorse tecniche. Le nuove necessità dell’uomo sono sempre meno determinate dalla sua natura e sempre più dallo stesso progresso tecnico-scientifico. La liberazione si è tradotta in una nuova forma di dipendenza.
Non è necessario insistere oltre su questo aspetto. Basta guardarci attorno. O riflettere su ciò che facciamo, sul tipo relazioni che viviamo. Ogni aspetto della nostra vita oggi è condizionato dalla tecnica, anche quando riteniamo di non essere “fuori controllo”. Può sembrare terribile, per molti versi lo è: ma l’ho già scritto sopra, non abbiamo alternative alla tecnica. Come scrive Ortega: “L’unica alternativa possibile all’uso delle macchine è quella di ritirarsi in se stessi e limitarsi a contemplare il mondo, rinunciando ai propri sogni e alle proprie aspirazioni per un futuro migliore”, e “vivendo in un continuo e vacuo sforzo di adattamento ai suoi (della tecnica) mutamenti”.
Questo non significa che non abbiamo alcuna possibilità di riprenderne almeno in parte il controllo, di sfruttarne positivamente i potenziali, di decidere se e quando cambiare marcia e svoltare. Significa che abbiamo una alternativa non all’uso, ma nell’uso.
Per darci un taglio, ed evitare di incartarmi ulteriormente, ricorro ad un esempio. Di fronte alla crescente digitalizzazione delle opportunità e delle competenze si parla del rischio di una “amnesia digitale”. Con questo si indica sia la precarietà dei contenuti, che possono andare dispersi per un qualsivoglia motivo, dall’attacco hacker all’incidente tecnico nel sistema, sia la perdita di competenze, la loro atrofizzazione, dal momento che l’operatività può essere demandata ai sistemi operanti sul web. Pensiamo alle mappe stradali, o alle calcolatrici sullo smartphone, o all’enorme deposito di conoscenze presente su Google. È chiaro che se ci affidiamo all’ausilio delle mappe digitali, che ci suggeriscono ogni svolta del nostro percorso, alla lunga perdiamo la capacità di orientarci autonomamente, di interrogare la segnaletica stradale, di affidarci al ricordo visivo. Lo stesso vale naturalmente se anziché ricorrere alle competenze di calcolo mi affido alla calcolatrice, o se per le mie ricerche consulto Google anziché faticare a rintracciare, a leggere e a comparare le fonti scritte.
È però da considerare un altro fatto: questo modo di procedere esige un investimento di tempo, di attenzione, di sforzo molto inferiore a quello classico. Se ci disabitua all’uso delle nostre facoltà, libera però anche molto spazio nel nostro cervello, che può essere riempito con altre conoscenze e competenze. È qui semmai che viene fuori il vero volto del problema: lo spazio liberato andrebbe riempito con conoscenze e competenze intelligenti, non col ciarpame. La responsabilità quindi non è della tecnica, che fino a questo punto ci offre una opportunità, ma nostra: siamo noi a dover decidere come utilizzare positivamente questi spazi. Il fatto che ciò non avvenga non può essere imputato all’invadenza degli strumenti, ma all’incapacità nostra di farne un uso sensato.
Quindi, lasciamo perdere le recriminazioni su come è andata a partire da Adamo ed Eva, o i vagheggiamenti di un’Arcadia presocratica desertificata dall’iper-razionalizzazione e dalle tecnologie. Abbiamo demandato alla tecnica la soluzione dei nostri problemi materiali, ci stiamo accingendo a demandarle anche il compito di pensare e decidere per nostro conto. È il momento di tracciare dei confini, e questo siamo ancora in grado di farlo: se non ci riusciremo come comunità umana, potremo comunque sempre volerlo come singoli. Non ci sono alibi.
Come vorrebbe dimostrare la postilla successiva.

2) Ne La société du spectacle Debord indica tra i suoi riferimenti Cervantes, dandogli atto di aver precocemente intuito dove sarebbe andata a parare la “modernità”. E questo pur vivendo lo scrittore spagnolo in un paese che nel XVII secolo accusava un grave ritardo nella nascita di un capitalismo moderno. Nella seconda parte del Don Chisciotte attorno al “cavaliere dalla trista figura” viene infatti costruito un mondo artificioso, nel quale tutti recitano uno spettacolo ininterrotto, un po’ alla maniera del Truman Show. In questo caso lo spettacolo non è finalizzato come accade oggi a realizzare un dominio economico e psicologico totale, risponde semplicemente alla maligna voglia di divertimento del duca e della duchessa d’Aragona; ma si tratta comunque di una rappresentazione ingannevole, nella quale tutti hanno una loro parte, e che finisce per far perdere il senso della realtà anche a chi l’ha inscenata. Mano a mano che l’inganno si complica e richiede una partecipazione sempre più allargata ci accorgiamo che i primi a crederci sono proprio coloro che lo ordiscono, nel senso almeno che nello sbeffeggiamento della loro vittima cercano un riscatto, qualcosa che dia un surrogato di senso alle loro vuote esistenze.
L’ultima rilettura del romanzo mi ha rafforzato nel convincimento che avevo già maturato sessant’anni fa, al primo incontro: il cavaliere sarà un pazzo, almeno in base ai criteri di normalità che vigevano all’epoca e vigono tutt’oggi, ma non è un idiota. Attraversa tutte le sue disavventure consapevole di vivere nell’illusione, ma preferisce quella eroica che lui stesso si è scelta a quella squallidamente prosaica nella quale gli altri pretenderebbero di confinarlo. Lo dice chiaramente nel suo testamento: “Ed ancorché tutto avvenisse al rovescio di quello che io mi figuro, non potrà venire oscurata da malizia di sorta alcuna la gloria di aver tentata quest’alta e nuova impresa”. Ma non è l’unico ad avere questa consapevolezza: poco alla volta la sua determinazione scuote anche l’ignavia di Sancho Panza, e apre gli occhi a Sansone Carrasco, lo studente di Salamanca suo amico-avversario, che così lo ricorda dopo la morte: “Giace qui l’hidalgo forte / che i più forti superò, / e che pure nella morte / la sua vita trionfò. / Fu del mondo, ad ogni tratto, / lo spavento e la paura; / fu per lui la gran ventura / morir savio e viver matto”.
L’hidalgo non ha combattuto e vissuto invano.

Appendice
Informazioni più dettagliate sul situazionismo si possono trovare cliccando la voce su Wikipedia, e magari andando poi a confrontarle con quelle presenti su altri siti (ad esempio, su quello della Treccani, su Situazionismo.it, su Anarcopedia, ecc …) o in blog come Doppiozero e Carmilla; oppure consultando direttamente volumi come “AA VV, Situazionismo. Materiali per un’economia politica dell’immaginario, Massari, 1998”, o “Mario Perniola, I situazionisti, Castelvecchi, 2005”, e “L’avventura situazionista. Storia critica dell’ultima avanguardia del XX secolo, Mimesis, 2013”.
È difficile dare un’idea dell’impatto reale che il situazionismo ha avuto sul pensiero alternativo del secondo novecento. Nato nell’ambiente delle avanguardie artistiche, il movimento si è poi spostato progressivamente sul terreno della critica rivoluzionaria, andando incontro nel frattempo a diverse scissioni (chi ha vissuto gli anni attorno al Sessantotto sa di cosa parlo) e prestandosi alle più svariate riletture. Gli va comunque riconosciuto di aver portato nella sinistra una ventata di rinnovamento, mettendo a nudo i ritardi e le miopie dei partiti tradizionali e la loro incapacità di far fronte alle trasformazioni in atto nel secondo dopoguerra.
Aggiungo solo un personalissimo ricordo di uno degli autori qui citati, Mario Perniola, una delle persone più aperte, intelligenti e disponibili che io abbia mai conosciuto, a dispetto di una non sempre totale convergenza delle nostre opinioni. Lo cito perché, a differenza di troppi altri cialtroni incontrati dentro e fuori del mondo accademico, mi ha regalato, col suo solo modo di essere, una straordinaria lezione di vita.

“Manifesto”, redazionale del 17 maggio 1960, I.S. n. 4, Giugno 1960
Una nuova forza umana, che il quadro esistente non potrà soggiogare, si accresce di giorno in giorno con l’irresistibile sviluppo tecnico e l’insoddisfazione per i suoi impieghi possibili nella nostra vita sociale privata di senso. L’alienazione e l’oppressione nella società non possono venire pianificate in nessuna delle loro varianti, ma solo rigettate in blocco con questa stessa società. Ogni progresso reale è evidentemente sospeso alla soluzione rivoluzionaria della multiforme crisi del presente.
Quali sono le prospettive d’organizzazione della vita in una società che, autenticamente, “riorganizzerà la produzione sulle basi di una associazione libera ed uguale dei produttori”? L’automazione della produzione e la socializzazione dei beni vitali ridurranno sempre di più il lavoro come necessità esterna, e daranno infine la libertà completa all’individuo. Liberato così da ogni responsabilità economica, liberato da tutti i suoi debiti e le sue colpe verso il passato e gli altri, l’uomo avrà a disposizione un nuovo plusvalore, incalcolabile in denaro perché impossibile da ridurre a misura del lavoro salariato: il valore del gioco, della vita liberamente costruita.
L’esercizio di questa creazione ludica è la garanzia della libertà di ognuno e di tutti, nel quadro della sola uguaglianza garantita con il non sfruttamento dell’uomo sull’uomo. La liberazione del gioco, è la sua autonomia creativa, che supera l’antica divisione tra il lavoro imposto e i divertimenti passivi. La Chiesa ha bruciato un tempo le cosiddette streghe per reprimere le tendenze ludiche primitive conservate nelle feste popolari. Nella società attualmente dominante, che produce in maniera massiccia degli squallidi pseudo-giochi di non partecipazione, una vera e propria attività artistica è classificata necessariamente come criminalità. È semiclandestina. Si presenta come fatto scandaloso.
Cos’è, in effetti, la situazione? È la realizzazione di un gioco superiore, con più esattezza, è la provocazione a quel gioco che è la presenza umana. I giocatori rivoluzionari di tutti i paesi possono unirsi nell’I.S. per cominciare ad uscire dalla preistoria della vita quotidiana. Proponiamo fin d’ora un’organizzazione autonoma dei produttori della nuova cultura, indipendente dalle organizzazioni politiche e sindacali che esistono in questo momento, poiché non riconosciamo loro la capacità di organizzare nient’altro che il riassetto dell’esistente.
L’obiettivo più urgente che fissiamo per questa organizzazione, dal momento in cui esce dalla sua fase sperimentale iniziale per una prima campagna pubblica, è la presa dell’UNESCO. La burocratizzazione, unificata su scala mondiale, dell’arte e di tutta la cultura è un fenomeno nuovo che esprime la profonda affinità dei sistemi sociali coesistenti nel mondo, sulla base della conservazione eclettica e della riproduzione del passato. La risposta degli artisti rivoluzionari a queste nuove condizioni deve essere un tipo nuovo di azione. Siccome l’esistenza stessa di questa concentrazione direttoriale della cultura, localizzata in un solo edificio, favorisce la conquista con un putsch; e siccome l’istituzione è del tutto sprovvista della possibilità di un uso sensato al di fuori della nostra prospettiva sovversiva, ci troviamo giustificati, di fronte ai nostri contemporanei, se ci impossessiamo di questo apparato. E l’avremo. Siamo determinati ad impadronirci dell’UNESCO, anche se per poco tempo, perché siamo sicuri di fare all’istante un’opera che resterà tra le più significative per illuminare un lungo periodo di rivendicazioni.
Quali dovranno essere i caratteri principali della nuova cultura, prima di tutto in rapporto all’arte del passato?
Contro lo spettacolo, la cultura situazionista realizzata introduce la partecipazione sociale.
Contro l’arte conservata, è un’organizzazione del momento vissuto, direttamente.
Contro l’arte parcellare, sarà una pratica globale basata contemporaneamente su tutti gli elementi utilizzabili. Tende naturalmente ad una produzione collettiva e senza dubbio anonima (almeno nella misura in cui, non essendo le opere immagazzinate in merci, questa cultura non sarà governata dal bisogno di lasciare delle tracce). Le sue esperienze si propongono, come minimo, una rivoluzione del comportamento ed un urbanismo unitario dinamico, suscettibile di essere esteso all’intero pianeta, e di essere poi diffuso su tutti i pianeti abitabili.
Contro l’arte unilaterale, la cultura situazionista sarà un’arte del dialogo, un’arte dell’interazione. Gli artisti — con tutta la cultura visibile — si sono separati del tutto dalla società, come sono separati tra loro dalla concorrenza. Ma anche prima di questa impasse del capitalismo, l’arte era essenzialmente unilaterale, senza risposta. Essa supererà questo periodo chiuso del suo primitivismo a favore di una comunicazione completa.
Poiché tutti diventeranno artisti ad uno stadio superiore, cioè in modo inseparabile produttori-consumatori di una creazione culturale totale, si assisterà alla rapida dissoluzione del criterio lineare di novità. Poiché tutti diventeranno, per così dire, situazionisti, si assisterà ad un’inflazione multidimensionale di tendenze, esperienze, di “scuole”, radicalmente differenti, e tutto questo non più successivamente ma simultaneamente. Inauguriamo ora quello che sarà, storicamente, l’ultimo dei mestieri. Il ruolo di situazionista, di dilettante-professionista, di anti-specialista è ancora una specializzazione fino a quel momento di abbondanza economica e mentale in cui tutti diventeranno «artisti», in un senso che gli artisti non hanno raggiunto: la costruzione della loro vita. Tuttavia, l’ultimo mestiere della storia è così vicino alla società senza divisione permanente del lavoro, che non gli si riconosce la qualifica di mestiere quando fa la sua apparizione nell’I.S. A quelli che non ci comprendessero bene, diciamo con un irriducibile disprezzo: “I situazionisti, di cui vi credete forse i giudici, vi giudicheranno un giorno o l’altro. Vi aspettiamo alla svolta, che è la liquidazione inevitabile del mondo della privazione, sotto tutte le forme. Questi sono i nostri fini, e saranno i fini futuri dell’umanità”.