Il viaggio e l’escursione nella letteratura e nella saggistica per ragazzi (di tutte le età …)
di Fabrizio Rinaldi e Paolo Repetto, 30 maggio 1997
 Gli itinerari suggeriti in questa rassegna sono frutto di scelte molto personali, in qualche modo arbitrarie, ma anche di un preciso intento: quello di proporre solo cose che in tempi diversi hanno alimentato e soddisfatto le nostre curiosità e la nostra passione. Sono indicazioni di lettura sul tema del viaggio, e segnatamente sul “camminare” e sullo stretto legame che intercorre tra il camminante e l’ambiente che lo circonda. Sono rivolti tanto ai fanciulli di ogni età, quelli anagrafici e quelli che hanno comunque conservati intatti il piacere di viaggiare con la fantasia – quando non possono fare altrimenti -, la curiosità genuina per gli altri e per l’altrove e soprattutto la capacità di sognare e di stupirsi in proprio.
Gli itinerari suggeriti in questa rassegna sono frutto di scelte molto personali, in qualche modo arbitrarie, ma anche di un preciso intento: quello di proporre solo cose che in tempi diversi hanno alimentato e soddisfatto le nostre curiosità e la nostra passione. Sono indicazioni di lettura sul tema del viaggio, e segnatamente sul “camminare” e sullo stretto legame che intercorre tra il camminante e l’ambiente che lo circonda. Sono rivolti tanto ai fanciulli di ogni età, quelli anagrafici e quelli che hanno comunque conservati intatti il piacere di viaggiare con la fantasia – quando non possono fare altrimenti -, la curiosità genuina per gli altri e per l’altrove e soprattutto la capacità di sognare e di stupirsi in proprio.
A questi Peter Pan (che sono – siamo – molti più di quanto non si creda) le prime rotte per l’isola che non c’è sono state tracciate da Verne e da Salgari, da Tommy River e da Corto Maltese: e queste rimangono ancora oggi rotte piacevolissime da percorrersi. Noi vorremmo suggerirne anche qualche altra, non meno affascinante. Solo per indicare la direzione, s’intende: tolte le ancore, ciascuno è poi capitano di se stesso.


Incanto di montagne maestose, di gole profonde come abissi, di picchi alti come campanili. Marco Polo, attonito, si imprime nel cuore quelle immagini e tanti anni dopo le ricorda lucidamente: “Vi dirò come sono queste montagne. Sono molto elevate sì che uno deve camminare da mattina a sera se vuol giungere al sommo. Ma, una volta arrivati, si trovano vasti pianori, dove abbondano erbe e le piante, dove le acque sorgive, copiose e purissime, si rovesciano come fiumi giù per dirupi”.
L’Autore ripercorre la storia delle esplorazioni con la competenza che gli è propria e che è frutto non solo di lungo studio e di profondo amore, ma anche di una concreta esperienza.
Dalla collaborazione dello studioso con l’esploratore è nata così un’opera ricchissima e complessa, che non si esaurisce in una esplorazione freddamente storica, ma diviene un racconto reso vivo e vibrante dall’elemento geografico sempre presente, da brani di diario, da aneddoti che meglio servono a inquadrare figure e avvenimenti, e da un continuo fervore di partecipazione umana alla grande avventura, mai esaurita e conclusa.
Largo spazio è stato dato in queste pagine agli esploratori italiani, che hanno lasciato orme gloriose sulla via di tutti i continenti, senza tuttavia sminuire il valore e l’importanza delle imprese compiute dai grandi esploratori stranieri.
Silvio Zavatti, Alla scoperta del mondo – Storia delle esplorazioni, Mursia 1972
 Humboldt sperimentò ampiamente sul suo corpo le difficoltà opposte dal fiume a tutti gli intrusi. La piaga delle zanzare, dei tafani, dei “piumes” e di altri insetti succhiatori di sangue era intollerabile perfino agli indiani; gli esploratori soffrivano per gli incessanti rovesci di pioggia e la fame li tormentava – il loro nutrimento consisteva in banane, manioca, acqua e talvolta un po’ di riso. […]
Humboldt sperimentò ampiamente sul suo corpo le difficoltà opposte dal fiume a tutti gli intrusi. La piaga delle zanzare, dei tafani, dei “piumes” e di altri insetti succhiatori di sangue era intollerabile perfino agli indiani; gli esploratori soffrivano per gli incessanti rovesci di pioggia e la fame li tormentava – il loro nutrimento consisteva in banane, manioca, acqua e talvolta un po’ di riso. […]
Nonostante tutto, Humboldt potè scrivere: “Sono penetrato nell’interno fino alle sorgenti dell’Orinoco … Di oltre cinquanta luoghi ho determinato la latitudine e la longitudine, ho osservato molte comparse e scomparse di pianeti e farò un’esatta carta di questo immenso paese, abitato da più di duecento popolazioni indiane, la maggior parte delle quali non ha veduto ancor mai un uomo bianco; esse parlano lingue diverse e posseggono culture diverse”.
Questo libro non è un’apologia di eroi.
Avrebbe potuto esserlo facilmente, perché ben di rado una così piccola schiera di uomini ha tanto contribuito alla trasformazione del mondo quanto i navigatori, i conquistatori e gli esploratori europei dell’epoca delle scoperte. Furono così arditi – o temerari – da spingersi sino ai confini del mondo ed oltre.
Questo libro tenta di descrivere gli avvenimenti come realmente si svolsero, con i loro moventi e atti grandiosi, vili o fortuiti, con la temerarietà, energia, mancanza di scrupoli, abilità e dedizione che resero possibile il successo, allargarono il mondo conosciuto e lo trasformarono.
Joachim G. Leithäusen, Il libro delle esplorazioni, Ed. Massimo 1963
 Sono andato con Sekeletu a vedere le cascate che qui chiamano “Chongué” o “Mosi-oa-Tunya”. Aventi minuti di navigazione da Calai si scorgono grandi colonne di vapore. Il panorama è stupendo. Mi sono fatto lasciare in un’isola situata quasi in mezzo al gorgo d’acqua e da lì ho goduto dello spettacolo: il fiume, largo un chilometro, diventa improvvisamente un’unica massa impetuosa che precipita lungo un abisso stretto appena venti metri. È il passaggio più avvincente che abbia mai contemplato in Africa. Ho dato a queste cascate il nome Vittoria. Dopo aver piantato nell’isola un centinaio di noccioli di pesca e di albicocca e una quarantina di chicchi di caffè, per dar vita a un giardino che un indigeno mi ha promesso di cingere con una siepe e di curare, ho inciso su un albero le mie iniziali e, sotto, la data: 1885.
Sono andato con Sekeletu a vedere le cascate che qui chiamano “Chongué” o “Mosi-oa-Tunya”. Aventi minuti di navigazione da Calai si scorgono grandi colonne di vapore. Il panorama è stupendo. Mi sono fatto lasciare in un’isola situata quasi in mezzo al gorgo d’acqua e da lì ho goduto dello spettacolo: il fiume, largo un chilometro, diventa improvvisamente un’unica massa impetuosa che precipita lungo un abisso stretto appena venti metri. È il passaggio più avvincente che abbia mai contemplato in Africa. Ho dato a queste cascate il nome Vittoria. Dopo aver piantato nell’isola un centinaio di noccioli di pesca e di albicocca e una quarantina di chicchi di caffè, per dar vita a un giardino che un indigeno mi ha promesso di cingere con una siepe e di curare, ho inciso su un albero le mie iniziali e, sotto, la data: 1885.
DAVID LIVINGSTONE
All’inizio dell’Ottocento il cuore dell’Africa era ancora una “terra incognita”. Burton, Speke, Baker, Stanley, Livingstone, Brazzà, Miani, Kingsley: con le loro spedizioni, in pochi decenni, sono state scoperte le sorgenti del Nilo, esplorati i bacini del Congo e dello Zambesi, conquistati i Monti della Luna.
L’avventura dei grandi esploratori ha rivelato all’Europa le straordinarie ricchezze del continente nero, alimentando le sue mire imperialistiche. Quando inizia il nuovo secolo, tutta l’Africa è ormai sottomessa alla dominazione coloniale.
Anne Hugon, L’Africa – esploratori nel continente nero, Electa/Gallimard 1994
 Marciamo sotto la pioggia, lungo il golfo, che forse ci offrirà qualche sorpresa. Esso, col prolungasi dentro terra, diventa sempre più enigmatico. È quasi impossibile vedere il chiaro specchio delle acque traverso le alte canne palustri delle rive. La speranza di saper qualche cosa sorge e svanisce ad ogni curva di questa landa di sabbia.
Marciamo sotto la pioggia, lungo il golfo, che forse ci offrirà qualche sorpresa. Esso, col prolungasi dentro terra, diventa sempre più enigmatico. È quasi impossibile vedere il chiaro specchio delle acque traverso le alte canne palustri delle rive. La speranza di saper qualche cosa sorge e svanisce ad ogni curva di questa landa di sabbia.
La seconda metà dell’Ottocento segna il culmine della penetrazione coloniale in Africa caratterizzata dalle grandi esplorazioni nell’interno della cosiddetta Africa nera. Il capitano Vittorio Bottego, partendo dalla Somalia, compie una serie di esplorazioni lungo il corso del Giuba, attraverso il deserto dell’Ogaden e, infine, alla ricerca delle misteriose sorgenti del fiume Omo nei territori del Kenia, del Sudan e dell’Etiopia. Di questa impresa viene tenuto un diario da parte di due membri della spedizione che riescono miracolosamente a trovare la via del ritorno mentre Bottego perisce.
Attraverso territori sconosciuti, che le carte geografiche di allora indicavano unicamente con una vasta macchia bianca, Bottego, i suoi compagni e la sua carovana procedono in mezzo a mille pericoli e insidie, aggrediti da tribù selvagge, tormentati dalla fame, stremati dalla sete, decimati dalle malattie, ma procedono fino alla meta.
L. Vannutelli – C. Citerni, Esploratori. Alla ricerca delle sorgenti del fiume Omo, Tasco 1987
 Sono passati circa duecento anni da quando Carlo Linneo, docente all’Università svedese di Uppsala, ebbe a notare con disappunto che, sebbene gli atti di eroismo compiuti dagli studiosi di botanica non fossero di alcun modo inferiori a quelli che avevano reso grandi “re, eroi e imperatori”, ad essi veniva negato un uguale riconoscimento di valore i immortalità. Sembra anche che aggiungesse, con la cupa seriosità tipica della sua razza: “Quale lavoro è più arduo, quale scienza più faticosa della botanica?”.
Sono passati circa duecento anni da quando Carlo Linneo, docente all’Università svedese di Uppsala, ebbe a notare con disappunto che, sebbene gli atti di eroismo compiuti dagli studiosi di botanica non fossero di alcun modo inferiori a quelli che avevano reso grandi “re, eroi e imperatori”, ad essi veniva negato un uguale riconoscimento di valore i immortalità. Sembra anche che aggiungesse, con la cupa seriosità tipica della sua razza: “Quale lavoro è più arduo, quale scienza più faticosa della botanica?”.
L’autore è riuscito a stipare in questo libro più di tre millenni di storia delle più avventurose spedizioni alla ricerca di piante e fiori sconosciuti. “Cacciatori di piante” disposti a tutto pur di raggiungere lo scopo di classificare, identificare esseri vegetali.
Tyler Whittle, I cacciatori di piante, Rizzoli 1980
 L’uomo che volge le spalle alle comodità di una civiltà più antica per affrontare la selvaggia giovinezza, la primordiale semplicità del Nord, potrebbe valutare la sua riuscita in ragione inversa alla quantità ed alla qualità delle sue abitudini incurabilmente consolidate. Scoprirà presto, se è la persona giusta, che le abitudini materiali sono le meno importanti. Il rinunciare a un menù raffinato per del cibo grossolano, a delle scarpe di cuoio rigido per dei mocassini morbidi e informi, ad un letto di piume per un giaciglio nella neve, è dopo tutto cosa abbastanza agevole. Ma avrà il suo da fare ad imparare in maniera adeguata a foggiare il proprio atteggiamento mentale verso tutte le cose, e in particolare verso gli altri uomini.
L’uomo che volge le spalle alle comodità di una civiltà più antica per affrontare la selvaggia giovinezza, la primordiale semplicità del Nord, potrebbe valutare la sua riuscita in ragione inversa alla quantità ed alla qualità delle sue abitudini incurabilmente consolidate. Scoprirà presto, se è la persona giusta, che le abitudini materiali sono le meno importanti. Il rinunciare a un menù raffinato per del cibo grossolano, a delle scarpe di cuoio rigido per dei mocassini morbidi e informi, ad un letto di piume per un giaciglio nella neve, è dopo tutto cosa abbastanza agevole. Ma avrà il suo da fare ad imparare in maniera adeguata a foggiare il proprio atteggiamento mentale verso tutte le cose, e in particolare verso gli altri uomini.
Fra l’estate del 1897 e l’autunno del ‘98 il ventiduenne Jack London visse la più grande avventura della sua vita, intraprendendo un lungo viaggio nel Grande Nord, al confine tra Canada e Alaska, raggiungendo le migliaia di disperati di ogni età e condizione partiti per la corsa all’oro nello Yukon. A quell’esperienza straordinaria sono ispirati questi racconti. Queste storie di sogni impossibili, di indiani, ragazzi, cercatori d’oro, uomini soli con se stessi nel momento della prova suprema, oltre la quale nulla può esistere, sono tra le più belle che London abbia mai scritto.
Jack London, I racconti del Grande Nord e della corsa all’oro, Newton 1992
 Dersu camminava in silenzio e guardava tutto con indifferenza. Io mi entusiasmavo del paesaggio, lui invece esaminava un ramo rotto all’altezza della mano di un uomo, e da come era stato piegato, capiva la direzione tenuta dall’uomo. Dalla rottura più o meno recente egli risaliva a quando il fatto era accaduto, indovinava il tipo di scarpe ecc. Ogni volta che io non capivo qualcosa o manifestavo qualche dubbio, mi diceva:
Dersu camminava in silenzio e guardava tutto con indifferenza. Io mi entusiasmavo del paesaggio, lui invece esaminava un ramo rotto all’altezza della mano di un uomo, e da come era stato piegato, capiva la direzione tenuta dall’uomo. Dalla rottura più o meno recente egli risaliva a quando il fatto era accaduto, indovinava il tipo di scarpe ecc. Ogni volta che io non capivo qualcosa o manifestavo qualche dubbio, mi diceva:
– Hm! Tu essere bambino. Così camminare, scuotere testa. Occhi avere, non vedere, non capire. Tu essere uomo che vivere in città. Non occorre cercare cervo; volere mangiare, comprare. Solo, tu non potere vivere su monti, morire presto.
Dersu Uzala è un diario di viaggio scritto dal capitano Arsen’ev, esploratore e geografo, durante una serie di viaggi nelle lontane e allora (siamo agli inizi del 1900) poco conosciute terre della Siberia.
Nella prima di queste spedizioni conosce e fa amicizia con uno strano personaggio, Dersu Uzala, un uomo senza casa, senza famiglia, che vive tutto l’anno nella tajga.
Si stabilisce subito una affettuosa amicizia fra Dersu e il capitano; quest’ultimo propone al cacciatore di accompagnarlo lungo il viaggio. Dersu accetta, non finendo mai di stupire Arsen’ev per la sua abilità e soprattutto per la sua umanità, facendogli da maestro e da guida.
Fa da sfondo alle varie avventure la natura, selvaggia e pericolosa, ma tuttavia ricca di fascino, di bellezza, ed insieme il fascino dell’uomo che lotta con essa.
Vladimir K. Arsen’ev, Dersu Uzala – Il piccolo uomo delle grandi pianure, Mursia 1984
 Avrebbe fatto un viaggio! Per me, che non mi ero mai allontanato da casa, la parola “viaggio” era quanto di più allettante si potesse immaginare. Presto si sarebbe trovato a centinaia di miglia da me, in mezzo a praterie e deserti sconfinati, e sulle montagne del Far West! Avrebbe visto i bisonti e gli indiani, e i cani della prateria, e le antilopi, e chissà quante avventure gli sarebbero capitate: lo avrebbero impiccato, magari, o scotennato, si sarebbe divertito un mondo e ce lo avrebbe scritto e sarebbe diventato un eroe.
Avrebbe fatto un viaggio! Per me, che non mi ero mai allontanato da casa, la parola “viaggio” era quanto di più allettante si potesse immaginare. Presto si sarebbe trovato a centinaia di miglia da me, in mezzo a praterie e deserti sconfinati, e sulle montagne del Far West! Avrebbe visto i bisonti e gli indiani, e i cani della prateria, e le antilopi, e chissà quante avventure gli sarebbero capitate: lo avrebbero impiccato, magari, o scotennato, si sarebbe divertito un mondo e ce lo avrebbe scritto e sarebbe diventato un eroe.
Nel 1861 Mark Twain parte per il Far West al seguito del fratello Orion, nominato Segretario del Territorio del Nevada. Dopo ventun giorni di diligenza, in mezzo a paesaggi stupefacenti popolati di pistoleri, mormoni, pony express, indiani ante-beatificazione e resti di carovane, diventa milionario per una settimana e approda infine, per fame, a quelle corrispondenze per i giornali che gli daranno la celebrità. Questa è, in grezza telegrafia da terre di frontiere, la materia di In cerca di guai. Come sempre candido e scaltro, trascinante umorista e infiammato fustigatore, Mark Twain irride ogni cosa, dal governo centrale ai coyote, e ci offre una sequenza di settantanove capitoli che sono ciascuno un piccolo romanzo, con la prodigalità di un giocatore di roulette che per la prima volta è uscito dalla bisca senza farsi ripulire. Ogni capitolo è una chiacchierata intorno al fuoco – e la somma di queste chiacchiere è un’epopea. Twain ride per sopravvivere, e far sopravvivere, in mezzo agli orrori e allo splendore del West. E alla fine ci consegna uno di quei rari libri che divertono in qualsiasi punto li si apra – e dove ancora circola, pungente, il profumo selvatico dell’America.
Mark Twain, In cerca di guai, Adelphi 1993
 Era un mattino di ottobre. Ero andato a Córdoba approfittando delle vacanze del 17. Sotto il pergolato della casa di Alberto Granado bevevamo mate zuccherato commentando tutte le ultime traversie della “porca vita”, e intanto ci dedicavamo alla manutenzione della Poderosa II. […] Sui sentieri dell’immaginazione arrivammo a remoti paesi, navigando per mari tropicali e visitammo tutta l’Asia. E all’improvviso, materializzata dai nostri sogni, sorse la domanda: e se ce andassimo in Nordamerica?
Era un mattino di ottobre. Ero andato a Córdoba approfittando delle vacanze del 17. Sotto il pergolato della casa di Alberto Granado bevevamo mate zuccherato commentando tutte le ultime traversie della “porca vita”, e intanto ci dedicavamo alla manutenzione della Poderosa II. […] Sui sentieri dell’immaginazione arrivammo a remoti paesi, navigando per mari tropicali e visitammo tutta l’Asia. E all’improvviso, materializzata dai nostri sogni, sorse la domanda: e se ce andassimo in Nordamerica?
“In Nordamerica? E come?”
“Con la Poderosa, che diamine!”
Così venne deciso il viaggio, che in ogni momento si sarebbe attenuto alla linea generale su cui era stato progettato: l’improvvisazione. […] Ogni altro problema che non riguardasse la nostra impresa ci sfuggiva in quel momento, vedevamo solo la polvere della strada e noi sulla moto a divorare chilometri nella fuga verso Nord.
La vita di Ernesto Che Guevara e la sua esperienza politico-rivoluzionaria sono note a tutti. Meno nota, forse, è la sua giovinezza, di cui, qui, presentiamo un fondamentale capitolo.
Il diario del Che è il resoconto dettagliato di migliaia di chilometri, dall’Argentina al Venezuela, del viaggio in moto compiuto con il suo amico e compagno di studi Alberto Granado. Avventure e emozioni inframmezzate da infinite riflessioni sui mille aspetti dell’America, la miseria degli indios, l’emozione di vedere l’oceano … e dai suoi ventitré anni, con la voglia di organizzare uno scherzo, innamorarsi e corteggiare le ragazze, mentre la moto perde pezzi per strada, provocando cadute tragicomiche.
Il diario di Alberto Granado – una collezione di aneddoti e situazioni divertenti descritti con la felicità di chi fa un viaggio sognato sin dalla più giovane età – è una testimonianza ulteriore sull’amico Ernesto: generoso, intelligente, corsaro, poco loquace, tormentato dall’asma eppure sempre entusiasta, in cerca dell’avventura e infiammato da quel desiderio di vivere e di conoscere che lo accompagnerà per tutta la sua breve esistenza.
Ernesto Che Guevara – Alberto Granado, Latinoamericana, Feltrinelli 1993
 Capii quella volta che Mij significava per me assai più della maggior parte degli esseri umani di mia conoscenza, che avrei sofferto per la perdita della sua presenza fisica molto di più che per la loro, e non me ne vergognavo affatto.
Capii quella volta che Mij significava per me assai più della maggior parte degli esseri umani di mia conoscenza, che avrei sofferto per la perdita della sua presenza fisica molto di più che per la loro, e non me ne vergognavo affatto.
Stanco di dare la caccia ai pescecani al largo delle isole Ebridi, Maxwell riceve una insolita offerta: una vecchia casa disabitata, un tempo a guardia di un faro, nelle West Highlands: Camusfeàrna, la Baia degli ontani. Il suo desiderio di un rapporto diretto con la natura, non stravolto dalla “civiltà” urbana si realizzerà pienamente in questo angolo della Scozia. In questo mondo di scogli e di mare, persone, cose e animali parlano con lui – e col lettore di queste pagine percorse da una profonda sensibilità e da una sottile ironia – il linguaggio del rispetto reciproco, ignorando le sopraffazioni meschine di cui vive la società d’oggi.
Durante un viaggio in Iraq, presso i semisconosciuti arabi delle paludi, Maxwell acquista un irresistibile cucciolo di lontra – di una specie, fra l’altro, ancora ignota alla scienza. Da allora la sua esistenza muterà completamente per modellarsi su quella della sua lontra, e delle altre che la seguiranno. E questi animali giocherelloni e imprevedibili, affettuosi e selvaggi sono i veri protagonisti del libro.
Gavin Maxwell, L’anello di acque lucenti, Rizzoli 1980
 In uno slargo di bosco si sedette sotto un grosso abete bianco, riaccese la sua pipa e serenamente aspettò che ritornassero giù i cacciatori dalla montagna perché gli raccontassero. Nel frattempo ascoltava il bosco.
In uno slargo di bosco si sedette sotto un grosso abete bianco, riaccese la sua pipa e serenamente aspettò che ritornassero giù i cacciatori dalla montagna perché gli raccontassero. Nel frattempo ascoltava il bosco.
È il mondo di Rigoni Stern, i suoi inverni, con i segni rossi sulla neve del lepre ferito, le sue primavere, con le coturnici che cantano, e i prati che si riempiono del giallo del tarassaco e di sciami di api e la sua gente.
Mario Rigoni Stern, Uomini, boschi e api, Einaudi 1980

Era una sera di maggio del 1945, come questa. I due alberi c’erano ancora, e c’era la strada dove aveva tanto giocato, c’erano la corte con il cancello e i gradini di pietra; c’era ancora il colore verde che aveva dato al cancello prima di partire […], sulla porta c’era anche la sedia dove il nonno fumava la pipa guardando i rondoni e la maniglia d’ottone che la madre lucidava con farina gialla e aceto.
Sentì chiamare, gridare, piangere tanta gente attorno a lui. Nella camera c’erano sempre i tre letti di ferro dove aveva dormito con i fratelli. Il suo posto vicino al muro, le lenzuola con su ricamate le iniziali della nonna, i cuscini di piuma con le fodere rosse. Non dormì, ascoltò la casa tutta la notte finché le rondini incominciarono a cantare sotto il portico. In tanti anni non le aveva mai sentite.
Partiva al mattino e ritornava alla sera, girava tutto il giorno per i boschi come avesse da cercare qualcosa, così per tanti giorni. Finché una sera il vecchio zio curvo e bianco lo invitò a vangare l’orto. Quando ebbero finito disse il vecchio: – Domani dobbiamo zappare le patate.
Il bosco degli urogalli raccoglie storie di cacciatori, di animali selvatici, di cani, di montagne, in cui si respira un senso di spazi aperti, di paesaggi impervi, e soprattutto una calda presenza umana. Rigoni sa rendere la limpida immediatezza delle cose e delle giornate, e insieme ad essa un accento di virile fiducia nella vita. Queste pagine confermano “il dono della semplicità e di poesia che gli è proprio – ha scritto Geno Pampaloni -. Ritroviamo l’accento del sergente Rigoni là dove si narrano storie di caccia, il silenzio del bosco, i villaggi chiusi nell’inverno e il grato fuoco delle cucine e la limpida solitudine delle albe per i sentieri di montagna: quel paesaggio fraterno e familiare e forte come una presenza morale, la cui immagine antica e gentile egli ritrovava tra i contadini di Russia, nelle povere isbe coperte di neve”.
Mario Rigoni Stern, Il bosco degli urogalli, Einaudi 1981
 Il cacciatore d’immagini
Il cacciatore d’immagini
Salta dal letto di buon mattino, e parte soltanto se il suo spirito è chiaro, il suo cuore puro, il suo corpo leggero come un vestito d’estate. Non porta con sé alcuna provvista. Berrà l’aria fresca per la via, e respirerà gli odori salubri. Lascia a casa le armi e s’accontenta di aprire gli occhi. Gli occhi servono da reti, dove le immagini s’imprigionano da sé.
Coglie l’immagine dei grani ondeggianti, delle erbe mediche appetitose e dei prati orlati di ruscelli. Coglie al passaggio il volo d’un’allodola o d’un cardellino.
L’anitra immobile nello stagno, il salto di un pesce a pancia in su, una tacchina tronfia delle sue piume, cigni e farfalle, lucertole e lepri: questi e altri animali sono le “prede” di un singolare cacciatore d’immagini: lo scrittore francese Jules Renard.
Appassionato osservatore della natura quotidiana, in queste sue “Storie naturali” Renard raduna in uno zoo colorato e domestico gli animali incontrati durante le sue passeggiate tra cascine e aie, viottoli e stagni. Ne nasce un “album” unico: “le sue immagini – come osserva Italo Calvino nella sua presentazione – sono fantasiose ma sempre con un tono secco ed esatto: non c’è mai zucchero; alle volte un po’ d’amaro”.
Jules Renard, Storie naturali, Einaudi 1977
 Nell’antichità solo gli alberi degni di nota e indicati da un segno sovrannaturale diventavano oggetto di un culto, ma non per questo tutti gli altri non possedevano ognuno un’anima corrispondente alla sua particolare specie. A volte si trattava di un essere semidivino di cui la specie portava il nome e che si presumeva averle dato vita; il più delle volte era una ninfa che aveva subito una metamorfosi.
Nell’antichità solo gli alberi degni di nota e indicati da un segno sovrannaturale diventavano oggetto di un culto, ma non per questo tutti gli altri non possedevano ognuno un’anima corrispondente alla sua particolare specie. A volte si trattava di un essere semidivino di cui la specie portava il nome e che si presumeva averle dato vita; il più delle volte era una ninfa che aveva subito una metamorfosi.
Di questi tempi si parla con insistenza sempre crescente della distruzione dei boschi e delle foreste del pianeta e dei suoi effetti a lungo termine sull’insieme degli esseri viventi. Ma troppo spesso si dimentica che con gli alberi scompare anche un prezioso patrimonio dell’umanità. Perché è esistita un’epoca in cui le piante venivano considerate la manifestazione più immediata e concreta della divinità. Alle piante gli uomini si rivolgevano per chiedere protezione e conforto. Intorno ad esse fiorivano miti straordinari che toccavano i cuori e rasserenavano gli animi. E a ciascuna specie, a ogni albero venivano attribuite caratteristiche particolari, perché in ciascuno di essi il mistero della natura e quello del divino trovavano un diverso equilibrio.
Jacques Brosse ha ricostruito questo mondo perduto, raccogliendo racconti e tradizioni dall’immenso serbatoio delle mitologie egizia, semitica, cretese, indiana, greca, latina, germanica, celtica. Quella così compilata è dunque in primo luogo una piccola ma esauriente enciclopedia dei miti legati alle diverse specie: quercia, pino, frassino, betulla, noce, cipresso, fico, ulivo, melo, vite …
Jacques Brosse, Mitologia degli alberi, Rizzoli 1991
 A poco a poco la magia dell’isola ci avvolse gentile e persistente come un polline. Ogni giorno portava con sé una tale tranquillità, una tale durata fuori del tempo da far desiderare che non finisse mai. Ma poi la pelle scura della notte si sbucciava ed ecco un nuovo giorno davanti a noi, lustro e colorato come una decalcomania, e con lo stesso tocco di realtà.
A poco a poco la magia dell’isola ci avvolse gentile e persistente come un polline. Ogni giorno portava con sé una tale tranquillità, una tale durata fuori del tempo da far desiderare che non finisse mai. Ma poi la pelle scura della notte si sbucciava ed ecco un nuovo giorno davanti a noi, lustro e colorato come una decalcomania, e con lo stesso tocco di realtà.
“Questa è la storia dei cinque anni che ho trascorso da ragazzo, con la mia famiglia, nell’isola greca di Corfù. In origine doveva essere un resoconto blandamente nostalgico della storia naturale dell’isola, ma ho commesso il grave errore di infilare la mia famiglia nel primo capitolo del libro. Non appena si sono trovati sulla pagina non ne hanno più voluto sapere di levarsi di torno, e hanno persino invitato i vari amici a dividere i capitoli con loro”: così Gerald Durrell presenta questo libro, uno dei più universalmente amati che siano apparsi in Inghilterra negli ultimi trent’anni. Ma il lettore avrà il piacere di scoprirvi anche qualcos’altro: la storia di un Paradiso Terrestre, e di un ragazzo che vi scorrazza instancabilmente, curioso di scoprire la vita (che per lui, futuro illustre zoologo, è soprattutto la natura e gli animali), passando anche attraverso avventure, tensioni, turbamenti, tutti però stemperati in una atmosfera di tale felicità che il lettore ne viene fin dalle prime pagine contagiato.
Gerard Durrell, La mia famiglia e altri animali, Adelphi 1991
 Dopo un attimo, sollevando lo sguardo, mi pose a sua volte un interrogativo non facile. Mi disse che capiva come mai GS, essendo un biologo, avesse deciso di percorrere centinaia di chilometri in alta montagna per raccogliere sull’altipiano del Tibet informazioni scientifiche. Ma perché mai ci andavo anch’io? Che cosa speravo di trovare? […]
Dopo un attimo, sollevando lo sguardo, mi pose a sua volte un interrogativo non facile. Mi disse che capiva come mai GS, essendo un biologo, avesse deciso di percorrere centinaia di chilometri in alta montagna per raccogliere sull’altipiano del Tibet informazioni scientifiche. Ma perché mai ci andavo anch’io? Che cosa speravo di trovare? […]
Come avrei potuto dirgli che speravo di penetrare i segreti della montagna sulle tracce di qualcosa che tuttora ignoravo e che, come lo yeti, continuava a non essere visto proprio perché era l’oggetto di una ricerca?
Il leopardo delle nevi, il più bello e il più raro dei felini, vive sull’Himalaya ad altezze inaccessibili, non scende mai a valle e la sua stessa esistenza è avvolta in un alone di leggenda. È nella speranza di vederlo che Matthiessen ha compiuto due spedizioni scientifiche nella zona. Egli, colpito da questa figura apparentemente più simbolica che reale, si è addentrato nei misteri della spiritualità tibetana.
Peter Mathiessen, Il leopardo delle nevi, Frassinelli 1993
 Ma la storia della vita, per come la interpreto io, è costituita da una serie di dati stabili, punteggiati a intervalli da grandi eventi che avvengono con una grande rapidità e servono a realizzare il successivo periodo di stabilità.
Ma la storia della vita, per come la interpreto io, è costituita da una serie di dati stabili, punteggiati a intervalli da grandi eventi che avvengono con una grande rapidità e servono a realizzare il successivo periodo di stabilità.
La natura fa salti, eccome. Il più brillante dei paleontologi ci prende per mano lungo i sentieri e le svolte dell’evoluzione. Si parla dell’intelligenza dei dinosauri, dell’uomo fossile, di Topolino …
Stephen Jay Gould, Il pollice del panda – Riflessioni sulla storia naturale, Ed. Riuniti 1993
 È quindi ora, al ritorno, che comincerà la loro vera escursione, poiché la fantasia sarà, d’ora in poi, la loro guida ed essi viaggeranno nei loro ricordi.
È quindi ora, al ritorno, che comincerà la loro vera escursione, poiché la fantasia sarà, d’ora in poi, la loro guida ed essi viaggeranno nei loro ricordi.
Nel 1859 Jules Verne ha trentuno anni e sogna di viaggiare. Gli viene offerta l’occasione di visitare, insieme ad un amico, l’Inghilterra e la Scozia. Partiti da Nantes per sbarcare a Liverpool, sono costretti a passare per Bordeaux, da cui il viaggio “a ritroso”.
Jules Verne, Viaggio (a ritroso) in Inghilterra e Scozia, Biblioteca del Vascello 1990
 Le armi con cui abbiamo conseguito le vittorie più gloriose, quelle che dovrebbero venir trasmesse in eredità di padre in figlio, non sono la spada e la lancia, ma l’accetta, la falce, la vanga e la zappa, arrugginite dal sangue di infinite praterie, e annerite dalla polvere di infiniti campi che solo con la dura lotta poterono coltivare.
Le armi con cui abbiamo conseguito le vittorie più gloriose, quelle che dovrebbero venir trasmesse in eredità di padre in figlio, non sono la spada e la lancia, ma l’accetta, la falce, la vanga e la zappa, arrugginite dal sangue di infinite praterie, e annerite dalla polvere di infiniti campi che solo con la dura lotta poterono coltivare.
Camminare è il testo di una conferenza tenuta da Henry David Thoreau per la prima volta al Concord Lyceum il 23 aprile 1851; ben presto diventa il suo testo più noto e preferito e lo legge più volte, negli anni successivi, ampliandolo progressivamente. In esso, centrale è il simbolismo legato all’escursione come modello di vita: il quotidiano vagabondare nella natura costituisce una sorta di strategia di sopravvivenza sia reale che simbolica e l’anelito al movimento è nella sua essenza desiderio di liberazione dall’ansia e dal malessere avvertiti nel mondo.
Thoreau si fa così portavoce di un paradosso: il successo, l’assillante corsa al potere e alle prosperità materiali possono essere l’amara ricompensa di una sconfitta, mentre la vita in solitudine e in oscurità può offrire doni preziosi e insospettati.
Henry David Thoreau, Camminare, Mondadori 1991
 Mi ero ritirato qui, nel grande oceano della solitudine nel quale si vuotano i fiumi della società, ed ero tanto tanto lontano che, per la maggior parte – per ciò che riguardava le mie necessità – solo il sentimento più fine si depositava intorno a me.
Mi ero ritirato qui, nel grande oceano della solitudine nel quale si vuotano i fiumi della società, ed ero tanto tanto lontano che, per la maggior parte – per ciò che riguardava le mie necessità – solo il sentimento più fine si depositava intorno a me.
Testimonianza di una scelta di vita compiuta al di fuori di ogni schema, Walden è l’affascinante resoconto, redatto in uno stile che sta tra il saggio e il diario, dei due anni di soggiorno solitario che Thoreau trascorse in una foresta del New England. Da quest’opera – la più famosa fra quelle composte dallo scrittore americano – continuano ancor oggi a tratte ispirazione i pacifisti di ogni tendenza, i cultori d’ogni sorta di anticonformismo, gli alfieri dell’ecologia, della resistenza passiva, della disobbedienza civile, della non violenza.
Henry David Thoreau, Walden o Vita nei boschi, BIT 1995
 Nella tradizione fiabesca la Montagna è il legame fra la Terra e il Cielo. La sua cima unica tocca il mondo dell’eternità e la sua base si ramifica in molteplici contrafforti nel mondo dei mortali. È la via per la quale l’uomo può elevarsi alla divinità e la divinità rivelarsi all’uomo.
Nella tradizione fiabesca la Montagna è il legame fra la Terra e il Cielo. La sua cima unica tocca il mondo dell’eternità e la sua base si ramifica in molteplici contrafforti nel mondo dei mortali. È la via per la quale l’uomo può elevarsi alla divinità e la divinità rivelarsi all’uomo.
Un gruppo di singolari ed esperti alpinisti, certi dell’esistenza, in qualche parte del globo, di una montagna la cui vetta è più alta di tutte le vette, decide un giorno di partire da Parigi per tentare di scoprirla e di darne la scalata. Dopo una navigazione “non euclidea”, a bordo di un’imbarcazione chiamata l’Impossibile, gli esploratori approdano nell’isola-continente del Monte Analogo, dove trovano una popolazione, dagli usi apparentemente stravaganti, che discende da uomini di tutti i tempi e che, come loro, vive ormai, soltanto, nella speranza di scalare la vetta. Un breve soggiorno nel villaggio di Porto-delle-Scimmie, e il gruppo dei nostri alpinisti intraprende l’ascensione, arrivando in vista del campo base. A questo punto il racconto si interrompe: siamo soltanto all’inizio di un viaggio – che forse è sempre, continuamente, all’inizio – quando la morte coglie René Daumal, l’autore di questa storia, impedendogli di descrivere il seguito della scalata del monte simbolico che unisce la Terra e il Cielo.
René Daumal, Il Monte Analogo, Adelphi 1977
 Talvolta, seduto sulla cima del grande, solitario colle che dà nome alla città, fissavo per ore l’ampio paesaggio dell’entroterra, come se potessi distinguere, senza mai stancarmene, tutto quanto si stendeva davanti ai miei occhi: le pianure, i fiumi, i boschi, le colline, le capanne dove mi ero fermato, e più di un amabile volto umano. Anche i visi che mi avevano maltrattato o guardato con occhio malevolo mi apparivano ora sotto un aspetto bonario. Ma soprattutto pensavo al mio caro fiume, l’indimenticabile Yí, alla bianca casa ombrosa al margine della piccola città […].
Talvolta, seduto sulla cima del grande, solitario colle che dà nome alla città, fissavo per ore l’ampio paesaggio dell’entroterra, come se potessi distinguere, senza mai stancarmene, tutto quanto si stendeva davanti ai miei occhi: le pianure, i fiumi, i boschi, le colline, le capanne dove mi ero fermato, e più di un amabile volto umano. Anche i visi che mi avevano maltrattato o guardato con occhio malevolo mi apparivano ora sotto un aspetto bonario. Ma soprattutto pensavo al mio caro fiume, l’indimenticabile Yí, alla bianca casa ombrosa al margine della piccola città […].
La misteriosa pampa argentina è la terra di porpora: gli anni sono quelli della metà del secolo scorso all’incirca. La guerra civile fermata: la vivono uomini indolenti e selvaggi. Fra essi si muove, pellegrino a cavallo, un bel giovane inglese, Richard Lamb.
L’autore è un inglese che viaggiò per le solitarie praterie della Plata, della Banda Orientale e della Patagonia: era un naturalista, e i suoi viaggi ebbero pretesti scientifici.
William Henry Hudson, La terra di porpora, Rizzoli 1975
 Io, bambino di appena sei anni ma già capace di andar di galoppo e senza cadere su un cavallo non sellato, invito il lettore, anche lui in groppa a un cavallo – sia pure immaginario – ad allontanarsi con me dalla casa per raggiungere, a una lega circa di distanza, qualche posto che sovrasti un poco la pianura circostante. Là giunti, seduti sui nostri cavalli, potremo dominare un orizzonte più vasto di quello che contemplerebbe anche l’uomo più alto standocene semplicemente in piedi […].
Io, bambino di appena sei anni ma già capace di andar di galoppo e senza cadere su un cavallo non sellato, invito il lettore, anche lui in groppa a un cavallo – sia pure immaginario – ad allontanarsi con me dalla casa per raggiungere, a una lega circa di distanza, qualche posto che sovrasti un poco la pianura circostante. Là giunti, seduti sui nostri cavalli, potremo dominare un orizzonte più vasto di quello che contemplerebbe anche l’uomo più alto standocene semplicemente in piedi […].
Un mondo lontano dipinge l’infanzia e l’adolescenza di Hudson nella pampa argentina, luogo di appassionati e gioiosi incontri con innumerevoli esseri viventi – uccelli, serpenti, piante, fiori – con i quali il protagonista dialoga, felice di scoprire ogni volta una nuova manifestazione di vita. Avventurieri, mendicanti, guerrieri, allevatori di cavalli, donne pallide e misteriose, gente perduta, adulti e coetanei appaiono e scompaiono dopo avere ogni volta manifestato al giovane protagonista un qualche aspetto della vita: l’amore, l’amicizia, la gelosia, l’odio, il sopruso, la delusione, il dolore, la morte.
William H. Hudson, Un mondo lontano, Adelphi 1993
 In una parola, la natura si è mostrata con lei – quasi come coll’uomo – ingiusta, malevola, ironica, fantastica, illogica o perfida. Ma come l’uomo e – almeno fino ad oggi – qualche volta meglio di lui essa a saputo trar partito dall’unico vantaggio che una matrigna obliosa, curiosa o semplicemente indifferente a voluto lasciarle: una piccola forza che non si vede, che, in lei, chiamiamo istinto e, in noi, chi sa perché, intelligenza.
In una parola, la natura si è mostrata con lei – quasi come coll’uomo – ingiusta, malevola, ironica, fantastica, illogica o perfida. Ma come l’uomo e – almeno fino ad oggi – qualche volta meglio di lui essa a saputo trar partito dall’unico vantaggio che una matrigna obliosa, curiosa o semplicemente indifferente a voluto lasciarle: una piccola forza che non si vede, che, in lei, chiamiamo istinto e, in noi, chi sa perché, intelligenza.
Nel 1901 Maesterlinck scrive La vita delle api. La vita delle termiti è del 1926. Nei venticinque anni che corrono tra le due opere l’atteggiamento nei confronti della vita del poeta belga è profondamente mutato: “questo libro” scrive l’autore “ potrà essere accostato a La vita delle api: ma il colore e l’ambiente non sono gli stessi. È, in un certo senso, il giorno e la notte, l’alba e il crepuscolo, il cielo e l’inferno. Da un lato … tutto è luce, primavera, estate, sole, profumi, spazio, ali, azzurro, rugiada e felicità senza uguale tra le allegrezze della terra: dall’altro, tutto è tenebre, oppressione sotterranea, asprezza, avarizia sordida e grossolana, atmosfera di carcere, di ergastolo, di sepolcro …”.
Maurice Maeterlinck, La vita delle termiti, Rizzoli 1980
 L’acqua sommergeva il ponte delle nostre zattere, ed era bellissimo essere di nuovo liberi, fendere le acque in tumulto, udire i tonfi delle nostre prue contro i grandi fogli si schiuma, e sentirci tutti, io, Jorge e i quattro indios, bagnati da capo a piedi.
L’acqua sommergeva il ponte delle nostre zattere, ed era bellissimo essere di nuovo liberi, fendere le acque in tumulto, udire i tonfi delle nostre prue contro i grandi fogli si schiuma, e sentirci tutti, io, Jorge e i quattro indios, bagnati da capo a piedi.
A est delle Ande peruviane giace il Gran Pajonal, una sconfinata landa soffocata dalla giungla e solcata da una rete fittissima di fiumi. Leonard Clark è convinto che lì si nascondano le leggendarie Sette Città, di quel mitico El Dorado che sin dal XVI secolo gli esploratori cercarono invano.
Con un solo compagno, Clark si addentra nell’inferno verde e, dopo incredibili avventure, arriva finalmente alle città sepolte nella giungla, i cui avanzi testimoniano drammaticamente la dominazione spagnola.
Leonard Clark, I fiumi scendevano a Oriente, Vallardi 1985
“ Non conviene sapere la storia del detestabile verme per fargli guerra vantaggiosamente e sbarazzare il giardino da questa genìa?”
Non conviene sapere la storia del detestabile verme per fargli guerra vantaggiosamente e sbarazzare il giardino da questa genìa?”
Tutti furono del parere giudizioso dello zio. Invece di schiacciare scioccamente la bestia, era molto meglio esaminarla, anzitutto per sapere come è fatta, come vive e come s’introduce nel legno. Così si potrebbero, più tardi o arrestare i suoi guasti. Un nemico di cui si conoscono i mezzi d’azione è semivinto. Paolo prese dunque il bruco e lo mise nel cavo della sua mano.
C’è in questi dialoghi dello zio Paolo con i nipoti la semplice grazia degli antichi sillabari naturalistici, come pochi hanno saputo scrivere. C’è grazia e c’è fantasia: il libro comincia con una notte di vento, un lillà spezzato e delle lacrime, e di qui passa la descrizione della metamorfosi degli insetti, compie un continuo cammino a ritroso: dal segno, dalla traccia lasciata dall’insetto che i bambini trovano nel giardino, all’insetto che i bambini trovano nel giardino, all’insetto stesso, che viene cercato, scovato, cacciato e infine descritto, con una narrazione sempre chiara e limpida, con i suoi momenti di invenzione, come quando l’autore per spiegare la moltiplicazione degli afidi, e la progressione algebrica, narra la storia del dervis e del chicco di grano, e come nell’episodio del maggiolino, che da occasione per i giochi dei ragazzi nel racconto dello zio Paolo assurge alle dimensioni mitiche di un calamitoso flagello.
J. Henri Fabre, I devastatori, Rizzoli 1984
 E ho anche iniziato a considerare le praterie, poco distanti dalla città in cui sono nato, la mia terra natale, e ho cominciato ad amarle non perché attirano l’attenzione come i monti o la costa, ma perché la respingono sfidando la capacità di mantenerla sveglia. […]
E ho anche iniziato a considerare le praterie, poco distanti dalla città in cui sono nato, la mia terra natale, e ho cominciato ad amarle non perché attirano l’attenzione come i monti o la costa, ma perché la respingono sfidando la capacità di mantenerla sveglia. […]
Qui sembra che l’aria non sia ancora mai stata usata.
Questo libro afferma con forza che oggi, nell’era in cui la televisione trasmette in diretta dagli angoli più remoti del mondo per spettatori che non abbandonano mai la poltrona, è ancora possibile viaggiare. Non solo, è possibile viaggiare con la curiosità dei grandi esploratori, con la loro ingenuità, con la stessa sete di scoperte, e quella speciale scrupolosità nello sguardo.
In Prateria l’autore concentra la sua attenzione su una piccola contea del Kansas, la Chase County, lavorando in profondità, quasi come un archeologo, sulle infinite stratificazioni naturali e storiche che sfuggono all’occhio del turista frettoloso. La scelta del Kansas non è casuale: è un luogo apparentemente desolato e monotono che “sfida la capacità di mantenere sveglia l’attenzione”, ideale per studiare “la terra e ciò che la plasma”. L’intento è scoprire il carattere originario di questa terra, iniziando col descrivere l’erba bluestem (alta più di tre metri), parlando poi dell’importanza degli incendi per la rigenerazione della terra, e raccontando le alluvioni, il vento, la furia dei tornado, e rileggendo i racconti dei primi coloni, seguendo le tracce degli indiani Kaw, facendo parlare allevatori e agricoltori, e coltivando il sogno di un grande parco nazionale della prateria. Canto d’amore per la natura che, non solo in America, rischia di scomparire, Prateria è una grande “carta topografica di parole”, lo scenario di un’avventura che l’uomo può ancora vivere.
William Least Heat-Moon, Prateria, Einaudi 1994
 Per assolvere il compito di una passeggiata all’aperto non è necessario andare da soli, ma è ben possibile camminare accanto ad un compagno a noi concorde, insieme presi in un tranquillo colloquiare su temi generali della realtà umana, della letteratura, o su alcuni aspetti naturali che ci si offrano durante il percorso, senza che tutto ciò attenui in alcun modo gli effetti della natura sul nostro animo. Ma si deve pur dire che sarà bene, di tanto in tanto, passeggiare da solo, per colui il quale non desideri unicamente registrare impressioni esteriori, ma molto più percepisca l’incoercibile impulso di abbandonarsi al proprio genio e vivere solo con se stesso.
Per assolvere il compito di una passeggiata all’aperto non è necessario andare da soli, ma è ben possibile camminare accanto ad un compagno a noi concorde, insieme presi in un tranquillo colloquiare su temi generali della realtà umana, della letteratura, o su alcuni aspetti naturali che ci si offrano durante il percorso, senza che tutto ciò attenui in alcun modo gli effetti della natura sul nostro animo. Ma si deve pur dire che sarà bene, di tanto in tanto, passeggiare da solo, per colui il quale non desideri unicamente registrare impressioni esteriori, ma molto più percepisca l’incoercibile impulso di abbandonarsi al proprio genio e vivere solo con se stesso.
Il campo risveglia alla vista l’idea di una sollecita creatività umana e della conseguente speranza di un futuro più o meno prossimo. Alla vista di un prato si ottiene, attraverso quella sua calma uniformità, il senso di una tranquilla imperturbabile e ferma contentezza. Un bosco sembra accoglierci nelle sue sacre ombre, perché noi vi si possa soggiornare lontano dai turbamenti dell’animo e della natura.
La passeggiata è attività che avvia il corpo ad un silenzioso collaborare con l’anima in quel momento seria e meditabonda. Il corpo, in attività ma senza disturbare, crea lo spazio, tutto mentale, per il dispiegarsi della catena del pensiero.
L’arte di andare a passeggio è un’istruzione gioiosa, con divagazioni e colti riferimenti, su come ben condursi e proficuamente nella passeggiata, fragile esercizio etico-estetico.
Karl Gottlob Schelle, L’arte di andare a passeggio, Sellerio 1993
 Inizio d’estate, primissime ore del mattino: nel profondo delle Alpi, al punto di congiunzione fra due valli, su sedie verdi di metallo, davanti a un caffè ancora addormentato, sono sedute due figure che l’abbigliamento e l’attrezzatura rendono facilmente riconoscibili come alpinisti (spessi abiti di lana e cappelli di feltro, sacchi da montagna, uno dei quali con la fune arrotolata sopra, lunghe piccozze e pesanti scarpe chiodate: la vicenda si svolge in uno dei primi decenni del secolo).
Inizio d’estate, primissime ore del mattino: nel profondo delle Alpi, al punto di congiunzione fra due valli, su sedie verdi di metallo, davanti a un caffè ancora addormentato, sono sedute due figure che l’abbigliamento e l’attrezzatura rendono facilmente riconoscibili come alpinisti (spessi abiti di lana e cappelli di feltro, sacchi da montagna, uno dei quali con la fune arrotolata sopra, lunghe piccozze e pesanti scarpe chiodate: la vicenda si svolge in uno dei primi decenni del secolo).
La prosa scarna ma pregnante di Hohl trasforma la descrizione di un’ascensione in montagna in una parabola sulla vita, con un susseguirsi di interrogativi e riflessioni fulminanti come aforismi.
Protagonisti sono due giovani alpinisti e il ghiacciaio: uno scenario grandioso dalla cui descrizione minuziosa e al contempo lirica traspare l’immenso amore che Hohl stesso provò per la montagna.
In La salita quasi tutto appare estremo, non ultimo il rigore stilistico, perché la scrittura, diceva l’autore deve essere “più leggera di un pezzo di carta”.
Ludwig Hohl, La salita, Marcos y Marcos 1991
 Quando penso che un uomo solo, ridotto alle proprie semplici risorse fisiche e morali, è bastato a far uscire dal deserto quel paese di Canaan, trovo che, malgrado tutto, la condizione umana sia ammirevole.
Quando penso che un uomo solo, ridotto alle proprie semplici risorse fisiche e morali, è bastato a far uscire dal deserto quel paese di Canaan, trovo che, malgrado tutto, la condizione umana sia ammirevole.
Durante una delle sue passeggiate in Provenza, Jean Giono ha incontrato una personalità indimenticabile: un pastore solitario e tranquillo, di poche parole, con le pecore e il cane. Quest’uomo stava compiendo una grande azione, un’impresa che avrebbe cambiato la faccia della sua terra e la vita delle generazioni future.
Jean Giono, L’uomo che piantava gli alberi, Salani Ed. 1996
Le prolisse passeggiate mi ispirano mille pensieri fruttuosi, mentre rinchiuso in casa avvizzirei e inaridirei miseramente. L’andare a spasso non è per me solo salutare, ma anche profittevole, non è solo bello ma anche utile. Una passeggiata mi stimola professionalmente, ma al contempo mi procura anche uno svago personale; mi consola, allieta e ristora, mi dà godimento, ma ha anche il vantaggio di spronarmi a nuove creazioni, perché mi offre numerose occasioni concrete, più o meno significative, che, tornato a casa, posso elaborare con impegno. Ogni passeggiata è piena di incontri, di cose che meritano d’esser viste, sentite. Di figure, di poesie viventi, di oggetti attraenti, di bellezze naturali brulica letteralmente, per solito, ogni piacevole passeggiata, sia pur breve. La conoscenza della natura e del paese si schiude piena di deliziose lusinghe ai sensi e agli sguardi dell’attento passeggiatore, che beninteso deve andare in giro ad occhi non già abbassati, ma al contrario ben aperti e limpidi, se desidera che sorga in lui il bel sentimento, l’idea alta e nobile del passeggiatore.
 La passeggiata è uno dei testi più perfetti di Walser, il grande scrittore svizzero che ormai viene posto fra i massimi autori di lingua tedesca del nostro secolo. Ma La passeggiata ha anche un significato peculiare in rapporto a tutta l’opera di Walser: è in certo modo la metafora della sua scrittura nomade, perpetuamente dissociata e abbandonata agli incontri più incongrui, casuali, e sorprendenti, come lo è appunto ogni accanito passeggiatore – e tale Walser era -, che abbraccia amorosamente ogni particolare del circostante e insieme lo osserva da una invalicabile distanza, quella del solitario, estraneo a ogni rapporto funzionale col mondo.
La passeggiata è uno dei testi più perfetti di Walser, il grande scrittore svizzero che ormai viene posto fra i massimi autori di lingua tedesca del nostro secolo. Ma La passeggiata ha anche un significato peculiare in rapporto a tutta l’opera di Walser: è in certo modo la metafora della sua scrittura nomade, perpetuamente dissociata e abbandonata agli incontri più incongrui, casuali, e sorprendenti, come lo è appunto ogni accanito passeggiatore – e tale Walser era -, che abbraccia amorosamente ogni particolare del circostante e insieme lo osserva da una invalicabile distanza, quella del solitario, estraneo a ogni rapporto funzionale col mondo.
Robert Walser, La passeggiata, Adelphi 1993
 Il seguire un percorso dal principio alla fine dà una speciale soddisfazione sia nella vita che nella letteratura (il viaggio come struttura narrativa) […]. La necessità di comprendere in un’immagine la dimensione del tempo insieme dal principio alla fine dà una speciale soddisfazione sia nella vita che nella letteratura (il viaggio come struttura narrativa) […]. La necessità di comprendere in un’immagine la dimensione del tempo insieme a quella dello spazio è all’origine della cartografia. Tempo come storia del passato […] tempo al futuro: come presenza di ostacoli che s’incrotreranno nel viaggio, e qui il tempo atmosferico si salda al tempo cronologico […]. La cartografia insomma, anche se statica, presuppone una idea narrativa, è concepita in funzione di un itinerario, è Odissea.
Il seguire un percorso dal principio alla fine dà una speciale soddisfazione sia nella vita che nella letteratura (il viaggio come struttura narrativa) […]. La necessità di comprendere in un’immagine la dimensione del tempo insieme dal principio alla fine dà una speciale soddisfazione sia nella vita che nella letteratura (il viaggio come struttura narrativa) […]. La necessità di comprendere in un’immagine la dimensione del tempo insieme a quella dello spazio è all’origine della cartografia. Tempo come storia del passato […] tempo al futuro: come presenza di ostacoli che s’incrotreranno nel viaggio, e qui il tempo atmosferico si salda al tempo cronologico […]. La cartografia insomma, anche se statica, presuppone una idea narrativa, è concepita in funzione di un itinerario, è Odissea.
ITALO CALVINO
Soprattutto, non perdete la voglia di camminare: io, camminando ogni giorno, raggiungo uno stato di benessere e mi lascio alle spalle ogni malanno; i pensieri migliori li ho avuti mentre camminavo, e non conosco pensiero così gravoso da non poter essere lasciato alle spalle con una camminata … ma stando fermi si arriva sempre più vicini a sentirsi malati … Perciò basta continuare a camminare, e andrà tutto bene.
SØREN KIERKEEGAARD
Sono come un animale selvatico: mi faccio le mie piste […] non come l’antilope o la zebra né come il bufalo o altri animali da branco: di quelli che si soccorrono, affrontano in massa le difficoltà per sopravvivere a ciò cui singolarmente soccomberebbero, e che tuttavia diventano singole prede e muoiono soli, ciascuno a suo tempo. Io faccio la mia pista privata […]. Forse dovrei dire che anch’io sopravvivo qui, ma conto su me sola; anche nei giorni in cui mi sembra che la terra sia piena di serpenti.
WILMA STOKENSTRÖM
Questa raccolta di citazioni, massime, aforismi e proverbi è dedicata al viaggio, al nomadismo, al territorio da percorrere, fuori e dentro di sé.
Vanni Beltrami, Breviario per nomadi, Biblioteca del Vascello 1995
 Noi, vassalli della voglia di viaggiare, passiamo la vita a inseguire la nostra madre terra in tutte le sue forme ed espressioni, vorremmo perfino fare tutt’uno con essa, pronti alla dedizione assoluta, lo sogniamo, lo desideriamo con tutte le nostre forze. E questa nostra passione, questa nostra caccia alla terra non è in sé, forse, meglio di una qualsiasi altra passionaccia, sia quella del giocatore o dello speculatore, del Don Giovanni e dell’arrivista. Quando la terra ci chiama, quando noialtri eterni camminatori senza sosta prendiamo commiato da casa, non stiamo abbandonando alcunché, non stiamo fuggendo, stiamo semplicemente per tuffarci nel fuoco dell’esperienza. Siamo curiosi del Sud-america, di una qualsiasi baietta ancora inesplorata dei Mari del Sud, dei Poli della terra, vogliamo comprendere il moto dei venti, delle correnti, dei lampi, delle slavine – ma ancor più curiosi siamo della morte, l’ultima e forse più intensa esperienza del nostro esserci. Perché di tutte le esperienze possibili, sono fondamentali, secondo noi, quelle per cui siamo pronti anche a dare la vita.
Noi, vassalli della voglia di viaggiare, passiamo la vita a inseguire la nostra madre terra in tutte le sue forme ed espressioni, vorremmo perfino fare tutt’uno con essa, pronti alla dedizione assoluta, lo sogniamo, lo desideriamo con tutte le nostre forze. E questa nostra passione, questa nostra caccia alla terra non è in sé, forse, meglio di una qualsiasi altra passionaccia, sia quella del giocatore o dello speculatore, del Don Giovanni e dell’arrivista. Quando la terra ci chiama, quando noialtri eterni camminatori senza sosta prendiamo commiato da casa, non stiamo abbandonando alcunché, non stiamo fuggendo, stiamo semplicemente per tuffarci nel fuoco dell’esperienza. Siamo curiosi del Sud-america, di una qualsiasi baietta ancora inesplorata dei Mari del Sud, dei Poli della terra, vogliamo comprendere il moto dei venti, delle correnti, dei lampi, delle slavine – ma ancor più curiosi siamo della morte, l’ultima e forse più intensa esperienza del nostro esserci. Perché di tutte le esperienze possibili, sono fondamentali, secondo noi, quelle per cui siamo pronti anche a dare la vita.
Per amore o per sfida, per necessità o per fuga, tutti i personaggi di Hermann Hesse, prima o poi, si misurano con il viaggio. Questa raccolta offre un compendio esauriente e ben organizzato con i migliori scritti di viaggio del giovane Hesse.
Hermann Hesse, Viaggiare, Marcos y Marcos 1994
 Se esistessero molti uomini nei quali fosse così radicato come lo è in me il disprezzo per i confini nazionali, allora non ci sarebbero più guerre né blocchi. Niente è più odioso dei confini, niente è più stupido. Essi sono come cannoni, come generali: sino a quando ragione, senso di umiltà e pace dominano, non se ne ha sentore e di loro si ride, – ma non appena guerra e follia divampano essi divengono importanti e sacri.
Se esistessero molti uomini nei quali fosse così radicato come lo è in me il disprezzo per i confini nazionali, allora non ci sarebbero più guerre né blocchi. Niente è più odioso dei confini, niente è più stupido. Essi sono come cannoni, come generali: sino a quando ragione, senso di umiltà e pace dominano, non se ne ha sentore e di loro si ride, – ma non appena guerra e follia divampano essi divengono importanti e sacri.
Nel mondo poetico e narrativo dell’autore ricorre con frequenza la figura del vagabondo, del cercatore irrequieto, sospinto senza tregua tra boschi e villaggi, sempre a un valico o a una frontiera. In questa condizione di libertà assoluta, di totale disponibilità, il viandante si fa protagonista di un’esperienza superiore, quasi sacrale. In senso e la poesia del vagabondaggio sono chiaramente metaforici: ogni uomo che voglia incamminarsi alla ricerca dell’essenza mistica e spirituale della vita, è da quel momento viandante, uomo solo.
Hermann Hesse, Vagabondaggio, Newton 1992
 Il sole era già calato dietro a una nebbia dall’aspetto ventoso e […] il nostro sentiero era immerso nel grigio e nel freddo. Un’infinità di stradine secondarie portava qua e là tra i campi. Era un labirinto senza capo né coda. Potevo vedere sopra di me la mia destinazione, ovvero la cima che la dominava; ma qualsiasi di esse scegliessi, le strade finivano sempre per allontanarsene e scendere a serpentina verso la valle o salire verso nord lungo il margine delle colline.
Il sole era già calato dietro a una nebbia dall’aspetto ventoso e […] il nostro sentiero era immerso nel grigio e nel freddo. Un’infinità di stradine secondarie portava qua e là tra i campi. Era un labirinto senza capo né coda. Potevo vedere sopra di me la mia destinazione, ovvero la cima che la dominava; ma qualsiasi di esse scegliessi, le strade finivano sempre per allontanarsene e scendere a serpentina verso la valle o salire verso nord lungo il margine delle colline.
Stevenson racconta in questo libro il viaggio che lo portò ad attraversare, in compagnia di un asino, le Cévennes, nel sud della Francia. Un viaggio davvero avventuroso, fatto a piedi, con bivacchi sotto le stelle e incontri insoliti, in un paesaggio dagli ampi spazi e dai grandi silenzi.
Robert Louis Stevenson, Viaggio nelle Cévennes in compagnia di un asino, Ibis 1993
 Voglio andarmene sui monti
Voglio andarmene sui monti
dove stanne le capanne quiete
dove il cuore si dilata libero
e l’aria soffia libera.
Voglio andarmene sui monti
dove sono gli abeti alti e scuri,
dove i ruscelli mormorano, gli uccelli cantano,
e le nuvole galoppano orgogliose.
Addio, saloni lucidi,
lucidi gentiluomini, signore levigate,
voglio andarmene sui monti
e da lassù ridere su di voi.
I resoconti di viaggio sono da secoli un genere letterario molto comune, quello di Heine fu uno dei meglio riusciti.
Heinrich Heine, Impressioni di viaggio, Istituto Geografico De Agostini 1983
 Nessun suono tranne quello del vento, che sibilava fra i cespugli spinosi e l’erba morta, nessun altro segno di vita all’infuori di un falco e di uno scarafaggio immobile su una pietra bianca.
Nessun suono tranne quello del vento, che sibilava fra i cespugli spinosi e l’erba morta, nessun altro segno di vita all’infuori di un falco e di uno scarafaggio immobile su una pietra bianca.
Il deserto della Patagonia non è un deserto di sabbia o di ghiaia, ma una distesa di bassi rovi dalle foglie grigie, che quando sono schiacciate emanano un odore amaro. Diversamente dai deserti dell’Arabia non ha prodotto nessun drammatico eccesso dello spirito, ma ha certamente un posto nella storia dell’esperienza umana. Darwin trovò le sue qualità negative irresistibili. Ricapitolando Il viaggio della Beagle tentò, senza riuscirvi, di spiegare perché, più di tutte le meraviglie da lui viste, questo “arido deserto” aveva tanto colpito la sua mente.
Dopo l’ultima guerra, alcuni ragazzi inglesi, fra cui l’autore di questo libro, chini sulle carte geografiche, cercavano l’unico luogo giusto per sfuggire alla prossima distruzione nucleare. Scelsero la Patagonia. E proprio in Patagonia si sarebbe spinto Bruce Chatwin per trovare l’incanto di viaggiare. All’interno di una natura povera, disabituata all’uomo, incontrerà un arcipelago di vite e di casi molto più sorprendente di quel che ogni esotismo permetta di pensare. Questa terra eccentrica per eccellenza è un perfetto ricettacolo per l’allucinazione, la solitudine e l’esilio.
La Patagonia di Chatwin diventa, per chiunque si appassioni a questo libro, un luogo che mancava alla propria geografia personale e di cui avvertiva segretamente il bisogno.
Bruce Chatwin, In Patagonia, Adelphi 1982
 La Patagonia è la cura per i mali dell’umanità.
La Patagonia è la cura per i mali dell’umanità.
Melville usò l’aggettivo “patagonico” per indicare qualcosa di totalmente esotico, mostruoso e pericolosamente attraente. Un’attrazione che agì anche sul giovane Bruce Chatwin. Fin dall’età di tre anni la Patagonia gli apparve come la Terra delle meraviglie. Poi dall’esperienza nacque In Patagonia, il più bel libro di viaggi dei nostri tempi. Qualche tempo dopo, un altro scrittore di viaggi, Paul Theroux, pubblicava un altro affascinante libro su quella terra, The Old Patagoniam Express. Infine, nel 1985, i due scrittori composero, in una sorta di contrappunto a due voci, questo libretto, dove entrambi tornano sulle tracce della loro passione.
Bruce Chatwin – Paul Theroux, Ritorno in Patagonia, Adelphi 1991
 Dopo la marcia forzata, i portatori rifiutano di camminare e aspettano di essere raggiunti dalle loro anime.
Dopo la marcia forzata, i portatori rifiutano di camminare e aspettano di essere raggiunti dalle loro anime.
Gli aborigeni non credono all’esistenza del paese finché non lo vedono e lo cantano.
Quasi tutti noi, che eroi non siamo, nella vita perdiamo il nostro tempo, agiamo a sproposito e alla fine siamo vittime dei nostri vari disordini emotivi. L’Eroe no. L’Eroe – e per questo lo proclamiamo tale – affronta ogni cimento quando gli si presenta, e accumula punti su punti.
Per gli aborigeni australiani, la loro terra era tutta segnata da un intrecciarsi di Vie dei Canti, un labirinto di percorsi visibili soltanto ai loro occhi. Dietro questo fenomeno, che apparve subito enigmatico agli antropologi occidentali, si cela una vera metafisica del nomadismo. Questo libro potrebbe essere descritto anch’esso come una Via del Canti: romanzo e percorso di idee, una musica di idee che muove tutta da un interrogativo: perché l’uomo, fin dalle origini, ha sentito un impulso irresistibile a spostarsi, a migrare?
Bruce Chatwin, Le Vie del Canti, Adelphi 1988
 Mi spiegarono come misurassero le distanze intonando canzoni dai ritmi ben precisi. Alcune erano composte da oltre cento versi, e ogni parola e ogni pausa doveva essere ripetuta fedelmente, né erano permessi vuoti di memoria o improvvisazioni dato che ogni canzone costituiva una vera e propria asta di misurazione.
Mi spiegarono come misurassero le distanze intonando canzoni dai ritmi ben precisi. Alcune erano composte da oltre cento versi, e ogni parola e ogni pausa doveva essere ripetuta fedelmente, né erano permessi vuoti di memoria o improvvisazioni dato che ogni canzone costituiva una vera e propria asta di misurazione.
… e vene chiamata Due Cuori è il racconto romanzato della straordinaria avventura umana e spirituale di una donna, Marlo Morgan, che per motivi di lavoro si trova a vivere in Australia e accetta un invito di una tribù di aborigeni. Con sua grande sorpresa, Marlo viene portata nel cuore di una foresta, e inizia da qui il vagabondaggio che durerà per quattro mesi percorrendo a piedi nudi l’Outback australiano.
Marlo Morgan, … e venne chiamata Due Cuori, Rizzoli 1994
 Me ne andai a zonzo fino a un lontano costone, contento di star solo per un po’, e mi sedetti a guardare le ombre uniformi che screziavano la pianura color terra d’ombra su cui nient’altro si muoveva. Tutto era immobile, con quel silenzio che noi abbiamo cacciato dal nostro mondo.
Me ne andai a zonzo fino a un lontano costone, contento di star solo per un po’, e mi sedetti a guardare le ombre uniformi che screziavano la pianura color terra d’ombra su cui nient’altro si muoveva. Tutto era immobile, con quel silenzio che noi abbiamo cacciato dal nostro mondo.
Wilfred Thesiger, che possiamo considerare in un certo senso l’ultimo dei grandi esploratori britannici di stampo romantico, ci restituisce con questo “diario di viaggi” un affresco vivo e affascinante dei deserti meridionali della penisola arabica.
Dopo aver condiviso per diversi anni, subito dopo la fine del secondo conflitto mondiale, la dura vita delle popolazioni beduine che vivono ai margini di queste immense distese desolate di sabbia, l’autore racconta un’esperienza probabilmente unica, intessuta di particolari quotidiani.
L’andamento narrativo è quello del resoconto di stampo antropologico, che ci porta con immediatezza nell’atmosfera implacabile e silenziosa del deserto, a contatto con le genti fiere e generose che faticosamente trascorrono la propria esistenza in un habitat tanto inospitale.
Wilfred Thesiger, Sabbie arabe – Viaggio nell’Arabia deserta, Mondadori 1991
 Nel mezzo della giornata, la fornace arde; il cielo, da tanto è luminoso, si scolora; il caldo torrido si abbatte dal sole a picco in nastri brucianti; sale dalla sabbia incandescente e dalle pietre surriscaldate. Allora è impossibile posare il piede sulla nuda terra; il suolo può raggiungere gli 80°C.
Nel mezzo della giornata, la fornace arde; il cielo, da tanto è luminoso, si scolora; il caldo torrido si abbatte dal sole a picco in nastri brucianti; sale dalla sabbia incandescente e dalle pietre surriscaldate. Allora è impossibile posare il piede sulla nuda terra; il suolo può raggiungere gli 80°C.
Tappe. Bivacchi di una sera in luoghi senza nome, che non rivedremo più. Partenze, eterne partenze senza arrivo che sono l’immagine pregnante del nostro viaggio interiore per non straziarci l’anima.
Questo libro, risultato di lunghi anni di esplorazione, è un inno al deserto del Sahara, alla sua grandezza opprimente, alla sua selvaggia e pericolosa bellezza, ma è anche un resoconto affascinante della fauna, della flora, della storia e della preistoria di questa regione, nonché una descrizione della vita quotidiana dell’uomo del deserto, con una tale dovizia di dettagli che questo libro potrebbe essere utilizzato come un vero e proprio manuale di sopravvivenza.
Theodore Monod, Il viaggiatore delle dune, Tasco 1990
 “Poiché Sua Maestà, malgrado le pesanti preoccupazioni di governo in questi tempi così calamitosi, cerca incessantemente di promuovere la diffusione delle conoscenze e delle scienze e di accrescere l’onore del suo popolo con imprese utili e lodevoli …”
“Poiché Sua Maestà, malgrado le pesanti preoccupazioni di governo in questi tempi così calamitosi, cerca incessantemente di promuovere la diffusione delle conoscenze e delle scienze e di accrescere l’onore del suo popolo con imprese utili e lodevoli …”
Malgrado questi tempi calamitosi … Forse è proprio in tempi calamitosi che si sogna di partire per l’Arabia Felice.
La meta della spedizione scientifica danese è lo Yemen, terra sconosciuta detta anche “Arabia Felice”. Gli scienziati partono, per scoprire e conoscere, ma in realtà proiettano sogni – di sapere, di gloria, di ricchezza – troveranno sofferenze, fatiche, gioie, conquiste, fallimenti, e la morte. Solo uno farà ritorno, partito convinto di non essere all’altezza del suo compito, ma aperto alle esperienze, capace perfino di rinunciare alla propria identità per fare sua la lezione del deserto: “non avere niente, non essere niente”.
Thorkild Hansen, Arabia Felix, Iperborea 1993
 Dopo tutto ‘sto casino, e via dicendo, arrivai al punto che avevo bisogno di un po’ di solitudine proprio per fermare il meccanismo di “pensare” e di “godere” che chiamano “vita”, avevo bisogno di stendermi sull’erba e guardare le nuvole –
Dopo tutto ‘sto casino, e via dicendo, arrivai al punto che avevo bisogno di un po’ di solitudine proprio per fermare il meccanismo di “pensare” e di “godere” che chiamano “vita”, avevo bisogno di stendermi sull’erba e guardare le nuvole –
È scritto anche nell’antica scrittura: – “La saggezza può essere raggiunta soltanto nella solitudine.”
Viaggiatore solitario è una raccolta di scritti collegati da uno stesso filo conduttore: il viaggiare. I viaggi coprono gli Stati Uniti dal sud alla costa orientale, fino a quella occidentale e al lontano nord-ovest, il Messico, il Marocco, Parigi, Londra, l’oceano Atlantico e quello Pacifico percorsi in nave e vi sono incluse altre città e persone interessanti.
Lo scopo e l’intenzione è semplicemente la poesia o, le descrizioni naturali.
Jack Kerouac, Viaggiatore solitario, Sugarco 1987
 Breve sosta in un boschetto. Vedo la valle, prendo la scorciatoia per prati fradici, sguazzanti; la strada qui fa come un grande otto. Che razza di tempesta di neve; ora tutto torna a placarsi, a poco a poco mi asciugo. […] Dagli abeti piovono ancora gocce sul terreno coperto di aghi. Le mie cosce fumano come se fossi un cavallo. Paesaggio ondulato, molto bosco, e tutto mi è così sconosciuto. Quando ci si avvicina, i paesi fanno finta di essere morti.
Breve sosta in un boschetto. Vedo la valle, prendo la scorciatoia per prati fradici, sguazzanti; la strada qui fa come un grande otto. Che razza di tempesta di neve; ora tutto torna a placarsi, a poco a poco mi asciugo. […] Dagli abeti piovono ancora gocce sul terreno coperto di aghi. Le mie cosce fumano come se fossi un cavallo. Paesaggio ondulato, molto bosco, e tutto mi è così sconosciuto. Quando ci si avvicina, i paesi fanno finta di essere morti.
Questo libro è la storia di un viaggio in certo modo straordinario: il viaggio a piedi intrapreso nell’inverno 1974 da Werner Herzog, per recarsi da Monaco a Parigi, dove lo aspettava un’amica malata, Lotte Eisner, storica e studiosa del cinema tedesco. Strade, boschi, paesi squassati da temporali e bufere di neve, villaggi deserti e campi disabitati: questo il paesaggio che percorriamo insieme a un uomo che compie il più anacronistico dei gesti.
Werner Herzog, Sentieri nel ghiaccio, Guanda 1994
 Sotto la bufera bianca è avvenuta una straordinaria transizione. Nell’arco di cinque minuti siamo usciti da un mondo di pietra, di fango, di sabbia e di perenne siccità, che ci aveva accompagnato da Damasco in poi, per penetrare in un mondo di legna, di foglie e di linfa, dove le montagne erano ricoperte di arbusti, che diventavano alberi, e questi, cessata la neve, si raggruppavano in una lucida foresta di tronchi nudi le cui volte frondose velavano il cielo.
Sotto la bufera bianca è avvenuta una straordinaria transizione. Nell’arco di cinque minuti siamo usciti da un mondo di pietra, di fango, di sabbia e di perenne siccità, che ci aveva accompagnato da Damasco in poi, per penetrare in un mondo di legna, di foglie e di linfa, dove le montagne erano ricoperte di arbusti, che diventavano alberi, e questi, cessata la neve, si raggruppavano in una lucida foresta di tronchi nudi le cui volte frondose velavano il cielo.
Secondo Bruce Chatwin questo libro è il capolavoro dei libri che trattano di viaggio. L’Oxiana è una regione fra l’Afghanistan e l’Iran dove si può procedere sulle orme di Marco Polo.
Robert Byron, La via per l’Oxiana, Adelphi 1993
 Non è dimostrabile, eppure io ci credo: nel mondo ci sono luoghi in cui un arrivo o una partenza vengono misteriosamente moltiplicati dai sentimenti di quanti nello stesso luogo sono arrivati o da lì ripartiti. […] Ormai i viaggi non durano anni, sappiamo dove andare e anche le probabilità di tornare sono molto più alte.
Non è dimostrabile, eppure io ci credo: nel mondo ci sono luoghi in cui un arrivo o una partenza vengono misteriosamente moltiplicati dai sentimenti di quanti nello stesso luogo sono arrivati o da lì ripartiti. […] Ormai i viaggi non durano anni, sappiamo dove andare e anche le probabilità di tornare sono molto più alte.
Un viaggio spagnolo nello spazio e nel tempo, lungo percorsi inusuali, attraverso le vie di pellegrinaggio, il labirinto dei ricordi, le suggestioni del paesaggio, l’intreccio di colori, di parole, di leggende, l’ispirazione del momento. Da Don Chisciotte a Zurbaràn, da Velàzquez a Garcia Lorca, da una sperduta abbazia cistercense alla solennità del Prado: Cees Nooteboom ci guida alla scoperta di personaggi e luoghi di una Spagna profonda e misteriosa, invitandoci ad abbandonare le vesti del turista per diventare veri viaggiatori.
Cees Nooteboom, Verso Santiago – Itinerari spagnoli, Feltrinelli 1996
 La steppa ha grandi ondulazioni, come delle lunghissime dune biondastre, separate da grandi distanze l’una dall’altra. Non è priva di colore. Alcuni tratti sono dello stesso bianco-biondo spento dei capelli dei bambini russi. Ma numerose sono le tinte – sempre spente – che serpeggiano per la distesa come correnti marine. Anche l’aria ha un colore spento.
La steppa ha grandi ondulazioni, come delle lunghissime dune biondastre, separate da grandi distanze l’una dall’altra. Non è priva di colore. Alcuni tratti sono dello stesso bianco-biondo spento dei capelli dei bambini russi. Ma numerose sono le tinte – sempre spente – che serpeggiano per la distesa come correnti marine. Anche l’aria ha un colore spento.
Un libro e un viaggio su rotaie lunghe trentamila chilometri. Dopo i primi tremilacinquecento chilometri da Roma a Mosca, i novemila in Transiberiana, da Mosca a Pechino. E poi, sempre in treno, da Pechino a Shangai. Poi c’è il ritorno, con un unico biglietto ferroviario, dalla foce del fiume Azzurro sino alla Yogoslavia passando, a differenza della andata, attraverso la Mongolia e il Gobi. Al rientro in Italia non si è più gli stessi, anche se si torna a sedersi sulla stessa poltrona. Tra la persona di prima e quella del ritorno c’è di mezzo una buona metà del mondo e straordinari incontri umani. Non è poco.
Allora è giocoforza raccontare.
Angelo Maria Pellegrino, In Transiberiana, Stampa Alternativa 1992
 Farsi coinvolgere, comunicare sono essenziali per arricchirsi mediante i viaggi. Si potrebbe andare ovunque senza urtare contro qualcosa di nuovo, se si rimane legati al proprio mondo. Oggi è data molta importanza a dove si va, ma forse importa soprattutto come e perché lo si fa.
Farsi coinvolgere, comunicare sono essenziali per arricchirsi mediante i viaggi. Si potrebbe andare ovunque senza urtare contro qualcosa di nuovo, se si rimane legati al proprio mondo. Oggi è data molta importanza a dove si va, ma forse importa soprattutto come e perché lo si fa.
L’inter rail – un mese di treno a basso costo in giro per l’Europa, il Marocco, la Turchia per chi ha meno di 26 anni – è, per chi lo vuole, disorganizzazione, in una società sempre più inquadrata ed asettica.
L’inter rail è, per chi sa giocarsela bene, libertà in una società che organizza e limita anche l’avventura, la sorpresa, la gioia, il sogno. Abbiamo provato con l’inter rail a disorganizzarci, a riprenderci spazi di libertà. Qui lo raccontiamo con le istruzioni per l’uso.
Luca Conti, Inter rail man – Manuale per chi viaggia in treno, Stampa Alternativa 1992
 Il silenzio ci mette a disagio.
Il silenzio ci mette a disagio.
Il silenzio radio viene chiamato “aria morta”, qualcosa da evitare ad ogni costo. Così lo tamponiamo con parole o musica, spesso parole e musica, e troviamo sollievo nello schiamazzo, per quanto possa essere privo di significato. Abbiamo perduto la pausa ricca di significato. Il silenzio durante l’audizione viene invariabilmente distrutto dall’applauso di qualche idiota che pensa che il concerto sia finito.
La prima definitiva storia del vento: come porta la vita nel mondo distribuendo energia e calore, influenzando i fenomeni meteorologici, favorendo la riproduzione delle piante e la migrazione di molte specie di animali, modificando il paesaggio, agendo sul comportamento dell’uomo.
Lyall Watson, Il libro del vento, Frassinelli 1985
 Cosa fa un viaggiatore di notte in una città sconosciuta quando vuole scambiar due parole? Negli Stati Uniti non c’è quasi altra scelta che ficcarsi in un bar. […]
Cosa fa un viaggiatore di notte in una città sconosciuta quando vuole scambiar due parole? Negli Stati Uniti non c’è quasi altra scelta che ficcarsi in un bar. […]
In una angolo c’era una stecca da biliardo spezzata; la piccola stanza laterale era illuminata soltanto dal tremolio di una luce al neon che reclamizzava una birra, quel tipo di luce vacillante che farebbe impazzire chiunque.
Un tempo, sulle vecchie cartine d’America, le strade principali erano segnate in rosso e quelle secondarie in blu. È sulle strade blu che si svolge di tre mesi di un solitario mezzo pellirossa, che, restando privo del suo lavoro e della sua donna, va a ricercare un poco di interesse alla vita in un itinerario circolare che lo porta e riporta nell’America settentrionale. E ritrova, ricostruisce, riscopre l’America periferica, decentrata, provinciale come un altro, diverso continente.
William Least Heat-Moon, Strade blu, Einaudi 1995
 […] perché le uniche persone che esistono per me sono i pazzi, i pazzi di voglia di vivere, di parole, di salvezza, i pazzi del tutto e del subito, quelli che non sbadigliano mai e non dicono mai banalità ma bruciano, bruciano, bruciano come favolosi fuochi d’artificio gialli che esplodono simili a ragni sopra le stelle e nel mezzo si vede scoppiare la luce azzurra e tutti fanno “Oooooh!”.
[…] perché le uniche persone che esistono per me sono i pazzi, i pazzi di voglia di vivere, di parole, di salvezza, i pazzi del tutto e del subito, quelli che non sbadigliano mai e non dicono mai banalità ma bruciano, bruciano, bruciano come favolosi fuochi d’artificio gialli che esplodono simili a ragni sopra le stelle e nel mezzo si vede scoppiare la luce azzurra e tutti fanno “Oooooh!”.
Intere generazioni hanno preso a modello i protagonisti di questo libro che in trent’anni è diventano un libro di culto. In fuga dalla mediocrità del mondo, in auto, in camper traballanti.
La fuga attraverso gli Stati Uniti e il Messico su malconce auto, traballanti camper, o autobus affollati di umanità americana ed europea. Il romanzo dell’amicizia e delle difficoltà, dell’amore, del malessere e della rivolta. Il “manifesto” della beat generation preso a modello da sempre nuove generazioni di giovani.
Jack Kerouac, Sulla strada, Leonando Ed. 1989
 Sono qui raccolte alcune fra le migliori pagine di Vittorio G. Rossi: vorremmo dire le più limpide, atte a delineare la sua schietta e spontanea vena di narratore: scritti d’avventura, di viaggi, di “conoscenze”, tutte profondamente umane e sentite.
Sono qui raccolte alcune fra le migliori pagine di Vittorio G. Rossi: vorremmo dire le più limpide, atte a delineare la sua schietta e spontanea vena di narratore: scritti d’avventura, di viaggi, di “conoscenze”, tutte profondamente umane e sentite.
I giovani potranno invidiare le innumerevoli esperienze dell’autore, che ha fatto “quasi tutti i mestieri rischiosi difficili: il palombaro, il minatore, il navigante, il pescatore di balene, di merluzzi, l’uomo di bordo delle navi-faro”, ma sapranno scoprire il messaggio racchiuso nelle sue opere: “presi l’uomo come protagonista e feci del viaggio un racconto, come avventura umana. Insieme come l’uomo, ho preso come protagoniste le grandi forze della natura, sopra tutto il mare …”. V’è quindi in queste pagine narrative anche una profonda attenzione agli ideali, ai dolori e alle miserie degli uomini. Pur senza perdere nulla della sua vivacità, della sua arguta visione delle cose, del suo stile tutto particolare, Vittorio G. Rossi ci induce a meditare su ciò che rappresenta l’uomo nel mondo, su noi stessi, sul senso della vita.
Vittorio G. Rossi, Terra e acqua, Mursia 1966









 Nel corso dei suoi viaggi Jannon raccoglie immagini (tante!) e ricordi, di cui peraltro fa partecipi solo pochi eletti, e con parsimonia: ma riporta soprattutto frammenti di segni, flash di colori o di profili, e anche di odori, o di suoni. Li cova nella memoria, li seleziona, lascia dapprima che reagiscano al contatto con gli agenti esterni o interni più disparati (letture, immagini, reminiscenze di altri viaggi già fatti o aspettative per quelli in programma) e poi ne leviga ogni connotazione spaziale e temporale, sino a tradurli in simboli. Solo a questo punto li riversa infine sulla carta, sul legno o sulla tela. Quel che ne sortisce sono emozioni essenziali, rarefatte ma profonde, sedimentate e tuttavia mai fredde; perché i segni ritornano in serie di approssimazioni, appena leggermente variate, che producono un effetto di mobilità, un percorso, appunto. Nessuna delle sue opere vuole chiudere in sé, fermare per intero il ricordo; tutte si iscrivono in sequenze, e pur riuscendo autoconclusiva ognuna già allude alle variabili e alle possibilità altrove esplorate. Come i suoi piedi, anche la pittura di Jannon non può mai essere in quiete; rifiuta la staticità del reportage, i divani dell’introspezione e gli specchi dell’autocompiacimento, per esprimere invece una primordiale meraviglia al cospetto del mondo, e la voglia di rinnovarla costantemente. Per questo, appena la mostra chiuderà i battenti, o forse anche prima, non perdete tempo a cercare Pietro. Sarà già altrove, lungo le vie dei canti, con uno zaino da duecento litri stipato di magliette, calze e suggestioni.
Nel corso dei suoi viaggi Jannon raccoglie immagini (tante!) e ricordi, di cui peraltro fa partecipi solo pochi eletti, e con parsimonia: ma riporta soprattutto frammenti di segni, flash di colori o di profili, e anche di odori, o di suoni. Li cova nella memoria, li seleziona, lascia dapprima che reagiscano al contatto con gli agenti esterni o interni più disparati (letture, immagini, reminiscenze di altri viaggi già fatti o aspettative per quelli in programma) e poi ne leviga ogni connotazione spaziale e temporale, sino a tradurli in simboli. Solo a questo punto li riversa infine sulla carta, sul legno o sulla tela. Quel che ne sortisce sono emozioni essenziali, rarefatte ma profonde, sedimentate e tuttavia mai fredde; perché i segni ritornano in serie di approssimazioni, appena leggermente variate, che producono un effetto di mobilità, un percorso, appunto. Nessuna delle sue opere vuole chiudere in sé, fermare per intero il ricordo; tutte si iscrivono in sequenze, e pur riuscendo autoconclusiva ognuna già allude alle variabili e alle possibilità altrove esplorate. Come i suoi piedi, anche la pittura di Jannon non può mai essere in quiete; rifiuta la staticità del reportage, i divani dell’introspezione e gli specchi dell’autocompiacimento, per esprimere invece una primordiale meraviglia al cospetto del mondo, e la voglia di rinnovarla costantemente. Per questo, appena la mostra chiuderà i battenti, o forse anche prima, non perdete tempo a cercare Pietro. Sarà già altrove, lungo le vie dei canti, con uno zaino da duecento litri stipato di magliette, calze e suggestioni.



 Humboldt sperimentò ampiamente sul suo corpo le difficoltà opposte dal fiume a tutti gli intrusi. La piaga delle zanzare, dei tafani, dei “piumes” e di altri insetti succhiatori di sangue era intollerabile perfino agli indiani; gli esploratori soffrivano per gli incessanti rovesci di pioggia e la fame li tormentava – il loro nutrimento consisteva in banane, manioca, acqua e talvolta un po’ di riso. […]
Humboldt sperimentò ampiamente sul suo corpo le difficoltà opposte dal fiume a tutti gli intrusi. La piaga delle zanzare, dei tafani, dei “piumes” e di altri insetti succhiatori di sangue era intollerabile perfino agli indiani; gli esploratori soffrivano per gli incessanti rovesci di pioggia e la fame li tormentava – il loro nutrimento consisteva in banane, manioca, acqua e talvolta un po’ di riso. […] Sono andato con Sekeletu a vedere le cascate che qui chiamano “Chongué” o “Mosi-oa-Tunya”. Aventi minuti di navigazione da Calai si scorgono grandi colonne di vapore. Il panorama è stupendo. Mi sono fatto lasciare in un’isola situata quasi in mezzo al gorgo d’acqua e da lì ho goduto dello spettacolo: il fiume, largo un chilometro, diventa improvvisamente un’unica massa impetuosa che precipita lungo un abisso stretto appena venti metri. È il passaggio più avvincente che abbia mai contemplato in Africa. Ho dato a queste cascate il nome Vittoria. Dopo aver piantato nell’isola un centinaio di noccioli di pesca e di albicocca e una quarantina di chicchi di caffè, per dar vita a un giardino che un indigeno mi ha promesso di cingere con una siepe e di curare, ho inciso su un albero le mie iniziali e, sotto, la data: 1885.
Sono andato con Sekeletu a vedere le cascate che qui chiamano “Chongué” o “Mosi-oa-Tunya”. Aventi minuti di navigazione da Calai si scorgono grandi colonne di vapore. Il panorama è stupendo. Mi sono fatto lasciare in un’isola situata quasi in mezzo al gorgo d’acqua e da lì ho goduto dello spettacolo: il fiume, largo un chilometro, diventa improvvisamente un’unica massa impetuosa che precipita lungo un abisso stretto appena venti metri. È il passaggio più avvincente che abbia mai contemplato in Africa. Ho dato a queste cascate il nome Vittoria. Dopo aver piantato nell’isola un centinaio di noccioli di pesca e di albicocca e una quarantina di chicchi di caffè, per dar vita a un giardino che un indigeno mi ha promesso di cingere con una siepe e di curare, ho inciso su un albero le mie iniziali e, sotto, la data: 1885. Marciamo sotto la pioggia, lungo il golfo, che forse ci offrirà qualche sorpresa. Esso, col prolungasi dentro terra, diventa sempre più enigmatico. È quasi impossibile vedere il chiaro specchio delle acque traverso le alte canne palustri delle rive. La speranza di saper qualche cosa sorge e svanisce ad ogni curva di questa landa di sabbia.
Marciamo sotto la pioggia, lungo il golfo, che forse ci offrirà qualche sorpresa. Esso, col prolungasi dentro terra, diventa sempre più enigmatico. È quasi impossibile vedere il chiaro specchio delle acque traverso le alte canne palustri delle rive. La speranza di saper qualche cosa sorge e svanisce ad ogni curva di questa landa di sabbia. Sono passati circa duecento anni da quando Carlo Linneo, docente all’Università svedese di Uppsala, ebbe a notare con disappunto che, sebbene gli atti di eroismo compiuti dagli studiosi di botanica non fossero di alcun modo inferiori a quelli che avevano reso grandi “re, eroi e imperatori”, ad essi veniva negato un uguale riconoscimento di valore i immortalità. Sembra anche che aggiungesse, con la cupa seriosità tipica della sua razza: “Quale lavoro è più arduo, quale scienza più faticosa della botanica?”.
Sono passati circa duecento anni da quando Carlo Linneo, docente all’Università svedese di Uppsala, ebbe a notare con disappunto che, sebbene gli atti di eroismo compiuti dagli studiosi di botanica non fossero di alcun modo inferiori a quelli che avevano reso grandi “re, eroi e imperatori”, ad essi veniva negato un uguale riconoscimento di valore i immortalità. Sembra anche che aggiungesse, con la cupa seriosità tipica della sua razza: “Quale lavoro è più arduo, quale scienza più faticosa della botanica?”. L’uomo che volge le spalle alle comodità di una civiltà più antica per affrontare la selvaggia giovinezza, la primordiale semplicità del Nord, potrebbe valutare la sua riuscita in ragione inversa alla quantità ed alla qualità delle sue abitudini incurabilmente consolidate. Scoprirà presto, se è la persona giusta, che le abitudini materiali sono le meno importanti. Il rinunciare a un menù raffinato per del cibo grossolano, a delle scarpe di cuoio rigido per dei mocassini morbidi e informi, ad un letto di piume per un giaciglio nella neve, è dopo tutto cosa abbastanza agevole. Ma avrà il suo da fare ad imparare in maniera adeguata a foggiare il proprio atteggiamento mentale verso tutte le cose, e in particolare verso gli altri uomini.
L’uomo che volge le spalle alle comodità di una civiltà più antica per affrontare la selvaggia giovinezza, la primordiale semplicità del Nord, potrebbe valutare la sua riuscita in ragione inversa alla quantità ed alla qualità delle sue abitudini incurabilmente consolidate. Scoprirà presto, se è la persona giusta, che le abitudini materiali sono le meno importanti. Il rinunciare a un menù raffinato per del cibo grossolano, a delle scarpe di cuoio rigido per dei mocassini morbidi e informi, ad un letto di piume per un giaciglio nella neve, è dopo tutto cosa abbastanza agevole. Ma avrà il suo da fare ad imparare in maniera adeguata a foggiare il proprio atteggiamento mentale verso tutte le cose, e in particolare verso gli altri uomini. Dersu camminava in silenzio e guardava tutto con indifferenza. Io mi entusiasmavo del paesaggio, lui invece esaminava un ramo rotto all’altezza della mano di un uomo, e da come era stato piegato, capiva la direzione tenuta dall’uomo. Dalla rottura più o meno recente egli risaliva a quando il fatto era accaduto, indovinava il tipo di scarpe ecc. Ogni volta che io non capivo qualcosa o manifestavo qualche dubbio, mi diceva:
Dersu camminava in silenzio e guardava tutto con indifferenza. Io mi entusiasmavo del paesaggio, lui invece esaminava un ramo rotto all’altezza della mano di un uomo, e da come era stato piegato, capiva la direzione tenuta dall’uomo. Dalla rottura più o meno recente egli risaliva a quando il fatto era accaduto, indovinava il tipo di scarpe ecc. Ogni volta che io non capivo qualcosa o manifestavo qualche dubbio, mi diceva: Avrebbe fatto un viaggio! Per me, che non mi ero mai allontanato da casa, la parola “viaggio” era quanto di più allettante si potesse immaginare. Presto si sarebbe trovato a centinaia di miglia da me, in mezzo a praterie e deserti sconfinati, e sulle montagne del Far West! Avrebbe visto i bisonti e gli indiani, e i cani della prateria, e le antilopi, e chissà quante avventure gli sarebbero capitate: lo avrebbero impiccato, magari, o scotennato, si sarebbe divertito un mondo e ce lo avrebbe scritto e sarebbe diventato un eroe.
Avrebbe fatto un viaggio! Per me, che non mi ero mai allontanato da casa, la parola “viaggio” era quanto di più allettante si potesse immaginare. Presto si sarebbe trovato a centinaia di miglia da me, in mezzo a praterie e deserti sconfinati, e sulle montagne del Far West! Avrebbe visto i bisonti e gli indiani, e i cani della prateria, e le antilopi, e chissà quante avventure gli sarebbero capitate: lo avrebbero impiccato, magari, o scotennato, si sarebbe divertito un mondo e ce lo avrebbe scritto e sarebbe diventato un eroe. Era un mattino di ottobre. Ero andato a Córdoba approfittando delle vacanze del 17. Sotto il pergolato della casa di Alberto Granado bevevamo mate zuccherato commentando tutte le ultime traversie della “porca vita”, e intanto ci dedicavamo alla manutenzione della Poderosa II. […] Sui sentieri dell’immaginazione arrivammo a remoti paesi, navigando per mari tropicali e visitammo tutta l’Asia. E all’improvviso, materializzata dai nostri sogni, sorse la domanda: e se ce andassimo in Nordamerica?
Era un mattino di ottobre. Ero andato a Córdoba approfittando delle vacanze del 17. Sotto il pergolato della casa di Alberto Granado bevevamo mate zuccherato commentando tutte le ultime traversie della “porca vita”, e intanto ci dedicavamo alla manutenzione della Poderosa II. […] Sui sentieri dell’immaginazione arrivammo a remoti paesi, navigando per mari tropicali e visitammo tutta l’Asia. E all’improvviso, materializzata dai nostri sogni, sorse la domanda: e se ce andassimo in Nordamerica? Capii quella volta che Mij significava per me assai più della maggior parte degli esseri umani di mia conoscenza, che avrei sofferto per la perdita della sua presenza fisica molto di più che per la loro, e non me ne vergognavo affatto.
Capii quella volta che Mij significava per me assai più della maggior parte degli esseri umani di mia conoscenza, che avrei sofferto per la perdita della sua presenza fisica molto di più che per la loro, e non me ne vergognavo affatto. In uno slargo di bosco si sedette sotto un grosso abete bianco, riaccese la sua pipa e serenamente aspettò che ritornassero giù i cacciatori dalla montagna perché gli raccontassero. Nel frattempo ascoltava il bosco.
In uno slargo di bosco si sedette sotto un grosso abete bianco, riaccese la sua pipa e serenamente aspettò che ritornassero giù i cacciatori dalla montagna perché gli raccontassero. Nel frattempo ascoltava il bosco.
 Il cacciatore d’immagini
Il cacciatore d’immagini Nell’antichità solo gli alberi degni di nota e indicati da un segno sovrannaturale diventavano oggetto di un culto, ma non per questo tutti gli altri non possedevano ognuno un’anima corrispondente alla sua particolare specie. A volte si trattava di un essere semidivino di cui la specie portava il nome e che si presumeva averle dato vita; il più delle volte era una ninfa che aveva subito una metamorfosi.
Nell’antichità solo gli alberi degni di nota e indicati da un segno sovrannaturale diventavano oggetto di un culto, ma non per questo tutti gli altri non possedevano ognuno un’anima corrispondente alla sua particolare specie. A volte si trattava di un essere semidivino di cui la specie portava il nome e che si presumeva averle dato vita; il più delle volte era una ninfa che aveva subito una metamorfosi. A poco a poco la magia dell’isola ci avvolse gentile e persistente come un polline. Ogni giorno portava con sé una tale tranquillità, una tale durata fuori del tempo da far desiderare che non finisse mai. Ma poi la pelle scura della notte si sbucciava ed ecco un nuovo giorno davanti a noi, lustro e colorato come una decalcomania, e con lo stesso tocco di realtà.
A poco a poco la magia dell’isola ci avvolse gentile e persistente come un polline. Ogni giorno portava con sé una tale tranquillità, una tale durata fuori del tempo da far desiderare che non finisse mai. Ma poi la pelle scura della notte si sbucciava ed ecco un nuovo giorno davanti a noi, lustro e colorato come una decalcomania, e con lo stesso tocco di realtà. Dopo un attimo, sollevando lo sguardo, mi pose a sua volte un interrogativo non facile. Mi disse che capiva come mai GS, essendo un biologo, avesse deciso di percorrere centinaia di chilometri in alta montagna per raccogliere sull’altipiano del Tibet informazioni scientifiche. Ma perché mai ci andavo anch’io? Che cosa speravo di trovare? […]
Dopo un attimo, sollevando lo sguardo, mi pose a sua volte un interrogativo non facile. Mi disse che capiva come mai GS, essendo un biologo, avesse deciso di percorrere centinaia di chilometri in alta montagna per raccogliere sull’altipiano del Tibet informazioni scientifiche. Ma perché mai ci andavo anch’io? Che cosa speravo di trovare? […] Ma la storia della vita, per come la interpreto io, è costituita da una serie di dati stabili, punteggiati a intervalli da grandi eventi che avvengono con una grande rapidità e servono a realizzare il successivo periodo di stabilità.
Ma la storia della vita, per come la interpreto io, è costituita da una serie di dati stabili, punteggiati a intervalli da grandi eventi che avvengono con una grande rapidità e servono a realizzare il successivo periodo di stabilità. È quindi ora, al ritorno, che comincerà la loro vera escursione, poiché la fantasia sarà, d’ora in poi, la loro guida ed essi viaggeranno nei loro ricordi.
È quindi ora, al ritorno, che comincerà la loro vera escursione, poiché la fantasia sarà, d’ora in poi, la loro guida ed essi viaggeranno nei loro ricordi. Le armi con cui abbiamo conseguito le vittorie più gloriose, quelle che dovrebbero venir trasmesse in eredità di padre in figlio, non sono la spada e la lancia, ma l’accetta, la falce, la vanga e la zappa, arrugginite dal sangue di infinite praterie, e annerite dalla polvere di infiniti campi che solo con la dura lotta poterono coltivare.
Le armi con cui abbiamo conseguito le vittorie più gloriose, quelle che dovrebbero venir trasmesse in eredità di padre in figlio, non sono la spada e la lancia, ma l’accetta, la falce, la vanga e la zappa, arrugginite dal sangue di infinite praterie, e annerite dalla polvere di infiniti campi che solo con la dura lotta poterono coltivare. Mi ero ritirato qui, nel grande oceano della solitudine nel quale si vuotano i fiumi della società, ed ero tanto tanto lontano che, per la maggior parte – per ciò che riguardava le mie necessità – solo il sentimento più fine si depositava intorno a me.
Mi ero ritirato qui, nel grande oceano della solitudine nel quale si vuotano i fiumi della società, ed ero tanto tanto lontano che, per la maggior parte – per ciò che riguardava le mie necessità – solo il sentimento più fine si depositava intorno a me. Nella tradizione fiabesca la Montagna è il legame fra la Terra e il Cielo. La sua cima unica tocca il mondo dell’eternità e la sua base si ramifica in molteplici contrafforti nel mondo dei mortali. È la via per la quale l’uomo può elevarsi alla divinità e la divinità rivelarsi all’uomo.
Nella tradizione fiabesca la Montagna è il legame fra la Terra e il Cielo. La sua cima unica tocca il mondo dell’eternità e la sua base si ramifica in molteplici contrafforti nel mondo dei mortali. È la via per la quale l’uomo può elevarsi alla divinità e la divinità rivelarsi all’uomo. Talvolta, seduto sulla cima del grande, solitario colle che dà nome alla città, fissavo per ore l’ampio paesaggio dell’entroterra, come se potessi distinguere, senza mai stancarmene, tutto quanto si stendeva davanti ai miei occhi: le pianure, i fiumi, i boschi, le colline, le capanne dove mi ero fermato, e più di un amabile volto umano. Anche i visi che mi avevano maltrattato o guardato con occhio malevolo mi apparivano ora sotto un aspetto bonario. Ma soprattutto pensavo al mio caro fiume, l’indimenticabile Yí, alla bianca casa ombrosa al margine della piccola città […].
Talvolta, seduto sulla cima del grande, solitario colle che dà nome alla città, fissavo per ore l’ampio paesaggio dell’entroterra, come se potessi distinguere, senza mai stancarmene, tutto quanto si stendeva davanti ai miei occhi: le pianure, i fiumi, i boschi, le colline, le capanne dove mi ero fermato, e più di un amabile volto umano. Anche i visi che mi avevano maltrattato o guardato con occhio malevolo mi apparivano ora sotto un aspetto bonario. Ma soprattutto pensavo al mio caro fiume, l’indimenticabile Yí, alla bianca casa ombrosa al margine della piccola città […]. Io, bambino di appena sei anni ma già capace di andar di galoppo e senza cadere su un cavallo non sellato, invito il lettore, anche lui in groppa a un cavallo – sia pure immaginario – ad allontanarsi con me dalla casa per raggiungere, a una lega circa di distanza, qualche posto che sovrasti un poco la pianura circostante. Là giunti, seduti sui nostri cavalli, potremo dominare un orizzonte più vasto di quello che contemplerebbe anche l’uomo più alto standocene semplicemente in piedi […].
Io, bambino di appena sei anni ma già capace di andar di galoppo e senza cadere su un cavallo non sellato, invito il lettore, anche lui in groppa a un cavallo – sia pure immaginario – ad allontanarsi con me dalla casa per raggiungere, a una lega circa di distanza, qualche posto che sovrasti un poco la pianura circostante. Là giunti, seduti sui nostri cavalli, potremo dominare un orizzonte più vasto di quello che contemplerebbe anche l’uomo più alto standocene semplicemente in piedi […]. In una parola, la natura si è mostrata con lei – quasi come coll’uomo – ingiusta, malevola, ironica, fantastica, illogica o perfida. Ma come l’uomo e – almeno fino ad oggi – qualche volta meglio di lui essa a saputo trar partito dall’unico vantaggio che una matrigna obliosa, curiosa o semplicemente indifferente a voluto lasciarle: una piccola forza che non si vede, che, in lei, chiamiamo istinto e, in noi, chi sa perché, intelligenza.
In una parola, la natura si è mostrata con lei – quasi come coll’uomo – ingiusta, malevola, ironica, fantastica, illogica o perfida. Ma come l’uomo e – almeno fino ad oggi – qualche volta meglio di lui essa a saputo trar partito dall’unico vantaggio che una matrigna obliosa, curiosa o semplicemente indifferente a voluto lasciarle: una piccola forza che non si vede, che, in lei, chiamiamo istinto e, in noi, chi sa perché, intelligenza. L’acqua sommergeva il ponte delle nostre zattere, ed era bellissimo essere di nuovo liberi, fendere le acque in tumulto, udire i tonfi delle nostre prue contro i grandi fogli si schiuma, e sentirci tutti, io, Jorge e i quattro indios, bagnati da capo a piedi.
L’acqua sommergeva il ponte delle nostre zattere, ed era bellissimo essere di nuovo liberi, fendere le acque in tumulto, udire i tonfi delle nostre prue contro i grandi fogli si schiuma, e sentirci tutti, io, Jorge e i quattro indios, bagnati da capo a piedi. Non conviene sapere la storia del detestabile verme per fargli guerra vantaggiosamente e sbarazzare il giardino da questa genìa?”
Non conviene sapere la storia del detestabile verme per fargli guerra vantaggiosamente e sbarazzare il giardino da questa genìa?” E ho anche iniziato a considerare le praterie, poco distanti dalla città in cui sono nato, la mia terra natale, e ho cominciato ad amarle non perché attirano l’attenzione come i monti o la costa, ma perché la respingono sfidando la capacità di mantenerla sveglia. […]
E ho anche iniziato a considerare le praterie, poco distanti dalla città in cui sono nato, la mia terra natale, e ho cominciato ad amarle non perché attirano l’attenzione come i monti o la costa, ma perché la respingono sfidando la capacità di mantenerla sveglia. […] Per assolvere il compito di una passeggiata all’aperto non è necessario andare da soli, ma è ben possibile camminare accanto ad un compagno a noi concorde, insieme presi in un tranquillo colloquiare su temi generali della realtà umana, della letteratura, o su alcuni aspetti naturali che ci si offrano durante il percorso, senza che tutto ciò attenui in alcun modo gli effetti della natura sul nostro animo. Ma si deve pur dire che sarà bene, di tanto in tanto, passeggiare da solo, per colui il quale non desideri unicamente registrare impressioni esteriori, ma molto più percepisca l’incoercibile impulso di abbandonarsi al proprio genio e vivere solo con se stesso.
Per assolvere il compito di una passeggiata all’aperto non è necessario andare da soli, ma è ben possibile camminare accanto ad un compagno a noi concorde, insieme presi in un tranquillo colloquiare su temi generali della realtà umana, della letteratura, o su alcuni aspetti naturali che ci si offrano durante il percorso, senza che tutto ciò attenui in alcun modo gli effetti della natura sul nostro animo. Ma si deve pur dire che sarà bene, di tanto in tanto, passeggiare da solo, per colui il quale non desideri unicamente registrare impressioni esteriori, ma molto più percepisca l’incoercibile impulso di abbandonarsi al proprio genio e vivere solo con se stesso. Inizio d’estate, primissime ore del mattino: nel profondo delle Alpi, al punto di congiunzione fra due valli, su sedie verdi di metallo, davanti a un caffè ancora addormentato, sono sedute due figure che l’abbigliamento e l’attrezzatura rendono facilmente riconoscibili come alpinisti (spessi abiti di lana e cappelli di feltro, sacchi da montagna, uno dei quali con la fune arrotolata sopra, lunghe piccozze e pesanti scarpe chiodate: la vicenda si svolge in uno dei primi decenni del secolo).
Inizio d’estate, primissime ore del mattino: nel profondo delle Alpi, al punto di congiunzione fra due valli, su sedie verdi di metallo, davanti a un caffè ancora addormentato, sono sedute due figure che l’abbigliamento e l’attrezzatura rendono facilmente riconoscibili come alpinisti (spessi abiti di lana e cappelli di feltro, sacchi da montagna, uno dei quali con la fune arrotolata sopra, lunghe piccozze e pesanti scarpe chiodate: la vicenda si svolge in uno dei primi decenni del secolo). Quando penso che un uomo solo, ridotto alle proprie semplici risorse fisiche e morali, è bastato a far uscire dal deserto quel paese di Canaan, trovo che, malgrado tutto, la condizione umana sia ammirevole.
Quando penso che un uomo solo, ridotto alle proprie semplici risorse fisiche e morali, è bastato a far uscire dal deserto quel paese di Canaan, trovo che, malgrado tutto, la condizione umana sia ammirevole. La passeggiata è uno dei testi più perfetti di Walser, il grande scrittore svizzero che ormai viene posto fra i massimi autori di lingua tedesca del nostro secolo. Ma La passeggiata ha anche un significato peculiare in rapporto a tutta l’opera di Walser: è in certo modo la metafora della sua scrittura nomade, perpetuamente dissociata e abbandonata agli incontri più incongrui, casuali, e sorprendenti, come lo è appunto ogni accanito passeggiatore – e tale Walser era -, che abbraccia amorosamente ogni particolare del circostante e insieme lo osserva da una invalicabile distanza, quella del solitario, estraneo a ogni rapporto funzionale col mondo.
La passeggiata è uno dei testi più perfetti di Walser, il grande scrittore svizzero che ormai viene posto fra i massimi autori di lingua tedesca del nostro secolo. Ma La passeggiata ha anche un significato peculiare in rapporto a tutta l’opera di Walser: è in certo modo la metafora della sua scrittura nomade, perpetuamente dissociata e abbandonata agli incontri più incongrui, casuali, e sorprendenti, come lo è appunto ogni accanito passeggiatore – e tale Walser era -, che abbraccia amorosamente ogni particolare del circostante e insieme lo osserva da una invalicabile distanza, quella del solitario, estraneo a ogni rapporto funzionale col mondo. Il seguire un percorso dal principio alla fine dà una speciale soddisfazione sia nella vita che nella letteratura (il viaggio come struttura narrativa) […]. La necessità di comprendere in un’immagine la dimensione del tempo insieme dal principio alla fine dà una speciale soddisfazione sia nella vita che nella letteratura (il viaggio come struttura narrativa) […]. La necessità di comprendere in un’immagine la dimensione del tempo insieme a quella dello spazio è all’origine della cartografia. Tempo come storia del passato […] tempo al futuro: come presenza di ostacoli che s’incrotreranno nel viaggio, e qui il tempo atmosferico si salda al tempo cronologico […]. La cartografia insomma, anche se statica, presuppone una idea narrativa, è concepita in funzione di un itinerario, è Odissea.
Il seguire un percorso dal principio alla fine dà una speciale soddisfazione sia nella vita che nella letteratura (il viaggio come struttura narrativa) […]. La necessità di comprendere in un’immagine la dimensione del tempo insieme dal principio alla fine dà una speciale soddisfazione sia nella vita che nella letteratura (il viaggio come struttura narrativa) […]. La necessità di comprendere in un’immagine la dimensione del tempo insieme a quella dello spazio è all’origine della cartografia. Tempo come storia del passato […] tempo al futuro: come presenza di ostacoli che s’incrotreranno nel viaggio, e qui il tempo atmosferico si salda al tempo cronologico […]. La cartografia insomma, anche se statica, presuppone una idea narrativa, è concepita in funzione di un itinerario, è Odissea. Noi, vassalli della voglia di viaggiare, passiamo la vita a inseguire la nostra madre terra in tutte le sue forme ed espressioni, vorremmo perfino fare tutt’uno con essa, pronti alla dedizione assoluta, lo sogniamo, lo desideriamo con tutte le nostre forze. E questa nostra passione, questa nostra caccia alla terra non è in sé, forse, meglio di una qualsiasi altra passionaccia, sia quella del giocatore o dello speculatore, del Don Giovanni e dell’arrivista. Quando la terra ci chiama, quando noialtri eterni camminatori senza sosta prendiamo commiato da casa, non stiamo abbandonando alcunché, non stiamo fuggendo, stiamo semplicemente per tuffarci nel fuoco dell’esperienza. Siamo curiosi del Sud-america, di una qualsiasi baietta ancora inesplorata dei Mari del Sud, dei Poli della terra, vogliamo comprendere il moto dei venti, delle correnti, dei lampi, delle slavine – ma ancor più curiosi siamo della morte, l’ultima e forse più intensa esperienza del nostro esserci. Perché di tutte le esperienze possibili, sono fondamentali, secondo noi, quelle per cui siamo pronti anche a dare la vita.
Noi, vassalli della voglia di viaggiare, passiamo la vita a inseguire la nostra madre terra in tutte le sue forme ed espressioni, vorremmo perfino fare tutt’uno con essa, pronti alla dedizione assoluta, lo sogniamo, lo desideriamo con tutte le nostre forze. E questa nostra passione, questa nostra caccia alla terra non è in sé, forse, meglio di una qualsiasi altra passionaccia, sia quella del giocatore o dello speculatore, del Don Giovanni e dell’arrivista. Quando la terra ci chiama, quando noialtri eterni camminatori senza sosta prendiamo commiato da casa, non stiamo abbandonando alcunché, non stiamo fuggendo, stiamo semplicemente per tuffarci nel fuoco dell’esperienza. Siamo curiosi del Sud-america, di una qualsiasi baietta ancora inesplorata dei Mari del Sud, dei Poli della terra, vogliamo comprendere il moto dei venti, delle correnti, dei lampi, delle slavine – ma ancor più curiosi siamo della morte, l’ultima e forse più intensa esperienza del nostro esserci. Perché di tutte le esperienze possibili, sono fondamentali, secondo noi, quelle per cui siamo pronti anche a dare la vita. Se esistessero molti uomini nei quali fosse così radicato come lo è in me il disprezzo per i confini nazionali, allora non ci sarebbero più guerre né blocchi. Niente è più odioso dei confini, niente è più stupido. Essi sono come cannoni, come generali: sino a quando ragione, senso di umiltà e pace dominano, non se ne ha sentore e di loro si ride, – ma non appena guerra e follia divampano essi divengono importanti e sacri.
Se esistessero molti uomini nei quali fosse così radicato come lo è in me il disprezzo per i confini nazionali, allora non ci sarebbero più guerre né blocchi. Niente è più odioso dei confini, niente è più stupido. Essi sono come cannoni, come generali: sino a quando ragione, senso di umiltà e pace dominano, non se ne ha sentore e di loro si ride, – ma non appena guerra e follia divampano essi divengono importanti e sacri. Il sole era già calato dietro a una nebbia dall’aspetto ventoso e […] il nostro sentiero era immerso nel grigio e nel freddo. Un’infinità di stradine secondarie portava qua e là tra i campi. Era un labirinto senza capo né coda. Potevo vedere sopra di me la mia destinazione, ovvero la cima che la dominava; ma qualsiasi di esse scegliessi, le strade finivano sempre per allontanarsene e scendere a serpentina verso la valle o salire verso nord lungo il margine delle colline.
Il sole era già calato dietro a una nebbia dall’aspetto ventoso e […] il nostro sentiero era immerso nel grigio e nel freddo. Un’infinità di stradine secondarie portava qua e là tra i campi. Era un labirinto senza capo né coda. Potevo vedere sopra di me la mia destinazione, ovvero la cima che la dominava; ma qualsiasi di esse scegliessi, le strade finivano sempre per allontanarsene e scendere a serpentina verso la valle o salire verso nord lungo il margine delle colline. Voglio andarmene sui monti
Voglio andarmene sui monti Nessun suono tranne quello del vento, che sibilava fra i cespugli spinosi e l’erba morta, nessun altro segno di vita all’infuori di un falco e di uno scarafaggio immobile su una pietra bianca.
Nessun suono tranne quello del vento, che sibilava fra i cespugli spinosi e l’erba morta, nessun altro segno di vita all’infuori di un falco e di uno scarafaggio immobile su una pietra bianca. La Patagonia è la cura per i mali dell’umanità.
La Patagonia è la cura per i mali dell’umanità. Dopo la marcia forzata, i portatori rifiutano di camminare e aspettano di essere raggiunti dalle loro anime.
Dopo la marcia forzata, i portatori rifiutano di camminare e aspettano di essere raggiunti dalle loro anime. Mi spiegarono come misurassero le distanze intonando canzoni dai ritmi ben precisi. Alcune erano composte da oltre cento versi, e ogni parola e ogni pausa doveva essere ripetuta fedelmente, né erano permessi vuoti di memoria o improvvisazioni dato che ogni canzone costituiva una vera e propria asta di misurazione.
Mi spiegarono come misurassero le distanze intonando canzoni dai ritmi ben precisi. Alcune erano composte da oltre cento versi, e ogni parola e ogni pausa doveva essere ripetuta fedelmente, né erano permessi vuoti di memoria o improvvisazioni dato che ogni canzone costituiva una vera e propria asta di misurazione. Me ne andai a zonzo fino a un lontano costone, contento di star solo per un po’, e mi sedetti a guardare le ombre uniformi che screziavano la pianura color terra d’ombra su cui nient’altro si muoveva. Tutto era immobile, con quel silenzio che noi abbiamo cacciato dal nostro mondo.
Me ne andai a zonzo fino a un lontano costone, contento di star solo per un po’, e mi sedetti a guardare le ombre uniformi che screziavano la pianura color terra d’ombra su cui nient’altro si muoveva. Tutto era immobile, con quel silenzio che noi abbiamo cacciato dal nostro mondo. Nel mezzo della giornata, la fornace arde; il cielo, da tanto è luminoso, si scolora; il caldo torrido si abbatte dal sole a picco in nastri brucianti; sale dalla sabbia incandescente e dalle pietre surriscaldate. Allora è impossibile posare il piede sulla nuda terra; il suolo può raggiungere gli 80°C.
Nel mezzo della giornata, la fornace arde; il cielo, da tanto è luminoso, si scolora; il caldo torrido si abbatte dal sole a picco in nastri brucianti; sale dalla sabbia incandescente e dalle pietre surriscaldate. Allora è impossibile posare il piede sulla nuda terra; il suolo può raggiungere gli 80°C. “Poiché Sua Maestà, malgrado le pesanti preoccupazioni di governo in questi tempi così calamitosi, cerca incessantemente di promuovere la diffusione delle conoscenze e delle scienze e di accrescere l’onore del suo popolo con imprese utili e lodevoli …”
“Poiché Sua Maestà, malgrado le pesanti preoccupazioni di governo in questi tempi così calamitosi, cerca incessantemente di promuovere la diffusione delle conoscenze e delle scienze e di accrescere l’onore del suo popolo con imprese utili e lodevoli …” Dopo tutto ‘sto casino, e via dicendo, arrivai al punto che avevo bisogno di un po’ di solitudine proprio per fermare il meccanismo di “pensare” e di “godere” che chiamano “vita”, avevo bisogno di stendermi sull’erba e guardare le nuvole –
Dopo tutto ‘sto casino, e via dicendo, arrivai al punto che avevo bisogno di un po’ di solitudine proprio per fermare il meccanismo di “pensare” e di “godere” che chiamano “vita”, avevo bisogno di stendermi sull’erba e guardare le nuvole – Breve sosta in un boschetto. Vedo la valle, prendo la scorciatoia per prati fradici, sguazzanti; la strada qui fa come un grande otto. Che razza di tempesta di neve; ora tutto torna a placarsi, a poco a poco mi asciugo. […] Dagli abeti piovono ancora gocce sul terreno coperto di aghi. Le mie cosce fumano come se fossi un cavallo. Paesaggio ondulato, molto bosco, e tutto mi è così sconosciuto. Quando ci si avvicina, i paesi fanno finta di essere morti.
Breve sosta in un boschetto. Vedo la valle, prendo la scorciatoia per prati fradici, sguazzanti; la strada qui fa come un grande otto. Che razza di tempesta di neve; ora tutto torna a placarsi, a poco a poco mi asciugo. […] Dagli abeti piovono ancora gocce sul terreno coperto di aghi. Le mie cosce fumano come se fossi un cavallo. Paesaggio ondulato, molto bosco, e tutto mi è così sconosciuto. Quando ci si avvicina, i paesi fanno finta di essere morti. Sotto la bufera bianca è avvenuta una straordinaria transizione. Nell’arco di cinque minuti siamo usciti da un mondo di pietra, di fango, di sabbia e di perenne siccità, che ci aveva accompagnato da Damasco in poi, per penetrare in un mondo di legna, di foglie e di linfa, dove le montagne erano ricoperte di arbusti, che diventavano alberi, e questi, cessata la neve, si raggruppavano in una lucida foresta di tronchi nudi le cui volte frondose velavano il cielo.
Sotto la bufera bianca è avvenuta una straordinaria transizione. Nell’arco di cinque minuti siamo usciti da un mondo di pietra, di fango, di sabbia e di perenne siccità, che ci aveva accompagnato da Damasco in poi, per penetrare in un mondo di legna, di foglie e di linfa, dove le montagne erano ricoperte di arbusti, che diventavano alberi, e questi, cessata la neve, si raggruppavano in una lucida foresta di tronchi nudi le cui volte frondose velavano il cielo. Non è dimostrabile, eppure io ci credo: nel mondo ci sono luoghi in cui un arrivo o una partenza vengono misteriosamente moltiplicati dai sentimenti di quanti nello stesso luogo sono arrivati o da lì ripartiti. […] Ormai i viaggi non durano anni, sappiamo dove andare e anche le probabilità di tornare sono molto più alte.
Non è dimostrabile, eppure io ci credo: nel mondo ci sono luoghi in cui un arrivo o una partenza vengono misteriosamente moltiplicati dai sentimenti di quanti nello stesso luogo sono arrivati o da lì ripartiti. […] Ormai i viaggi non durano anni, sappiamo dove andare e anche le probabilità di tornare sono molto più alte. La steppa ha grandi ondulazioni, come delle lunghissime dune biondastre, separate da grandi distanze l’una dall’altra. Non è priva di colore. Alcuni tratti sono dello stesso bianco-biondo spento dei capelli dei bambini russi. Ma numerose sono le tinte – sempre spente – che serpeggiano per la distesa come correnti marine. Anche l’aria ha un colore spento.
La steppa ha grandi ondulazioni, come delle lunghissime dune biondastre, separate da grandi distanze l’una dall’altra. Non è priva di colore. Alcuni tratti sono dello stesso bianco-biondo spento dei capelli dei bambini russi. Ma numerose sono le tinte – sempre spente – che serpeggiano per la distesa come correnti marine. Anche l’aria ha un colore spento. Farsi coinvolgere, comunicare sono essenziali per arricchirsi mediante i viaggi. Si potrebbe andare ovunque senza urtare contro qualcosa di nuovo, se si rimane legati al proprio mondo. Oggi è data molta importanza a dove si va, ma forse importa soprattutto come e perché lo si fa.
Farsi coinvolgere, comunicare sono essenziali per arricchirsi mediante i viaggi. Si potrebbe andare ovunque senza urtare contro qualcosa di nuovo, se si rimane legati al proprio mondo. Oggi è data molta importanza a dove si va, ma forse importa soprattutto come e perché lo si fa. Il silenzio ci mette a disagio.
Il silenzio ci mette a disagio. Cosa fa un viaggiatore di notte in una città sconosciuta quando vuole scambiar due parole? Negli Stati Uniti non c’è quasi altra scelta che ficcarsi in un bar. […]
Cosa fa un viaggiatore di notte in una città sconosciuta quando vuole scambiar due parole? Negli Stati Uniti non c’è quasi altra scelta che ficcarsi in un bar. […] […] perché le uniche persone che esistono per me sono i pazzi, i pazzi di voglia di vivere, di parole, di salvezza, i pazzi del tutto e del subito, quelli che non sbadigliano mai e non dicono mai banalità ma bruciano, bruciano, bruciano come favolosi fuochi d’artificio gialli che esplodono simili a ragni sopra le stelle e nel mezzo si vede scoppiare la luce azzurra e tutti fanno “Oooooh!”.
[…] perché le uniche persone che esistono per me sono i pazzi, i pazzi di voglia di vivere, di parole, di salvezza, i pazzi del tutto e del subito, quelli che non sbadigliano mai e non dicono mai banalità ma bruciano, bruciano, bruciano come favolosi fuochi d’artificio gialli che esplodono simili a ragni sopra le stelle e nel mezzo si vede scoppiare la luce azzurra e tutti fanno “Oooooh!”. Sono qui raccolte alcune fra le migliori pagine di Vittorio G. Rossi: vorremmo dire le più limpide, atte a delineare la sua schietta e spontanea vena di narratore: scritti d’avventura, di viaggi, di “conoscenze”, tutte profondamente umane e sentite.
Sono qui raccolte alcune fra le migliori pagine di Vittorio G. Rossi: vorremmo dire le più limpide, atte a delineare la sua schietta e spontanea vena di narratore: scritti d’avventura, di viaggi, di “conoscenze”, tutte profondamente umane e sentite.
 Luciano Canfora ne “Libro e Libertà” scrive: “Don Chisciotte che, a furia di leggere, entra nel mondo dei suoi libri e ragiona come se fosse egli stesso un soggetto di quei libri e addirittura vive come quei personaggi, è una creazione inquietante, che incombe, per così dire, come esito possibile sul mondo dei lettori”.
Luciano Canfora ne “Libro e Libertà” scrive: “Don Chisciotte che, a furia di leggere, entra nel mondo dei suoi libri e ragiona come se fosse egli stesso un soggetto di quei libri e addirittura vive come quei personaggi, è una creazione inquietante, che incombe, per così dire, come esito possibile sul mondo dei lettori”. Pure noi Viandanti delle Nebbie cerchiamo quel paese; non importa se alla fine non lo raggiungeremo, quel che conta è insistere nella sua ricerca. Il nostro Barangain è un luogo dove si concretizzano i nostri sogni, le nostre utopie, dove incontriamo personaggi fantastici e reali, che in una qualche maniera ci appartengono. Un posto dove si possa discutere di letteratura con Calvino, di poesia con Leopardi. Viaggiare nello spazio e nel tempo con Corto Maltese. Apprendere il coraggio, l’onore e la cavalleria da Don Chisciotte e Re Artù. Studiare il Medioevo, le eresie e l’Inquisizione con chi l’ha subita, come il Gran Maestro Templare De Molay. Ubriacarci con Bukowski. Sognare con Valentina (va bene anche se qualcuno è sconcio). Entrare nella biblioteca dell’Abbazia con Gugliemo da Baskerville e Jorge Luis Borges. Amare Madame Bovary.
Pure noi Viandanti delle Nebbie cerchiamo quel paese; non importa se alla fine non lo raggiungeremo, quel che conta è insistere nella sua ricerca. Il nostro Barangain è un luogo dove si concretizzano i nostri sogni, le nostre utopie, dove incontriamo personaggi fantastici e reali, che in una qualche maniera ci appartengono. Un posto dove si possa discutere di letteratura con Calvino, di poesia con Leopardi. Viaggiare nello spazio e nel tempo con Corto Maltese. Apprendere il coraggio, l’onore e la cavalleria da Don Chisciotte e Re Artù. Studiare il Medioevo, le eresie e l’Inquisizione con chi l’ha subita, come il Gran Maestro Templare De Molay. Ubriacarci con Bukowski. Sognare con Valentina (va bene anche se qualcuno è sconcio). Entrare nella biblioteca dell’Abbazia con Gugliemo da Baskerville e Jorge Luis Borges. Amare Madame Bovary.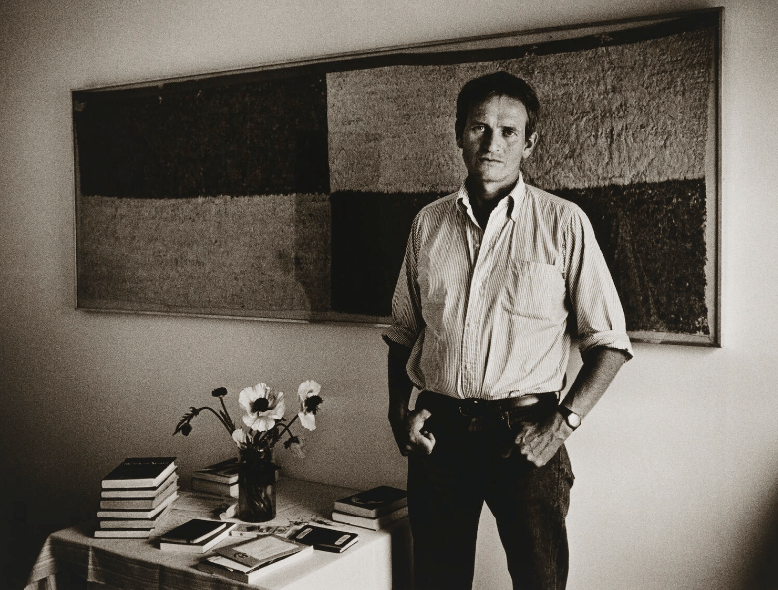
 Bruce Chatwin è scomparso nell’89, non ancora cinquantenne. Le sue opere hanno cominciato a circolare in Italia nei primi anni ottanta, incontrando anche un certo successo, ma senza fornire mai lo spunto per l’esplosione di un “caso letterario”. Il che, se ho ben capito il personaggio, è esattamente ciò che l’autore voleva, o comunque è ciò che io amo pensare preferisse. (Così come non mi è affatto spiaciuto che nessuno dei sacerdoti della critica letteraria italiana si sia accorto della sua morte – e d’altronde neanche della sua opera – e che gli siano state risparmiate le aspersioni delle solite brode di ovvietà). In questo modo posso continuare a pensare a lui come ad un amico, ai suoi libri come a lunghe missive personali, condivise al più da una piccola cerchia selezionata. e se mi sono deciso scrivere queste poche righe che lo riguardano è proprio perché so che pochissimi le leggeranno.
Bruce Chatwin è scomparso nell’89, non ancora cinquantenne. Le sue opere hanno cominciato a circolare in Italia nei primi anni ottanta, incontrando anche un certo successo, ma senza fornire mai lo spunto per l’esplosione di un “caso letterario”. Il che, se ho ben capito il personaggio, è esattamente ciò che l’autore voleva, o comunque è ciò che io amo pensare preferisse. (Così come non mi è affatto spiaciuto che nessuno dei sacerdoti della critica letteraria italiana si sia accorto della sua morte – e d’altronde neanche della sua opera – e che gli siano state risparmiate le aspersioni delle solite brode di ovvietà). In questo modo posso continuare a pensare a lui come ad un amico, ai suoi libri come a lunghe missive personali, condivise al più da una piccola cerchia selezionata. e se mi sono deciso scrivere queste poche righe che lo riguardano è proprio perché so che pochissimi le leggeranno.