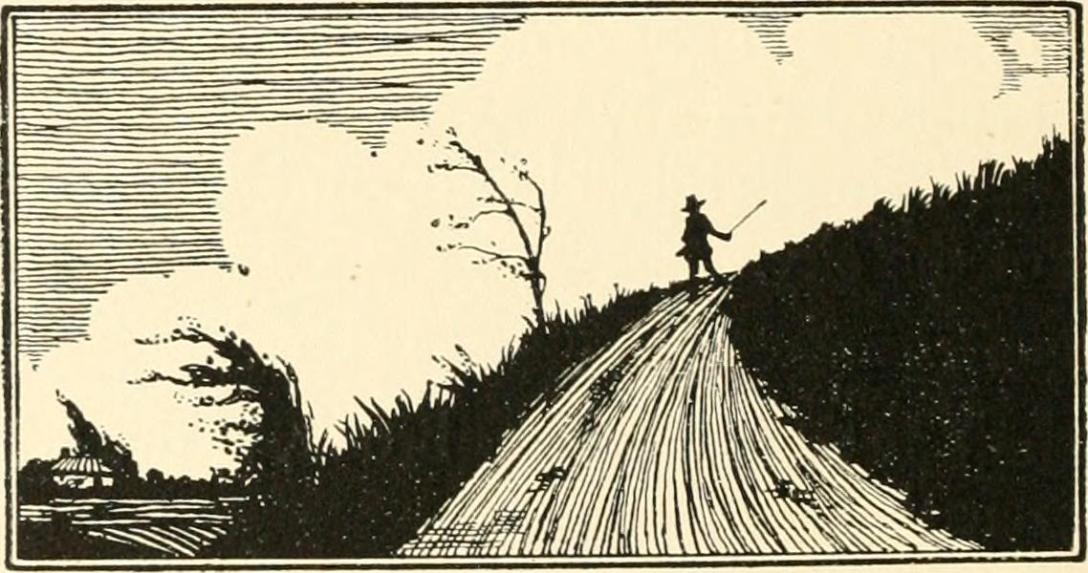Postilla
di Paolo Repetto, 2013
Per una fertile combinazione di motivi (le cose che ho trovato per caso, quelle che ho ostinatamente cercato e quelle che ho scritto) la letteratura di viaggio ospitata nella parte destra della scaffalatura a tutta parete ha continuato in questi anni a debordare verso sinistra, a conquistare prima nuovi ripiani e poi interi scaffali e a costringermi a periodiche risistemazioni.
Dovessi scriverlo oggi, quindi, il capitoletto sul viaggio occuperebbe almeno il doppio di pagine. Le nuove scoperte, sia per quanto concerne le opere che per i personaggi, riguardano soprattutto la storia delle esplorazioni e dei viaggi scientifici. Provo a rendertene sommariamente conto.
Innanzitutto, i protagonisti. A Humboldt ho dedicato un piccolo saggio biografico (glielo dovevo) e nel frattempo ho acquisito tutto ciò che di suo era reperibile, comprese le edizioni in italiano, in tedesco e in francese del Cosmos. Le lacune ora riguardano solo la corrispondenza: non esiste una raccolta completa in francese, e quella tedesca, in fase di edizione, occupa già oltre dieci volumi: in compenso ho trovato in Francia una scelta abbastanza ampia e significativa delle lettere scambiate con Bonpland, (A. von Humboldt, A. Bonpland – Correspondance 1805-1858, a cura di Nicolas Hossard) e una biografia di Bonpland (Aimè Bonpland, mèdecin, naturaliste, explorateur en Amerique du Sud, dello stesso Hossard), l’unica che conosco e che possiedo A differenza di trent’anni fa, quando è partita la mia humboldt-mania, e quando era praticamente sconosciuto in Italia e dimenticato in patria, oggi lo scienziato-viaggiatore tedesco conosce un piccolo ritorno di popolarità grazie anche a due recenti biografie: Federico Focher ha scritto A. von Humboldt. Abbozzo di una biografia, mentre Andrea Wulf, già autrice de La confraternita dei giardinieri, gli ha dedicato quel volumone dal titolo L’invenzione della natura, sul quale, ti confesso, ho molte riserve. Insomma, anche il mio personalissimo eroe comincia ad essere macinato dall’industria culturale.
Sull’onda delle ricerche dedicate a Humboldt è cresciuta la curiosità per le biografie di altri scienziati-esploratori. Darwin, naturalmente (del Viaggio di un naturalista attorno al mondo possiedo ormai quattro diverse edizioni, e due dell’Autobiografia, oltre alla biografia classica di Desmond e Moore, a quella leggermente più romanzata di Irwing Shaw, L’origine, e ai Taccuini); ma anche, e soprattutto, il suo corrispondente-amico-antagonista Alfred Douglas Wallace, un po’ meno ignoto anche agli italiani da quando il buon Federico Focher ne ha scritto una avvincente storia (L’uomo che gettò nel panico Darwin). Wallace è un personaggio che riserva un sacco di sorprese: oltre che esploratore, cercatore di specie, scienziato autodidatta, era un socialista umanitario, pronto a battersi per ogni causa, soprattutto per quelle perse, e un convinto spiritista, tanto solare e disposto a mettersi in gioco quanto Darwin era riservato e pieno di dubbi. Dei suoi scritti è stato finalmente tradotto L’arcipelago malese, divertente e commovente resoconto di quattro anni di avventure (e soprattutto disavventure) a caccia di nuove specie vegetali nel sud-est asiatico. Lo trovi accanto ai libri di e su Darwin, e a quello sullo spiritismo che ho scaricato dalla rete.
La passione per la montagna mi ha aiutato a scoprirne il miglior interprete e precursore in Déodat de Dolomieu, l’”inventore” delle Dolomiti. Dolomieu ebbe un’esistenza che definire avventurosa è riduttivo. Fece le esperienze più disparate, da un duello mortale (per l’avversario) a sedici anni fino a venti mesi di assoluto isolamento in una fetida e piccolissima cella di un carcere borbonico, poco prima di morire, ma compì soprattutto una ricognizione minuziosa e completa di ogni vallata alpina. Era un camminatore formidabile, capace di sfiancare non solo i compagni di percorso ma anche i muli e i cavalli da soma, e uno spericolato arrampicatore, che tuttavia nei Viaggi sulle Alpi non rivendica alcuna delle innumerevoli vette da lui per primo conquistate. Per conoscerlo mi sono avvalso di una monumentale (ma piuttosto confusa) biografia scritta da Luigi Zanzi (Dolomieu, un avventuriero nella storia della natura) e ho poi ricostruito il resto attraverso la lettura diretta dei suoi resoconti di viaggio.
Del tutto fortuita è sta invece la conoscenza con l’opera e la vita di Guido Boggiani. Attraverso un volume dedicato principalmente alla sua pittura (Guido Boggiani. Pittore, esploratore, etnografo, di Maurizio Leigheb) ho scoperto una seconda esistenza, quella di etnologo e viaggiatore (raccontata da Boggiani stesso nei Viaggi di un artista nell’America meridionale) che lo ha portato a vivere per anni ai margini del Gran Chaco paraguagio e a morirvi, ucciso da un indigeno, prima dei quarant’anni.
Altre storie come la sua, o come quelle di Wallace e di Dolomieu, ho trovato in un paio volumi piuttosto stagionati, I cacciatori di piante di Thaylor Whittle e Scienziati ed esploratori alla scoperta del Sudamerica di Victor von Hagen, e in uno recentissimo, Cercatori di specie, di Richard Conniff. Quella del viaggio a scopo scientifico è una vera e propria epopea, naturalmente poco conosciuta e per niente celebrata nelle nostre scuole, che ha cambiato non solo lo sguardo ma anche la quotidianità della vita dell’Occidente. I libri che ho appena citati offrirebbero ai nostri demotivati studenti, e non solo a loro, ben altri stimoli rispetto alle ricostruzioni politiche e militari alle quali si riduce in genere l’insegnamento della storia, e li aiuterebbero a coltivare un minimo di passione per le scienze e ad acquisire qualche fondamento etico.
Attraverso un gioco di rimandi, di letture di sponda, sono poi arrivato ad alcuni personaggi davvero singolari, avventurieri nel senso più letterale del termine. L’ultimo in ordine di comparsa, ma primo per collocazione storica, è Lodovico de Varthema. Ne ho trovato traccia nei testi di Herrmann e di Brilli di cui parlerò tra breve, ho poi acquisito una sua biografia (Lodovico di Varthema alle Isole della Sonda) e ho scovato infine le recentissime edizioni del suo Itinerario e del Viaggio alla Mecca. De Varthema si trovava già a Calicut quando, nei primissimi anni del ‘500, ci arrivarono i Portoghesi. Dalle mie parti si usa dire che quando Colombo approdò in America ci trovò i mandrogni che già gestivano un ben avviato giro d’affari. Bene, i lusitani trovarono senz’altro un bolognese che già aveva girato tutto il Medio Oriente e visitato le Isole della Sonda, pronto a far fruttare le informazioni accumulate e ad acquisirsi meriti (al ritorno in Europa fu insignito dal re del Portogallo della dignità nobiliare, oltre che di una pensione). Anche se probabilmente molte delle sue avventure sono enfatizzate, soprattutto per il gusto di inserire situazioni boccaccesche delle quali è immancabile protagonista, resta il fatto che quelle terre le aveva realmente visitate e che per esserne tornato vivo e vegeto doveva avere senz’altro la scorza dura.
Non quanto Enrico Tonti, o Henry de Tonti, però. Tonti è stato una vera folgorazione. Non lo avevo mai sentito nominare sino a dieci anni fa, e vengo poi a scoprire che è stato uno dei protagonisti dell’esplorazione nordamericana, al fianco di de La Salle. Non esiste una sua biografia in italiano (che mi risulti, nemmeno in francese), ma le notizie essenziali sulle sue incredibili avventure si possono ricavare da L’Europa alla conquista dell’America, un bellissimo libro di Raymond Cartier che racconta nel dettaglio le guerre indiane sui Grandi Laghi tra Sei e Settecento – quelle de L’Ultimo dei Mohicani, per intenderci, o di Ticonderoga –, o da Mississippi di Mario Maffi. “Mano di ferro”, come lo chiamavano gli indiani, fu uno dei pochi che mise in soggezione persino gli Irochesi, che quanto a ferocia e coraggio non la cedevano a nessuno, e fu determinante per l’esplorazione del bacino del Mississippi, consegnato poi nelle mani della corona francese. Su questo tema e sulla storia di La Salle è invece appassionante La Louisiana per il mio re, di Hans Otto Meissner, mentre interessanti sono alcuni libri di memorie legati alla fase americana della guerra dei Sette Anni: ad esempio il diario anonimo di un soldato francese che ha partecipato a tutte le fasi della campagna e alla caduta di Montreal (Oltre le cascate del Niagara).
Altrettanto singolare, e secondo nemmeno agli Irochesi per determinazione, è il personaggio di Augusto Franzoj. Militare, disertore, giornalista radicale sempre in cerca di rogne e capace di sopravvivere ad oltre cinquanta duelli, Franzoj attraversò nella seconda metà dell’Ottocento mezza Africa centro-orientale per andare a recuperare le spoglie di un esploratore italiano morto nel paese dei Galla. L’Africa fu per lui inizialmente un rifugio, ma divenne poi una vocazione. Sebbene non avesse alcuna necessità di spostarsi per vivere pericolosamente, l’Etiopia gli offrì il teatro ideale per un’avventura che più pazza e disperata è difficile immaginare. Ne uscì, e la raccontò, naturalmente con tutti gli aggiustamenti del caso, in Continente nero, che nella sua ostentata “obiettività” è davvero un resoconto spassosissimo: ma per conoscere anche gli altri particolari della sua vita sempre sopra le righe occorre leggere Un viaggiatore in brache di tela, di Felice Pozzo.
Queste ed altre figure altrettanto avvincenti sono balzate fuori dalle pagine di diverse opere sulla storia generale delle esplorazioni da tempo fuori commercio, alle quali solo recentemente ho potuto arrivare attraverso il mercato on line. Pur restando fermo sulla mia linea di principio, secondo la quale l’eccessiva facilità nel reperire testi ritenuti a lungo introvabili sottrae una buona fetta di piacere al gioco, quella dell’attesa, della ricerca febbrile sulle bancarelle e magari dell’incredula sorpresa di un ritrovamento, devo ammettere che la diffusione di siti dedicati alla compravendita dei libri ha reso accessibili cose che mai mi sarei sognato di poter un giorno possedere. È il caso della fondamentale trilogia di Paul Herrmann (Sulle vie dell’ignoto, Sette sono passate e l’ottava sta passando e Santa vergine di Guadalupa, aiutaci tu) o di La conquista della terra di Giotto Dainelli, opere edite più di mezzo secolo fa. Mentre il libro di Dainelli lo conoscevo (e lo desideravo) da tempo, quelli di Herrmann sono stati un’autentica rivelazione. Soprattutto mi ha stupito il non averne mai sentito parlare in precedenza, il non avere mai colto alcun rimando. Forniscono una messe incredibile di informazioni, ma sono anche di lettura piacevolissima: avrei voluto averli tra le mani a quindici anni, e forse mi avrebbero cambiata la vita.
Ma sarebbe stato probabilmente sufficiente poter disporre per tempo di opere divulgative illustratissime come Il grande libro delle esplorazioni o Le grandi esplorazioni che cambiarono il mondo, che a dispetto dell’apparente destinazione a fare tappezzeria nei salotti forniscono un racconto dettagliato ed esauriente delle grandi imprese di esplorazione. Ne ho fatto incetta, e adesso mi ritrovo a confrontare le diverse narrazioni, a scovare le imprecisioni e a sommare i piccoli tasselli forniti da ciascuna per costruirmi un quadro il più vasto e completo possibile.
In che senso una precoce conoscenza di opere del genere può riuscire determinante? Beh, intanto perché consente di affinare lo sguardo sulle vicende storiche, di sottrarlo ai condizionamenti che le letture ideologiche legate al clima del momento immancabilmente ne danno. Faccio un esempio. Ho amato molto presto la storia e la civiltà del popolo irochese, o meglio, della Società delle Cinque Nazioni, attraverso la lettura di “Dovuto agli irochesi”, di Edmund Wilson, un classico di quello che Pascal Bruckner chiama “il singhiozzo dell’uomo bianco”. Wilson racconta di una cultura avanzatissima sotto il profilo politico e sociale, che non ha nulla da invidiare alle coeve istituzioni occidentali, ed esprime un accorato rimpianto per la sua distruzione da parte degli invasori bianchi. Bene, leggendo i diari di Tonti, di De La Salle e di padre Hennepin, che con gli Irochesi ebbero a trattare direttamente, nonché le testimonianze di quei pochi gesuiti e francescani che riuscirono a sopravvivere ad una caccia spietata, viene fuori un quadro ben diverso, quello di una popolazione dai costumi ferocissimi, che provava un sadico gusto nella lenta tortura dei prigionieri, delle cui carni spesso e volentieri si cibava, e che per un secolo e mezzo costituì un vero e proprio incubo per tutte le altre nazioni indiane dell’area dei grandi laghi. L’accusa di cannibalismo non è affatto pretestuosa, come si è affannata invece a dimostrare nella seconda metà del novecento l’antropologia terzomondista, e lo dimostra il fatto che i nostri testimoni non hanno esitazione a raccontare come questa pratica fosse fatta propria comunemente, nelle situazioni di necessità, anche dagli occidentali. Quanto al diritto sul suolo, gli Irochesi erano degli invasori al pari degli occidentali: arrivavano da un’altra area, non combattevano per difendere le proprie terre, ma per conquistare nuovi territori sterminandone sistematicamente gli abitanti.
Lo stesso vale per la complessa vicenda dello schiavismo. I diari degli esploratori africani ci mettono di fronte alla realtà di una pratica istituzionalizzata da millenni, tanto comune all’interno delle singole popolazioni quanto normale nei confronti di quelle esterne, e a quella di una tratta araba che ebbe sulla demografia del continente un impatto ben più devastante di quella europea, e che per motivi ideologici viene sempre sottaciuta o minimizzata. Certo, i portoghesi prima e poi via via tutti gli altri hanno intensificato questa pratica, hanno incanalato il flusso addirittura verso un altro continente: ma non hanno inventato nulla. Al più hanno fornito armi e incentivi per intensificare una tragedia presente da sempre, in ogni epoca e presso ogni civiltà: e a partire da un certo periodo, almeno dalla prima metà dell’Ottocento, hanno almeno teoricamente combattuto la tratta. Questo non assolve certamente l’occidente dalle sue colpe: spagnoli, inglesi, francesi, olandesi, belgi, tedeschi, e non ultimi gli italiani, si sono resi responsabili di veri e propri genocidi: ma quando Franzoj ci testimonia dal vivo (è arruolato più o meno a forza come osservatore) che nel corso di una delle periodiche campagne di guerra Menelik fa almeno cinquantamila morti e conduce via quasi il doppio di prigionieri, ovvero di schiavi, la storia lascia spazio a sfumature interpretative un po’ diverse.
Queste sfumature sono state volutamente ignorate nell’ultimo settantennio, a causa di un preconcetto ideologico, purtroppo radicato in quella che continua ad autodefinirsi “cultura di sinistra”, che ha condizionato costantemente la narrazione storica. Ti faccio un esempio. Nel 2008 è uscito in Francia il saggio Le génocide voilé (Il genocidio nascosto), di uno studioso di origine senegalese, Tidiane N’Diaye. In esso, con un calcolo certamente approssimato per difetto, N’Diaye dimostra che nel corso di tredici secoli, arrivando praticamente sino ad oggi, sono stati ridotti in schiavitù e deportati verso il Medio Oriente o verso la fascia mediterranea del continente almeno diciassette milioni di abitanti dell’Africa sub-sahariana. Di costoro, ed è questa la cosa che dovrebbe far maggiormente riflettere, non è rimasta praticamente traccia, mentre ad esempio negli Stati Uniti o nell’America del Sud i discendenti dei nove milioni di schiavi deportati tra il cinquecento e l’ottocento sono oggi più di settanta milioni. Ciò si spiega col fatto che gli schiavi deportati dagli arabi venivano castrati o uccisi, e non potevano lasciare alcuna discendenza. Ora, tutto questo non significa affatto che gli schiavi in America fossero trattati umanamente, non diminuisce lo scandalo della tratta: ma mi pare lecito chiedersi come mai si parli solo di quest’ultimo, e non dello schiavismo arabo, e come mai mentre questo scandalo la cultura occidentale lo ha bene o male denunciato ed esecrato, nessuno storico arabo lo abbia mai ammesso a carico del suo popolo. E anche perché questo dato venga costantemente ignorato in qualsiasi dibattito sulle colpe dell’Occidente.
L’altro aspetto, più personale, riguarda un possibile esito professionale che avrebbe potuto scaturire dai miei interessi. C’è stato un momento, al termine degli studi universitari, in cui ho dovuto scegliere tra strade diverse per il mio futuro. Forse non sarebbe cambiato nulla, ma forse una conoscenza di questi argomenti non legata più soltanto alle letture di Salgari e Verne o del vecchissimo Cantù mi avrebbe reso più determinato ad inseguire quella che era già allora una passione profonda (col rischio magari, come accade per ogni passione che diviene professione, di vedere poi spento ogni entusiasmo).
Ma torniamo all’oggi. I percorsi di questi ultimi anni mi hanno indotto a rivedere, almeno parzialmente, il giudizio negativo sull’attenzione riservata in Italia alla letteratura di viaggio che avevo espresso in “Perché non esiste una letteratura di viaggio in Italia”. L’assenza di interesse riguarda a quanto pare soprattutto il periodo del secondo dopoguerra (guarda caso, proprio quello della mia formazione). Gli italiani avevano un sacco di altre cose da sistemare e di cui occuparsi, e il clima culturale era tutt’altro che propizio alla rievocazione delle scoperte e delle conseguenti avventure coloniali. Ma nella prima metà del novecento, per le ragioni opposte, questo interesse c’era, e lo testimonia ad esempio una iniziativa editoriale della Paravia dedicata a I grandi viaggi di esplorazione, che contava decine e decine di titoli. Si trattava di operette divulgative, caratterizzate da un marcato taglio agiografico e intrise, soprattutto quelle degli anni trenta, dello sciovinismo di regime: ma avevano comunque il merito di portare all’attenzione degli adolescenti, e anche degli adulti, la storia delle esplorazioni e dei viaggi. E anche quello di proporre, accanto alle storie di Colombo, Magellano e Cook, quelle di Humboldt, Boggiani e Carlo Piaggia, e persino di Lodovico de Varthema. Le sto raccogliendo con cura, e una buona parte le trovi qui.
Sempre nella prima metà del secolo (ma anche nell’immediato dopoguerra) hanno goduto di una certa popolarità i libri di Vittorio G. Rossi (quella G puntata mi ha sempre fatto impazzire: essendo il mio secondo nome Giuseppe, ho continuato per anni a firmarmi Paolo G. Repetto, fino a quando esigenze di “razionalizzazione” dell’anagrafe non mi hanno costretto a tenermi un solo nome). Alcuni titoli sono davvero suggestivi (Pelle d’uomo, L’orso sogna le pere, Il cane abbaia alla luna). Rossi era uno scrittore atipico, almeno per l’epoca: di mestiere faceva altro, era un navigante, e in questa veste ha visitato praticamente tutto il mondo. Poi riversava nei libri (e tra il 1930 e il 1980 ne ha scritti più di due dozzine) quello che aveva visto e quello che aveva provato, dando spesso spazio, soprattutto nell’ultimo periodo, a considerazioni a ruota libera di filosofia spicciola. Per un sacco di tempo è stato lo scrittore di viaggio più venduto e più conosciuto in Italia, poi, complici da un lato una certa ripetitività e dall’altro l’ostracismo decretatogli dopo gli anni sessanta per i suoi trascorsi politici, è stato totalmente rimosso. Anche nel suo caso sto recuperando tutto il possibile. Prova a leggerlo. Non credo ti appassionerà, non è un grande scrittore, ed è chiaro che per me vale l’aura particolare della quale lo rivestivo da ragazzino, una sorta di precursore di Corto Maltese: ma è un ottimo testimone di come l’occidente guardasse al resto del mondo fino almeno alla seconda guerra mondiale, e del fatto che questo sguardo fosse meno velato dall’ipocrisia di quello dei futuri “terzomondisti”.
La riscoperta del piacere e del valore culturale del viaggio, alla quale già accennavo nell’articolo citato poco sopra ma che attribuivo soprattutto ad una moda di importazione, ha invece dato in questi ultimi anni dei frutti notevoli, non inferiori a quelli anglosassoni. Il merito va soprattutto ad autori come Paolo Rumiz, che con La leggenda dei monti naviganti ha toccato le vette della migliore letteratura di viaggio raccontando un fantastico itinerario dalle Alpi marittime alla Sicilia compiuto a bordo di una vecchia Topolino, seguendo a zig zag la dorsale appenninica, quindi la parte più sconosciuta e relativamente intatta della nostra penisola. Rumiz aveva già pubblicato il resoconto di un viaggio attraverso i Balcani in direzione di Costantinopoli (È oriente) ed ha poi proseguito nella riscoperta dell’Italia con Annibale. Un viaggio, una rivisitazione-confronto tra il passato e l’oggi sulle orme del grande condottiero cartaginese, per spostarsi infine nuovamente fuori dell’Italia con Trans-Europa Express, un itinerario che segue il vecchio confine della cortina di ferro dal circolo polare sino all’Adriatico. (In questo è stato preceduto però da Wilhelm Buescher, che in Germania, un viaggio percorre uno stralunato itinerario invernale seguendo l’ormai scomparsa linea di demarcazione tra est ed ovest).
Una traversata latitudinale completa della penisola è raccontata anche da Enrico Brizzi, sia pure con qualche eccessiva concessione al romanzesco, ne Gli Psicoatleti. Brizzi viaggia rigorosamente a piedi, e percorre preferibilmente i vecchi itinerari del pellegrinaggio, quelli per intenderci della via francigena o del Camino di Santiago di Compostela. Non so se ne abbia tratto ispirazione, ma ha dei precedenti illustri: nel 1801 lo scrittore tedesco J. G. Seume (altro bel personaggio: arruolato a forza nelle truppe vendute dal sovrano dell’Hannover agli inglesi per combattere in America, poi disertore, quindi ufficiale nelle truppe russe impegnate in Polonia, curatore di edizioni di classici, libero pensatore), si è fatto a piedi tutta la penisola, diretto a Siracusa, e lo ha poi raccontato in un gustosissimo L’Italia a piedi, ormai quasi introvabile ma che ho fortunosamente rimediato in un’asta mediatica.
Rimanendo nel campo dei camminatori, una scoperta sensazionale è stata quella di Patrick Leight Fermor, scomparso recentemente in tardissima età e protagonista di vicende degne di un Tonti. Nel corso del secondo conflitto mondiale Fermor venne impiegato dagli inglesi, per le sue conoscenze linguistiche e culturali della Grecia, come agente di collegamento con i partigiani ellenici che operavano a Creta. Bene, in quella veste organizzò e condusse a termine personalmente il rapimento del comandante delle truppe tedesche che occupavano l’isola, portandoselo a spasso per settimane in barba a tutti i rastrellamenti. Ma di possedere la stoffa Fermor lo aveva dimostrato già diverso tempo prima, a diciotto anni, quando intraprese da solo un lunghissimo viaggio a piedi che lo portò dall’Inghilterra a Costantinopoli, lungo la linea del Reno prima e del Danubio poi, attraverso un’Europa che stava appena entrando negli anni oscuri del nazismo. Di questo passaggio e del clima nel quale si stava svolgendo Fermor è un testimone anomalo e interessantissimo in Tempo di regali, dove raccoglie le ultime vestigia di un mondo, soprattutto quello asburgico, che stava ormai rapidamente scomparendo, e avverte tutte le inquietudini e le ombre di ciò che stava arrivando.
Altro formidabile camminatore, questo, come Rumiz, più o meno mio coetaneo, è Bernard Ollivier, un giornalista francese che al momento di andare in pensione si imbarca in un’impresa titanica, la traversata dal Mediterraneo alle porte della Cina attraverso l’Anatolia e il Medio Oriente, in pratica una variante dell’antica via della seta, resa ancor più ardua di quanto non fosse secoli fa dalla situazione politica interna ai diversi paesi. Il percorso è raccontato in una trilogia che comprende La lunga marcia, Il vento delle steppe e Verso Samarcanda.
Stavo però parlando della diffusione della letteratura di viaggio anche in Italia. È indubbia, i viaggiatori-narratori pullulano e le collane nelle quali possono trovare spazio si moltiplicano. Allo stesso tempo è in atto anche una riscoperta e ripubblicazione delle opere del passato che consente di avvicinare cose ormai scomparse addirittura dalla memoria (un caso emblematico è proprio quello di Lodovico di Varthema). A questa rinascita di interesse, a livello storico oltre che di pura evasione, ha dato un fortissimo contributo l’insieme dell’opera di Attilio Brilli, che per certi aspetti può essere considerato l’equivalente italiano di J. Leed, e per altri lo ha sicuramente sopravanzato. Brilli sta sfornando uno dietro l’altro studi avvincenti e documentatissimi sulla storia del viaggio, partendo da quello in Italia, dal Gran Tour sette-ottocentesco (Il viaggio in Italia, Quando viaggiare era un’arte, Un paese di romantici briganti, Il viaggiatore raffinato), per spaziare poi su tutto il globo con Il viaggio in Oriente, Mercanti e avventurieri, Dove finiscono le mappe.
È il segno di un passaggio di interesse, di una raggiunta maturità anche nei confronti di una pratica, quella del viaggio, che dagli italiani è stata sempre considerata piuttosto una costrizione che una scelta. Ma è anche, come tutte le forme di bilancio che si possono fare sulle varie attività umane, il segno di un suggello finale, la manifestazione della coscienza che un’epoca, e un modo di interpretarla, è ormai finita. E che può essere rivissuta, e rimpianta, solo attraverso le tracce lasciate sulla carta.