di Paolo Repetto, 1996
Per convincersi che l’alpinismo è una pratica settaria. è sufficiente considerare i parametri sui quali si gradua la militanza. Sono straordinariamente simili a quelli in uso tra i Catari, o tra i Filadelfi di Filippo Buonarroti (ma anche nelle Brigate Rosse). Come nelle conventicole ereticali e carbonare gli adepti si raggruppano in una struttura piramidale, che prevede gradi differenziati di frequentazione, di impegno e, conseguentemente, di autorevolezza. Si sale dai semplici simpatizzanti o apprendisti ai praticanti assidui, e di lì al vertice, costituito dai sublimi maestri perfetti. Allo stesso modo, si comunica attraverso una sorta di codice cifrato, si progredisce superando prove iniziatiche di crescente difficoltà, si abbraccia un’etica del sacrificio che arriva fino a prendere in considerazione quello supremo (quale alpinista vero non sogna, sotto sotto, la “bella morte” in parete?); e si assume anche, indubbiamente, quella disposizione snobistica che nasce dall’idea di una appartenenza minoritaria, di una pratica, e quindi di riflesso di una personale capacità e sensibilità, non comuni.
Questa disposizione accomuna tutti, indipendentemente dal livello delle prestazioni o dal tipo di approccio alla montagna, sportivo, professionistico o escursionistico che sia: direi che vale però in maniera particolare per i principianti, o per coloro che si limitano ad un tipo di frequentazione sporadica e poco “qualificata” quanto a difficoltà e impegno. Non che lo snobismo venga meno al di sopra di un certo livello, ché anzi, aumenta sino ad indurre uno spirito di casta: ma ha altre motivazioni, a volte fondate, spesso pretestuose, e comunque di ordine “interno” al gruppo (anche perché il “sublime maestro perfetto” opera di norma là dove gli “esterni” non arrivano nemmeno per caso). Il novizio o il simpatizzante agiscono invece ancora in una zona di confine, materialmente e metaforicamente, nella quale la differenziazione rispetto alle genti di pianura, ai discesisti e ai funicolaristi è ancora incerta, non evidente: sentono quindi la necessità di marcare questa diversità, vuoi nell’abbigliamento e nell’attrezzatura, vuoi nei comportamenti, vuoi soprattutto nell’atteggiamento mentale, e lo fanno per sé, prima ancora che per gli altri. Aspirano ad una ideale stella gialla che li renda immediatamente riconoscibili e accetti al gruppo, e li escluda nel contempo dalla massa.
Ma è proprio necessaria, e pertinente, una lettura in chiave sociologica, o addirittura esoterica, dell’alpinismo? Non è forse sufficiente un tramonto che irraggia le cime innevate, o il semplice piacere di un siderale silenzio, a giustificare una fede innocua, anche se non immune dall’integralismo? In effetti non è necessaria. Ma è interessante, e forse è più pertinente di quanto non appaia. Inoltre può riservare sorprese, soprattutto quando si abbia il coraggio di applicarla a se stessi.
Come alpinista io bivacco alle prime pendici della piramide. Mi sono accostato alla montagna molto tardi, ma con tanto entusiasmo, bruciando anche alcune delle normali tappe di avvicinamento: e tuttavia non sono andato oltre l’attacco della parete. Qualcosa ha sempre interferito nel mio rapporto con la montagna. Una volta il lavoro, un’altra la famiglia, un’altra ancora varie sorte di impegni. Credo però che questi siano in fondo solo alibi. La verità è che il rapporto non è mai stato chiaro, e che ho chiesto alla montagna risposte che non poteva darmi, oppure ho posto le domande nel modo sbagliato.
L’equivoco è nato probabilmente dalla singolare modalità del mio approccio, che è stato spirituale molto prima che fisico. Ho platonicamente amato l’idea della montagna prima della montagna stessa. L’attrazione risale all’infanzia, alle suggestioni create dalle favole ambientate tra le “montagne della neve”, come ho sempre sentito chiamare le Alpi da mio nonno e da mio padre, e dalle illustrazioni dei libri di fiabe sui quali ho cominciato a sognare. Ogni tanto, in giornate invernali particolarmente secche e limpide, o nelle mezze stagioni, all’indomani di violenti temporali che avevano ripulita l’atmosfera, quelle montagne mi apparivano dalle finestre di casa (il Monviso nella cornice del tramonto) o dal crinale del vigneto (il massiccio del Rosa, che nello splendore dell’alba prometteva fantastici “regni dei ghiacci”) e alimentavano sensazioni contraddittorie: da un lato uno struggente richiamo e dall’altro quasi il timore di violare un incanto.
Forse anche per questo, per una sorta di religiosa riverenza, sino a trent’anni a quei monti non mi sono nemmeno avvicinato, accontentandomi di surrogarli col Tobbio e con gli altri panettoni appenninici; ma nel frattempo il mio immaginario si dilatava e si andava riempiendo dei panorami alpestri tratti dai vecchi calendari svizzeri che mia zia mi regalava, delle Ande e delle Montagne Rocciose lette in Salgari o in London, degli stupendi scenari delle storie di Ken Parker o o di Jeremy Johnson. Da ultima era arrivata anche la letteratura, prima quella filosofica (Milarepa e i suoi esegeti occidentali, da Evola a Zolla), poi quella specificamente alpinistica (la casuale scoperta di Pete Boardman, e poi via via tutti gli altri).
Era inevitabile che quando arrivai a mettere piede su un ghiacciaio il mio zaino fosse talmente zavorrato da aspettative e sogni da rendermi impossibile una normale esperienza alpinistica. Non stavo compiendo un’ascensione, ma andavo ad inverare avventure e sensazioni e pericoli già vissuti mille volte, a ripetere itinerari già conosciuti e percorsi. E naturalmente, anche se scoprivo emozioni e luoghi straordinari, il risultato era alla fin fine inferiore alle attese. La fatica si rivelava più sorda, il freddo più intenso, il sudore più fastidioso, il rischio più subdolo: io, soprattutto, ero più vulnerabile e prosaicamente umano dell’eroe delle mie fantasticherie d’alta quota.
Mi ci è voluto del tempo per piegarmi all’idea che le rocce e le creste e le cenge e i seracchi che incontri sono diversi da quelli che popolano le tue fantasie, e che sei tu, se vuoi salire, e soprattutto ridiscendere, a doverti adattare. Ho dovuto cancellare quei picchi e quegli strapiombi che avevo immaginato a mia misura e somiglianza, e insieme l’immagine di me che aveva dettato la misura, per scoprire la gratificazione di una salita fatta in umiltà, compiuta senza dover dimostrare nulla a nessuno. Ma temo che la cancellazione sia stata solo parziale. Ciò che ancora non riesco ad accettare è il fatto che in montagna si trovi solo quello che ci si porta. Non mi attendevo rivelazioni, né di vacare le porte iniziatiche del Tutto, ma almeno di guadagnare qualcosa in termini di armonia con me stesso, di equilibrio. Invece ogni volta, trascorsa l’euforia da sforzo, da rischio e da altitudine, mi ritrovo più confuso ed irrequieto, combattuto tra la nostalgia di quello stato e la percezione della sua effimera artificiosità, così da non capire che cosa veramente mi attrae nel rapporto con la montagna.
Credevo che dell’alpinismo mi piacesse lo spirito di cordata, e mi sono trovato ad apprezzare soprattutto l’isolamento e la solitudine. Credevo mi piacesse il rischio, e invece ho constatato che mi piace solo la sfida con me stesso, il suo superamento: ma non è un piacere, me lo impongo. In fondo appartengo alla schiera di coloro che pensano che si possa arrivare in cima per la via più sicura: e tuttavia invidio coloro che ci provano e ci riescono per la più difficile.
Mi piace la fatica, ma non come liberazione. È un accumulo, una sorta di dovere, come fosse una pena purgatoriale nemmeno finalizzata al paradiso. È l’idea in sé di far fatica che insieme mi attrae e mi ripugna: e questo non riesco a capirlo. Ho letto e sentito le motivazioni più varie all’alpinismo, praticamente le condivido tutte, ma nessuna mi soddisfa in maniera esauriente. E mi ritrovo a parlare di montagna in maniera un po’ tartarinesca, più con i profani che con i praticanti, quindi più per sottolineare la mia diversità che per sancire un’appartenenza.
Nello scrivere queste cose mi accorgo che la mia distonia con l’alpinismo riflette molto bene quella che avverto rispetto alla vita in generale, alla cultura, allo studio, alle amicizie, alla partecipazione politica, ai sentimenti. Riflette una storia di rapporti sempre incompiuti o asincroni, falsati dal tentativo di far coincidere gli altri e l’esistente con un universo ideale di cui sono l’ordinatore, di far corrispondere ogni profilo ai contorni da me disegnati. Non credo si tratti solo di presunzione: temo sia qualcosa di molto peggio, una debolezza, una malattia dell’animo che mi rende incapace di reggere il non senso di questa vita, ma anche di accontentarmi di surrogati d’ogni sorta. Una malattia che nemmeno l’immobile ed eterna concretezza della montagna, nemmeno la brutale terapia di autocoscienza che essa impone a chi la frequenta, riescono a sanare: e che forse addirittura acuiscono.
E allora? Sospendere la cura? Ma neppure per idea. Anzi, come direbbe il passeggere leopardiano, voglio l’almanacco più bello, più caro, più illustrato che ci sia. Voglio continuare a sognare. E quest’anno voglio il Cervino!












 L’ipotesi è che esista un livello di solidarietà e di sintonia attingibile solo in sistemi relazionali unisessuali: e che ciò accada perché all’interno di tali sistemi ciascuno dei soggetti risulta più libero. Nessuno infatti, in una situazione almeno teoricamente paritaria, è indotto a farsi carico di un supplemento di responsabilizzazione, come invece automaticamente accade quando il rapporto coinvolge persone dell’altro sesso (e questo vale sia quando esista un coinvolgimento affettivo vero e proprio, sia a livello di semplice amicizia intersessuale). Sappiamo benissimo che si tratta di una generalizzazione, e che spesso la dinamica del rapporto si inverte. Sappiamo anche che questo atteggiamento nasce da un equivoco di fondo, da una presunzione di superiorità maschile e dal conseguente ruolo protettivo del quale il maschio si sente investito. Sappiamo tutto. Sta di fatto, però, che questo retaggio storico, a dispetto di ogni liberazione ed emancipazione, è divenuto un dato psicologico consolidato: e lo è, checché se ne dica, per entrambe le parti. Inoltre è abbastanza naturale che in situazioni di sodalizio intersessuale si creino complicazioni, intrecci, vincoli binari. Se la sintonia con un sodale di sesso opposto è perfetta, questa percezione si traduce prima o poi in un sentimento affettivo, che pur non sfociando necessariamente in un legame innesca la stessa dinamica. Diciamo dunque che in un sistema unisessuale ciascuno è più libero perché deve pensare solo a sé, e che ciò, paradossalmente, invece di creare sistemi difensivi, quali insorgono a salvaguardia dei rapporti di coppia, e tradursi in esasperato egoismo, ingenera una forma superiore di altruismo.
L’ipotesi è che esista un livello di solidarietà e di sintonia attingibile solo in sistemi relazionali unisessuali: e che ciò accada perché all’interno di tali sistemi ciascuno dei soggetti risulta più libero. Nessuno infatti, in una situazione almeno teoricamente paritaria, è indotto a farsi carico di un supplemento di responsabilizzazione, come invece automaticamente accade quando il rapporto coinvolge persone dell’altro sesso (e questo vale sia quando esista un coinvolgimento affettivo vero e proprio, sia a livello di semplice amicizia intersessuale). Sappiamo benissimo che si tratta di una generalizzazione, e che spesso la dinamica del rapporto si inverte. Sappiamo anche che questo atteggiamento nasce da un equivoco di fondo, da una presunzione di superiorità maschile e dal conseguente ruolo protettivo del quale il maschio si sente investito. Sappiamo tutto. Sta di fatto, però, che questo retaggio storico, a dispetto di ogni liberazione ed emancipazione, è divenuto un dato psicologico consolidato: e lo è, checché se ne dica, per entrambe le parti. Inoltre è abbastanza naturale che in situazioni di sodalizio intersessuale si creino complicazioni, intrecci, vincoli binari. Se la sintonia con un sodale di sesso opposto è perfetta, questa percezione si traduce prima o poi in un sentimento affettivo, che pur non sfociando necessariamente in un legame innesca la stessa dinamica. Diciamo dunque che in un sistema unisessuale ciascuno è più libero perché deve pensare solo a sé, e che ciò, paradossalmente, invece di creare sistemi difensivi, quali insorgono a salvaguardia dei rapporti di coppia, e tradursi in esasperato egoismo, ingenera una forma superiore di altruismo.


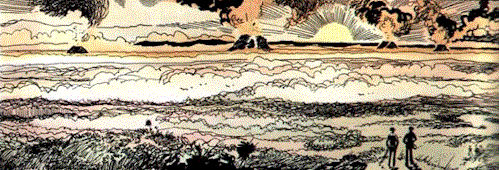


 La domanda suonerà superflua per chi il monte lo ha già salito, una o innumerevoli volte: o anche solo per chi è stato affascinato, nelle occasioni e dalle angolazioni più svariate, dall’inconfondibilità del suo profilo. Ma una spiegazione è dovuta a coloro che non hanno provato né l’una né l’altra emozione. Il Tobbio è diverso, è speciale: e intento della mostra, attraverso l’insistenza sulla sua immagine, è di celebrare una diversità da sempre avvertita, che ha rivestito di un’aura di sacralità e di leggenda una vetta accessibile e modesta.
La domanda suonerà superflua per chi il monte lo ha già salito, una o innumerevoli volte: o anche solo per chi è stato affascinato, nelle occasioni e dalle angolazioni più svariate, dall’inconfondibilità del suo profilo. Ma una spiegazione è dovuta a coloro che non hanno provato né l’una né l’altra emozione. Il Tobbio è diverso, è speciale: e intento della mostra, attraverso l’insistenza sulla sua immagine, è di celebrare una diversità da sempre avvertita, che ha rivestito di un’aura di sacralità e di leggenda una vetta accessibile e modesta.
 Quando rispunta sono alla terza sigaretta. Mi vede e fa cenno col braccio. Non rispondo. Continuo a fumare e a guardarlo. Non so se essere più irritato o sconfortato. Quasi due ore di ritardo dopo sole quattro di marcia.
Quando rispunta sono alla terza sigaretta. Mi vede e fa cenno col braccio. Non rispondo. Continuo a fumare e a guardarlo. Non so se essere più irritato o sconfortato. Quasi due ore di ritardo dopo sole quattro di marcia.