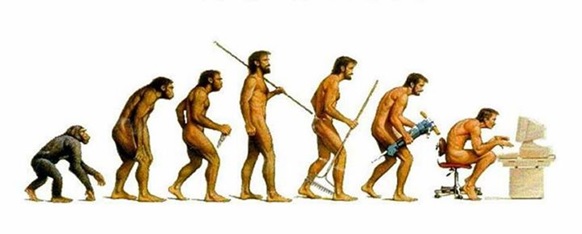di Paolo Repetto, 8 marzo 2021
Come anticipavo ne “Gli orfani del progresso”, allego quella che avrebbe dovuto essere la parte introduttiva di uno studio piuttosto ambizioso sull’argomento, concepito una quarantina d’anni fa a margine di una serie di conferenze e poi mai decollato, proprio per l’eccesso di ambizione. Del progetto sono rimasti solo questa introduzione, l’unica parte in qualche misura sviluppata, e un cumulo di appunti nei quali farei oggi una gran fatica ad orientarmi. Ripropongo questo scritto, sia pure incompleto e ancora a livello di bozza, perché strettamente inerente il tema trattato sopra, e perché trovo ancora pienamente condivisibili le considerazioni sviluppate all’epoca.
****
Le magnifiche sorti e progressive
Origini, apogeo e declino dell’idea di progresso
La nostra Zivilization è caratterizzata dalla parola “progresso”. Il progresso è la sua forma, non una delle sue proprietà, quella di progredire. Essa è tipicamente costruttiva. La sua proprietà consiste nell’erigere una struttura sempre più complessa.
Ludwig Wittgenstein
Premessa
“Tra tutte le civiltà, quella occidentale è la sola a coltivare le nozioni di una libertà individuale e di un progresso morale direttamente connessi, secondo la sua etica, al continuo perfezionamento delle tecniche di manipolazione e di dominio della natura. Proprio da queste nozioni l’Occidente ha tratto la sua potenza e la giustificazione della sua conquista del mondo, realizzata talvolta con la violenza e sempre, comunque, con la negazione di tutti i valori diversi dai propri che ha incontrato sulla sua strada.” (Gilles Lapouge)
La civiltà occidentale pone dunque il problema della sua unicità. È il problema che mi sono prefisso di affrontare in questa nuova serie di conversazioni e che cercherò di presentare da svariate angolazioni. Quella indicata da Lapouge costituisce il tema dell’incontro odierno. In sostanza porrò la questione in questi termini: qual è l’origine del movimento interno che anima l’occidente e lo spinge a modellare il mondo a sua immagine?
Io ritengo che le origini dell’ideologia che ha segnato la differenza della civiltà occidentale, e che noi riassumiamo nella nozione di “progresso”, vadano rintracciate in entrambe le culture delle quali essa è debitrice, quella giudaico-cristiana e quella classica. Credo anche che il fattore chiave per la nascita e l’affermazione di tale idea risieda in una particolare intuizione del tempo. Sono convinto infine che questa concezione, e il quadro complessivo di valori da essa determinato, pur essendo maturati nel corso di almeno due millenni, si siano affermati soltanto negli ultimi tre secoli.
So di non dire nulla di nuovo: c’è una fittissima bibliografia a dimostrare che queste tesi sono ormai acquisite. Ma temo si tratti di un’acquisizione in realtà ben poco diffusa al di fuori dell’ambito filosofico, o diffusa ad un livello solo superficiale. Nel corso della conversazione odierna cercherò dunque di giustificare nella maniera più chiara e più semplice, compatibilmente con l’argomento, i miei assunti, delineando brevemente la parabola dell’idea di progresso, rintracciando le matrici di quest’ultima, cogliendone l’apogeo e cercando di individuare le ragioni del suo recente declino. L’intento è quello di evidenziare un percorso intellegibile e conseguente dalla prospettiva soteriologica, cioè dall’attesa di salvezza, alla volontà di realizzazione qui ed ora della stessa, e di mostrare come una particolare concezione del tempo abbia condizionato negli ultimi tre secoli tutti gli atteggiamenti politici ed economici, etici e sociali, pubblici e privati dell’occidente.
Nel farlo utilizzerò un approccio che definirei attinente la “storia delle idee”, qualcosa per intenderci che non ambisce né alla dignità filosofica né al rigore scientifico, ma procede per quelli che Carlo Ginsburg ha definito “paradigmi indiziari”: questo dovrebbe ad un tempo giustificarne le modalità e delimitarne le finalità.
È possibile, con un approccio di questo genere, non esprimere giudizi di valore sul tema in oggetto, ovvero sulla nozione di progresso? Non lo so, ma vorrei provare a farlo, limitandomi ad indagare come essa nasce e dove conduce. Se qualche giudizio apparirà implicito, vorrà dire che non sarò stato sufficientemente bravo a trattare la nozione di progresso come una delle tante, al pari di quella di provvidenza, di fato, ecc…, che hanno caratterizzato e differenziato le diverse civiltà.

0.
Dal momento che il tema di questa conversazione riprende e sviluppa quello del seminario precedente (Da Pico a Bacone. Le origini umanistiche della mentalità scientifica), è forse opportuno riassumere per sommi capi le conclusioni cui ero già pervenuto. In quella sede mi ero concentrato sui cambiamenti che avevano interessato la mentalità occidentale tra il XV e il XVI secolo, preparando la strada alla rivoluzione scientifica. Avevo sostenuto la tesi che il mutamento dell’attitudine gnoseologica non è semplicemente la conseguenza delle innovazioni economiche e sociali maturate nel corso di tutto il medioevo, ma piuttosto una precondizione, che accoglie e sintetizza questi fattori in un grande movimento di trasformazione. Avevo inoltre affermato che questa trasformazione non prescinde dal pensiero religioso della cristianità, ma ne porta alle estreme conseguenze taluni aspetti mistici e messianici, trasferendo sulla terra quell’aspettativa di salvezza che in precedenza era rivolta al cielo. Mi ero soprattutto soffermato sulle modalità di conoscenza della natura, sulla posizione che viene assunta nei confronti del mondo materiale, posizione che irradia peraltro le sue conseguenze sulle concezioni artistiche, letterarie, politiche, oltre che scientifiche. In sostanza, avevo colto nell’attitudine giudaico-cristiana, che riprende e fa propri taluni aspetti della filosofia greca, l’origine di una diversa concezione della natura, e nel suo affermarsi progressivo verso la fine del medioevo la condizione per il passaggio alla nuova mentalità.
Il quadro che avevo cercato di delineare era pressappoco il seguente:
- Il presupposto teorico per l’avvento della rivoluzione scientifica è in sostanza il passaggio dall’aristotelismo medioevale al platonismo umanistico. L’aristotelismo è teoria della conoscenza come esperienza: si conosce quello che si esperisce attraverso la sensazione, e la conoscenza è una somma di dati sensoriali. Si disvela il mondo nella sua variabilità infinita, nella sua disomogeneità, e il tutto è tenuto assieme da un contenitore superiore, che è l’imperscrutabile volontà divina. Non ci sono leggi, in questo senso, non c’è serialità; al più c’è una ripetizione (i cicli naturali), che è mossa però da norme esterne, superiori, e non da un principio interiore.
Il platonismo è invece possibilità di conoscenza dei principi generali (l’eidòn). Il mondo delle idee è il mondo delle forme soggiacenti all’apparente disordine di superficie, è l’ordine nascosto in funzione del quale si manifestano i fenomeni. Nella sua accezione umanistica, che è filtrata attraverso il neo-platonismo e contaminata con l’ermetismo e la qabbalah, quest’ordine non è semplicemente un pallido riflesso della trascendenza, di quello ideale, ma è immanente alla natura e al mondo. In più, il platonismo umanistico è fortemente ibridato anche con l’aristotelismo, del quale conserva la validità dell’apparato sensoriale di raccolta dei dati. Quello che cambia è lo schema entro il quale sistemarli, e conseguentemente la finalità stessa della raccolta (ovvero, l’atteggiamento performante).
- Una volta accettata l’idea dell’esistenza di quest’ordine – il che avviene anche in conseguenza dello spostamento dell’osservazione dalla terra al cielo (la rivoluzione astronomica) – la tentazione di decifrarlo procede automatica. Penetrare i misteri della natura, invece di limitarsi a descriverne i comportamenti fenomenici, è già spirito scientifico. Questo spirito si manifesta dapprima nel tentativo di cogliere la forza vitale, attiva, che muove dall’interno il creato (Telesio e i filosofi della natura). Dio è già allontanato, non è più presente costantemente, ma è inteso come un creatore che ha dotato la propria creazione di forza autonoma, e alcuni degli esseri creati della capacità di riflettere sugli accadimenti (naturali e storici), di ricondurli ad un piano o ad un disegno e infine di assumere il controllo del piano stesso (dalla magia, nella quale il controllo si attua con strumenti naturali, alla scienza, nella quale invece il controllo è esercitato attraverso strumenti “artificiali”).
- Questa direzione, quella che vuole penetrare l’essenza per mettersi in sintonia totale con la natura, è quella percorsa lungo tutto il ‘500, fino a Giordano Bruno, dalla “magia naturalis”. In pratica si tratta di trovare le leggi intime della composizione e del divenire delle cose per accordarsi pienamente ad esse. Da Bacone in poi, invece, prevale un’altra direzione, anch’essa originata dal platonismo, che mira ad elaborare criteri funzionali di lettura dei fenomeni (le “leggi” scientifiche), quindi a creare parametri convenzionali, artificiali, che consentano di introdurre (e non di rinvenire) un ordine nel caos del reale.
In altre parole: assumendo quella che nel platonismo era considerata la forma perfetta di conoscenza (o la conoscenza delle forme perfette), quella matematica, si cerca di ricondurre a termini matematici la possibilità di conoscenza del mondo (ordine, pondere et mensura). Solo una conoscenza matematizzata, nella quale le cose siano numeri e grandezze e i fenomeni siano combinazioni di queste, ovvero operazioni, può diventare previsionale, e quindi operativa. Questo tipo di conoscenza si attua col passaggio dalla esperienza diretta della natura all’esperimento, cioè all’accadimento artificialmente riprodotto in laboratorio, in presenza di condizioni ambientali (spazio-tempo in primis) che rendono possibile la comparabilità. Le differenze di comportamento dei fenomeni debbono essere valutate sulla base di uno standard che non è intrinseco ai fenomeni stessi, ma è dettato convenzionalmente da chi li studia e li riproduce sulla base delle sue possibilità, delle intenzionalità di ricerca, della ricaduta pratica alla quale si punta. Dalla scienza naturale si passa quindi alla scienza sperimentale, che si dota di un metodo (Cartesio), di una strumentazione e soprattutto di un progetto (cioè di una direzione, di un senso).
Il passaggio cruciale si attua appunto con Galileo e Cartesio. Il primo impone definitivamente la lettura matematizzata e quantitativa della natura (“provando e riprovando”: la verità scaturisce dalla possibilità di ripetere infinite volte l’esperienza standardizzata in laboratorio), anche se ancora ritiene che le leggi siano intrinseche alla natura; il secondo fornisce letteralmente, rendendo la geometria suscettibile di analisi mediante l’algebra, le coordinate per una lettura matematica degli oggetti.
Perché prevale questo atteggiamento, rispetto ad esempio a quello di un Bruno, o di un Campanella? Perché di fronte alla liquidazione di tutte le certezze geografiche, astronomiche, religiose e politiche prodotta dal Cinquecento, e alla necessità di affrontare un mondo che si rivela del tutto ignoto, che non appare di per sé razionale e non è fatto di numeri e di misure, l’uomo prova paura. La summa di questo nuovo atteggiamento si attuerà poi nella fisica di Newton, che reggerà fino alla critica kantiana. Solo Kant chiarirà che “l’intelletto non attinge le sue leggi dalla natura, ma le prescrive a questa”.
In questo contesto compariva più volte, sia pure sullo sfondo, l’idea di progresso; prendeva forma cioè la coscienza, dapprima sfocata e poi, a partire da Bacone, sempre più nitida, del potenziale di miglioramento spirituale e materiale di cui l’umanità disponeva e dell’anelito ad una redenzione terrena che la animava. Si trattava però di una nozione confusa, ancora debitrice per la gran parte delle aspettative escatologiche, e dalla quale era assente la dimensione entro cui soltanto può esplicarsi l’idealità del progresso, quella storica. Quella della fede nel progresso è dunque una vicenda nuova, che ha se vogliamo un sacco di precursori ma che va letta a partire da un momento ben preciso, nel quale diventa decisiva. Il che ci impone di chiarire cosa implica questa nozione, prima di andare a indagare da dove nasce e come si sviluppa.
1.
L’idea del progresso umano nasce da un’interpretazione storica del passato – cioè dalla sua lettura secondo uno schema di continuità – che viene proiettata ad individuare una tendenza del futuro, e contemporaneamente dall’assunzione di questo futuro come campo non predeterminato, ma aperto. Si basa sul convincimento che gli uomini avanzino gradualmente verso una direzione definita, e che tale direzione sia desiderabile per tutti; e ne deduce che questa avanzata continuerà indefinitamente. Ciò implica da un lato che un giorno si perverrà ad una felicità generale, meta che giustificherà tutto il processo della civiltà, e dall’altro che questo processo è il risultato necessario della natura psichica e sociale dell’uomo, e non di una volontà superiore, trascendente o immanente (altrimenti l’idea di Progresso scivolerebbe in quella di Provvidenza).
Questa idea non è presente nella cultura occidentale delle età classica e medioevale, e nemmeno compare automaticamente con l’avvento della rivoluzione scientifica. Essa si afferma in verità piuttosto tardi, non prima del XVIII° secolo. Designa un movimento i cui caratteri sono la linearità e l’irreversibilità, e questo concetto è in contrasto con i modelli ciclici dei processi naturali, sociali e individuali che informavano il pensiero degli antichi. Proprio da questi modelli prendiamo ora l’avvio.
Immaginiamo l’umanità agli albori dell’epoca storica, nella fase del passaggio dall’economia nomade di caccia e raccolta a quella stanziale agricola. Ogni gruppo, ogni area abitata conosce una qualche forma di cultura religiosa, magari fortemente caratterizzata dalla situazione ambientale, ma apparentata alle altre dal fatto di rispondere ad un bisogno primordiale e connaturato. Intendo dire che questo bisogno può nascere dalle esperienze più diverse, ad esempio da suggestioni visionarie, da momenti di delirio, ecc … : ma fondamentalmente è connesso ad una “rivelazione originaria”, nel senso della predisposizione ad attribuire una “intenzionalità” agli oggetti, animati o inanimati. L’intenzionalità suppone un’anima, uno spirito: quindi comporta il riconoscimento di una “interiorità” anche agli altri (e, in una prima fase, alle cose). Questa intenzionalità è applicata alla coscienza, sia pure indistinta, della morte, e si esprimeva in prima istanza soprattutto attraverso il culto degli antenati.
C’è un termine, la parola “mana”, che designa questo atteggiamento unificante dell’uomo di fronte all’universo, un universo che lo comprende. Il mana è una struttura della coscienza, che lo spinge ad agire intuitivamente come se gli oggetti circostanti fossero pieni di impulsi verso di lui. Questa primordiale struttura della coscienza può produrre due atteggiamenti, quello magico e quello religioso. Il primo tende ad utilizzare le forze impersonali della natura, il secondo a personalizzare queste forze. I due atteggiamenti naturalmente coesistono, hanno origine da un fondo comune, ma a seconda del loro prevalere conducono in direzioni diverse. L’atteggiamento magico conduce, prima ancora di tradursi in scientifico, all’ateismo: l’altro, naturalmente, alle fasi successive dell’evoluzione religiosa.
La prima fase può dunque essere definita mitica. L’uomo attribuisce alle cose delle intenzioni che cerca di sfruttare a proprio vantaggio: non si pone razionalmente problemi del perché e del percome, semplicemente vive immerso nel mito, non fa distinzione tra sacro e profano.
Dopo questa fase, subentra l’autocoscienza: questo porta a separare, e conseguentemente ad analizzare, ciò che prima era vissuto come una totalità indistinta: si comincia ad opporre sé al mondo, il sacro al profano, il mito vissuto a quello pensato. Il risveglio della coscienza determina una separazione dal mondo della natura. La coscienza separa, è la divisione primordiale. Il sé e il mondo cessano di essere ovvi, e questo induce un bisogno di affermazione esplicita e di stima.
La concettualizzazione del mito ne fa una realtà autonoma, strutturata dall’intelligenza. Il mito diventa un oggetto simbolico, riorganizzato in un complesso di scritture sacre. Questa separazione, la dissoluzione dello stato mitico primordiale, crea nell’uomo angoscia e inquietudine, la percezione di una frattura col proprio ambiente. La religione è un tentativo di colmare il vuoto che si è aperto, di ritrovare grazie al sacro l’età dell’oro, il paradiso terrestre. Il mito religioso e teologico stabilisce un legame con il sacro: crea un modello esemplare per tutte le azioni umane rilevanti, consentendo la loro conformità al volere divino. Il mito fonda l’archetipo dei rituali religiosi, mediante i quali il tempo e la frattura originaria sono cancellati. La ripetizione ha per conseguenza l’abolizione del tempo profano e la proiezione dell’uomo in un tempo magico religioso che non ha nulla a che vedere con la durata propriamente detta, ma costituisce l’eterno presente del tempo mitico. La ricomposizione di questa frattura, la ricerca dell’unità perduta, daranno origine a due nuovi atteggiamenti, quello religioso e quello scientifico. Al fondo di entrambi c’è l’intervento dell’intelligenza, della ragione: e questa finisce per ridurre sempre più lo spazio della rivelazione, quando da strumento ausiliario diventa quello principale. La spiegazione razionale finisce per demolire i miti della fede. Inoltre, quanto più il mito religioso viene interiorizzato, e la religiosità diventa questione personale, tanto più il “sacro” viene frantumato, diventa sentimento interiore.
Il problema che ora ci si pone è pertanto: perché solo, o almeno precipuamente, in occidente ha prevalso l’atteggiamento di superamento dello stadio religioso?
In Occidente si danno due momenti chiave di questo superamento. Uno è legato alla cultura ebraica, l’altro a quella greca. Le spiegazioni di questa diversità sono molteplici, ma seguendo Martin Bernal si può arrivare ad una matrice unica. L’atteggiamento sarebbe fondamentalmente lo stesso, e avrebbe origine nella cultura semitica, salvo poi svilupparsi diversamente nei diversi contesti.
Le società antiche (che chiameremo tradizionali) erano strutturate sulla base di archetipi mitici (l’età dell’oro, il paradiso terrestre, ecc…), nel senso che facevano ascendere a modelli primordiali la giustificazione delle loro strutture sociali e istituzionali. Vivevano lo scarto tra la realtà e il mito come conseguenza di una colpa o di una profanazione, ed erano costantemente tese ad un riavvicinamento alla perfezione delle origini, prolungando ritualmente il momento primordiale della fondazione. Ciò significava rimanere disperatamente ancorate al presente e rivolte al passato, nel ricordo del tempo in cui l’uomo viveva in comunione con l’invisibile, integrato nell’universo (l’età dell’oro): ma a dispetto della ripetizione dei riti di consacrazione esse non potevano vedere che alterata nel tempo la loro purezza, ovvero la loro fedeltà al mito. Con ogni forza pertanto volevano evitare quei cambiamenti che, allontanandole dalla perfezione mitica, rischiavano di accentuare maggiormente lo squilibrio nato dalla rottura del grande interdetto, quello che noi chiamiamo peccato originale.
Di fronte a situazioni nuove le società tradizionali reagivano quindi con tutta una serie di meccanismi compensatori, destinati a salvaguardare il loro equilibrio. Ogni società rimaneva uguale a se stessa così a lungo da poter mantenere negli individui che la componevano la coscienza diffusa di partecipare della sua immortalità, anche integrando al patrimonio comune le nuove acquisizioni. Nei suoi rapporti con la società l’individuo era come una delle tessere che compongono un mosaico, il colore, la forma e la posizione delle quali non possono spiegarsi se non in funzione dell’insieme. Il risveglio della coscienza individuale, del libero arbitrio era impossibile in un ambiente sociale che condizionava l’individuo dalla nascita e gli insegnava a confondere le leggi e i costumi con una “necessità”.
Nelle civiltà pre-cristiane insomma, e segnatamente in quelle orientali, i popoli erano più testimoni che attori degli avvenimenti che si producevano nel tempo. Vivevano in una sorta di incantesimo, nel quale ogni anno riproduceva quello precedente e il tempo girava su stesso, riproponendo le sue feste, i suoi massacri, il suo eterno ritorno. Questo ordine universale non andava turbato e il corso delle cose non doveva essere ostacolato, perché ogni intervento non poteva originare altro che male. Dal momento che gli eventi erano governati da una loro intima legge, risultava vano per l’uomo perseguire qualsiasi fine. Come afferma Eliade[1], nella vita del genere umano i popoli si sono per lo più aggrappati all’idea del ciclo temporale, nel quale il passato è futuro, non esiste una vera storia e l’umanità si dispone a rinascere e a rigenerarsi.
In tutta l’antichità l’idea di una decadenza successiva all’età dell’oro iniziale[2] – e quella, ad essa strettamente collegata, di un ritorno ciclico – hanno dunque impedito lo sviluppo di una autentica nozione di progresso. Ciò vale sia per la versione “cosmologica” dell’Eterno Ritorno, quella che prevede una distruzione e ripetizione puntuale di tutto il ciclo (più diffusa nella mentalità orientale, e sostenuta, nel mondo occidentale, soprattutto dai pitagorici), sia per quella “storica”, che prospetta invece una palingenesi, intesa come aetas assolutamente nuova, novum saeculum, quindi non ripetizione ma rigenerazione. In entrambi i casi l’umanità non ha alcun ruolo nel determinare gli eventi. È sovrana la legge di natura.
La rottura di questo incanto paralizzante avviene ad opera di due diversi popoli, che per motivi e in modi differenti danno una svolta all’attitudine nei confronti della conoscenza. I loro modelli di pensiero si sviluppano dapprima separatamente, ma vengono poi a convergere nella sintesi romano-cristiana, dando vita a quella cultura e a quella civiltà che definiamo “occidentale”.
Uno di questi popoli è naturalmente quello greco. Per ragioni politico-economiche (la strutturazione territoriale in piccole unità, nelle quali si afferma la prima forma di democrazia), ma anche in virtù di una particolare concezione religiosa (una religione naturalistica, nella quale la divinità non è altro che una proiezione dell’uomo – per cui non è insondabile, e per arrivare ad essa non è necessario negare se stessi) l’idea greca di sapienza, di conoscenza non è in linea con quella puramente contemplativa delle culture tradizionali. È già un’idea di ricerca, fondata su un sapere in divenire (ricerca del sapere, philosophia, appunto) che non ammette verità rivelate ed immutabili, ma è al perenne inseguimento della verità delle cose al di là delle apparenze. Ed è un sapere aperto a tutti, non patrimonio delle caste sacerdotali privilegiate e non trasmesso per via iniziatica.
Gli indizi di una “differenza” greca sono svariati, e sono già percepibili nella narrazione del primo scontro tra la civiltà occidentale e quella orientale, quello descritto nell’Iliade, riferito peraltro ad un’epoca nella quale le democrazie erano ancora ben lontane dall’affermarsi. In quel contesto il modello di potere orientale è rappresentato da Priamo. Un potere apparentemente assoluto, in realtà nullo. Priamo è solo la voce di un oracolo, non decide ma registra, enuncia una volontà superiore, il disegno del Fato: e in pratica assiste impotente alla rovina del suo popolo. Un oracolo non si rivolge al futuro, discopre solo ciò che è presente, che è già deciso. Agamennone prende invece delle decisioni, le sue azioni non sono già decise, dipendono dalla volontà e dagli umori, suoi ma anche e soprattutto dell’assemblea. Sarà perché combattono in trasferta, lontani dai loro luoghi sacri, e quindi dai vincoli e dai rituali della tradizione, ma i Greci sono liberi, e le loro sono scelte vere. In qualunque momento possono prendere decisioni diverse per quello successivo, e il fatto che si diano diverse possibilità è testimoniato proprio dalle dispute che si accendono ogni volta che è necessario decidere.
L’agire o il pensare al di fuori dei luoghi sacri tradizionali sembra decisivo per l’emergere di una diversità ellenica. Come agiscono liberamente i guerrieri di Omero, pensano liberamente i filosofi ionici o gli eleati. Il pensiero filosofico greco nasce lontano dalla Grecia, in uomini che si sono laicizzati, hanno messo il mare tra sé e i luoghi delle epifanie del sacro, si sono sottratti ai recinti magici della tradizione e della ritualità, venendo a contatto con altri modelli di pensiero e altre tradizioni e sviluppando nei confronti di queste uno spirito critico e scettico che non tarda ad intaccare anche le loro credenze mitiche.
Ma ci sono anche altre possibili letture del tema del distacco. Ad esempio, secondo Karl Jaspers l’occidente non si è sempre necessariamente inteso come centro, ma piuttosto come parte, come appendice staccatasi dalla matrice asiatica attraverso una diaspora lacerante (le migrazioni indoeuropee? gli echi di questa concezione si trovano comunque in effetti già in Platone, e successivamente soprattutto nella collocazione orientale di terre felici ed edeniche). L’antitesi oriente-occidente sarebbe pertanto costitutiva della cultura europea: la pretesa di quest’ultima di riplasmare il mondo con la sua opera avrebbe radice nel senso di mancanza e di incompletezza.
Altri segni di questa diversità vengono ancora dalla concezione politica. Mentre nella società tradizionale l’ordine politico risulta perfettamente adeguato all’ordine cosmico, in quella greca le cose vanno diversamente. Non è soltanto lo strutturarsi delle varie città in forme istituzionali diverse a dircelo. C’è proprio un atteggiamento di fondo, che ritroviamo ad esempio nella elaborazione di progetti urbanistici ideali, nei quali la città (e in questo caso essa si identifica con lo stato) è calcolata dagli uomini per gli uomini. Nella cultura tradizionale le città erano segni disseminati dagli dei sulla terra per celebrare la propria signoria e trasmettere in linguaggio cifrato i loro disegni. Ora, sostituendo alla architettura fatale della tradizione l’ordine governato della città ortogonale, si pronuncia un giudizio sull’universo ordito dagli dei. In pratica si dice che questo universo è piuttosto mal concepito, e che l’uomo deve metterci mano per migliorarlo. Il creatore viene così relegato nei suoi lontani domini, e la dimora degli uomini rimane competenza di questi ultimi.
La cultura greca viene dunque ad infrangere un ordine mentale che, pur nelle differenze e nella varietà dei costumi e delle credenze, era sostanzialmente simile per tutti (o quasi, come vedremo) i popoli dell’antichità. E questo è indubitabile. Ma la mentalità nuova che i Greci portano non è ancora permeata dell’idea alla quale stiamo dando la caccia, della nozione di progresso.
Presso i greci infatti il progresso rappresentava una mera categoria relazionale (prokopè, termine che compare nel IV secolo a.C.). L’idea del progredire (prokoptein) indicava un mutamento correlato a settori determinati, fossero essi la scienza, la tecnica o anche lo sviluppo etico del singolo. Di conseguenza la dinamica progressiva si ritrovava incapsulata entro contesti specifici, oppure rivestiva un carattere puramente comparativo-descrittivo, ma non stava in nessun caso ad indicare un processo storico a carattere generale. Analogamente, progressio e progressus hanno sempre avuto presso i latini un’accezione materiale e non innovativa: indicavano il semplice fatto del procedere.
La verità è che nel mondo classico manca uno dei presupposti fondamentali per la nascita di un’idea di progresso: quello della constatazione di una effettiva messe di innovazioni. Si intuisce, a partire già da Eschilo e da Euripide, che in tempi remoti si viveva nella barbarie: ma permane, dominante, l’idea di un regresso dall’età dell’oro. Sia Democrito che Epicuro immaginavano che ciascun mondo dell’universo con i suoi abitanti si evolvesse, decadesse e si riformasse ancora. Il progresso cosmico, considerato nella sua globalità, si riduceva quindi ad una oscillazione attorno ad un punto fisso, senza presentare alcuna evoluzione cumulativa. Lo stesso Platone parla di ere della durata di 72000 anni, nel corso delle quali fino a metà si conserva l’ordine originario, poi subentrano la decadenza e la degenerazione. Anche la riflessione filosofica, almeno nel senso ampio nel quale oggi noi la intendiamo, è quindi, se non impedita, decisamente limitata. I filosofi dell’antichità potevano al più tentare di modellare, di fronte alla crisi, o addirittura alla distruzione delle strutture tradizionali, nuove strutture più stabili, meglio protette contro i pericoli esterni o contro la corruzione interna, ma sempre di “quelle” specifiche strutture si trattava. In Platone, in Aristotele, non c’è mai l’idea di un ordine che possa essere esteso all’ecumene intero, di un percorso possibile per tutta l’umanità futura. Entrambi, poi, sono contrari ad ogni deviazione da un ordinamento politico costituito, intesa sempre come una degenerazione, e quindi all’idea di un perfezionamento sempre in fieri.
Ciò che soprattutto inibisce lo sviluppo di una visione progressiva è la concezione del tempo. Nell’epoca premoderrna il computo del tempo è fortemente determinato da ciò che si vuole che il tempo significhi. I parametri vengono fissati in funzione delle esperienze acquisite, del vissuto presente e delle aspettative per il futuro. L’attenzione ruota attorno agli aspetti qualitativi del tempo, di conseguenza alla durata, piuttosto che a quelli quantitativi, cioè alla misurabilità. Quello che importa determinare sono le ere, e non il valore dei nanosecondi.
Le prime misurazioni del tempo sono certamente collegate alla necessità di prevedere la comparsa della pioggia o del sole, o il regime periodico dei fiumi, per controllare e assicurare il rinnovo delle riserve alimentari, per organizzare la continuità dei mezzi di sussistenza della comunità. Le primissime società racchiudono perciò il tempo in norme rigorose, fissate da vari miti e dalle esigenze dell’agricoltura e dell’allevamento.
Platone afferma che dare un nome al tempo, suddividerlo e contarne le parti significa per l’uomo tentare di tradurre l’eternità nella propria caducità. E’ quanto già pensavano i Parmenidei (i paradossi di Zenone di Elea). Nel Timeo distingue tra l’Essere e il divenire. Il mondo dell’Essere è un mondo reale, apprensibile dall’intelligenza mediante ragionamento perché è sempre allo stesso modo, mentre il mondo del Divenire (il regno del Tempo) è opinabile dall’opinione mediante la sensazione irrazionale, “perché si nasce e si muore, e non è mai veramente”. Dal cosmo l’uomo deduce una sequenza di segni, la cui realtà originaria e indivisa supera la sua capacità di comprensione. Allontanando il tempo nella direzione doppiamente inaccessibile dei simboli religiosi e matematici Platone crea un modello che in Occidente ispirerà le élites religiose e politiche sino alla modernità.
Nemmeno Aristotele si discosta da questa concezione. La sfera celeste è quella in cui regnano la necessità, la legge, il numero, la regolarità. In quella sublunare gli eventi sono assurdi e il futuro è imprevedibile, regnano il caos e la libertà, o almeno leggi così nascoste, numerose e contraddittorie che non si riesce a venirne a capo. Liquida quindi il problema affermando che il tempo è eterno e circolare, e tutte le cose sono disseminate lungo la sua circonferenza[3].
Il mondo latino eredita integralmente le concezioni elleniche, filtrate magari attraverso l’epicureismo e lo stoicismo. Sia in Lucrezio che in Seneca c’è la coscienza di un aumento delle conoscenze rispetto alle epoche precedenti, e magari l’aspettativa di ulteriori innovazioni; ma tutto questo ha un senso solo per la conoscenza in sé, per i filosofi, e non per l’umanità nel suo complesso. E comunque è sempre presente l’idea del collasso finale. “I nostri figli non vedranno mai nulla di nuovo, così come i nostri padri non videro mai nient’altro che ciò che vediamo noi stessi.” (Marco Aurelio)
Lo stesso avviene per il pensiero cristiano antico, anche se una innovazione è costituita dall’introduzione in Sant’Agostino (De civitate Dei) del procursus, concetto in contrasto con la teoria classica del ritorno ciclico. Quest’ultima non è però contestata sul terreno cosmologico, quanto piuttosto da un punto di vista teologico-morale, in quanto l’idea di una decadenza e di una rigenerazione che si ripetono all’infinito sottrae all’uomo la dimensione della speranza in una felicità finale. Agostino si oppone però al calcolo del tempo, ovvero alla fusione di tempo e numero. È tra i primi a porsi il problema della percezione psicologica del tempo, ma diffida della sua matematizzazione (e di tutto ciò che concerne la matematica, che gli appare come un tentativo sacrilego di attingere alla perfezione divina): ciò a dispetto, o meglio a riprova, di una concezione dell’opera divina come ordinata secondo numero, misura e peso.
Con Boezio e Cassiodoro abbiamo invece una celebrazione della matematica come fondamento della conoscenza: per il primo la natura originaria delle cose è modellata secondo numeri ragionevoli, per il secondo l’uomo si distingue dagli animali proprio per la capacità di “calculi intelligere quantitate”.
In realtà per tutto l’alto medioevo il problema che viene posto è quello del “computus”, cioè del calcolo del tempo, e non della misurazione. Quest’ultima si era sempre fatta con gli horologia (solari di giorno e ad acqua di notte), ed aveva interessato la sfera pratica, non quella teorica. Ma il dibattito che si sviluppa lungo tutto questo periodo finisce per coinvolgere anche la misurazione. Gregorio Magno, ad esempio, accomuna l’uno e l’altro in un’unica condanna, sulle orme di Agostino.
Con Agostino siamo però già andati troppo oltre. Occorre risalire all’indietro, per individuare l’altra sorgente dalla quale scaturiscono le premesse per la teoria del progresso. E l’altra fonte, l’altra cultura che rompe decisamente con la tradizione è quella giudaica. Il pensiero occidentale nasce anche e soprattutto con la marcia di Israele verso la terra promessa e con l’attesa della venuta di un messia. Nasce apparentemente da una contraddizione, perché il popolo che maggiormente contribuisce alla definizione di una modernità è un popolo nomade, che discende almeno moralmente da Abele, il pastore, e che è costantemente in conflitto con gli agricoltori discendenti di Caino, cioè con le popolazioni stanziali che lo circondano. Il paradosso sta in questo: mentre le popolazioni nomadi operano nella dimensione dello spazio, il quale non oppone alcuna limitazione e apre possibilità sempre nuove, i sedentari, costretti nello spazio di un dominio strettamente limitato, per quanto ampio sia, sviluppano la loro attività in un continuum temporale che appare loro indefinito: in altre parole, progettano e costruiscono per un futuro. I primi, inoltre, si rapportano prevalentemente al regno animale, anch’esso nomade, mentre i sedentari hanno come oggetto della loro attività i due regni fissi, quello vegetale e quello minerale (e quindi le loro attività sono, prevalentemente, la costruzione e la metallurgia). Storicamente, i sedentari assorbono i nomadi: nel corso delle età il tempo inghiotte lo spazio, affermando in tal modo la sua natura di “divoratore” (il mito di Kronos) e di uccisore (Caino, che compie sacrifici vegetali, uccide Abele, sacrificatore di animali). Ma questo avviene solo sul piano materiale: su quello spirituale, invece, la situazione si capovolge. I sedentari sono infatti portati ad adottare dei simboli visuali, a edificare strutture e a forgiare, plasmare, dipingere, scolpire opere durevoli, immagini fatte di sostanze diverse, le quali si riconducono però più o meno direttamente allo schematismo geometrico, origine e fondamento di ogni struttura spaziale.
I secondi invece, a cui le immagini sono vietate (cfr. ebraismo e islamismo), così come è vietato tutto ciò che tenderebbe a radicarli in un luogo determinato, si costituiscono dei simboli sonori, i soli che siano compatibili con il loro stato di migrazione continua. Paradossalmente, fra le facoltà sensibili la vista è in rapporto con lo spazio, e l’udito con il tempo: gli elementi del simbolo visuale si esprimono in simultaneità, quelli del simbolo sonoro in successione. Si opera in tal senso un rovesciamento delle relazioni in campo simbolico. I sedentari danno vita alle arti plastiche (architettura, scultura, pittura), cioè alle arti delle forme che si dispongono nello spazio: i nomadi danno vita alle arti fonetiche (musica e poesia), cioè alle arti delle forme che si sviluppano nel tempo. L’esilio perenne, l’erranza secolare verso la terra promessa fanno cadere per il popolo ebraico la necessità di quel tracciato magico, consacrato dall’opera edificatoria e dai simboli visivi, che reintegra l’uomo nell’universo e lo imprigiona nei riti, mentre lo conducono a dare valore sacrale alla parola, al verbo, e alla sua trascrizione. Può suonare singolare un’affermazione del genere, riferita ad uno dei popoli che pare maggiormente attaccato ad un suolo particolare e alla celebrazione del rituale: ma in verità quello ebraico non è il popolo di una terra, bensì di un libro: porta con sé, nei suoi rotoli della Legge, la sua sacralità, e dovunque esso è, lì è terra d’Israele.
Allo stesso modo il nomadismo, l’originaria vocazione pastorale degli Ebrei, è anche alla base dell’adozione da parte di questi ultimi di un primordiale sistema lunare di divisione del tempo: il calendario ebraico, strutturato in base ai bisogni dei pastori, era (ed è tuttora) fondato sul mutevole aspetto della luna nelle sue fasi, mentre quello egizio era indirizzato ai lavori dei contadini, e quindi orientato sulla presunta orbita del sole nel corso delle stagioni.
Il giudaismo porta con sé anche la certezza della salvezza finale per la promessa di Dio, l’attesa dell’avvento del Messia alla fine dei tempi. Questo pensiero, questa speranza non può che distruggere ciò che è volto al passato, o anche semplicemente ancorato al presente. La promessa di un Messia rompe l’incanto dell’eterno ritorno: il messia annunciato è un dio storico, l’evento atteso si annuncia come unico, irripetibile, definitivo. Crea una tensione, un’aspettativa di cambiamento volta al futuro. Il tempo diventa attesa dell’imminente e del possibile, al mondo viene assegnato uno scopo. E nel distendersi della curva dei secoli, come essa si scopre un fine, si inventa anche un’origine. Diventa una linea, una direzione. Gli avvenimenti non si sciolgono più gli uni negli altri, ma si dispongono come tasselli di un edificio. La Bibbia non è stata letta per secoli dagli ebrei come mito di creazione del mondo, ma come un manifesto rivoluzionario pieno di profezie considerate come altrettante allusioni a tutti i periodi di crisi, a tutti gli esili, a tutte le cattività. Degli uomini – a milioni – hanno creduto e credono ancora di vivere la fine dei tempi annunciata dai profeti, salutando ogni tribolazione come un segno precursore degli ultimi giorni, l’anticamera insanguinata dell’età novella: il regno dei giusti.
Dato che il tempo non è più ciclico ma a senso unico e irreversibile, è ora possibile la storia personale e una vita individuale può avere il suo valore. L’essere umano in quanto pedina sta cedendo impercettibilmente il passo a una più esaltata visione di ciò che l’essere umano è. Le conversioni al monoteismo saranno individuali, ed è questo che disgrega le strutture tradizionali.
In tutta la narrazione biblica è presente una dimensione che manca nelle narrazioni mitologiche degli altri popoli: quella della tentazione. Dio mette alla prova costantemente la capacità di scegliere dell’uomo. Si comincia con Adamo, si prosegue con Caino, si arriva ad Abramo. Nella vicenda di Abramo il rapporto con la divinità diventa davvero la storia di un rapporto interpersonale. Questo nasce prima di tutto dal senso spiccato della propria personalità che Abramo possiede. Ragiona come un individuo, non come la tessera di un mosaico. Nell’episodio di Isacco Dio dà e prende al di là di ogni ragione e di ogni giustificazione. Poiché le sue ragioni non sono interpretabili e i suoi pensieri non sono prevedibili, tutto e niente è possibile. Quindi la fede prende il posto della generalizzata prevedibilità del mondo antico, con la possibilità di autentico successo o di autentico fallimento: cioè, è un autentico viaggio il cui esito deve ancora darsi.
Un altro tema distintivo che caratterizza entrambe le culture alle quali ho fatto riferimento è quello dell’autorità. Per motivi e in modi diversi l’autorità politica viene distinta da greci ed ebrei da quella religiosa. Nel secondo caso non esiste nemmeno, a dispetto del monoteismo, una vera autorità religiosa, ma solo un criterio di autorevolezza: e questo anche all’epoca dell’esistenza di uno stato ebraico. La storia ha poi fatto si che il problema non si ponesse, e che gli ebrei mantenessero sempre un rapporto decisamente ambiguo con le diverse forme di autorità alle quali erano di volta in volta e di luogo in luogo soggetti: e tuttavia è unica la loro capacità di mantenere un’unità religiosa in assenza di una autorità riconosciuta. O forse tutto questo è frutto del particolare modo di accostare la verità religiosa, e cioè dell’approccio individuale e non mediato, o quasi, al contrario di quello cristiano che è mediato da una autorità o rappresentanza, che si arroga l’interpretazione ortodossa dei testi.
Per quanto concerne la cultura greca, qui è proprio la religiosità stessa, il politeismo piuttosto tiepido a non consentire l’instaurazione di una autorità religiosa e la commistione di autorità politica e autorità religiosa.
L’accento sulla individualità ha dunque questa duplice matrice. Non a caso poi passa attraverso la riforma protestante (ciascuno è sacerdote di se stesso), che nasce anche dai nuovi studi filologici del verbo testamentario incentivati dalla diffusione del qabbalismo (Reuchlin). Il rapporto non sacrale, ed anzi antitetico, degli ebrei con l’autorità è il terreno sul quale può svilupparsi una concezione convenzionalistica della stessa, l’idea del patto sociale e del diritto individuale che salvaguarda il singolo nei confronti di un potere accettato solo come formale.
Anche la concezione del tempo è naturalmente influenzata da questo rapporto con l’autorità. Valorizzando il significato e l’azione individuale, si è portati a leggere e privilegiare il tempo personale nei confronti di quello collettivo, a cercare di dar senso e di riempire di significati il proprio vissuto: significati che si traducono in esperienze nuove, invece che in ripetizioni, in azioni che distinguono, invece che in rituali che accomunano, in creazioni ed opere che rimangono, che forzano la natura e introducono la novità. (…..)
[1] Mircea Eliade, Trattato di storia delle religioni, Bollati Boringhieri, 1999
[2] Viene espressa ad esempio nel mito platonico di Er, nella Repubblica, ma anche nel Timeo
[3] Aristotele, Fisica, IV



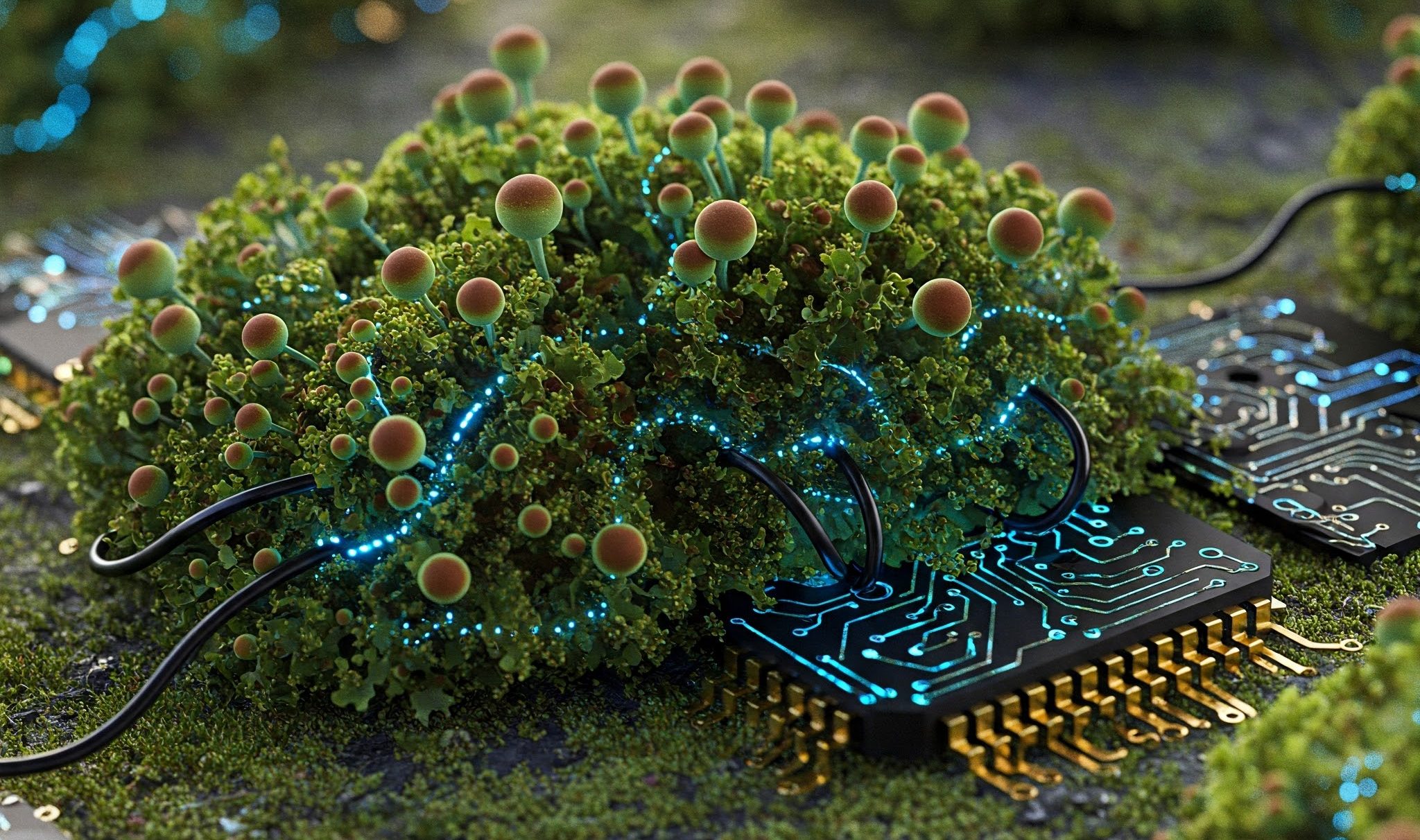
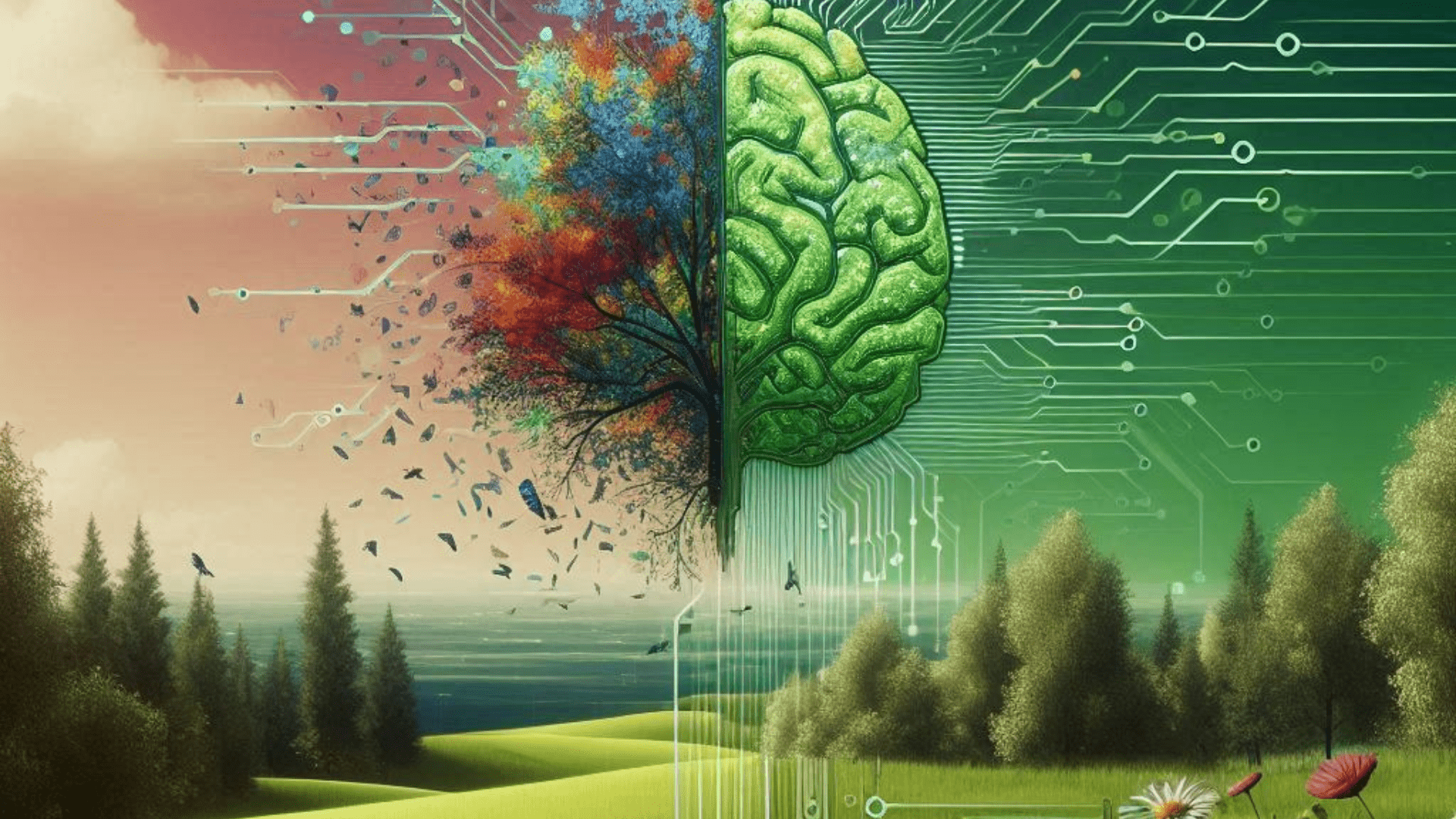


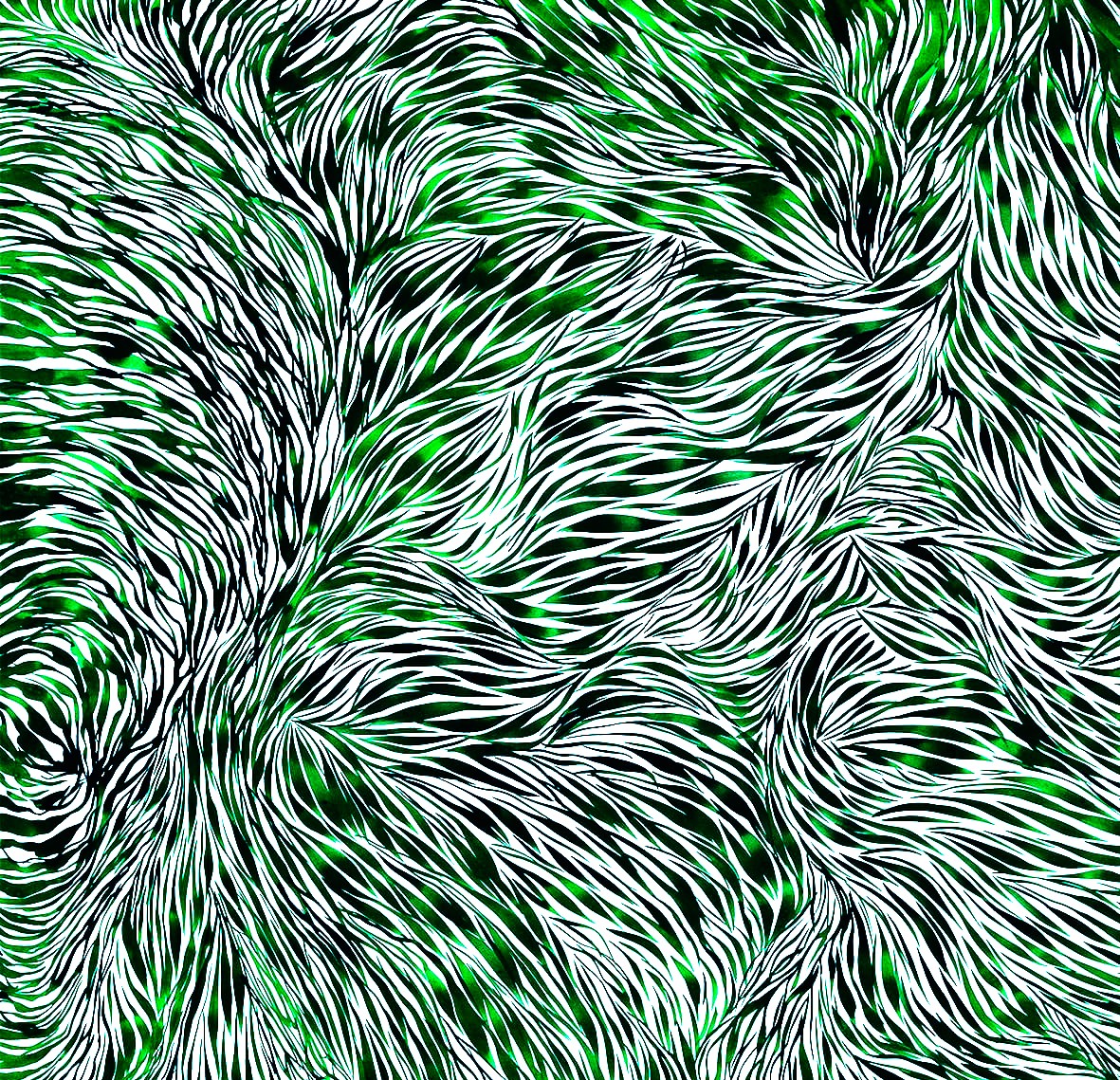


















 Mettiamo però che per qualche loro ragione, fosse anche solo per abitudine, il gruppetto, la coppia o il singolo decidano di tirare dritto e approdare alla mezzanotte. Non possono rimanere con forchetta e coltello in mano dalla cena all’ora x, almeno qui in Piemonte, dove il pasto serale inizia alle 20. Bisogna mettere sul tavolo, oltre ai ravioli, alle lenticchie, ai panettoni e alle bevande, anche qualcos’altro. E non è necessario farlo in maniera ufficiale, dichiarando il tema della serata e inducendo subito tutti a lasciar cadere le braccia e le posate. Si può buttare l’amo con leggerezza, innescandovi un banale riferimento o una battuta: che so, la nascita di un nipote o il rifiuto sempre più diffuso di responsabilità familiari da parte dei figli potrebbe aprire la strada a un dibattito sulla sovrappopolazione; una considerazione sul tipo di fauna che monopolizza i programmi televisivi potrebbe far scivolare verso la questione gender, ecc. L’importante è che poi la discussione e le argomentazioni rimangano su un piano di assoluta levità: ovvero, non scadano nel litigio o nella volgarità, e l’occasione non venga sfruttata per tenere conferenze o impartire lezioni.
Mettiamo però che per qualche loro ragione, fosse anche solo per abitudine, il gruppetto, la coppia o il singolo decidano di tirare dritto e approdare alla mezzanotte. Non possono rimanere con forchetta e coltello in mano dalla cena all’ora x, almeno qui in Piemonte, dove il pasto serale inizia alle 20. Bisogna mettere sul tavolo, oltre ai ravioli, alle lenticchie, ai panettoni e alle bevande, anche qualcos’altro. E non è necessario farlo in maniera ufficiale, dichiarando il tema della serata e inducendo subito tutti a lasciar cadere le braccia e le posate. Si può buttare l’amo con leggerezza, innescandovi un banale riferimento o una battuta: che so, la nascita di un nipote o il rifiuto sempre più diffuso di responsabilità familiari da parte dei figli potrebbe aprire la strada a un dibattito sulla sovrappopolazione; una considerazione sul tipo di fauna che monopolizza i programmi televisivi potrebbe far scivolare verso la questione gender, ecc. L’importante è che poi la discussione e le argomentazioni rimangano su un piano di assoluta levità: ovvero, non scadano nel litigio o nella volgarità, e l’occasione non venga sfruttata per tenere conferenze o impartire lezioni. 1. L’intelligenza artificiale, ad esempio. Viene per prima perché è lo stimolo che ha fatto scattare tutta questa operazione. Ne ragionavo ieri con Nico, e mi è rimasto in testa. Non è, come dicevo sopra, uno degli argomenti di cui si parla normalmente a tavola, soprattutto in questo periodo, nel quale la pandemia ha fatto uscire semmai allo scoperto un grave deficit di intelligenza naturale. Ma il motivo vero per cui non se ne parla è che le competenze in proposito sono decisamente poco diffuse. Preferiamo lasciare che se ne occupino i matematici, gli informatici e i cognitivisti.
1. L’intelligenza artificiale, ad esempio. Viene per prima perché è lo stimolo che ha fatto scattare tutta questa operazione. Ne ragionavo ieri con Nico, e mi è rimasto in testa. Non è, come dicevo sopra, uno degli argomenti di cui si parla normalmente a tavola, soprattutto in questo periodo, nel quale la pandemia ha fatto uscire semmai allo scoperto un grave deficit di intelligenza naturale. Ma il motivo vero per cui non se ne parla è che le competenze in proposito sono decisamente poco diffuse. Preferiamo lasciare che se ne occupino i matematici, gli informatici e i cognitivisti. 2. Altro argomento poco affrontato all’ora di cena, ma anche in tutte le altre, è quello del sovrappopolamento del pianeta, In questo caso a indurci a glissare sono diversi fattori. Intanto la convinzione che si tratti di un fenomeno ineluttabile, rispetto al quale non c’è politica o scelta che tenga, e che sarà semmai la natura stessa presto o tardi a farsene carico. Poi il disagio, un fastidio da un lato e quasi un senso di colpa dall’altro, che proviamo nel renderci conto come in realtà dalle nostre parti sia in atto già da un pezzo un decremento demografico, mentre altrove, nelle aree che un tempo erano definite sottosviluppate e che in gran parte sono effettivamente tali ancora oggi, la direzione si inverte. Di oggettivo ci sono solo alcuni dati: ci stiamo approssimando agli otto miliardi, e a questo ritmo il prossimo capodanno li avremo superati, perché la popolazione mondiale è cresciuta nell’ultimo anno di oltre ottantun milioni: negli ultimi trentacinque anni è rimasta pressoché stabile in Europa, è più che raddoppiata in Africa, è aumentata di oltre il cinquanta per cento in Asia e in America Latina, e del quaranta per cento nell’America del nord. In Italia il saldo demografico è negativo da dieci anni, il che significa che la popolazione è calata sotto i sessanta milioni, dopo averli abbondantemente superati: quello naturale, il rapporto cioè tra nati e morti, è stato lo scorso anno quasi di uno a due, le nascite sono state la metà dei decessi. Sulle cause di questi differenti fenomeni non mi dilungo, dovrebbero essere appunto il sale della discussione.
2. Altro argomento poco affrontato all’ora di cena, ma anche in tutte le altre, è quello del sovrappopolamento del pianeta, In questo caso a indurci a glissare sono diversi fattori. Intanto la convinzione che si tratti di un fenomeno ineluttabile, rispetto al quale non c’è politica o scelta che tenga, e che sarà semmai la natura stessa presto o tardi a farsene carico. Poi il disagio, un fastidio da un lato e quasi un senso di colpa dall’altro, che proviamo nel renderci conto come in realtà dalle nostre parti sia in atto già da un pezzo un decremento demografico, mentre altrove, nelle aree che un tempo erano definite sottosviluppate e che in gran parte sono effettivamente tali ancora oggi, la direzione si inverte. Di oggettivo ci sono solo alcuni dati: ci stiamo approssimando agli otto miliardi, e a questo ritmo il prossimo capodanno li avremo superati, perché la popolazione mondiale è cresciuta nell’ultimo anno di oltre ottantun milioni: negli ultimi trentacinque anni è rimasta pressoché stabile in Europa, è più che raddoppiata in Africa, è aumentata di oltre il cinquanta per cento in Asia e in America Latina, e del quaranta per cento nell’America del nord. In Italia il saldo demografico è negativo da dieci anni, il che significa che la popolazione è calata sotto i sessanta milioni, dopo averli abbondantemente superati: quello naturale, il rapporto cioè tra nati e morti, è stato lo scorso anno quasi di uno a due, le nascite sono state la metà dei decessi. Sulle cause di questi differenti fenomeni non mi dilungo, dovrebbero essere appunto il sale della discussione. 3. Si parla molto, invece, anche troppo, di identità di genere, e l’impressione è che lo si faccia sempre in termini sbagliati, o quantomeno ambigui. In realtà se ne sente parlare quasi esclusivamente da chi questa identità la vive come un problema, ciò che di per sé sarebbe più che giusto, o da chi l’ha ridotta allo stato “liquido” oggi tanto di moda, e questo invece ci irrita. A disturbarci sono prima di tutto i modi e i luoghi della discussione, l’esasperazione isterica e i salotti televisivi, la sua resa totale alla spettacolarizzazione. Nemmeno questo è dunque un argomento conviviale, sia pure per tavolate ristrette, perché affrontarlo ci mette in difficoltà: da un lato c’è sempre il rischio di urtare la sensibilità di qualcuno direttamente o indirettamente interessato, dall’altro abbiamo timore di essere fraintesi, oppure proviamo la sensazione di tradire la nostra vocazione “di sinistra”, progressista, che dovrebbe vederci disponibili alle più ampie aperture. Finisce così che quando capita di sbatterci contro liquidiamo la faccenda o assumendo posizioni ideologizzanti o trincerandoci sarcasticamente dietro banali battute.
3. Si parla molto, invece, anche troppo, di identità di genere, e l’impressione è che lo si faccia sempre in termini sbagliati, o quantomeno ambigui. In realtà se ne sente parlare quasi esclusivamente da chi questa identità la vive come un problema, ciò che di per sé sarebbe più che giusto, o da chi l’ha ridotta allo stato “liquido” oggi tanto di moda, e questo invece ci irrita. A disturbarci sono prima di tutto i modi e i luoghi della discussione, l’esasperazione isterica e i salotti televisivi, la sua resa totale alla spettacolarizzazione. Nemmeno questo è dunque un argomento conviviale, sia pure per tavolate ristrette, perché affrontarlo ci mette in difficoltà: da un lato c’è sempre il rischio di urtare la sensibilità di qualcuno direttamente o indirettamente interessato, dall’altro abbiamo timore di essere fraintesi, oppure proviamo la sensazione di tradire la nostra vocazione “di sinistra”, progressista, che dovrebbe vederci disponibili alle più ampie aperture. Finisce così che quando capita di sbatterci contro liquidiamo la faccenda o assumendo posizioni ideologizzanti o trincerandoci sarcasticamente dietro banali battute. 4. In questo gioco delle ipocrisie la “sinistra”, o quel che ne resta, o quel che ancora si autoetichetta tale, senza dubbio primeggia. Non avendo uno straccio di idea, di progetto, di visione del presente e tanto meno del futuro, vive di continui apparentamenti, insegue movimenti e campagne d’opinione specifiche, cerca di stare al passo con un mondo in trasformazione ma non ha chiara nemmeno la direzione in cui muoversi. La miopia relativa al presente e al futuro nasce dalla rimozione del passato. Voglio dire che la sinistra, quella eterodossa non meno di quella tradizionale, non ha mai fatto una pulizia reale nella propria storia: nel secondo caso l’ha semplicemente messa in soffitta pensando di potersi riconvertire (in cosa?) senza pagare alcun dazio, nel primo continua a trastullarsi con scampoli di nostalgie o con cause abbracciate senza alcuno spirito critico, per avere una qualche bandiera, uno slogan, una kefiah da esporre, e un nemico su cui scaricare i mali del mondo. Mi piacerebbe poter sognare una “rifondazione” della sinistra a partire da alcune basilari prese d’atto, ad esempio quella relativa all’inesistenza di una “natura umana” positiva (alla Rousseau, per intenderci) e alla “naturalezza” invece delle soluzioni culturali escogitate dall’uomo per garantirsi la sopravvivenza, con tutto quel che nel bene e nel male ne è conseguito: ma sembra proprio si continui a viaggiare nella direzione opposta. Anzi, a marciare sul posto. L’antisemitismo sinistrorso riemergente e la riscoperta di un’antropologia ideologizzata (i pacifici cacciatori-raccoglitori del paleolitico, le società libere dei nomadi) sono lì a confermarmelo.
4. In questo gioco delle ipocrisie la “sinistra”, o quel che ne resta, o quel che ancora si autoetichetta tale, senza dubbio primeggia. Non avendo uno straccio di idea, di progetto, di visione del presente e tanto meno del futuro, vive di continui apparentamenti, insegue movimenti e campagne d’opinione specifiche, cerca di stare al passo con un mondo in trasformazione ma non ha chiara nemmeno la direzione in cui muoversi. La miopia relativa al presente e al futuro nasce dalla rimozione del passato. Voglio dire che la sinistra, quella eterodossa non meno di quella tradizionale, non ha mai fatto una pulizia reale nella propria storia: nel secondo caso l’ha semplicemente messa in soffitta pensando di potersi riconvertire (in cosa?) senza pagare alcun dazio, nel primo continua a trastullarsi con scampoli di nostalgie o con cause abbracciate senza alcuno spirito critico, per avere una qualche bandiera, uno slogan, una kefiah da esporre, e un nemico su cui scaricare i mali del mondo. Mi piacerebbe poter sognare una “rifondazione” della sinistra a partire da alcune basilari prese d’atto, ad esempio quella relativa all’inesistenza di una “natura umana” positiva (alla Rousseau, per intenderci) e alla “naturalezza” invece delle soluzioni culturali escogitate dall’uomo per garantirsi la sopravvivenza, con tutto quel che nel bene e nel male ne è conseguito: ma sembra proprio si continui a viaggiare nella direzione opposta. Anzi, a marciare sul posto. L’antisemitismo sinistrorso riemergente e la riscoperta di un’antropologia ideologizzata (i pacifici cacciatori-raccoglitori del paleolitico, le società libere dei nomadi) sono lì a confermarmelo. 5. Il cotechino rappresenta un piccolo tassello di conservazione della memoria. Rimanda al maiale, alla sua importanza nell’economia e nella dieta contadina, ai significati positivi che in quella alimentazione rivestivano i cibi molto grassi e alle simbologie ad essi connesse. Questo della conservazione della memoria è un altro tema particolarmente consono alla serata. In fondo si celebra un rituale tradizionale di rinnovamento, che sia pure in tempi diversi è presente presso tutti i popoli della terra.
5. Il cotechino rappresenta un piccolo tassello di conservazione della memoria. Rimanda al maiale, alla sua importanza nell’economia e nella dieta contadina, ai significati positivi che in quella alimentazione rivestivano i cibi molto grassi e alle simbologie ad essi connesse. Questo della conservazione della memoria è un altro tema particolarmente consono alla serata. In fondo si celebra un rituale tradizionale di rinnovamento, che sia pure in tempi diversi è presente presso tutti i popoli della terra. Ora, questo ha qualcosa a che vedere con le lenticchie e tutto il resto? In un certo senso si, e mi riferisco soprattutto alle modalità conservative orientali, dal momento che quelle che chiamiamo tradizioni son in realtà delle copie, nel nostro caso nemmeno tanto fedeli, di costumi antichi. Ma quel che trovo interessante non sono tanto i modi quanto i moventi alla conservazione. Voglio dire: ha senso tenere in vita queste testimonianze del passato, quando poi nella realtà, al di là di un interesse puramente affettivo o nostalgico (quando va bene), esse non ci parlano più?
Ora, questo ha qualcosa a che vedere con le lenticchie e tutto il resto? In un certo senso si, e mi riferisco soprattutto alle modalità conservative orientali, dal momento che quelle che chiamiamo tradizioni son in realtà delle copie, nel nostro caso nemmeno tanto fedeli, di costumi antichi. Ma quel che trovo interessante non sono tanto i modi quanto i moventi alla conservazione. Voglio dire: ha senso tenere in vita queste testimonianze del passato, quando poi nella realtà, al di là di un interesse puramente affettivo o nostalgico (quando va bene), esse non ci parlano più? Dunque. Due settimane fa sono andato a prendere mia figlia Chiara che sbarcava a Linate. Tra ritardi e controlli sanitari rafforzati ho atteso più di un’ora davanti al varco d’uscita, cosa che si verifica ogni volta e che tutto sommato non mi spiace più di tanto, perché mi consente una panoramica spesso assai divertente sul mondo dei traveller’s. Stavolta però a guastarmi il piacere c’erano sei cani, che giustamente per tutto il tempo dell’attesa hanno fatto cagnara, con sommo compiacimento dei loro padroni, che al contrario dei cani hanno subito fraternizzato. Non mi era mai capitato prima, credevo anzi che fosse loro interdetto l’accesso. Non solo, ma quando finalmente i passeggeri sono sbarcati, all’apparire dal varco il loro grido di gioia era rivolto non a genitori o fratelli o fidanzati, ma ai cani, e così anche il primo abbraccio. Ora, io mi chiedo, e vi chiedo: tutto questo, vorrà dire qualcosa?
Dunque. Due settimane fa sono andato a prendere mia figlia Chiara che sbarcava a Linate. Tra ritardi e controlli sanitari rafforzati ho atteso più di un’ora davanti al varco d’uscita, cosa che si verifica ogni volta e che tutto sommato non mi spiace più di tanto, perché mi consente una panoramica spesso assai divertente sul mondo dei traveller’s. Stavolta però a guastarmi il piacere c’erano sei cani, che giustamente per tutto il tempo dell’attesa hanno fatto cagnara, con sommo compiacimento dei loro padroni, che al contrario dei cani hanno subito fraternizzato. Non mi era mai capitato prima, credevo anzi che fosse loro interdetto l’accesso. Non solo, ma quando finalmente i passeggeri sono sbarcati, all’apparire dal varco il loro grido di gioia era rivolto non a genitori o fratelli o fidanzati, ma ai cani, e così anche il primo abbraccio. Ora, io mi chiedo, e vi chiedo: tutto questo, vorrà dire qualcosa?