di Paolo Repetto, 23 agosto 2025
E tuttavia …. Devo tornare su Berselli e sulle “giovani promesse”. In Doppiozero trovo una recensione al suo libro appena riedito, scritta da Alessandro Banda. S’intitola Venerati stronzi. La leggo, mi piace, vado a cercare altri pezzi dello stesso autore. Una rivelazione.
Comincio da Il mio mercatino di Natale, sui mercati natalizi di recentissima e tutta inventata “tradizione”, come le sagre paesane estive. In questo caso si parla del mercatino meranese, frequentato anche da alcuni miei conoscenti quando non hanno la voglia o la benzina per arrivare fino a Salisburgo o addirittura a Danzica. Banda non ha bisogno di insaporire l’evento, è già abbastanza sapido di per sé: “Baracche, baracchette e baraccone lignee si disponevano ai due lati del Corso suddetto in una teoria pressoché infinita. Ognuna di queste baracche e baracchette e baraccone vendeva determinati prodotti, natalizi e affini. Per esempio candele al profumo di speck, stecche d’incenso automatico (si accendevano da sé non appena faceva buio), alberelli di Natale in vetroresina con lucine psichedeliche intermittenti incorporate, palle di Natale fluorescenti levigatissime, angeli di marzapane e angeli di panpepato, nonché angeli di biscotto e cannella. Poi, prodotto particolarmente fortunato, simpatici colbacchi in pelo di pony avelignese, guanti foderati di pelo di pony avelignese, pantofole di feltro, rivestite di pelo di pony avelignese, nonché sciarpe e scialli in pelo di pony (avelignese).

Erano tutti prodotti tipici meridianesi, che, come tutti i prodotti tipici di tutti i posti del mondo (tranne Hong Kong e Taiwan) venivano direttamente da Hong Kong e Taiwan. (A Hong Kong e Taiwan non perdono tempo con i loro propri prodotti tipici, occupati come sono a produrre quelli degli altri)”.
In effetti la ratio dei mercati di Natale (se di una ratio si può parlare) è esattamente all’opposto di quella che spinge a frequentare i mercatini dell’usato. Non è la speranza di imbattersi in qualcosa che avvii una personalissima “recherche”, o di rinvenire un oggetto (nel mio caso, naturalmente, un libro) del quale magari si ignorava l’esistenza o che si considerava ormai irreperibile, e che improvvisamente ci accorgiamo di aver sempre desiderato: è piuttosto l’adempimento dell’ennesimo rituale consumistico che si è sovrapposto ai vecchi rituali religiosi, una pratica che dà punteggio nella graduatoria “main stream”, e tanto più quanto più esotico. È insomma la voglia di poter dire: “ci sono stato anch’io”.
Trovo poi la segnalazione di un libro che parla dei trecento del battaglione sacro di Tebe (Eran trecento giovani e forti). Non solo mi era sfuggito il libro, ma avevo anche dimenticato il battaglione. Non lo avevo inserito nella rassegna di Trecento che ho postato pochi mesi fa. Il battaglione tebano era una formazione militare particolare, centocinquanta coppie di amanti (naturalmente omo, ma siamo nella Grecia classica, parliamo di rapporti di una natura completamente diversa).
Banda qui cita Plutarco: “Nessun amante tollererebbe di mostrarsi codardo di fronte al proprio amato, ed è esattamente per questo che un battaglione, composto da uomini reciprocamente legati da vincoli di passione, diventa invincibile e incrollabile”. Potrebbe essere un’idea per il nuovo esercito europeo. Tra l’altro, il lungimirante Epaminonda spostò il peso dell’attacco di quella formazione dalla tradizionale ala destra a quella sinistra, e questo gli consentì di confondere gli spartani a Mantinea e di sconfiggerli. Una sinistra combattente. Altro che battaglione Azov!
Sempre più piacevolmente incuriosito risalgo un po’ indietro, e leggo in successione un bel pezzo su Lucrezio (Lucrezio apocalittico), uno su Nicola Chiaromonte, uno su Saviane (Sergio Saviane e l’invenzione del mezzobusto). Le consonanze si moltiplicano.
Ma il bello deve ancora venire. Alessandro Banda ha in cantiere un libretto sull’arte di camminare in città, che dovrebbe titolarsi Il camminante malinconico e raccogliere una serie di considerazioni postate con cadenza settimanale. “Io non ho intenzione di occuparmi di camminate e camminatori in luoghi paradisiaci. No, per niente. A rigore non mi occuperò nemmeno di camminatori. È del camminante che parlerò… io intendo il camminante come uno che cammina in situazioni reali. Consuete. Quotidiane. Cittadine.”
E qui si entra direttamente nel nostro campo.
Da dove inizia Banda? Alla grande: va dritto al problema, al rapporto tra il camminante e le merde dei cani (La schiavitù canina), cui succede quello tra il camminante e i padroni dei cani (La celeberrima passeggiata Tappeiner); per poi tornare indietro a Rousseau e a Walser (Il patrono dei camminanti) e rimbalzare nell’oggi con L’invasione degli ultraveicoli, la Metafisica del Suv e Crisi e biciclette.

Trovo tutti questi quadretti pienamente condivisibili, e penso dovrebbero esserlo anche da parte dei più sedentari. In realtà, immagino che con essi Banda si sia fatto un sacco di nemici, che lo tempesteranno di tweet indignati: un po’ perché l’ironia non abita più i nostri lidi, un po’ perché la verità è costretta da sempre a navigare controcorrente; ma soprattutto perché nella “swipe era”, o sfera dei social media, a provare irrefrenabile l’imperativo di esprimersi sono gli imbecilli. Comunque, mi scuso subito: ho usato la locuzione “padroni dei cani”, che non è più considerata corretta. Avrei dovuto sostituirla con pet mate, compagni dei cani, a sottolineare il rapporto di amicizia e rispetto tra umani e animali. Questo tra l’altro spiega perché gli ex-padroni tendano a declinare, contestualmente alla proprietà, anche la responsabilità di rimuovere le deiezioni dei loro compagni. Speriamo non arrivino a volerne condividere anche l’interpretazione fecale della libertà.
Ragazzi, quanto bisogno avremmo non di uno, ma di mille Berselli!
Nel corso di questa divertente scorribanda, che viaggia tutta fuori dagli schemi del “politicamente corretto”, mi imbatto infine in interventi sparsi lungo una decina d’anni, che mi aggiornano sullo stato della scuola da quando l’ho lasciata. Avevo deciso di non tornare su questo argomento, non mi ci riconosco più: può sembrare strano per uno che per la scuola e nella scuola ha vissuto sessant’anni, ma la vedo ormai da una distanza siderale. Eppure, appena vi si fa cenno, e non per la solita manfrina celebrativa dell’inizio e della fine dell’anno scolastico, con tanto di interviste alle madri appena scese dal suv, qualcosa continua a scattare. E allora, qualche riflessione non guasta.
Su moltissime delle cose di cui Banda parla, prima tra tutte l’insensatezza dell’esame di maturità, concordo perfettamente.
Scrive: “La prima maturità classica fu superata dal cinquantanove per cento dei candidati. Il governo fascista corse allora ai ripari. Negli anni a seguire l’esame fu, more italico, annacquato e edulcorato. […] È da molti anni che i promossi superano il 99 per cento. Io sono contento di questi dati. Non sono un insegnante che boccia. Non ho la bava alla bocca quando metto un’ insufficienza. Non ne metto quasi mai. Ma, se un esame non opera un minimo di selezione, che senso ha? […]
La maturità no. Passano regolarmente tutti. Da anni. Da decenni. In trent’anni che insegno ho visto un solo respinto. Che poi ha fatto ricorso e l’ha vinto. Quindi nessuno in trent’anni”. (Maturità: persino Franz Kafka barò all’esame, 2020)
Quest’anno a ravvivare un po’ la scena è arrivata anche la sceneggiata del “gran rifiuto” (del voto, non della promozione), a denunciare l’assenza di “empatia” da parte degli insegnanti (quella ormai la mostrano solo i cani): rifiuto che è valso agli eroici nuovi martiri di Belfiore decine di migliaia di followers, viatico per entrare nel mondo dorato degli influencer.
La penso esattamente come Banda anche riguardo le riforme che si succedono ad ogni cambio di ministro, perché tutti vogliono lasciare la loro impronta. “Di riforme autentiche, nella scuola italiana post-unitaria, ce ne sono state unicamente due: quella del 1923 e quella del 1962. La cosiddetta riforma Gentile e la riforma che introduceva la scuola media unica.
Una presentata come fascistissima, ma in realtà, come riconobbe lo stesso Gentile in parlamento, d’impianto liberale, l’altra ispirata alla stagione riformista del centro-sinistra. Queste due riforme possono piacere o non piacere. Però nessuno può negare che nascessero da idee”.
Da allora: “Le riforme della scuola non sono riforme. Sono ritocchi parziali, spesso scoordinati e raffazzonati, tendenti ad un unico fine, triplicemente modulato: tagliare, tagliare, tagliare. Ore, posti di lavoro, siano cattedre o segreterie e dirigenze”.
Altre cose invece mi lasciano perplesso: ad esempio il fatto che Banda approvasse l’introduzione dello smartphone nelle aule (il pezzo in cui ne parla risale ad otto anni fa. Ma la cosa è coerente con la sua convinzione di fondo che ogni resistenza al nuovo nella scuola non abbia senso): “Non so i colleghi (anzi lo so, ma faccio finta di non saperlo, perché a scuola si procede così), ma io lo smartphone sono almeno sette anni che lo faccio usare. Se dico una cosa e gli alunni non mi credono, aggiungo: controllate in rete. Verificate le mie affermazioni in tempo reale, secondo l’abusata espressione”. (Lo smartphone a scuola, 2017)
Sette più otto quindici. Quindici anni fa eravamo in era pre-covid, ancora non era arrivata a compimento la pervasione totalizzante dei social, ma quale sarebbe stato l’uso futuro dello smartphone era già ben chiaro (chissà cosa pensa Banda della loro proibizione, in vigore dal prossimo anno. Al di là del fatto che rimarrà lettera morta). Non credo che oggi i suoi allievi si informino su Wikipedia: è più probabile che si affidino a qualche piattaforma di AI sfacciatamente condizionata e orientata. Ma soprattutto, non impareranno mai che la cultura non consiste in ciò che sai, ma nello sforzo che fai per arrivare a saperlo.
Non condivido affatto, poi, un atteggiamento generale che definirei “rinunciatario” nei confronti del ruolo della scuola, anche se ad avallarlo viene chiamato un “venerato maestro” (e riferimento costante di Banda): “Non vedo errore certo, irreparabile, se non nell’acconsentire ad avere un primo giorno di scuola. Da quel momento incomincia la sistematica vessazione”. (citazione da Giorgio Manganelli, ne Il primo giorno di scuola, 2017)

Mi spiace che Manganelli l’abbia vissuta come una vessazione sistematica. Forse la vivono così le menti davvero geniali, quelle che non sopportano i ritmi lenti imposti dal gruppo, o, al contrario, le menti meno sveglie, che non reggono nemmeno quei ritmi. Ma la gran parte dei ragazzi, magari per ragioni completamente diverse e con atteggiamenti ed esiti i più disparati, credo non l’abbiano vissuta così. Almeno fino a ieri, fino a quando la scuola la frequentavo, sul versante cattedra, anch’io.
Per questo mi suonano troppo liquidatorie queste affermazioni: “Perché lamentarsi che la scuola soffochi il genio? È esattamente quello il suo compito. Perché lamentarsi degli insegnanti impreparati, o ingiusti, o dai nervi labili? Sono come devono essere. Perché lamentarsi dello scadimento degli studi? Gli studi scadono da sempre, e sono scaduti da sempre, se è vero, com’è vero, che già Tacito e Petronio la stigmatizzano, quest’eterna decadenza degli studi […]. Sono sicuro che la lagna scolastica proseguirà. Con gli stessi argomenti. Con le stesse parole. Con le stesse identiche frasi, che si ripetono da duemila anni e che si ripeteranno per altri tremila.” (Il lamento dell’insegnante, 2015)
Non credo affatto che siamo di fronte alla “solita lagna”. Per chi ha vissuto nella scuola gli ultimi sessant’anni lo scadimento è quanto mai palpabile e reale, e corre a una velocità mai conosciuta prima. Non riguarda solo la realtà scolastica, naturalmente, ma la scuola ne è il primo e più evidente sensore. Può darsi si tratti di un normale adeguamento, della transizione ad una realtà culturale e sociale del tutto inedita, a modi completamente nuovi di trasmissione del sapere. Ma nessuno può negare che al momento ci si trovi davanti ad una istituzione allo sfacelo. Perché non è stato sempre così.
Sul muro della terrazza sovrastante la palestra, nell’istituto in cui ho insegnato per un quarto di secolo, campeggiava una scritta in caratteri cubitali: “La pacchia è finita, arrivano le vacanze”. Era l’unico luogo in cui all’epoca ci fosse concesso fumare, frequentatissimo dai tabagisti ma nella bella stagione anche dai non fumatori. Una piccola agorà dove, molto più che nell’aula magna, trovava espressione il libero pensiero. Faticai molto a convincere il preside a non fare cancellare la scritta, ma alla fine la spuntai. Non so che fine abbia fatto dopo il mio trasferimento.
Trovavo quelle parole estremamente significative. Al di là dell’intenzione beffarda, inconsciamente situazionista, esprimeva a mio giudizio una profonda verità: gli allievi a scuola in fondo si divertivano, e la pacchia non consisteva nella possibilità di fare una mazza, perché ancora non erano state inventati i Disturbi Specifici dell’Apprendimento, i Bisogni Educativi speciali e tutte le altre immaginifiche sindromi attestate da psicologi compiacenti, cui non par vero coltivare nuovi orticelli (o meglio, i disturbi dell’apprendimento c’erano, e quelli tra noi più coscienziosi se ne accorgevano benissimo, e li tenevano nel debito conto, ma non era ancora partito lo squallido mercato delle certificazioni volute dai genitori per rifiutare ogni responsabilità educativa).
Posso affermarlo con cognizione di causa perché tutti gli allievi coi quali sono rimasto in contatto, e sono molti, me lo confermano: ma lo sapevo già all’epoca, altrimenti non sarebbe stato spiegabile perché cinque neo-maturi, all’indomani dell’orale conclusivo, chiedessero di potermi raggiungere nel luogo dove quell’anno facevo la maturità da commissario, in quel caso in Toscana. Erano disposti a dormire nei sacchi a pelo in un vecchio seminario abbandonato e a seguire il mattino le sessioni d’esame dei loro colleghi (soprattutto colleghe) toscani. Alla domanda: ma non avete niente di meglio da fare? la risposta fu: sentiamo già la nostalgia della scuola. E il bello è che erano sinceri. Ora, va precisato che quei cinque non erano affatto dei secchioni, viravano anzi parecchio sul lavativo: ma quando uno di loro, il re dei lavativi, una tarda sera, di ritorno dal mare dove avevamo trascorso tutto il pomeriggio e di fronte al paesaggio che ci su spalancava davanti, le colline di Volterra inondate dalla luce lunare, ruppe il nostro silenzio estatico citando Foscolo: “Lieta dell’aer tuo veste la Luna/ di luce limpidissima i tuoi colli”; ebbene, allora compresi che persino lui a scuola si era divertito e ne aveva tratto ciò che può rendere più ricca e piacevole la vita. Altro che soffocare il genio. Fino a ieri era così: io mi divertivo, loro anche. Diversamente, avrei cambiato subito mestiere. Non so se oggi questo è ancora possibile. Per tutti i motivi che Banda cita: perché è diverso il mondo, perché sono diversi i ragazzi, perché cercano altrove quello che un tempo trovavano nella scuola, perché quest’ultima, che era rimasta l’ultimo baluardo contro l’ingresso dei “Barbari” tanto auspicata do Baricco, è stata ridotta in pochi anni a parcheggio per una fascia d’umanità altrimenti ingestibile.
Penso che comunque in cuor suo queste cose Banda le sappia. Altrimenti non avrebbe descritto così il protagonista di un libro recensito in un altro intervento (Scuola di felicità, 2016): “È un insegnante vero, non un impiegato, non uno di quelli che viene per fare le ore, scrivere programmi, registri … Un insegnante che insegna qualcosa in più rispetto alla sua insignificante materia”.
E che senz’altro si diverte quanto i suoi allievi.








 E infatti. Vengo convocato per lunedì 21 gennaio. Una settimana prima sono sottoposto a un prericovero, con analisi, prelievi, rilevamento di tutti i parametri vitali, radiografia toracica, storia medica, ipotesi terapeutiche successive, ecc. L’antivigilia del ricovero è d’obbligo la procedura anticovid: tampone e altra radiografia polmonare (quella della settimana precedente non è più considerata valida). La domenica della vigilia, nel primo pomeriggio, sono pronto ad entrare in ospedale con la mia valigia piena di libri, di agende e di penne, quando un messaggio del ministero della salute mi avvisa che il mio green pass non è più valido, essendo io risultato positivo al tampone. Quindi salta naturalmente anche l’intervento. Telefono in ospedale, mi dicono che già lo sapevano, obietto che avrebbero potuto informarmi, ribattono che quello non era compito loro, ma del ministero. Scatta la quarantena. Per sei giorni rimango chiuso in casa a Lerma, mai stato meglio in vita mia. Al settimo, nuovo tampone: che risulta negativo, cosa che comunico all’ospedale, da dove mi informano però che essendo saltato il turno dovrò attendere il prossimo. Quando, non si sa.
E infatti. Vengo convocato per lunedì 21 gennaio. Una settimana prima sono sottoposto a un prericovero, con analisi, prelievi, rilevamento di tutti i parametri vitali, radiografia toracica, storia medica, ipotesi terapeutiche successive, ecc. L’antivigilia del ricovero è d’obbligo la procedura anticovid: tampone e altra radiografia polmonare (quella della settimana precedente non è più considerata valida). La domenica della vigilia, nel primo pomeriggio, sono pronto ad entrare in ospedale con la mia valigia piena di libri, di agende e di penne, quando un messaggio del ministero della salute mi avvisa che il mio green pass non è più valido, essendo io risultato positivo al tampone. Quindi salta naturalmente anche l’intervento. Telefono in ospedale, mi dicono che già lo sapevano, obietto che avrebbero potuto informarmi, ribattono che quello non era compito loro, ma del ministero. Scatta la quarantena. Per sei giorni rimango chiuso in casa a Lerma, mai stato meglio in vita mia. Al settimo, nuovo tampone: che risulta negativo, cosa che comunico all’ospedale, da dove mi informano però che essendo saltato il turno dovrò attendere il prossimo. Quando, non si sa.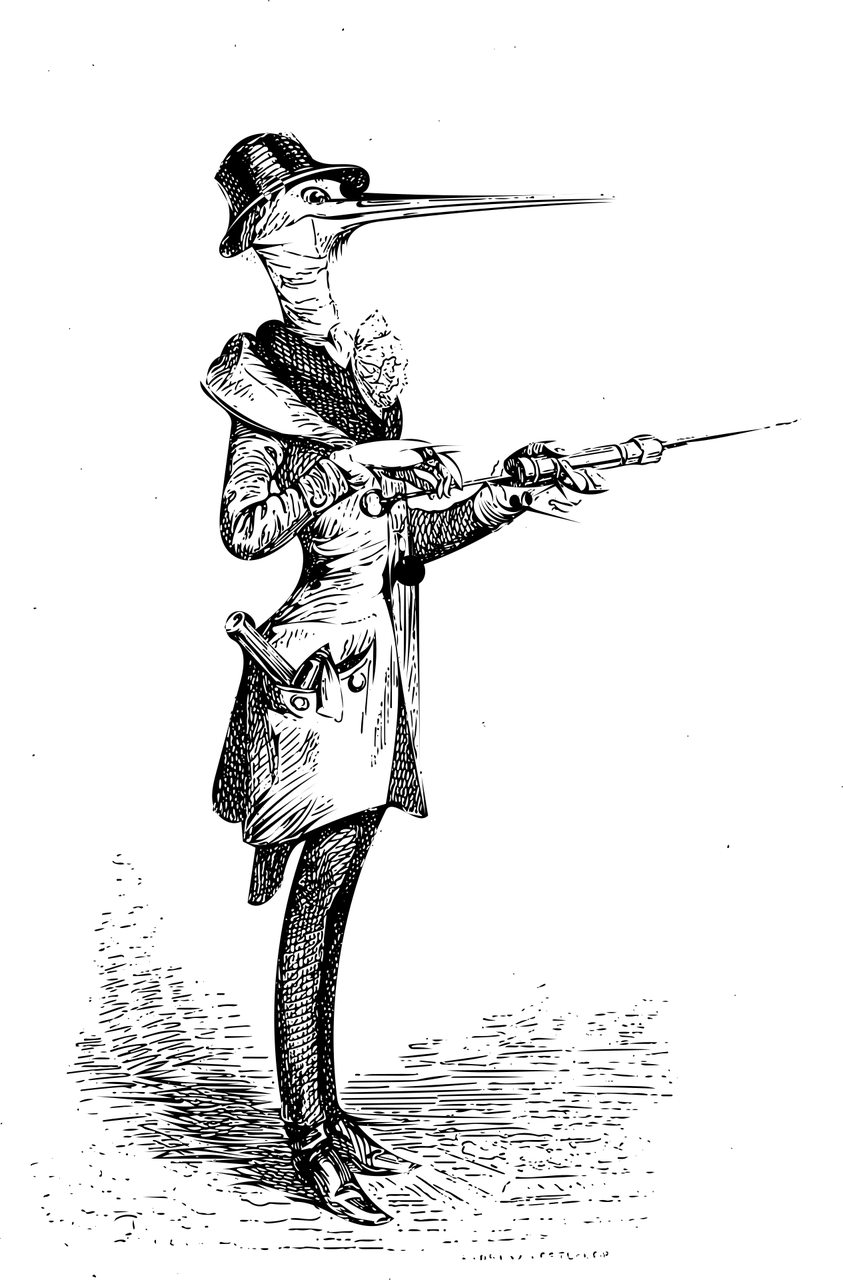 Del giorno successivo, quello dell’intervento, ricordo poco. Mi hanno addormentato alle otto del mattino, mi sono risvegliato, credo, verso le diciassette, con una cauta sensazione di benessere, nessun dolore: quando ho realizzato non mi pareva vero di averla sfangata così.
Del giorno successivo, quello dell’intervento, ricordo poco. Mi hanno addormentato alle otto del mattino, mi sono risvegliato, credo, verso le diciassette, con una cauta sensazione di benessere, nessun dolore: quando ho realizzato non mi pareva vero di averla sfangata così.
