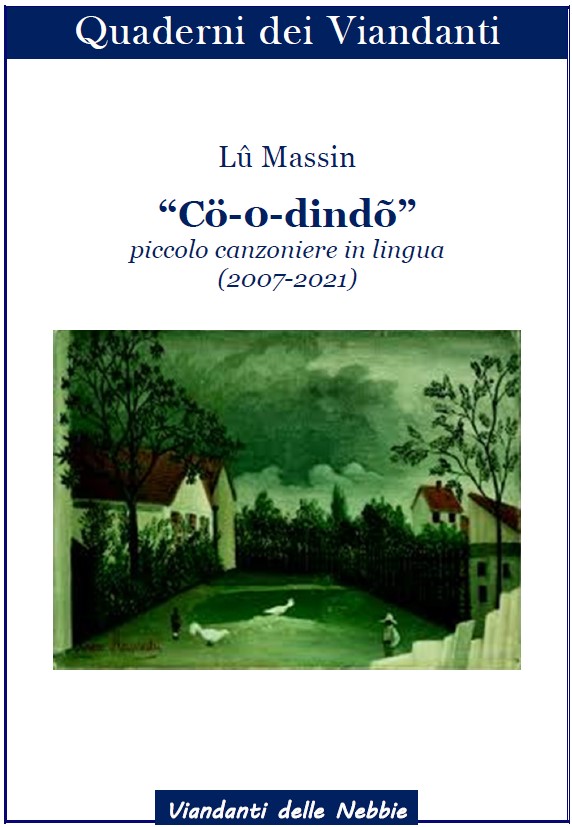di Paolo Repetto, 2001
Ci siamo convertiti al recupero. Finite le vacche grasse ci si riscopre sobri e virtuosi, si ricava energia dai rifiuti e dalle scorie e si riciclano le sostanze non deperibili e gli organi vitali espiantati. Si risica anche sul tempo, immagazzinandolo in banche e velocizzando gli spostamenti, le comunicazioni, le attività lavorative e gli apprendimenti. Insomma, dalla cultura dello spreco e del consumo sconsiderato si sta passando, o meglio tornando, almeno nei propositi, a quella del ciclo di sfruttamento totale. E questo sfruttamento postumo interessa anche culture agonizzanti, tradizioni già sepolte, costumi da tempo dismessi.
Tutte le varie forme di recupero materiale, ecologico, energetico o chirurgico sono dettate naturalmente da necessità di sopravvivenza, dall’urgenza per il genere umano di arginare in qualche modo la propria polluzione; ed anche se al momento operano più nel regno degli intenti che in quello della realtà, e sembrano finalizzate a creare nuove possibilità di business piuttosto che alla effettiva salvaguardia del pianeta, in una prospettiva a lungo termine paiono imprescindibili.
Il recupero culturale ha invece in sé altre valenze, pur rispondendo almeno in parte alle stesse istanze di fondo. Esso nasce dalla constatazione che ogni singolo e locale patrimonio di cultura e di tradizioni che va perduto si porta appresso epoche e fette intere dell’umanità, e dalla coscienza che questa perdita l’umanità non se la può permettere. Ma a differenza di quanto accade per l’ambiente e per l’energia, nei confronti dei quali la necessità e l’urgenza del recupero si impongono in maniera immediata e ben definita, per la cultura questa coscienza rimane vaga e nebulosa, ed entra in crisi di fronte alla domanda precisa: perché non ce lo possiamo permettere?
Il perché sta nel fatto che ogni cultura che sparisce porta con sé una serie di possibilità che si aprivano e che ora non si aprono più. Si va verso una cultura uniforme, monocorde, e il ventaglio delle possibilità aperte appare sempre meno ampio. In termini di biologia evolutiva questo è un handicap, perché caratteri che risultano recessivi o inutili in un in un particolare momento o in una determinata situazione ambientale possono rivelarsi adattivi sul lungo termine o a fronte di un mutamento delle condizioni esterne. Ma lo è altrettanto in termini di crescita culturale, perché la novità e lo stimolo possono venire solo dall’ibridazione, nel nostro caso dal confronto tra differenze, e l’azzeramento delle differenze induce uno stato comatoso. Quello appunto al quale sembriamo da qualche tempo destinati.
Il problema che si pone è dunque quello di salvaguardare il più possibile ogni diversa espressione di cultura, prime tra tutte quelle a rischio più prossimo di scomparsa, ovvero quelle linguistiche, compatibilmente però col fatto che il mondo si muove, e non solo su orbite o assi nello spazio, ma anche lungo un’ascissa temporale. In altre parole: l’interazione tra le diverse culture diventa sempre più intensa e impone una semplificazione comunicativa (leggi: lingua unica, a diversi livelli di competenza a seconda del livello degli scambi), allo stesso modo in cui impone una standardizzazione alimentare e comportamentale. Di fronte a questa realtà di fatto è importante capire prima di tutto che non è possibile non scartare nulla lungo il cammino, poi che va deciso non solo cosa salvare, ma in che modo. Dove una risposta certa non esiste – e noi sappiamo che in questo caso non esiste – le risposte finiscono naturalmente per moltiplicarsi, e con esse le giustificazioni, le strategie e le modalità operative. Il che, di per sé, sarebbe anche positivo, se non fosse che nella gran parte dei casi si tratta di false risposte, o addirittura soltanto di pretesti per operazioni autopromozionali, pubblicitarie o fini a se stesse.
Non mi riferisco soltanto agli aspetti più appariscenti e pacchiani, quelli per intenderci dell’anniversarismo, delle grandi mostre, del rilancio del folcklore (la festa paesana, il palio, i carnevali), ma anche e soprattutto a quelli che vantano una serietà o un approccio scientifico, come le iniziative di recupero nel campo lessicale (ad esempio, atlanti o vocabolari dei dialetti) e in quello della cultura materiale (etno ed ecomusei). Operazioni sacrosante, ma troppo spesso conniventi con quel mercatino pseudo-antiquario che all’insegna dell’antropologia storica falsifica il passato prossimo dell’occidente, e soprattutto dell’Italia. Il caso del dialetto si presta meglio di ogni altro ad evidenziare il malinteso (quando non si tratti di malafede).
Il dialetto è la voce di una società particolare, molto ristretta e dotata di un orizzonte semantico limitato quanto agli oggetti referenti, e complesso per la somma di interazioni che va a caricarsi sugli stessi. Essendo (relativamente) pochi e semplici gli oggetti d’uso, i gesti della quotidianità e gli eventi extra-ordinari, la loro denominazione si allarga per analogia o per metafora a significati diversi, in una rete di allusioni che ha senso solo nell’ambito di una piccola comunità. È un sistema comunicativo che si regge su un repertorio lessicale non asettico e laico, ma profondamente sacralizzato dalla ritualità della consuetudine e dalla forza dei legami di conoscenza. Non contempla ad esempio la necessità di verbalizzare impegni e transazioni: all’interno della piccola comunità dialettale lo scambio avviene per il tramite della viva voce, e la parola proferita e udita da tutti e della quale tutti condividono la pregnanza di significato è più autorevole e vincolante di carte che nessuno o quasi sa decifrare. Nella cultura dialettale le parole, proprio perché sono poche, non volano e non si disperdono: pesano e restano, accolte non nei testi, ma nella memoria. Regole, conoscenze e tradizioni vengono tramandate mnemonicamente: ed esiste la capacità di memorizzare perché la mente è ingombra solo di informazioni essenziali, quelle sufficienti per una vita che si svolge in ambienti sempre uguali secondo cicli ripetitivi. Il dialetto è dunque la voce di un mondo orale, che non necessita di un riscontro scritto. Dove lo ha avuto (Roma, ad esempio, o Milano, o Venezia) si tratta di idiomi urbani, che hanno funzionato a lungo come lingue vere e proprie: e comunque, sempre di meta-dialetti, alla maniera di un Verga.
I nostri dialetti, quelli che fanno riferimento ad una società rurale, si sono sviluppati in un ambito di cultura sociale e materiale molto più ristretto, molto più statico, e ne hanno rispecchiato le caratteristiche di povertà e di ossificazione. Sono dunque dialetti poveri lessicalmente e cristallizzati per il persistere secolare delle stesse culture, degli stessi usi e consuetudini, per l’assenza o quasi di scambi e di confronti. Fino a cinquant’anni fa un dialetto era una carta d’identità, perché faceva riferimento ad una realtà specifica: a oggetti, attività, usi alimentari, tradizioni viventi, modi di abbigliamento, persino ad un contesto naturale particolare. Era plasmato sui caratteri di un paesaggio che a seconda fosse pianeggiante, collinare, montagnoso, arido, fertile induceva determinate attività lavorative, consuetudini sociali, giochi, rapporti di proprietà, modi di misurare, di camminare, di concepire il tempo e lo spazio, e poi paure, chiusure o aperture, che condizionava cioè in toto l’agire e l’essere di una comunità. I soli a sottrarsi a questo condizionamento erano i vagabondi, le lingere, gli sradicati, che in genere perdevano l’identità linguistica per adottare un idioma spurio, adatto alla comunicazione elementare e allargata piuttosto che alla connotazione.
L’avvento della società industriale, nei nostri paesi, è stato così rapido da non consentire alcun adeguamento linguistico, alcuna evoluzione. Nell’arco di una generazione, anzi, in un tempo molto più breve, si è passati ad una adozione più o meno corretta della lingua comune, nello stesso tempo in cui si passava al lavoro di fabbrica, al trasporto su autoveicoli, all’uso degli elettrodomestici e dei recipienti di plastica, e la veglia televisiva sostituiva quella familiare. Strade e autostrade e mezzi a motore hanno dragato a tappeto il territorio, creando e imponendo una rete fittissima di scambi, e televisione, supermercati, cibi confezionati hanno provveduto alla nuova semina, omogeneizzando i gusti e liquidando gli ultimi baluardi della differenza. Le nuove tecnologie, i nuovi materiali, le diverse percezioni temporali e spaziali e tutto l’habitus psicologico e comportamentale connesso alla loro adozione non potevano trovare riscontro in un linguaggio forgiato su tecnologie elementari e su rapporti sociali estremamente semplici e consolidati. Non può esistere un corrispettivo dialettale di automobile, e infatti non si è andati oltre quello più generico di macchina, nel quale si assume qualsiasi oggetto che abbia un funzionamento meccanico complesso, ed è quindi applicabile dalla pompa per l’irrorazione alla mietitrebbia o alla pastiera. È esattamente ciò che accade alla lingua italiana rispetto ad un’altra rivoluzione, quella informatica, che rifiuta nei fatti l’esistenza, o almeno l’uso, dei corrispettivi italiani di computer, chip, ecc…, e che prelude alla scomparsa o al declassamento, in tempi altrettanto brevi, dell’idioma nazionale.
Per questi motivi oggi, a due generazioni dal miracolo economico, il dialetto è sepolto, assieme a quelle differenze che un tempo marcava, sotto gli strati di scorie culturali che la modernità accumula a ritmi sempre più accelerati. Ogni identità è stata annullata dall’omogeneizzazione alimentare, abitativa, lavorativa, comportamentale. Il dialetto non può dunque salvaguardare nulla, perché non c’è più nulla da salvaguardare.
È naturale pertanto che anch’esso scompaia, assieme al terreno di riferimento che gli è stato strappato sotto i piedi. Può conoscere una crepuscolare sopravvivenza nei rapporti di consuetudine ristretti, tra gli anziani dei borghi o dei paesotti rurali, ma in realtà aveva già cessato ogni funzione comunicativa a metà degli anni sessanta, sotto le ondate migratorie e nella dispersione scolastica e lavorativa. È materia per gli storici del linguaggio, per gli antropologi, per gli etnologi, ma come può esserlo un cadavere su un tavolo anatomico. Non ha senso praticargli la respirazione artificiale o attaccarlo a tubicini e trasfusori. Merita almeno una dignitosa sepoltura.
Mi chiedo allora da dove nasca tutto questo fervore di iniziative per la difesa, per la promozione, addirittura nei casi più deliranti per l’introduzione nell’insegnamento scolastico del dialetto. È evidente che le motivazioni e le posizioni sono molte e variamente sfumate: ma credo che alla fin fine possano essere ricondotte a due matrici di massima.
Da un lato c’è la sindrome a mio avviso diffusissima dell’orticello: cioè della necessità, da parte di una congerie di precari del lavoro intellettuale o di umanisti della domenica, di recintarsi uno spazio di sopravvivenza, di sfogo o di visibilità. Costoro forniscono in genere la manovalanza ai professionisti del settore, che si creano dal canto loro veri e propri pascoli. Storia locale, folklore, studio del dialetto si prestano benissimo, offrono terreni non lussureggianti ma poco sfruttati, consentono di accedere ai fondi per la cultura dei vari enticelli locali e garantiscono un minimo di esposizione anche a chi non riesce ad approdare al Costanzo show. Non c’è dubbio che nel settore bazzichi anche gente in buona fede, o addirittura benemerita, come i genuini cultori della poesia dialettale (per intenderci, quelli che il dialetto l’hanno ancora succhiato assieme al latte), che peraltro si ritrovano poi a raccontarsela tra di loro nelle manifestazioni promosse dalle Pro Loco (e non si vede come potrebbe essere altrimenti); o qualche studioso serio che si limita a far bene il suo lavoro di storico e di linguista: ma questo non cambia granché il quadro. E talvolta anche le migliori intenzioni sono male indirizzate. La redazione di dizionari dialettali, ad esempio, al di là del dibattito e della confusione sulle modalità trascrittive, rischia spesso di voler trascendere la funzione documentaria, ed è comunque già di per sé un’operazione ambigua e snaturante, perché costringe nei modi, nelle forme e nei mezzi della cultura scritta una materia che con quest’ultima non ha nulla a che vedere. Lo stesso vale per la trascrizione poetica. In essa va perduta ogni caratteristica del dialetto: tonalità, velocità, timbro, sfumatura. Non c’è nulla di più anonimo, per non dire di più irritante, di un detto o di una filastrocca dialettale pastorizzati dalla stampa.
E questo è l’aspetto più innocente della faccenda. Perché c’è di peggio. Dietro il proliferare delle associazioni di salvaguardia o di recupero linguistico spira talora un esplicito vento di rivendicazione etnica, di “limpieza” culturale. Si muovono categorie diverse di mestatori, che vanno dagli imbecilli puri in camicia verde ai faccendieri della politica locale, in cerca di bandiere localistiche alle quali legare la propria arrampicata alle poltrone amministrative. Ma la proposta di introduzione dell’insegnamento del dialetto e in dialetto nelle scuole non va ascritta solo allo stupidario leghista. Era già stata ventilata qualche decina d’anni fa, sia pure in forma più “politicamente corretta”, anche dai recuperanti della sinistra, quando la difesa dell’identità popolare contro la colonizzazione linguistica e consumistica era letta come una forma di resistenza, e non come un atteggiamento egoistico e razzista (ma anche oggi sul “diritto alla differenza” le idee sono alquanto confuse). Non è comunque un fenomeno da sottovalutare, perché a dispetto della demenzialità dell’assunto e della ironica sufficienza con la quale viene liquidato si è radicato in diverse zone del profondo nord, e si va organizzando.
In tutti questi atteggiamenti, in queste manovre il problema del dialetto finisce dunque o per fornire solo dei pretesti, o per essere affrontato secondo una mentalità museale, o peggio ancora post-moderna, che destoricizza ogni portato, lo sottrae al suo naturale e temporale contesto, lo stravolge e ne fa un uso improprio e disinvolto. Fingendo un recupero storico si negano invece i modi della storia, la quale lascia cadaveri sul suo cammino e consente tutt’al più di seppellirli e costruire monumenti, non di resuscitarli.
Mi arrogo dunque il diritto di affermare che il dialetto è morto, e che deve essere lasciato in pace, perché penso e parlo e provo emozioni in dialetto dalla nascita. Ho il dialetto nel sangue, sono affetto da una forma mentis dialettale, che mi porta a sentire, a conoscere e a valutare in modi e secondo criteri particolari, e ad incontrare di conseguenza non pochi problemi di comunicazione (come si può comunicare, ad esempio, la cautela negli entusiasmi, negli amori, negli odi, nelle disperazioni, che ti viene trasmessa da un microcosmo nel quale ogni tua parola o gesto rimangono, sono patrimonio pubblico e vengono oralmente registrati a futura memoria con apprezzamenti che ti marchiano a fuoco: o ancora, nel quale ognuno viene ribattezzato con un soprannome e con quello è universalmente conosciuto, in barba ad ogni registrazione anagrafica). So anche cose che gli studiosi e i ricercatori in genere non sanno o non possono comprendere, e cioè quanto sia più efficace sacramentare o dare ordini o profferire minacce in dialetto, e invece difficile esprimere sentimenti d’amore. Ma so poi perfettamente che certe parole e certe atmosfere sono ormai intraducibili e lontane, e che quello che è avvenuto qui è accaduto o sta accadendo dovunque, e che nel terzo mondo le resistenze sono state superate ancor più facilmente, senza neanche passare per la fase delle lingue nazionali, grazie all’intermediazione coloniale; e so che i miei figli, che già mangiano e vestono e pensano all’americana, avranno figli o al massimo nipoti che parleranno in inglese. Tutto questo non mi piace, ma lo so. E dal momento che considero ormai il dialetto solo come un codice naturale, buono per comunicare in solitudine con la mia terra e del quale sono tra gli ultimi depositari, non se l’abbiano a male tutti i suoi neofiti se li mando di cuore a quel paese.

 di Paolo Repetto, 23 febbraio 2025
Nel programma pomeridiano di Paolo Mieli, Passato e Presente, David Bidussa ha parlato martedì scorso de Il “Mistero buffo” di Fo; la verità del giullare. L’ho intercettato a trasmissione già avviata, quindi non so se lo spunto fosse un qualche libro di Bidussa stesso o di altri, visto che nel corso del programma non se ne è fatto cenno (e nemmeno ne ho trovati in una successiva ricerca).
Comunque. Confesso di essermi sulle prime un po’ irritato (mi capita sempre quando sento nominare Dario Fo), perché conosco Bidussa da tempo, lo considero una persona seria e uno ottimo studioso, e temevo si fosse adeguato alla solita zuppa celebrativa: ma non ho tardato a capire che Fo gli sta simpatico quanto a me (e che questo sentimento è condiviso anche da Mieli), e la cosa non poteva che darmi conforto.
Al di là però delle simpatie e delle antipatie, che hanno motivazioni recondite e non fanno testo, ho apprezzato il modo sottile in cui Bidussa, senza lanciarsi in stroncature, ha ridimensionato il personaggio, sia come uomo che come intellettuale “impegnato”.
Ha fatto presente ad esempio come diversi altri ricercatori e autori abbiano studiato il linguaggio e la cultura popolare, traducendo poi i risultati del loro lavoro in strumenti per consentire una migliore conoscenza di quel mondo: cosa che non si può certamente dire per Fo, che ha invece utilizzato quei materiali in funzione prettamente autoreferenziale, mettendoli al servizio di una “verve” teatrale che gli consentiva di rimanere sempre, e letteralmente, al centro della scena. Ne ha fatto cioè spettacolo, puntando sugli effetti speciali della gigioneria: ma sul piano concreto della conoscenza della cultura popolare in realtà non ha trasmesso nulla. Anche il famoso gramelot non è una forma di linguaggio inventata dal popolo, nata come ribellione alla lingua ufficiale, come la si è gabellata, ma un “linguaggio scenico” affidato totalmente all’estro dell’attore, e come tale non codificabile e non trasferibile. E infatti, Fo non ha lasciato eredi, non ha creato una “scuola”, perché non aveva alcuna eredità da trasmettere.
Bidussa queste cose le ha dette in maniera certamente meno brusca di come le sto riportando io, ma la sostanza era questa. Ha anche aggiunto che ciò vale un po’ per tutto il lascito culturale sessantottesco: dobbiamo ammettere che in fondo ricordiamo solo i nomi di alcuni capi carismatici, quasi nulla dei movimenti che stavano alle loro spalle, e nulla del tutto dei loro programmi, sempre che ne avessero uno.
Quanto al Nobel, per quel che vale un riconoscimento del genere, e tanto più in letteratura, la spiegazione data da Bidussa mi è parsa senz’altro credibile: assegnando il premio a Fo si è voluto affermare che la letteratura non è solo quella inscrivibile nei “canoni” e nei generi tradizionali, ma vanno comprese in essa anche i frutti di altre modalità espressive, che non passano necessariamente solo per la pagina scritta, Cosa poi riaffermata qualche anno dopo, col conferimento del premio a Bob Dylan. Insomma, mi è parso un modo elegante e non ipocrita di rimettere ordine nelle cose.
A margine mi permetto però di aggiungere un paio di considerazioni molto personali.
Quanto Fo fosse convinto della sua centralità intellettuale e politica (pardon, sua e della moglie, Franca Rame, a sua volta assurta a icona del femminismo) l’ho constatato in occasione di una polemica da lui scatenata nei confronti de Il manifesto. Mi spiace non aver conservato quel testo, perché sarebbe stato sufficiente riportarlo integralmente per dare un’idea dello sbraco cui può indurre l’eccesso di autostima. L’accusa rivolta al quotidiano, e scagliata con toni di insopportabile supponenza, era di non aver riservato uno spazio adeguato, in uno speciale per il decennale o il ventennale del Sessantotto, al peso politico rivestito dalla sua militanza teatrale. Una rivendicazione che di per sé avrebbe potuto essere solo patetica, ma in questo caso riusciva disgustosa per la presunzione e l’arroganza messe in campo.
Mi rimane una domanda: è mai possibile che la sinistra abbia continuato costantemente ad aggrapparsi a riferimenti “culturali” fasulli come i De André, i Gaber, i Fo, oggi gli Zero Calcare, per non parlare di Grillo o di Gino Paoli, ad accreditare un significato e un valore politico ad espressioni che se vogliamo, con molta larghezza, possiamo definire “artistiche”, ma che non scuotono e non risvegliano le coscienze, e anzi, le aiutano ad addormentarsi nella convinzione di aver già appreso per una via facile e piacevole come va il mondo e come dovrebbe andare? Che non si sia mai resa conto di come questa sia una clamorosa legittimazione del ruolo di spettatori che il sistema, e tanto più quello moderno, ci riserva?
Lo so, è sempre stato così, già gli ateniesi andavano ad assistere alle tragedie di Euripide e alle commedie di Aristofane, e attraverso quelle si facevano un’idea: ma intanto non avevano praticamente altre fonti cui abbeverarsi, e comunque non hanno mai candidato qualcuno di costoro a cariche pubbliche o al ruolo di arconte. Che poi il bacino nel quale viene arruolata la classe politica odierna non offra granché di meglio, è un altro discorso: ciò che intendo io è che varrebbe almeno la pena di non legittimare in modo così spudorato la resa al trionfo della spettacolarizzazione.
Torniamo però al nostro. Rischiando consapevolmente una caduta di stile, perché può sembrare che mi diverta a “smitizzare” gratuitamente le icone della sinistra, e a farlo al riparo sia di una distanza temporale che della irrilevanza delle mie opinioni. Il problema in realtà, come dicevo sopra, non è che Fo mi stia simpatico o meno: il problema sta piuttosto nel fatto che attorno a figure come la sua ancora oggi la sinistra, dalla quale nella mia ingenuità mi attenderei almeno un po’ di trasparenza, costruisca invece narrazioni apologetiche degne delle vite dei santi padri medioevali o delle mitologie staliniane e maoiste del secolo scorso, applicando gli stessi modelli censori o panegirici.
Un esempio? La prima voce che mi compare sul monitor in una ricerca sul rapporto di Fo con la politica presenta un pezzo tratto dal blog The vision. Nella nota biografica si dice: figlio di un capostazione che durante la seconda guerra mondiale venne coinvolto nella Resistenza contro i nazifascisti. Esatto. Del fatto però che lo stesso Dario venne coinvolto, ma sul versante opposto, in quanto volontario nelle milizie repubblichine di Salò (le brigate Nere, per intenderci), e che abbia giustificato poi questa sua adesione dandone almeno cinque motivazioni diverse (non ultima, quella di aver agito come quinta colonna della resistenza), non una parola. Per la carità: aveva diciassette anni, e so per esperienza quanto si può essere ingenui a quell’età, o nel suo caso indottrinati sino al midollo (ma il padre non era nella Resistenza?), e se avesse semplicemente ammesso “si, ero stupido, credevo di lottare contro le plutocrazie” lo avrei capito e persino in parte giustificato: ma raccontare panzane per ripulirsi l’immagine, questo mi sembra testimoniare di una assoluta malafede. Così come tutta la successiva militanza politica, a ben guardare, conferma l’ansia continua di protagonismo scenico. Una recita ininterrotta, che lo ha visto tra le altre cose avallare la lettera che ha condannato a morte Calabresi e prestare la voce al video di Giulietto Chiesa (altro buono, ma senza nemmeno un briciolo di “genialità”, vera o presunta) nel quale si denunciava il “complotto” imperialista all’origine dell’11 settembre (dopo aver sostenuto in un primo momento che l’attacco era la giusta reazione dei poveri contro i ricchi d’Occidente).
Una coerenza comunque gli va riconosciuta: è rimasto un convinto odiatore degli ebrei per tutta la vita: temo si rammaricasse di non averne rastrellati abbastanza quando gli si era presentata l’occasione.
Ecco, adesso mi sento davvero in colpa: ma solo per aver dato troppo spazio a uno così, che mi rappresenta tutto ciò che non sopporto della società in cui vivo, e prima ancora di quella brancaleonesca armata di millantatori e opportunisti che stanno usurpando e sputtanando idealità alle quali rimango ostinatamente aggrappato: quelle che un tempo, pur a livelli diversi di comprensione e di convinzione, animavano una vera “sinistra”.
di Paolo Repetto, 23 febbraio 2025
Nel programma pomeridiano di Paolo Mieli, Passato e Presente, David Bidussa ha parlato martedì scorso de Il “Mistero buffo” di Fo; la verità del giullare. L’ho intercettato a trasmissione già avviata, quindi non so se lo spunto fosse un qualche libro di Bidussa stesso o di altri, visto che nel corso del programma non se ne è fatto cenno (e nemmeno ne ho trovati in una successiva ricerca).
Comunque. Confesso di essermi sulle prime un po’ irritato (mi capita sempre quando sento nominare Dario Fo), perché conosco Bidussa da tempo, lo considero una persona seria e uno ottimo studioso, e temevo si fosse adeguato alla solita zuppa celebrativa: ma non ho tardato a capire che Fo gli sta simpatico quanto a me (e che questo sentimento è condiviso anche da Mieli), e la cosa non poteva che darmi conforto.
Al di là però delle simpatie e delle antipatie, che hanno motivazioni recondite e non fanno testo, ho apprezzato il modo sottile in cui Bidussa, senza lanciarsi in stroncature, ha ridimensionato il personaggio, sia come uomo che come intellettuale “impegnato”.
Ha fatto presente ad esempio come diversi altri ricercatori e autori abbiano studiato il linguaggio e la cultura popolare, traducendo poi i risultati del loro lavoro in strumenti per consentire una migliore conoscenza di quel mondo: cosa che non si può certamente dire per Fo, che ha invece utilizzato quei materiali in funzione prettamente autoreferenziale, mettendoli al servizio di una “verve” teatrale che gli consentiva di rimanere sempre, e letteralmente, al centro della scena. Ne ha fatto cioè spettacolo, puntando sugli effetti speciali della gigioneria: ma sul piano concreto della conoscenza della cultura popolare in realtà non ha trasmesso nulla. Anche il famoso gramelot non è una forma di linguaggio inventata dal popolo, nata come ribellione alla lingua ufficiale, come la si è gabellata, ma un “linguaggio scenico” affidato totalmente all’estro dell’attore, e come tale non codificabile e non trasferibile. E infatti, Fo non ha lasciato eredi, non ha creato una “scuola”, perché non aveva alcuna eredità da trasmettere.
Bidussa queste cose le ha dette in maniera certamente meno brusca di come le sto riportando io, ma la sostanza era questa. Ha anche aggiunto che ciò vale un po’ per tutto il lascito culturale sessantottesco: dobbiamo ammettere che in fondo ricordiamo solo i nomi di alcuni capi carismatici, quasi nulla dei movimenti che stavano alle loro spalle, e nulla del tutto dei loro programmi, sempre che ne avessero uno.
Quanto al Nobel, per quel che vale un riconoscimento del genere, e tanto più in letteratura, la spiegazione data da Bidussa mi è parsa senz’altro credibile: assegnando il premio a Fo si è voluto affermare che la letteratura non è solo quella inscrivibile nei “canoni” e nei generi tradizionali, ma vanno comprese in essa anche i frutti di altre modalità espressive, che non passano necessariamente solo per la pagina scritta, Cosa poi riaffermata qualche anno dopo, col conferimento del premio a Bob Dylan. Insomma, mi è parso un modo elegante e non ipocrita di rimettere ordine nelle cose.
A margine mi permetto però di aggiungere un paio di considerazioni molto personali.
Quanto Fo fosse convinto della sua centralità intellettuale e politica (pardon, sua e della moglie, Franca Rame, a sua volta assurta a icona del femminismo) l’ho constatato in occasione di una polemica da lui scatenata nei confronti de Il manifesto. Mi spiace non aver conservato quel testo, perché sarebbe stato sufficiente riportarlo integralmente per dare un’idea dello sbraco cui può indurre l’eccesso di autostima. L’accusa rivolta al quotidiano, e scagliata con toni di insopportabile supponenza, era di non aver riservato uno spazio adeguato, in uno speciale per il decennale o il ventennale del Sessantotto, al peso politico rivestito dalla sua militanza teatrale. Una rivendicazione che di per sé avrebbe potuto essere solo patetica, ma in questo caso riusciva disgustosa per la presunzione e l’arroganza messe in campo.
Mi rimane una domanda: è mai possibile che la sinistra abbia continuato costantemente ad aggrapparsi a riferimenti “culturali” fasulli come i De André, i Gaber, i Fo, oggi gli Zero Calcare, per non parlare di Grillo o di Gino Paoli, ad accreditare un significato e un valore politico ad espressioni che se vogliamo, con molta larghezza, possiamo definire “artistiche”, ma che non scuotono e non risvegliano le coscienze, e anzi, le aiutano ad addormentarsi nella convinzione di aver già appreso per una via facile e piacevole come va il mondo e come dovrebbe andare? Che non si sia mai resa conto di come questa sia una clamorosa legittimazione del ruolo di spettatori che il sistema, e tanto più quello moderno, ci riserva?
Lo so, è sempre stato così, già gli ateniesi andavano ad assistere alle tragedie di Euripide e alle commedie di Aristofane, e attraverso quelle si facevano un’idea: ma intanto non avevano praticamente altre fonti cui abbeverarsi, e comunque non hanno mai candidato qualcuno di costoro a cariche pubbliche o al ruolo di arconte. Che poi il bacino nel quale viene arruolata la classe politica odierna non offra granché di meglio, è un altro discorso: ciò che intendo io è che varrebbe almeno la pena di non legittimare in modo così spudorato la resa al trionfo della spettacolarizzazione.
Torniamo però al nostro. Rischiando consapevolmente una caduta di stile, perché può sembrare che mi diverta a “smitizzare” gratuitamente le icone della sinistra, e a farlo al riparo sia di una distanza temporale che della irrilevanza delle mie opinioni. Il problema in realtà, come dicevo sopra, non è che Fo mi stia simpatico o meno: il problema sta piuttosto nel fatto che attorno a figure come la sua ancora oggi la sinistra, dalla quale nella mia ingenuità mi attenderei almeno un po’ di trasparenza, costruisca invece narrazioni apologetiche degne delle vite dei santi padri medioevali o delle mitologie staliniane e maoiste del secolo scorso, applicando gli stessi modelli censori o panegirici.
Un esempio? La prima voce che mi compare sul monitor in una ricerca sul rapporto di Fo con la politica presenta un pezzo tratto dal blog The vision. Nella nota biografica si dice: figlio di un capostazione che durante la seconda guerra mondiale venne coinvolto nella Resistenza contro i nazifascisti. Esatto. Del fatto però che lo stesso Dario venne coinvolto, ma sul versante opposto, in quanto volontario nelle milizie repubblichine di Salò (le brigate Nere, per intenderci), e che abbia giustificato poi questa sua adesione dandone almeno cinque motivazioni diverse (non ultima, quella di aver agito come quinta colonna della resistenza), non una parola. Per la carità: aveva diciassette anni, e so per esperienza quanto si può essere ingenui a quell’età, o nel suo caso indottrinati sino al midollo (ma il padre non era nella Resistenza?), e se avesse semplicemente ammesso “si, ero stupido, credevo di lottare contro le plutocrazie” lo avrei capito e persino in parte giustificato: ma raccontare panzane per ripulirsi l’immagine, questo mi sembra testimoniare di una assoluta malafede. Così come tutta la successiva militanza politica, a ben guardare, conferma l’ansia continua di protagonismo scenico. Una recita ininterrotta, che lo ha visto tra le altre cose avallare la lettera che ha condannato a morte Calabresi e prestare la voce al video di Giulietto Chiesa (altro buono, ma senza nemmeno un briciolo di “genialità”, vera o presunta) nel quale si denunciava il “complotto” imperialista all’origine dell’11 settembre (dopo aver sostenuto in un primo momento che l’attacco era la giusta reazione dei poveri contro i ricchi d’Occidente).
Una coerenza comunque gli va riconosciuta: è rimasto un convinto odiatore degli ebrei per tutta la vita: temo si rammaricasse di non averne rastrellati abbastanza quando gli si era presentata l’occasione.
Ecco, adesso mi sento davvero in colpa: ma solo per aver dato troppo spazio a uno così, che mi rappresenta tutto ciò che non sopporto della società in cui vivo, e prima ancora di quella brancaleonesca armata di millantatori e opportunisti che stanno usurpando e sputtanando idealità alle quali rimango ostinatamente aggrappato: quelle che un tempo, pur a livelli diversi di comprensione e di convinzione, animavano una vera “sinistra”.