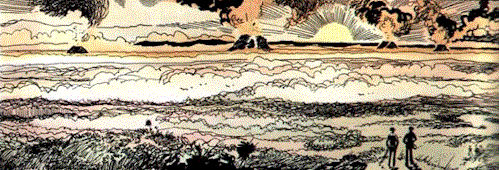di Paolo Repetto, 30 gennaio 2015
Camminare è l’attività più libera e indipendente,
niente vi è di peggio che star seduti
troppo a lungo in una scatola chiusa.
Johann Gottfried Seume
1. Sui prussiani pesa un vecchio pregiudizio e, dal momento che quasi nessuno sa dove si trovi effettivamente la Prussia, il pregiudizio ha finito per essere esteso a tutte le popolazioni della fascia più orientale e settentrionale della Germania.
Forse è colpa di Federico II, o di Von Clausewitz e di Bismarck (che peraltro erano tra gli uomini più intelligenti del loro tempo), sta di fatto che il termine “prussiano” evoca immediatamente un’enorme caserma abitata da milioni di militari, tutti ugualmente ottusi, tirati su a bastonate, pronti a scattare agli ordini e a marciare al passo dell’oca.
In Italia questa immagine l’ha diffusa Vittorio Alfieri, ben prima degli odierni detrattori della Merkel. Nella Vita scritta da esso racconta:
All’entrare negli stati del gran Federico, che mi parvero la continuazione di uno stesso corpo di guardia, mi sentii raddoppiare e triplicare l’orrore per quell’infame mestier militare, infamissima e sola base dell’autorità arbitraria […] Uscii da quella universal caserma prussiana verso il mese di novembre, aborrendola quanto bisognava […] perché quei perpetui soldati, non li posso neppur ora, tanti anni dopo, ingoiare senza sentirmi rinnovare lo stesso furore che la loro vista mi cagionava in quel punto.
In Francia, dove i prussiani li hanno sempre patiti in maniera particolare (e a ragion veduta, se si guarda alla storia degli ultimi tre secoli), un’identica considerazione era già radicata da un pezzo, così come nei paesi del Baltico e nella stessa Germania (si vedano gli sprezzanti giudizi di Goethe o di Heine, o le battute che ancora negli anni trenta del secolo scorso Leigh Fermor raccoglie attraversando la Baviera).
Malgrado Alfieri e il gran Federico, però, questo stereotipo è falso. I prussiani famosi che mi vengono in mente si chiamano Kant, Herder, i fratelli Humboldt, Jacobi, Hoffmann, Schopenhauer, Nietzche. Nessuno di costoro era un guerrafondaio, qualcuno, gli ultimi due soprattutto, era magari un po’ stravaganti, ma tutti erano intellettualmente geniali e moralmente liberissimi. Se anche fossero casi eccezionali, testimonierebbero comunque che, a volerlo, la dignità e l’indipendenza di spirito si possono coltivare ovunque.
A dimostrare che tanto eccezionali poi non sono, chiamo in causa Johann Gottfried Seume. Seume è certamente molto meno famoso dei suoi connazionali sopra citati e da noi è addirittura uno sconosciuto: ma questo gli fa torto, perché Seume era un uomo indipendente, ironico e integerrimo, e perché ha avuto con l’Italia un rapporto importante. L’ha infatti percorsa per intero nel 1802, in pieno subbuglio napoleonico, lo ha fatto a piedi, prendendosi tutto il tempo per capire ciò che vedeva e sentiva, l’ha infine raccontata in un simpaticissimo diario di viaggio, Spaziergang nach Syrakus (Una passeggiata verso Siracusa), facendoci cogliere attraverso l’occhio neutrale ma non freddo di uno straniero quella quotidianità che non entra nella storia ufficiale.
Ancora una volta quindi parlerò di un camminatore. Seume era anche altro, certamente: era un valente classicista, un filosofo tanto umile quanto coerente e, quasi suo malgrado, un militare. Ma a me interessano prima di tutto le sue buone gambe, perché sono quelle che hanno fatto affluire le giuste dosi di sangue alla sua testa.
Seume va dunque a infoltire una galleria di ritratti i cui soggetti hanno in comune, assieme a tante altre cose, l’amore per le camminate: esploratori illustri come Humboldt o misconosciuti come Raimondi, letterati-vagabondi come Gorkij, London, Hamsun e Leigh Fermor, scienziati-alpinisti come Dolomieu. È insomma in ottima compagnia.
I polpacci infaticabili, il tema del camminare, mi affascinano da sempre: lo dimostrano un migliaio di volumi della mia biblioteca, quelli che ne occupano il settore più ricco e prezioso e che trattano di viaggi, di esplorazioni, di scalate, di vagabondaggi. Io stesso, nel mio piccolo, ne ho scritto: e ho anche camminato parecchio.
Vorrei approfittare di Seume per soffermarmi con un po’ di calma su un’attività che è stata determinante per l’origine e la crescita dell’umanità intera, oltre ad aver avuto tanto peso nella mia vita, sia direttamente che attraverso le suggestioni letterarie. Il personaggio si presta.
Certo, può sembrare un argomento un po’ peregrino, o quanto meno troppo generico: camminare è una funzione naturale, come mangiare e dormire. Ma camminare sulle sole zampe posteriori è una funzione naturale riservata agli umani, quella che segna il limite di non ritorno tra noi e gli altri mammiferi. È una funzione acquisita, non si sa ancora bene quando e per quali motivi (continuano a essere proposte nuove teorie), che ha liberato delle abilità nuove e provocato un effetto volano, causando ricadute che vanno dagli usi alternativi delle estremità anteriori allo sviluppo del linguaggio, sino alle tecnologie che discendono dagli uni e dall’altro.
Ora, in genere noi diamo queste cose per scontate e siamo interessati solo al risvolto “volontaristico” della faccenda, alla possibilità cioè di camminare per scelta, ma nel fare ciò non dovremmo dimenticare che per la stragrande parte dell’umanità questa condizione è piuttosto recente e segna, almeno in apparenza, uno scarto dal percorso cultural-evolutivo.
A differenza di quanto è avvenuto per le altre funzioni primarie, che non sono state surrogate, ma solo agevolate (con la cottura dei cibi, con la costruzione di ripari e giacigli), l’uomo ha cercato per i suoi spostamenti di ovviare il più possibile al determinismo fisiologico, inventando o procurandosi dei mezzi di locomozione alternativi, delle “protesi” animali prima e meccaniche dopo. Lo ha fatto inizialmente a fini utilitaristici, per spostarsi più velocemente, per risparmiarsi la fatica, per procurarsi dei vantaggi sugli avversari, ma la cosa ha assunto col tempo anche una valenza simbolica.
Per un lunghissimo periodo della storia umana la possibilità di spostarsi senza usare le gambe ha addirittura costituito uno dei principali segni di affermazione sociale (Barthes scrive che «qualunque promozione sociale abolisce in primo luogo le gambe»). In effetti, se ci riflettete, il primo gradino di distinzione era nel mondo antico l’ingresso nel ceto degli equites e nel medio evo l’appartenenza alla cavalleria; allo stesso modo nel mondo contemporaneo l’auto rimane lo status simbol per eccellenza.
Qualcosa però è cambiato. Ecco, vorrei parlare proprio di questo, del fatto che da gesto istintivo, naturale e necessario qual era, il camminare sta diventando sempre più un comportamento volontaristico, un gesto culturale innalzato alla seconda potenza. Nel corso della trasformazione a questo gesto sono state associate diverse motivazioni: dapprima religiose e penitenziali, poi anticonformistiche, quindi sportive e infine, oggi, salutistiche, di auto rappresentazione o di protesta. Insomma, camminare non è più oggi solo un modo per spostarsi, ma un linguaggio attraverso il quale inviamo messaggi a noi stessi o agli altri.
Procediamo però con ordine. Il progetto iniziale era limitato alla biografia di Seume, anzi, più specificamente alla sua passeggiata per l’Italia. Poi, come sempre mi accade, l’argomento mi ha preso mano e mi ha spinto ad allargarmi. Diventa quindi necessario dividere il mio racconto in due momenti. Nel primo si seguirà grosso modo la scaletta originaria. Nel secondo prenderò invece spunto da quella per avventurarmi lungo altri sentieri, mantenendo comunque la stessa meta. Faremo, se lo vorrete, un pezzo in più di strada assieme. A piedi, naturalmente.
2. Devo precisare che Seume non è propriamente un prussiano. Nasce nel 1762 in una famiglia di contadini sassoni (ma la Sassonia era da tempo nell’orbita del regno di Prussia), già di per sé povera e gettata poi nella miseria estrema dalla morte del padre, dal quale il primogenito Johann eredita solo «la malattia di non poter vedere un’ingiustizia senza protestare».
La perdita del capofamiglia comporta di lì a poco anche quella del fazzoletto di terra su cui la madre viveva con altri quattro figli, per cui il ragazzino deve precocemente ingegnarsi per campare. Ci riesce bene, e la sua intelligenza viene segnalata da un maestro a Friedrich von Hohenthal, il signorotto locale che lo prende sotto tutela e lo aiuta a ricevere in qualche modo, sia pure tra molte ristrettezze, una solida istruzione.
La storia del ragazzo di modeste condizioni avviato agli studi dalla benevolenza di un aristocratico o di un ecclesiastico non è infrequente in Germania e nei paesi nordici. Negli stessi anni, a poche miglia di distanza, un’identica sorte capita a Fichte, coetaneo di Seume, che aveva iniziato la sua carriera come guardiano d’oche. La cosa ha senz’altro a che fare con lo spirito di fondo dell’etica protestante, con l’idea cioè che chi merita vada premiato e aiutato ad affermarsi, e con i suoi presupposti dottrinali, che contemplano il sacerdozio universale, ovvero la possibilità per tutti di avere accesso diretto alla parola di Dio, e quindi una scolarizzazione di base anche per i più poveri.
In sostanza, nei paesi protestanti si crea per la cultura uno spazio di reclutamento allargato, che basterebbe da solo a spiegare il loro primato culturale – ma lo stesso vale anche per la cultura ebraica – in tutta l’età moderna. Nel caso nostro, poi, va anche considerato che Federico II aveva introdotto nei suoi domini l’obbligo di una istruzione minima per tutti, non certo per zelo religioso, ma perché tutti fossero in grado di conoscere direttamente, e in questo caso senza libertà alcuna di interpretazione, la sua volontà.
Buona parte dei personaggi dei quali mi sono occupato ha seguito la stessa trafila, e forse me ne sono occupato proprio per questo, per una sorta di inconscia identificazione. Ciò spiegherebbe anche perché sono quasi tutti stranieri: vicende di questo tipo accadono raramente dalle nostre parti (per l’Italia, se si esclude forse Pascoli, non me ne viene in mente uno).
Al termine degli studi secondari, Seume è indirizzato alla facoltà di Teologia dell’università di Lipsia, perché quella religiosa è l’unica carriera aperta al figlio di un contadino (o a chi non sembra possedere doti particolari: sarà il caso, ad esempio, di Darwin). I geni ribelli e indipendenti ereditati dal padre non tardano però a manifestarsi. Dopo un solo anno, durante il quale anziché al canone ecclesiastico si dedica alla scoperta dei razionalisti inglesi (soprattutto dello scetticismo religioso di Shaftesbury), capisce che non è assolutamente il caso di insistere: «Intesi che da uomo onesto io non potevo continuare per quella strada».
Con grande rammarico del suo benefattore decide quindi di spostarsi a Parigi, la capitale dell’Illuminismo, col progetto di arruolarsi e tentare la carriera militare: ciò che in Germania, stante la sua estrazione sociale, gli sarebbe precluso. Alla fine di giugno del 1781 salda quindi tutti i suoi debiti (cosa decisamente inusuale per gli studenti dell’epoca) e lascia nascostamente Lipsia.
Per arrivare in territorio francese deve però attraversare una miriade di staterelli regionali tedeschi, e lo fa nel momento peggiore. Da diversi anni infatti i langravi dell’Assia e del Brunswick inviano in America milizie reclutate a forza tra i contadini o tra chiunque capiti nelle mani degli “arruolatori”. Vendono i soldati agli inglesi un tanto a capo, come fossero bestiame. È in corso la rivoluzione americana e l’Inghilterra non ha effettivi sufficienti per contenere la ribellione (è contemporaneamente impegnata a desertificare l’Irlanda); il parlamento è restio a creare un forte esercito con sudditi britannici, cosa contraria alla mentalità e alla tradizione inglese, oltre che pericolosa per l’autonomia parlamentare stessa, e soprattutto preferisce far svolgere il lavoro sporco della repressione alla soldataglia straniera. Dal canto loro i principi tedeschi non si fanno alcuno scrupolo, pur di incrementare risorse sempre inadeguate al tenore di vita che mantengono.
Quando a Erfurt, sulla strada per Metz, Seume viene fermato dagli uomini del langravio d’Assia e arruolato, combattono già oltreoceano circa trentamila “mercenari”, per la gran parte provenienti dall’Assia. Costituiscono in pratica l’ossatura dell’esercito lealista e sostengono gli scontri più impegnativi. Alla fine settemila di loro rimarranno sul campo, uccisi soprattutto dagli stenti e dalle malattie, mentre altrettanti disertano nel corso del conflitto e scelgono di andare a impinguare le colonie tedesche della zona costiera centrale. Non sono comunque solo i prussiani a fare commercio dei propri concittadini: anche i Savoia inviano un contingente mercenario di circa duemila uomini.
Seume e i suoi sventurati compagni vengono concentrati nel giugno del 1782 a Kassel, e di lì marciano sino al porto di Brema dove li attendono le navi inglesi. Il carattere di Seume viene fuori già dal modo in cui affronta questa circostanza. Scrive nell’Autobiografia:
Nonostante la generale tristezza, io godevo della bellezza della regione montana […] il viaggiare rende lieti, e la nostra compagnia era così variopinta, forniva una tal mescolanza da fornire a ogni momento un motivo di distrazione.
Johann Gottfried ha vent’anni e vive questa esperienza con eccitazione: in fondo, lo porterà addirittura a conoscere il Nuovo Mondo. Ciò non toglie che durante la marcia guidi un tentativo di fuga e che una volta ripreso salvi la pelle solo perché ogni uomo venduto agli inglesi vale sette sterline. È la prima delle tantissime situazioni estreme in cui verrà a trovarsi. A Brema è imbarcato su un vascello inglese che ha nulla da invidiare alle navi negriere. Il viaggio è un disastro. Per arrivare a destinazione sono necessari quasi tre mesi, vissuti in condizioni spaventose:
Venimmo pigiati accatastati, messi a strati come le aringhe […] Non c’era spazio […] Nessuno poteva cercare di muoversi o di dormire sul dorso. Il vitto era pessimo e l’acqua putrida. Non era possibile berla senza passarla per uno straccio, e ancora ci si dovevano chiudere le narici.
Nel corso di tutta la spedizione saranno in effetti più numerosi i morti per i disagi che quelli in combattimento; il contingente di Seume si risparmia almeno questi ultimi, dal momento che quando la nave finalmente arriva (nel settembre del 1782) è già avvenuto a Yorktown lo scontro decisivo che porterà alla conclusione del conflitto. Il battaglione al quale i rincalzi sono aggregati sverna pacificamente nella baia di Halifax ed è rimpatriato alla fine dell’estate successiva.
Unico risvolto positivo di questa drammatica esperienza è l’amicizia che Seume stringe ad Halifax con Karl von Münchhausen, omonimo e nipote del famoso barone che ispirò il libro di Raspe, di solo un paio d’anni più anziano di lui. Münchhausen è partito come volontario due anni prima e comanda la compagnia alla quale Seume, il più istruito del suo gruppo e probabilmente anche il più tosto, è assegnato come sergente.
L’intesa intellettuale è immediata e profonda e l’amicizia è destinata a durare anche dopo il rientro di entrambi in patria. In verità si rivedranno solo a distanza di vent’anni, per una sola volta, a Smalcalda (città della Turingia), al ritorno di Seume dall’Italia, ma manterranno una fittissima corrispondenza, parte della quale sarà pubblicata congiuntamente nel 1797 col titolo di Rückerinnerungen, che sta pressappoco per Memoria di un’amicizia. In essa rievocano le loro peripezie americane, ma si scambiano anche opinioni sulla situazione politica e sociale della Prussia, da posizioni repubblicane l’uno e aristocratico-conservatrici l’altro. Seume esprimerà poi la nostalgia per quei tempi difficili ma avventurosi e carichi di aspettative per il futuro in una poesia del 1802, Addio al mio amico Münchhausen, che fornirà appunto l’occasione per l’ultimo incontro.
Anche il viaggio, e nel complesso tutta la vicenda, viene vissuto (o almeno, così sarà poi raccontato) con una spensieratezza che non è per nulla frutto di giovanile incoscienza, ma nasce dall’esercizio continuo della forza di volontà. Seume non vuole lasciarsi travolgere dagli avvenimenti e riesce in qualche modo a dominarli, traducendo ogni disavventura in esperienza.
Il suo atteggiamento positivo risulta ancora più evidente se confrontato con quello di un compagno di sventura, un religioso, l’unico dotato di un po’ di istruzione, col quale inizialmente aveva sperato di instaurare un rapporto meno animalesco: quello però si lascia andare alla disperazione, rimedia continue punizioni e finisce poi per morire in un angolo isolato del ponte, abbandonato da tutti.
Seume oppone invece tutta la resistenza che gli è consentita dalle sue risorse culturali. È riuscito in mezzo a tutto questo pasticcio a conservare un volumetto delle odi di Orazio e quando ha un momento d’aria lo legge sul ponte. E qui accade un altro della serie di “miracoli” iniziati con la sua adozione da parte del conte di Hohenthal, che si ripeteranno lungo tutta la sua vita. Il capitano lo nota mentre legge, è incuriosito, è colpito dall’intelligenza, dalla cultura e dalla forza di carattere del giovane e fa in modo di rendergli meno penoso il viaggio e di procurargli un po’ di cibo in più.
3. Col ritorno in Germania, nell’agosto successivo, le disavventure di Seume non sono per niente finite. Riesce a eludere il controllo degli assiani, ma solo per finire nelle mani degli sbirri del re di Prussia, che lo obbligano di guarnigione a Emden senza nemmeno riconoscergli il grado precedente. Tenta altre due volte la fuga e due volte viene riacciuffato e processato come disertore.
Se la cava, al solito, per quella strana fortuna che pur nelle disgrazie lo assiste e perché sa far valere la sua istruzione. Una volta, durante il processo, uno dei magistrati dell’accusa contestata l’esattezza di un verso latino che il giovane ha scritto sulla porta della cella. Ne nasce una situazione da film di Totò, con la corte che si mette a discutere di metrica e l’accusato che spiega come deve essere costruito un esametro: a quanto pare riesce molto convincente, perché alla fine viene assolto.
Un’altra volta sfugge per un pelo a una fustigazione a sangue che probabilmente lo avrebbe ucciso. Viene graziato per l’intervento dei maggiorenti di Emden, ai cui figli ha nel frattempo impartito delle apprezzatissime lezioni: uno di essi paga anche una cauzione (successivamente rimborsata da Seume) che gli permette di tornare finalmente libero. Riesce così nel 1787 a rientrare a Lipsia e a rivedere la madre. Dalla sua forzata partenza sono trascorsi quasi cinque anni.
In patria è riaccolto calorosamente dai molti amici dell’università, che ne apprezzavano il carattere modesto e l’indipendenza di pensiero e che già all’epoca in cui era scomparso si erano mobilitati per rintracciarlo. Christian August Clodius, poeta, librettista e compagno di studi di Seume, del quale porterà poi a termine l’autobiografia, racconta come riuscisse immediatamente simpatico a tutti: e in effetti vedremo che anche all’estero non avrà mai difficoltà a conquistarsi la fiducia di altri viaggiatori e l’ospitalità degli autoctoni.
Seume riprende dunque a frequentare l’università, si mantiene con lezioni e traduzioni (soprattutto dall’inglese), vive una vita spartana e non cerca impieghi, perché questi gli creerebbero vincoli e limiterebbero la sua libertà di dire tutto ciò che pensa:
Mi si rimprovera di non cercarmi un impiego statale. Per molti impieghi del genere mi sento inadatto; d’altronde fa parte dei miei principi che debba essere lo stato a cercar gli uomini per i suoi impieghi, e non viceversa. Se fossi ministro, difficilmente concederei un impiego a chi lo chiede […] Molti riterranno questa mia una bizzarria. Io no. Se non fossi io, individuo isolato, a combattere per le mie idee, chi dunque dovrebbe farlo?
Consegue il dottorato nel 1791 e l’anno seguente si abilita all’insegnamento con una dissertazione su Arma veterum cum nostris breviter Comparata (L’armamento nell’antichità e nei tempi moderni. Un breve confronto). Seume wird Privatdozent.L’argomento è significativo perché a questo punto Seume continua a considerarsi un militare e a coltivare il vecchio sogno di diventare ufficiale (in fondo è un quasi-prussiano!) e quando gli si offre l’occasione di entrare come attendente al servizio del generale Otto von Igelström, prussiano al servizio dello zar e comandante in capo delle truppe di occupazione russe a Varsavia durante la campagna di Polonia, la coglie al volo.
Siamo nel 1794. La Polonia, oggetto l’anno precedente della seconda spartizione tra Russia, Prussia e Impero Asburgico, si è ribellata sotto la guida di Tadeusz Kościuszko. La rivolta è soffocata a prezzo di scontri sanguinosissimi e Seume stesso durante la decisiva battaglia di Varsavia cade nelle mani dei polacchi. Viene risparmiato perché come ufficiale può tornare utile negli scambi, rimane prigioniero per diversi mesi e torna libero solo dopo la resa definitiva degli insorti.
Al termine della campagna Seume si congeda: dopo le carneficine cui ha assistito, la carriera militare non gli sembra più tanto appetibile:
Feci allora come ufficiale russo il mio dovere, ma poi giudicai quei fatti a modo mio.
E meno che mai al servizio di un potere dispotico:
In Russia non mi mancherebbe certo qualche posto decoroso. Ma andrei a Lipsia ad azionare il mantice dell’organo piuttosto che dare la mia vita in ipoteca a un paese dove solo di tanto in tanto si vede galleggiare un frammento di umanità in un oceano di barbarie.
Ha anche dovuto rendersi conto dell’incompatibilità del suo carattere con un ambiente nel quale non sono i meriti a determinare la carriera:
In tutta la mia vita non mi sono mai abbassato a chiedere qualcosa che non abbia meritato, e nemmeno chiederò mai quel che ho meritato finché esistono in questo mondo tanti mezzi di vivere onestamente: e quando poi anche questi finissero, ne resterebbero alcuni altri per non vivere più.
4. Dopo una serie di vani tentativi per vedersi riconosciuti il servizio e il grado (era stato nominato da Igelström tenente dei granatieri) rinuncia a rivendicare i suoi diritti e torna in Sassonia. Nel catalogo dei liberi corsi offerti dall’università di Lipsia per il 1797 ci sono tre sue proposte ma evidentemente non riscuotono molte adesioni. Si mantiene quindi come al solito, dando lezioni di inglese e di francese, fino a quando non viene chiamato a collaborare da Göschen, un editore che pubblica a Grimma soprattutto traduzioni di classici. A Seume viene invece affidata la cura delle opere complete di Klopstock (in realtà non gli è particolarmente congeniale e più tardi, al momento della morte del poeta, rifiuterà di scriverne il necrologio). Lo stipendio non è principesco, ma a lui basta e avanza: tanto che è in grado di restituire al conte di Hohenthal buona parte della somma investita nella sua istruzione.
All’atto dell’assunzione si impegna per due anni e fa un ottimo lavoro, ma allo scadere esatto del secondo anno, come annunciato preventivamente all’editore, molla tutto quanto e dà corso al sogno che coltivava da anni: un viaggio in Italia.
La curiosità intellettuale per l’Italia era arrivata anche in Germania sull’onda degli studi di Winckelmann, altri viaggiatori tedeschi come Carl Moritz e Leopold zu Stolberg avevano contribuito poi a diffonderla sul finire del Settecento. Goethe aveva visitato la penisola a metà degli anni ottanta, ma la pubblicazione del suo diario avverrà solo nel 1816.
Seume non è tuttavia motivato dalla moda incipiente, il suo amore per i classici è genuino, fondato su una conoscenza profonda e su una perfetta sintonia del sentire. Come Leopardi, tra gli autori classici predilige Teocrito e il viaggio si configura quindi come una sorta di pellegrinaggio sino ai luoghi teocritei. Prima di partire scrive a un amico:
Sono sempre dell’idea di partire per l’Italia, fosse anche solo per leggere alcune odi di Orazio sotto il suo cielo. Non sarà male che io respiri altra aria. Vivi dunque fino a quando io ritorni e ti possa raccontare come si legge Teocrito vicino alla fonte Aretusa.
Come vedremo, però, l’immersione nella classicità è solo un pretesto: gli interessano altrettanto, e forse più, i suoi contemporanei e le loro storie. E non è tutto, c’è anche quella coazione del viaggiatore della quale torneremo a parlare, e che gli fa scrivere:
Che il destino mi spinga tanto singolarmente per il mondo non è sempre una mia scelta, ma io mi comporto in questi casi di solito assai passivamente.
Naturalmente, trattandosi di un pellegrinaggio e trattandosi di Seume, il viaggio avrà uno svolgimento tutto particolare. Innanzitutto sarà compiuto a piedi. Nella scelta entra senz’altro la motivazione economica, ma Seume è anche sinceramente convinto che:
Chi va a piedi vede di più di chi viaggia in carrozza, […]. Camminare è l’attività più libera e indipendente, niente vi è di peggio che star seduti troppo a lungo in una scatola chiusa […] chi si fa trascinare da un veicolo si abbassa di molti gradi dalla sua dignitosa e genuina umanità.
Poi sarà all’insegna della più assoluta sobrietà. Seume viaggia con un equipaggiamento essenziale: uno zaino di pelle di foca sormontato da una testa di tasso (oggetto di una stupita curiosità lungo tutto il viaggio), una giubba pesante polacca, un mantello, scarponi chiodati ai piedi, un nodoso bastone.
Dentro lo zaino ci sono un paio di ricambi di calze, un abito per le occasioni speciali, scarpe leggere, una fiaschetta di resina come borraccia e le edizioni economiche di Virgilio e di Omero, quelle stampate in corpo otto. Un bagaglio più che leggero. Evidentemente però è quanto basta, perché con questo corredo tirerà avanti per nove mesi. Scriverà in chiusura del suo diario:
A lode del mio calzolaio devo dire che sono andato e tornato sempre con gli stessi stivali, e che questi sembrano avere ancora solidità sufficiente da partecipare a un’altra scarpinata del genere.
In verità gli stivali ha dovuto farli risuolare in due volte in Italia.
5. Seume parte da Lipsia ai primi di dicembre del 1801. Passa per Dresda, Praga, Vienna, Graz, Lubiana e a gennaio è a Trieste; di lì, toccando Venezia, Bologna, Ferrara e Ancona, arriva a Roma al primo di marzo e a Napoli alla fine del mese. Da Napoli, la traversata sino a Palermo è effettuata via mare su un mercantile per evitare i pericoli di una Calabria infestata di briganti. Da Palermo va ad Agrigento e finalmente arriva a Siracusa, quattro mesi dopo la partenza. «Oggi sono qui, e leggo Teocrito nella sua città natale, seduto presso la fonte Aretusa» scrive all’amico.
A Catania compie anche un’ascensione sull’Etna, in mezzo alla nebbia e in un’aria gelida, in compagnia di cinque inglesi che si dopano col rhum e salgono con attrezzatura tecnica, finendo con i piedi congelati:
Continuai ad arrampicarmi, e a onore della nazione tedesca arrivai per primo sul ciglio dell’immensa voragine.
Il 20 di aprile, concluso il periplo della Sicilia, ha inizio il ritorno. Ancora a Napoli via mare, con salita solitaria al Vesuvio. Poi a Salerno, dove vede la reggia ma ha anche modo di fare esperienza, proprio nella persona della sua guida, dello stile della camorra. Tocca nuovamente Roma, questa volta solo di passaggio. Sulla via per Firenze deve rinunciare alle camminate solitarie per le notizie recenti di assalti banditeschi e di omicidi di viaggiatori. Si ferma pochissimo a Siena, dove ha modo di inorridire per il racconto delle atrocità compiute poche settimane prima con il benestare della chiesa (alla partenza dei soldati francesi, tredici ebrei accusati di giacobinismo sono stati arsi sul rogo, e l’arcivescovo ha impartito la benedizione ai carnefici). A metà giugno è a Milano, dopo essere ritransitato per Bologna, Modena e Reggio. Passa quindi le Alpi e tocca in successione Lucerna, Zurigo, Basilea, Digione, Auxerres, per essere a Parigi il 6 luglio. Di lì (21 luglio) Chalons, Nancy, Strasburgo, passaggio del Reno, Worms, Magonza, Francoforte, Bergen, Weimar, Lipsia.
Ho fatto un po’ di conti a braccio: non è facile desumerli dal suo giornale di viaggio, che fornisce solo raramente indicazioni sui tempi e sulle distanze, percorse oltretutto in misure prussiane (un miglio prussiano equivale a sette chilometri e mezzo), e non offre resoconti giornalieri dettagliati. Da Lipsia a Siracusa, lungo il percorso praticato da Seume, sono circa duemila e duecento chilometri. Al ritorno ce ne sono altrettanti da Siracusa a Parigi e quasi novecento da Parigi a Lipsia. Un totale di cinquemilatrecento chilometri.
Non li ha percorsi tutti a piedi come si era proposto, un po’ per motivi di sicurezza perché in alcune zone viaggiare da solo avrebbe significato farsi rapinare o ammazzare quasi certamente, un po’ per il cattivissimo stato in cui ha trovato le strade in piena stagione invernale e dopo un’alluvione che aveva sconvolto mezza penisola. Anche sottraendo i tratti percorsi in diligenza o in nave, sono comunque ben oltre i quattromila chilometri.
Si è concesso lunghi periodi di sosta nelle città più importanti o che semplicemente più gli aggradavano, quindici giorni a Vienna, nove a Venezia, un mese a Roma, e così via, durante i quali peraltro non è rimasto in poltrona, ma ha girato come una trottola, asceso vulcani, fatte escursioni nei dintorni. Sui nove mesi della durata complessiva del viaggio ha dedicato alle tappe di spostamento meno di centocinquanta giorni, coprendo in media più di trenta chilometri il giorno. In realtà spesso i chilometri giornalieri sono oltre cinquanta, percorsi in dieci ore comprensive della sosta per il pranzo: il che ci dice che marcia a un passo davvero sostenuto. Ma ci dice anche che altre volte se la prende comoda: non sta cercando il record, ma vuole guardarsi attorno, conversare quando capita, gustare buoni pranzi, fare deviazioni se qualcosa nel panorama lo attrae. Non a caso titola il suo diario di viaggio Una Passeggiata fino a Siracusa.
Vediamo dunque come Seume affronta questa passeggiata, come si pone di fronte ai luoghi che attraversa, alle persone che incontra, alle situazioni in cui viene a trovarsi. Cercherò di farlo il più possibile attraverso le sue stesse parole, anche a rischio di riuscire un po’ noioso. Con Seume non è necessario leggere tra le righe: è sempre estremamente chiaro, schietto e spontaneo.
6. Il nostro prussiano viaggia naturalmente armato di quei principi sui quali ha fondato le sue scelte di vita e il suo modo di rapportarsi agli altri: onestà, lealtà, semplicità, tolleranza, frugalità (ha ridotto i suoi bisogni al punto che gli amici lo chiamano il nobile cinico), e quando si presenta l’occasione, o qualche episodio lo spinge a considerazioni più generali, non manca di professarli e farne partecipe il lettore. Ma non è un integralista.
Nell’introduzione al diario scrive:
Non sono abbastanza forte per mettermi con le mie idee controcorrente, quando la corrente è fatta di milioni di uomini – in compenso ritiene però che – se contro la corrente del tempo l’individuo singolo non può nuotare, chi è a parte può tenersi saldo e non lasciarsi trascinare via.
Nell’etica privata è un pronipote di Seneca e in generale del sentire classico:
Chi è convinto in buona coscienza di avere compiuto il proprio dovere fino all’ultimo può, alla fine, quando gli vengono a mancare le forze, uscire dalla scena senza vergognarsene.
Per quella pubblica è invece un figlio dell’Illuminismo: libertà, diritti e progresso devono esserne i fondamenti, ma all’insegna di una razionalità tollerante o, più semplicemente, del buon senso.
Seume ha inizialmente creduto nella Rivoluzione Francese, come la gran parte dei suoi coetanei, anche in Germania, e ora, a dispetto degli esiti e della delusione, continua a pensare che:
La rivoluzione avrà sempre il merito di aver posto i fondamenti della ragione e del diritto pubblico – tuttavia ci tiene a chiarire – non sono, e tu lo sai, un rivoluzionario, perché convinto che la rivoluzione tragga dal male al peggio – convincimento senz’altro rafforzato dai guasti che vede prodotti, soprattutto in Italia e nella versione napoleonica, dal giacobinismo da esportazione.
Questo non gli impedisce di esprimere, a volte «con voce più alta del dovuto», le proprie idee e soprattutto la propria indignazione nei confronti del malgoverno e delle soperchierie. Come tutti i prussiani più seri, resi sensibili dal bastone del dispotismo, è tendenzialmente repubblicano. Scrive a un certo punto:
Se fossi un viaggiatore ordinato e sistematico, avrei dovuto prendere a destra verso i monti per visitare la felice Repubblica di San Marino, tanto più che ho un debole per le repubbliche, anche per quelle che non sono molto sane.
Non bastano comunque i cambiamenti istituzionali e nemmeno le costituzioni a rendere migliore il mondo:
La giustizia è la prima, la cardinale virtù divina che sola può far progredire l’umanità – ma – se cerchi la giustizia nelle leggi, ti sbagli di molto: quante più leggi, tanto minore giustizia.
Sono invece necessarie e sufficienti poche semplici regole, che ogni individuo deve impegnarsi a rispettare e ogni comunità a far rispettare. Entro questo quadro, ciascuno può poi godere del massimo della libertà.
Da buon illuminista è naturalmente anticlericale, infatti, la citazione precedente terminava con:
Quanta più teologia, tanto meno religione; quanto più lunghe le prediche, tanto meno moralità.
Seume non si professa ateo: nutre anzi legittimi dubbi su chi – ed erano molti all’epoca sua – dell’ateismo fa una bandiera, pronto poi magari, alla resa finale dei conti, a rifugiarsi nella misericordia divina. Sull’argomento ha pubblicato nel 1796 un brevissimo saggio, dal titolo Ubere Ateismi in Verhältniß gegen Religion, Tugend und Staat (Sull’ateismo in rapporto alla religione alla virtù e allo stato), nel quale, mettendo a confronto l’ateismo e il fanatismo religioso, sceglie naturalmente la via di mezzo, quella di una laicità coerente (non senza rilevare però che «la storia ci ha insegnato che i più famosi mascalzoni non erano certo sospetti di ateismo»).
È proprio la sua disposizione laica, paradossalmente informata all’idea che ogni dottrina morale si risolve «nel più fine egoismo», in altre parole che il conseguimento della felicità individuale è inscindibile da quello del benessere collettivo, a fargli provare disgusto di fronte alla superstizione e all’ipocrisia usate per asservire le masse.
Io sono così ben disposto, verso il Cattolicesimo, e mi atterrei volentieri a una suprema autorità anche nel campo spirituale, solo che la gente fosse un po’ più ragionevole. Il mio è il cattolicesimo della ragione, della generale giustizia per tutti, della libertà e dell’umanità, e il loro è invece la cappa di nebbia dei pregiudizi, dei privilegi, della ferrea oppressione delle coscienze.
Il suo anticlericalismo non nasce quindi da motivazioni teologiche, a muoverlo è l’indignazione nei confronti di chi della religione fa un uso sporco.
Di nuovo si vendono indulgenze a sconto di ogni genere di birbonate. È già di per sé abbastanza assurda la remissione dei peccati, ma colui che ha inventato tal sorta di remissione rimarrà una maledizione per l’umanità.
Per questo non si lascia sfuggire l’occasione di raccontare episodi boccacceschi che coinvolgono dei religiosi.
A Prewald, ospite in una locanda gestita da tre sorelle, nella quale soggiorna anche un cappellano militare, gli capita di alzarsi presto per chiedere il conto e, non trovando nessuno, di entrare in una stanza dalla porta appena socchiusa:
Ed ecco quel bel pezzo di peccato originale alzarsi dal letto scusandosi molto educatamente che nessuno fosse ancora sveglio. Dio sa come io, poverino, sarei rimasto imbarazzato se quella figliola non si fosse gettata sulle spalle il mantello che il sant’uomo aveva indosso la sera prima. Quell’indumento mi ispirò una buona dose di stoicismo, pagai il conto e me ne andai.
Dopo aver descritto le portate di un pranzo quaresimale in un convento messinese del quale è ospite, chiude: «Con tale dieta credo che si acquisti una fede ortodossa che sfida il buon senso».
I privilegi del clero, alimentati speculando sull’ignoranza e la superstizione, hanno il loro corrispettivo nell’oppressione e nella miseria in cui è tenuto il popolo. Dopo aver constatato che Messina è «ancora oggi uno spaventevole mucchio di rovine» (un terremoto l’aveva quasi completamente rasa al suolo nel 1783), racconta:
La santa vergine è notoriamente la patrona dei messinesi […] Se poi non difende dai terremoti, ciò è da imputare al fatto che i peccatori debbono venir puniti. Ho avuto occasione di assistere a una solenne cerimonia in suo onore. […] La processione sarebbe stata comica se non fosse stata fin troppo seria. Un frate predicò per mezz’ora nella cattedrale, parlando della santa Vergine, del suo grande credito in cielo, delle grazie speciali da lei ottenute per la città.
A Catania invece sbotta:
Qui si comincia a prendere viva coscienza dell’infelicità del paese […]. I frati hanno nelle loro mani la terza parte dei beni, e se il loro ingrassarsi fosse l’unico male che procurano allo stato, l’orribile errore di stampa dell’intelligenza umana sarebbe ancora perdonabile.
Non stigmatizza però solo la doppiezza e l’avidità dei religiosi, sottolinea anche il fariseismo dei credenti, quale che sia la classe sociale di appartenenza. Tra Pesaro e Fano ha a che fare con un vetturino che:
[…] era un perfetto cattolico ortodosso che si segnava davanti a ogni croce, mormorava giaculatorie, recitava la messa e per il resto bestemmiava come un lanzichenecco. […] se fossi dannato a udir spesso simili melodie, mi convertirei al materialismo e all’idea della completa distruzione dopo morte, perché non è possibile pensare che per questi esseri esista una sopravvivenza dell’anima.
Ad Agrigento fa la conoscenza di un revisore delle imposte, «un personaggio vestito con gran lusso» estremamente affabile, che si autoinvita a cenare con lui.
Il signor revisore a un certo punto venne a sapere, dietro sua domanda, che ero eretico. Per lo spavento lasciò cadere la forchetta e il coltello, e mi fissò come se già mi vedesse bruciare all’inferno. […] Il mio uomo era sposato nella capitale, aveva a casa tre figli e, secondo la sua aperta confessione, durante i suoi viaggi non poteva fare a meno, appena gli era possibile, di passare la notte con una ragazza. Del resto bestemmiava e diceva oscenità in latino e in italiano come un marinaio, ma non poteva assolutamente concepire come non si credesse al papa e che si potesse vivere senza frati. Nonostante tutto, decise di continuare a mangiare con me.
E tuttavia, il suo non è un anticlericalismo viscerale: niente a che vedere, per capirci, con quello astioso di un Voltaire. Seume riesce a essere equilibrato e tollerante anche nella condanna. A volte appare addirittura divertito davanti all’inverosimiglianza di certi comportamenti, e in altre occasioni si toglie lo sfizio di mettere i religiosi di fronte alla loro ignoranza. Nel convento benedettino di Catania:
[…] come tesoro di straordinaria rarità mi mostrarono uno splendido manoscritto della Vulgata. Io ne lessi qualche riga e dispiacque a quei signori una mia osservazione: dissi subito, cioè, che era un peccato che il copista non capisse il greco. Mi guardarono stupiti, e allora fui costretto a dimostrare che per tale ignoranza colui aveva commesso molti errori e inesattezze. La buona gente ci rimase male: rimisero subito al suo posto il sacro testo, con un’espressione sulla faccia che chiaramente mi avvisava che simili tesori non sono per profani.
Arriva anche ad apprezzare i pochissimi aspetti positivi del governo papale:
Quando un papa costruisce un bell’acquedotto fluente gli si può quasi perdonare d’essere papa – e a riconoscere i religiosi dabbene, quando (raramente) li incontra – Ho conosciuto un frate che, come frate, è l’unico esempio di buonsenso che abbia incontrato in vita mia.
7. Seume non viaggia “all’inglese” e neppure “alla francese”. Non ostenta lo snobistico understatement del viaggiatore d’oltremanica, il distacco che nasce dalla convinzione di rapportarsi (ovunque ci si trovi, sul continente o nel mondo intero) con livelli di civiltà inferiore, con i quali non vale neppure la pena del confronto (ciò che consente poi di rubricare e recuperare sotto le specie del “pittoresco” quanto appare primitivo, ma comunque intriga).
Allo stesso modo non insiste come i cugini d’oltralpe a criticare e a scandalizzarsi contrapponendo alla barbarie altrui la raffinatezza dei costumi e delle istituzioni proprie. Sta dentro la narrazione fino al collo, è pieno di curiosità non preconcetta e racconta il paesaggio, le persone incontrate, attraverso la sua interazione. Quello che ci rimane alla fine è una sorta di documentario ricchissimo e intrigante, perché non solo non ci offre cartoline scontate, ma ci fa conoscere anche un personaggio originale e carico di simpatia, onesto nei giudizi, umile e ironico. Seume è consapevole di compiere a suo modo un’impresa: anche se non lo sottolinea, ci tiene però a rimarcare (ad esempio in occasione dell’ascensione all’Etna) che quanto a velocità e resistenza non la cede a nessuno, si avverte che se ne compiace e lo fa spesso trapelare dai commenti altrui:
Precedendo a piedi la vettura, e mantenendo a malapena l’equilibrio su esili ponticelli (tanto che i miei compagni ammirarono assai la mia forza e la mia abilità nel frangente) – come anche, in occasione dell’incontro con altri viaggiatori – i signori furono sbalorditi all’udire che volevo viaggiare fino ad Agrigento col mio zaino sulla schiena.
Lungo tutto il percorso trova, in effetti, gente che lo guarda allibita e perplessa quando capisce cosa sta facendo, gli dice che solo un pazzo può cacciarsi in un’impresa del genere o cerca di dissuaderlo evocando i pericoli dei briganti.
La gente continuava a ripetermi che ero matto a voler andare da Trieste a Venezia attraverso le montagne, e mi dicevano che avrei rischiato di lasciarci la pelle. Le montagne erano malsicure, perché rifugio di tutta la marmaglia degli stati vicini.
Lui se la cava con un’alzata di spalle, facendo intendere che i pericoli ventilati sono spesso un’esagerazione:
Io continuo tranquillo la mia strada, e mi affido al mio buon bastone nocchieruto, con cui posso validamente battermi e rompere qualche costola.
Ma non è per nulla uno spaccone incosciente. Quando ancora cammina per la Germania col suo amico Snort, spiega al lettore:
Noi non diamo l’impressione di portare molto con noi, e nemmeno di cedere facilmente quel poco che portiamo – e ribadisce a più riprese – anche in quei luoghi non mancavano le storie di assassini e assassinati, ma io possiedo il dono di apparire talvolta più povero e più scemo di quanto sia, e così arrivai felicemente al Campidoglio.
In effetti si può dire che gli va liscia, anche se almeno un paio di volte corre dei seri pericoli. Tra Genzano e Ariccia è sequestrato da quattro individui con barbe finte e volto annerito, che puntandogli il pugnale alla gola e colpendolo col calcio dei fucili lo spingono nel folto della boscaglia, dove gli strappano la borsa e i pochi spiccioli che teneva in tasca. Probabilmente lo spoglierebbero del tutto se non fossero disturbati da voci che si avvicinano. Il danno materiale non è molto, ma la sensazione del rischio corso di essere assassinato è forte, tanto che quando, a Roma, viene a sapere che due di essi sono stati catturati, si augura di vederli impiccati.
Ad Alicata viene invece fermato da tre cavalieri che lo tempestano di domande, rovistano nel suo sacco e solo quando si convincono che è un povero cristo un po’ originale, che non ha nemmeno i soldi per permettersi un cavallo, lo lasciano andare, offrendogli anche una sorsata di vino.
Rimango convinto di essere stato salvato dalla mia palese povertà, e che l’orologio e le onze d’oro – che portava nascoste nel giaccone – avrebbero potuto spedirmi all’altro mondo.
Comunque, sa anche affrontare situazioni pesanti con buon senso e determinazione, senza lasciarsi eccessivamente intimidire. A Itri un gruppo di «villanzoni» irrompe nella locanda in cui è ospitato assieme a un militare francese con l’intento di fare giustizia sommaria dei due forestieri, o quantomeno di derubarli e malmenarli un po’:
Indossai mantello e stivali, raccolsi tutta la mia dignità e il mio poco di italiano, e feci atto di scendere le scale per andare loro incontro – dall’alto, li apostrofa con – il tono più alto e risoluto che mi riuscì di prendere […] si fece un poco di silenzio, l’ostessa e alcuni mi pregarono di non scendere, cosa che naturalmente feci molto volentieri; e poco a poco se la svignarono tutti.
Una scena quasi analoga si ripete a Terranova, in Sicilia. In un altro difficile frangente fornisce prova di una determinazione cocciuta:
Alcune ore dopo Ferrara le cose si misero male: la vettura affondò fino all’asse.
Dopo vari tentativi inutili, si cerca di ricorrere ai contadini del luogo, che pretendono però una ricompensa esorbitante. Seume esorta il conducente a non cedere al ricatto e i viaggiatori a scendere dalla carrozza e a spingere, ma il problema non è ancora risolto.
I cavalli finalmente si rialzarono, ma la carrozza non si muoveva. Direi che mai un alemanno si sia ritrovato in Italia in una condizione più miseranda: immagina il tuo amico, coperto di fango da capo a piedi, che, postosi con le spalle sotto l’asse posteriore della vettura spingeva con tutte le sue forze, tra lo stupore della signora, del commissario e del vetturino. Dopo tre tentativi la vettura incominciò a muoversi e finalmente si disincagliò […]. – L’ha vinta lui.
Pur rimanendo necessariamente e consapevolmente al centro della scena:
È una vecchia constatazione che ogni scrittore nei suoi libri parla sempre di sé – scrive – ma non può né deve essere altrimenti, sempreché ognuno guardi in se stesso senza schermi e con purezza di intenti, Seume differisce nel modo di porsi dalla maggior parte dei viaggiatori del Gran Tour.
Oltre che dentro se stesso guarda senza schermi e senza pregiudizi anche fuori. La sua è una curiosità genuina e davvero illuministica, e lo si capisce proprio dall’essenzialità dei dati relativi al viaggio materiale: parliamo di cose serie, sembra dire, al lettore interessa cosa ho visto, non quanto ho impiegato per vederlo.
Veniamo quindi anche noi a quel che ha visto. In primo luogo l’ambiente. Seume non è a caccia di scenari o di panorami. E nemmeno di suggestioni artistiche alla maniera di Goethe e sulla scia di Winckelmann:
Se fossi un artista, ma anche soltanto un conoscitore, ti parlerei di quel che vi è e di quel che vi è stato. Ma probabilmente tu conosci già tutto attraverso i libri – e quindi si sente libero di parlare d’altro.
A proposito di Winckelmann, anzi, trovandosi ad alloggiare a Trieste proprio nella locanda e forse addirittura nella stanza in cui era stato assassinato, nota che quasi nessuno se ne ricorda e nessuno sa dove si trovi la sua tomba (lo stesso accade quando cerca il monumento a Tito Livio in Padova, ma qui alla fine almeno chi lo accompagna gli si rivolge in latino).
8. Il suo sguardo ricorda un po’ quello con cui viaggerà, solo tre anni dopo, Alexander von Humboldt, che arrivato sul passo della Bocchetta, dal quale finalmente vede il mare e un lungo tratto della costa ligure, ci dice solo che il terreno in quel punto è di natura calcarea. Niente epifanie particolari.
Nel caso di Seume l’attenzione, anziché agli aspetti geologico-naturalistici, va a quelli economici, antropologici e sociali. Al suo ingresso in Italia trova le zone del Polesine devastate dall’alluvione, o quelle appenniniche costellate di frane.
Tra Padova e Monselice potei osservare i guasti prodotti dalle esondazioni dei numerosi corsi d’acqua – non gli andrebbe diversamente duecento anni dopo – le condizioni disastrose delle strade, la miseria che regnava nei casolari della campagna. Fermatomi in un’osteria nei pressi di Monselice, tentai disperatamente di avere un pezzo di pane, dichiarandomi disposto a pagarlo a qualsiasi prezzo, ma trovai soltanto una fetta di cattiva polenta.
Il pessimo stato delle strade sarà il suo cruccio costante per tutto il percorso, per ovvi motivi, eppure, anche su questo argomento evita ogni sciovinistica supponenza:
Però di strade è meglio che non parli con i miei concittadini, perché di rado se ne trovano di più brutte e più incoscientemente trascurate che in Sassonia.
Col progredire verso il centro l’impressione di miseria si attutisce. Probabilmente non è la situazione nel complesso a mutare, ma è lo spettatore a cambiare i parametri, una volta sopravvenuta una sorta di assuefazione. Gli scenari però oggettivamente migliorano, trova ordinate e feraci le campagne del versante adriatico, o quella emiliana:
A destra avevo magnifiche colline, coperte di grano tenero e di olivi. Prima di Ancona, il 19 febbraio, vidi fagioli e piselli in fiore. […] Le valli e le montagne sulla destra, dove si allineano vigneti, frutteti, oliveti e campi di grano, offrono una vista magnifica.
Lo stesso vale per alcune zone prima di Napoli:
La valle campana è il più bel luogo che finora io abbia veduto nel vecchio e nuovo mondo […] Olivi, fichi, arance […] e sotto biade, fagioli, piselli […], in abbondanza frutta, cereali, vino.
Persino in Sicilia, dove in genere «quanto più ci si allontana dalla capitale tanto più cresce la desolazione» e la situazione lo porta a esclamare «Mai veduta in vita mia una miseria maggiore!» si imbatte in piccoli paradisi terrestri.
Vicino a Barcellona:
[…] la valle è una mescolanza incantevole d’ogni specie di frutti, aranci e olivi, fichi e vigne, legumi e cereali: e i monti che la rinchiudono non sono né troppo alti né troppo aspri, e le loro cime sono tutte coronate di selve.
È vero che anche in quest’occasione non trova pane e dorme vicino alla greppia dei maiali, ma in compenso può apprezzare il gesto di un mulattiere che gli cede il suo mantello di lana grezza con cappuccio:
Mi ci trovai benissimo, e ci feci un bel sonno e, anche a giudicare da una sola notte, si direbbe che abbia la vocazione a fare il cappuccino.
Sulla via del ritorno apprezza invece le campagne toscane:
Da Siena a Firenze il viaggio è stupendo, e via via che ci si avvicina a Firenze il coltivato diventa sempre migliore, e alla fine magnifico. Da San Casciano, ultimo paese prima di Firenze, si ha la più bella alternanza di monti e valli fino alla capitale […] Tutto quello che Leopoldo ha fatto per la Toscana è nuovamente disfatto in gran fretta, e i frati riprendono qui il loro governo come a Roma. Però il grande e generale benessere che qui era stato raggiunto sotto un governo austriaco molto liberale non può essere facilmente distrutto […] Le colline dopo Firenze sono un vero giardino fino alle vette maggiori.
Più in generale, una volta ripassato l’Appennino per traversare la padana occidentale, trova segni maggiori di prosperità:
Qui era stato fatto un buon lavoro nel passato […] Da Sesto risalii il Ticino e poi il lago Maggiore, soltanto per godere della bellezza dei luoghi, che in verità sono splendidi […] La fertilità della zona del lago è straordinaria, e laddove le coltivazioni sono protette dai venti rigidi si trovano […] ancora bellissimi olivi e persino fichi d’India all’aperto.
Questo principalmente gli interessa dei luoghi, ma non è insensibile alle bellezze naturali. Anche se non rincorre il sublime, in alcuni casi non può sottrarsi alla magia degli spettacoli della natura:
Mi si aprì il cuore quando, alcune miglia prima di Terni, […] mi si aprì la valle del Nera, e di nuovo mi si spalancò davanti agli occhi il paradiso […].
E davanti alle cascate del Velino:
Mi misi seduto di contro, su una roccia, e per alcuni minuti dimenticai tutto quello che il mondo può avere di più bello e di più grande: difficilmente la mano dell’uomo avrebbe potuto creare qualcosa di più imponente, di più affascinante di quella cascata.
Non indossa gli occhiali deformanti che, visualizzando le aure classiche, sfocano la realtà:
Passai accanto alle fonti del Clitumno, che adesso vengono inquinate con perfetta incoscienza da asinai e lavandaie: […] ma assetato scesi devotamente alla fonte e bevvi a grandi sorsate, quasi fosse stata la fonte di Ippomene.
Ha uno sguardo clinico, prima e piuttosto che estetico. Certo, in qualche occasione, come all’ingresso in Italia «mi guardai attorno fiero, sicuro ormai di posare i piedi sul suolo classico», al cospetto di taluni monumenti, o quando arriva a Siracusa, non può non cedere alla commozione e a un sacrale rispetto: «Qui non c’è pietra che non abbia un nome». Ma è solo un attimo, passa subito.
Non lontano si dovrebbero vedere, credo, i ruderi della villa di Nerva. Ma mi interessai molto più degli aranceti che delle mura antiche della città, del lago, di san Tommaso e di tutte le altre meraviglie – e allo stesso modo – Ho girato un’ora per Pompei, e ho veduto cose che già altri hanno veduto.
Non rinnega certo la classicità di cui i luoghi, alcuni in particolare, sono intrisi, ma riesce ad ancorarsi a terra con l’ironia.
Qui dunque Cesare e io abbiamo varcato il Rubicone, ma per il resto non abbiamo niente in comune, se si eccettua il fato che ambedue andavamo a Rimini.
Il Soratte gli si presenta privo di neve, a differenza di come l’aveva visto e cantato Orazio. Ma non manca di un suo fascino: «Il Soratte non è straordinariamente alto, ma lo sembra perché si leva immediatamente dalla pianura».
L’impressione è che Seume diffidi della classicità-spettacolo, o dello spettacolo della classicità che comincia a essere allestito, sia pure molto malamente, dagli italiani, e che i viaggiatori stranieri si sono già costruiti per conto proprio creando una sorta di percorso a stazioni fisse, una sorta di via crucis. La classicità di cui è impregnato è quella che entra sottopelle attraverso la consuetudine con il pensiero classico, non quella offerta da immagini che rimangono in superficie.
9. Viaggiando con questa disposizione, pur se non può realisticamente esimersi dal rappresentarne un quadro generale di miseria e di ingiustizia sociale, non gli è difficile apprezzare il paese dei limoni: e anche i suoi abitanti, a differenza di quanto accade per quasi tutti coloro che lo precedono o lo seguono nel Tour.
È un apprezzamento benevolo, mai entusiasta, ma sincero. E quindi non incondizionato. Così «gli abitanti di Genzano mi sono apparsi i più laboriosi e costumati di tutto lo stato della Chiesa» mentre al contrario «Nepi potrebbe essere un posto magnifico, se i suoi abitanti amassero un poco di più il lavoro».
Dai suoi incontri con persone di ogni estrazione sociale, favoriti proprio dalle modalità del viaggio e resi significativi dalla situazione paritaria in cui sempre si pone, viene fuori una interessantissima rassegna che azzera appunto ogni stereotipo.
A Orticoli «borgo antico e sporco», un abitante
[…] dall’aspetto sembrava di umile condizione, eppure era uno degli uomini più intelligenti e meglio informati tra quanti ho incontrato in questo mio viaggio […] sembrava che in lui resistesse ancora l’antica fierezza romana.
In Sicilia trova un buon mulattiere che dà consigli a un ragazzo scappato di casa «con tanta bontà e tanto tatto da suscitare la mia ammirazione». Lo stesso mulattiere poi, colpito dal fatto che Seume regala una moneta d’argento al ragazzo, lo presenta ai suoi colleghi con le parole più cordiali.
Sulla via per Napoli incontra un signore
[…] che apparteneva alla casa del re, e questo aumentò ancor di più la mia meraviglia per la sua cortesia, perché da noi la cortesia non è, di regola, la virtù più cospicua di coloro che prestano servizio presso i grandi.
La situazione di Napoli gliela spiega un vecchio genovese che ha girato mezzo mondo e ora fa il servo di piazza e il cicerone:
Il vecchio è intelligente, ha buon senso e sa apprezzare ciò che è buono, e anche ciò che è bello.
Ma non si tratta solo di eccezioni, di individui isolati. Spesso è una disposizione diffusa a colpirlo. Ad Acerra, dove al termine di un pranzo scadente condito solo da un passabile vino finisce un po’ fuori giri:
La gente e l’asinaio mi guardarono e sorrisero del mio camminare e del mio linguaggio, ma furono generosi e non risero. Erano davvero gente urbanissima, e penso invece alle grasse risate dei tedeschi in un caso simile […].
Nello stretto di Sicilia assiste al salvataggio di una nave straniera, al quale partecipano gli abitanti di un intero paese: «mi sono commosso sin quasi alle lacrime pensando, io uomo, agli altri uomini».
Coglie le differenze tra le diverse etnie, frutto di successivi avvicendamenti e stratificazioni demografiche:
Qui la gente assomiglia ai Sicani, primi abitatori dell’isola, gente grande e forte, rude e d’aspetto temibile.
Individua anche, molto perspicacemente, i caratteri regionali. Commenta così l’incontro in una locanda con un gruppo di milanesi reduci da Napoli, dove con ogni evidenza hanno anche praticato turismo sessuale:
La conversazione fu viva e piacevole e potei capire che questi italiani del nord avevano saputo godere la bella Napoli in ogni modo possibile, letterariamente, esteticamente e fisicamente.
Considera infine le vicissitudini storiche che hanno indotto a certe differenze negli atteggiamenti. La separazione del giudizio sugli uomini da quello sui governi è un tema che ricorre con frequenza.
A Catania si trova la vita più limpida e più saggia di tutta la Sicilia, e forse dell’Italia. Ma […] qui perlomeno si comincia a prendere viva coscienza dell’infelicità del paese […] Si ritrova persino una sorta di agiatezza e floridezza, che parla a vergogna della cattiva amministrazione dell’isola.
E non c’è ombra di una lettura razzista:
Considero i napoletani una delle nazioni più valorose e generose, come in genere gli italiani. Tutto il male che si può dire di questo paese riguarda solamente il governo, la cattiva amministrazione e la depravazione religiosa.
Registra cose che non suonano per nulla nuove o superate ai nostri orecchi.
L’amnistia regia ha riempito l’esercito e le province di briganti matricolati. Il re ha assunto i banditi: erano bravi, come diceva il loro nome; li ha ricompensati regalmente, ha dato loro uffici e onori, e adesso essi esercitano i loro misfatti legalmente, come capi delle province. Amico, se fossi napoletano sarei tentato di diventare per esasperata onestà un brigante, e comincerei dal primo ministro.
E constata naturalmente anche il costume selvaggio, talora barbaro, che regola i rapporti in Sicilia. A Palermo:
Ero uscito il mattino: mi passò accanto di furia un uomo sanguinante, e un altro dietro che impugnava il pugnale. Si radunò folla e in pochi minuti l’uno cadde trafitto e l’altro fuggì ferito. La pattuglia, che non era lontana, si comportò come se la cosa non la riguardasse.
10. Non si limita però a raccontare i costumi degli italiani. In più occasioni ha modo di annotare anche i comportamenti degli stranieri, viaggiatori, residenti o occupanti.
Tutto sommato ha un’opinione positiva dei francesi: la maggior parte di quelli che incontra, e con i quali a tratti anche si accompagna, sono militari delle truppe napoleoniche che lo aiutano a capire come realmente si sono svolte le ultime campagne. Quanto a risorse, sono piazzati come lui, se non peggio.
Trova invece generalmente pesanti gli inglesi, compresi i suoi compagni di ascensione all’Etna: sono portati comunque a vedere e a giudicare tutto dall’alto di una radicata presunzione di superiorità, e a comportarsi di conseguenza. Arrivati in vetta al vulcano, di fronte alla spaventosa voragine del cratere:
[…] dopo aver ripreso fiato con ampi respiri il maggiore ruppe il silenzio: “Di certo valeva la pena per noi giovanotti di salire fin qui, una visione simile non possiamo averla nei parchi della nostra vecchia Inghilterra”. Da un genuino britanno non ti potevi aspettare di più: il suo spirito patriottico distribuiva ora fra i compagni roast-beaf e porto.
Gode nel raccontare dell’umiliazione inflitta a Roma da un pittore prussiano a un ecclesiastico inglese, tanto ricco e arrogante quanto ignorante, e fa proprie le sue parole:
Io so apprezzare chiunque io incontri, in qualsiasi luogo, e non bado alla casta e al patrimonio: giudico le persone per ciò che valgono, e vi dirò che voi non valete proprio nulla. Avete tutto ciò che meritate: il mio disprezzo.
Sulle città da lui toccate troviamo giudizi molto vari, a volte singolari, in qualche caso anche falsati dalle vicissitudini che lo toccano, soprattutto lentezze o incomprensioni burocratiche, o alloggio e pasto cattivo.
Dopo aver liquidato la prima città italiana, o l’ultima austriaca secondo i punti di vista, con:
Poche cose potrai sapere da me su Trieste, dove tutto è commerciale – insaporisce il giudizio riferendo che – un’altra singolarità di questo teatro era che la platea, da qualsiasi parte mi voltassi, puzzava orribilmente di stoccafisso.
A colpirlo in maniera decisamente negativa è anche Venezia:
La cosa più triste di Venezia è la miseria, la mendicità. Non si possono fare dieci passi senza sentirsi afflitti dalle più pungenti invocazioni di pietà […] Alla Giudecca, se possibile, la miseria è ancora maggiore che in città, ma proprio per questo ci sono meno mendicanti, forse perché nessuno può sperare di ricevere una sia pur piccola elemosina.
A Ferrara:
[…] la disposizione e l’architettura della città sono assai belle, le strade sono larghe, lunghe, luminose. Ma in tutta la città manca una cosa, una piccolezza, manca la gente.
Nemmeno Bologna ne esce bene:
Qui a Bologna ho trovato a ogni passo un sudiciume esemplare, quasi un vero porcile, e, se è vero che non si possono fare grandi elogi della lindura domestica degli italiani, tuttavia la gente di Bologna porta la palma per la sporcizia.
Mentre, al contrario:
Modena mi è piaciuta moltissimo. La città è pulita, vivace e ridente: i caffè e le trattorie sono buoni e non cari.
A volte, quando l’umore è stato guastato da qualcosa che non gli garba, il giudizio risulta seccamente liquidatorio:
Siena è pressoché vuota. Il santo odore dell’arcivescovo mi ha tolto la voglia di uscire di casa.
E anche:
Spoleto è grande, scura, antica e misera. Tutta la gente che ho osservato mi sembrava che avesse la faccia della cattiva coscienza.
In altri casi risente della comparazione con le aspettative maturate dalla lettura dei classici.
Nella Siracusa odierna, vale a dire nell’antica isoletta Ortigia, non vi è oggi niente più di notevole, fuorché l’antico tempio di Minerva e la fonte Aretusa.
Spesso valuta le città anche dal punto di vista strategico: annota di quali opere difensive dispongono, calcola quanti uomini sarebbero necessari per difenderle e con quali armamenti. Lo stesso avviene quando tocca luoghi resi famosi dalla storia militare recente, dalle campagne napoleoniche in particolare. Con il terreno degli scontri sott’occhio rievoca le disposizioni degli schieramenti e le soluzioni tattiche adottate, giocando a immaginare che risultati avrebbero prodotto scelte diverse. Ma non c’entra l’origine prussiana: sono abitudini mentali contratte negli anni di servizio, e coltivate poi, come abbiamo visto, anche attraverso lo studio della storia antica.
11. Lungo tutto il viaggio le sue bestie nere sono traghettatori, mulattieri e locandieri (non gli andrebbe diversamente con i tassisti e gli albergatori odierni). In genere sono dei tipacci o è comunque gente con un folto pelo sullo stomaco che vede lo straniero come un pollo da spennare. E ai prezzi Seume è molto sensibile, per necessità ma anche perché non gli va per principio di recitare la parte del pollo. Tratta lungamente e a volte, come nel caso dell’attraversamento del Reno, in Emilia, rinuncia al servizio e fa da solo. In altri casi non gli è consentito, viene quasi sequestrato a forza:
Le loro pretese in fatto di compenso furono poi sfacciate, ma il mio mulattiere fece intendere a bassa voce che era il caso di accontentarli di buona voglia, per evitare che si infuriassero – tanto più che si tratta di – due grossi, ciclopici diavolacci, che a forza di muscoli mi issarono sulle loro spalle e mi tragittarono […] Io avrei voluto passare a piedi, e la cosa non mi sarebbe stata difficile […].
Altrove cede al ricatto psicologico:
Fui preso di mira da una quantità di barcaioli che volevano accompagnarmi fino alla punta. A me sembrava che il mattino fosse troppo avanzato, e non volevo sentirne parlare; ma fui preso per il lato debole: si cominciò a guardare il mare, che si faceva grosso, il cielo, che si faceva minaccioso, e poi a guardare me come a dirmi: è questo a farti paura. Bastò perché subito pagassi una piastra in più per la via più pericolosa.
Alcune situazioni sono però talmente esasperanti da fargli perdere la pazienza e il controllo. Vicino a Catania prende a bastonate un asinaio indolente e incapace, che lo ha fatto finire in un ginepraio paludoso dal quale riescono a uscire con enorme difficoltà. Ma se ne vergogna subito e gli chiede poi di scusarlo. Immagino come si sarebbe comportato e come l’avrebbe raccontata l’Alfieri.
Molto sensibile è anche alla qualità dell’ospitalità. Non manca di rallegrarsi quando trova un ottimo servizio a un prezzo equo.
Alla sera, all’albergo, sono stato ottimamente trattato con minestra, lesso, salsiccia, fritto, cappone, frutta, uva e formaggio parmigiano. Vedi dunque che non sempre digiuno come il giorno del mio compleanno a Udine, e che gli albergatori di Lipsia possono forse prendere esempio da questi dell’alta Italia.
Oppure: Quando, in una chiara e fredda sera di febbraio, uno ha viaggiato per parecchie ore sotto l’acqua, una buona camera calda, una minestra e un cappone appena tolto dal forno costituiscono una piacevolissima accoglienza. E questo ben di Dio trovai a Pontelagoscuro.
O ancora, a Macerata:
[…] mi indirizzò a una trattoria non lontana dalla porta, dove venni trattato con tanta cordialità e discrezione da ispirarmi uno straordinario concetto di questa gente, malgrado tutto il loro bigottismo.
Gli capita spesso anche di sperimentare e di apprezzare l’ospitalità genuina dei privati:
A Pesaro […] essendo stanchissimo mi rivolsi al primo cittadino che incontrai per chiedergli dovei avrei potuto alloggiare. “Da me”, mi rispose. “Benissimo” dissi io, e gli andai dietro. L’uomo portava un grembiule di cuoio e, per dirla con Shakespeare, sembrava un chirurgo di scarpe vecchie. Adesso egli si rivolse a me chiedendomi cosa volessi mangiare. M’abbandonai completamente alla sua saggezza, ed egli ce la mise tutta per accontentarmi […] Da quella volta m’accadde spesso che mi si presentasse e mi preparasse una cena patriarcale mentre io davo una mano.
Naturalmente, le cose non vanno sempre a questo modo, ed è costretto a tacciare di ladroneria, di scortesia o di luridume più di una locanda. Anche quando non è stato trattato bene, però, tende a giustificare i comportamenti con lo stato imperante di disordine e di miseria. A Cesena, ad esempio
[…] l’oste mi riservò un’accoglienza dura e fredda, che mi valse una cameretta modestissima nel retro della casa. Ma […] trovai al rientro che le mie cose erano state spostate in una bella bella camera sul davanti. L’ostessa mi dette la spiegazione: ero stato preso per un francese che venisse alloggiato per conto della municipalità: ora questa da molto tempo non pagava nemmeno un centesimo per gli ospiti che inviava.
E nei pressi di Catania:
Chiesi dei maccheroni e l’oste mi rispose sarcastico: “A Catania ci sono maccheroni, qui non c’è niente”. Aveva la fisionomia scontrosa, accigliata della povertà oppressa e dell’indigenza a cui non si può fare colpa […].
Anche ad Agrigento:
Mi fu preparata una camera e, per quanto fosse tanto brutta, quella gente ci mise tanta buona volontà ad aggiustarmela: e questo basta perché un galantuomo sia soddisfatto.
Il bilancio finale è positivo, e non potrebbe essere diversamente per uno che si dichiara già soddisfatto in presenza della buona volontà. I suoi epigoni ottocenteschi avranno a disposizione una piccola guida Michelin per muoversi nel nostro paese, attenta alla pulizia, alla cortesia, al rapporto tra qualità (e quantità) e prezzo: ma avranno soprattutto un esempio di come per godere appieno di ogni esperienza offerta dal viaggio sia sufficiente adottare la giusta disposizione.
12. L’Italia non offre però soltanto arte, sole e paesaggi. Nell’immaginario dei frequentatori del Gran Tour, soprattutto degli anglosassoni o dei tedeschi, per un paio di secoli, è anche il luogo “esotico” della trasgressione, delle donne (e dei maschi) facili e disinibiti, dell’iniziazione per i più giovani e del collezionismo sessuale per i più navigati.
Seume non ha messo questo tra i suoi obiettivi. Non è per nulla insensibile al fascino femminile, tutt’altro, ne è già anche rimasto profondamente scottato, ma qui ne parla con assoluta leggerezza, senza fanfaronate e, anzi, con molta autoironia. «Ridi pure di questa osservazione di un rospo qual sono» scrive raccontando di essere stato salutato da una bella ragazza e immaginando la faccia dell’amico al quale le lettere di viaggio sono destinate. In effetti, non è un Apollo. Raggiunge a stento il metro e sessanta e i pochi suoi ritratti non testimoniano di una gran bellezza. E lui ne è perfettamente e serenamente consapevole.
Viaggiando su una carrozza tra Firenze e Bologna, si ritrova in compagnia di una signora svizzera con un bimbo di un anno e mezzo.
Il bimbo graziosissimo e vivacissimo dalle ginocchia della madre passò a quelle di tutti noi, e la compagnia rise quando lo vide tra le braccia di quell’uomo irsuto che io sono: e a me venne in mente il Sileno col Bacco fanciullo della Galleria Borghese. Tu vedi che io so darmi il dovuto onore. Comunque […] il fanciullo se ne stette tutto contento sulle mie braccia.
Non stento a crederlo. È una persona rassicurante e i bambini, come gli animali, hanno per queste cose antenne particolarmente sensibili.
Tutto questo non gli impedisce di stilare le sue graduatorie. Sia positive:
Devo dirti anche che a Milano ho veduto quelle che secondo il mio gusto sono le donne più belle di tutta Italia.
che negative:
Questo porto (Messina) e quello di Palermo sono gli unici luoghi in Sicilia in cui ho veduto qualche donna graziosa. Altrove, e specialmente ad Agrigento e a Siracusa, i miei ideali greci, tratti da Teocrito, sono stati tristemente bocciati.
I commenti sono tutti di questo tenore, mai volgari. Le figure femminili che descrive sono in genere deliziose e aggraziate:
Non puoi credere quanto sia piacevole che questi auguri (di buon viaggio) siano pronunciati da una bella ragazza, nel mese di gennaio, quando la tormenta di neve flagella le montagne.
Di ritorno dall’ascensione al Vesuvio si imbatte in una fresca bellezza campana:
Avevo già sete mentre salivo, e adesso cercavo anelando un po’ d’acqua. Una ragazza bella e gentile ce ne portò un’anfora colma. Per quanto assetato, la vista della ragazza mi fu quasi più gradita dell’acqua, e credo che se restassi qui più a lungo ripeterei spesso per questa strada la visita al vulcano.
Non ne viene fuori quindi l’immagine universalmente diffusa tra i viaggiatori nordici di donne italiane dai facili costumi. Semmai, ad esempio a Venezia e poi a Roma, sottolinea la presenza di un numero inverosimile di prostitute. Ma anche qui senza alcun moralismo. «Mi è capitato di trovarmi in piazza San Marco al centro di una scena alquanto comica». Due prostitute gli si appiccicano e
[…] mi presero amichevolmente a braccetto, mi si strinsero addosso e io gentilmente le pregai di non seccarmi e di lasciarmi andare […] erano in verità due graziose peccatrici, che si comportavano con finezza e decenza. – Seume ha però altro per la testa, e allora – cominciai a rabbuiarmi […] le esortai alla meglio a lasciarmi in pace – mentre – di lontano qualcuno cominciava a ridacchiare e mi giunse anche qualche grossa risata. – Alla fine, quando si fanno troppo intraprendenti – m’arrabbiai e cominciai a battere sul selciato col mio pesante bastone e a imprecare in russo, […] così enfaticamente che le due creature ripresero spaventate la loro strada.
Molto diversa è l’impressione riportata a Milano:
Una domenica mattina me ne stavo in tutta tranquillità nella mia camera e per caso leggevo appunto i carmi erotici di Catullo, quando fu bussato alla porta e, poi che ebbi risposto, entrò una ragazza la quale, Catullo a parte, avrebbe indotto in tentazione un santo. La giovane e bella peccatrice aveva studiato l’effetto della sua apparizione secondo le arti più fini della seduzione: “Signore, comanda qualche cosa?” bisbigliò in tono dolcissimo, mentre la mano graziosa giocava con un panierino che faceva atto di aprire. Io la guardai colpito, e mi occorse qualche attimo prima che rispondessi perplesso: “No”. “Niente?” disse lei. Gettai Catullo sul davanzale, e fui sul punto di dire una sciocchezza o di commetterla. “Niente”, brontolai, mezzo in collera con me stesso, e la tentatrice prese congedo con grazia indescrivibile. Chissà cosa sarebbe successo se la diavoletta mi avesse rivolto la domanda per la terza volta (proprio nulla mi piaceva?) o se io avessi esaminato meglio il suo panierino […] Così andò la cosa, amico mio; se fosse andata diversamente non sarei così meschino da raccontartela con particolari diversi, o da non raccontartela affatto.
Questa è una lezione di stile, di signorilità, tanto nel modo di comportarsi come in quello di raccontarlo.
13. Appena lasciata l’Italia Seume si ferma a prendere respiro e traccia un primo sommario bilancio di quel che ha visto nel suo lungo viaggio. Per la verità la sensazione di aver cambiato paese l’ha già avuta dopo aver valicato l’Appennino tosco-emiliano:
A Milano posso dire di aver definitivamente abbandonata l’Esperia, e già da lungo tempo non sono più nel paese “wo die Zitronen blühn”.
Rivolgendosi al destinatario delle sue lettere-diario scrive:
Da quanto ti ho raccontato hai veduto gli aspetti dolorosi, forse più dolorosi che in qualunque altra epoca. Io sono stato coscienzioso, e ogni mia parola è verità, per quel tanto che può garantire la verità storica.
In effetti, il panorama che ne esce è sconfortante. Partendo dalla punta estrema toccata a salire la situazione politica è disastrosa:
Tutto il regno di Napoli è in condizioni tristissime […] in Calabria deve regnare oggi un’anarchia generale […] In Sicilia il sistema feudale spinge la calamità a estreme manifestazioni […] A Roma si lavora a tutto spiano alla restaurazione della gerarchia e delle istituzioni feudali […] Nell’Etruria ci si sta riprendendo a stento dallo stupore per i continui cambiamenti domestici e interni […] – solo – la Repubblica Italiana, nonostante le prepotenze e le malversazioni dei francesi, suoi signori e vicini, si risveglia a poco a poco dal suo millenario letargo.
Della miseria delle popolazioni, dello sfruttamento cui sono sottoposte dalle autorità civili e religiose, dell’apatia che troppo spesso le caratterizza, ha già parlato a lungo. Non fa complimenti Seume. D’altro canto, la sua valutazione appare oggettiva ed equilibrata, nel senso che l’Italia quella era, e tutto sommato tale è rimasta.
C’è anche però la componente soggettiva. Se la ragione ha uno sguardo impietoso, il sentimento gli ha fatto cogliere altre cose. Non sono il pittoresco, la carnalità, la sensualità, tutto quel bagaglio di stereotipi con i quali la gran parte dei viaggiatori arriva e che si riporta poi a casa come souvenir da bancarella. È piuttosto l’aspirazione mortificata di un popolo a ritrovare, se non la gloria del passato, la dignità per reggere il confronto con il proprio tempo.
A differenza di un Montesquieu non ha visto solo «preti e canaglia», ha camminato con persone umili e oneste e ha incontrato fior di intelletti fini. E questo non può che aumentare il rammarico per le condizioni in cui il paese versa, ma al tempo stesso lascia aperta una porta alla speranza. Per il momento: «Qui si può anche abitare e trovarcisi benone, – scrive – soltanto bisogna lasciare a casa ogni sentimento d’umanità».
Di qui innanzi, Seume procede nella narrazione con un passo diverso. Non che gli manchino le cose da raccontare (vede tra l’altro a Parigi Napoleone, durante i festeggiamenti del 14 di luglio «è un uomo che si vede forse meglio da duecento miglia che da dieci passi», commenta), perché le conseguenze morali e materiali dei rivolgimenti politici dell’ultimo quindicennio sono evidenti dovunque, ed è soprattutto su queste che si appunta la sua attenzione. Avverte però che la parte più avventurosa (e quindi più interessante) del suo viaggio è ormai alle spalle, e che quanto potrebbe ora descrivere è risaputo:
Da Zurigo si qui corre un bel pezzo di strada, e io ti scrivo il meno possibile perché si tratta di cose piuttosto note.
Lo stesso vale per l’accoglienza:
Da quando ho cominciato a viaggiare sul territorio francese ho trovato prezzi buoni, tutto è andato senza intoppi e ho incontrato dovunque grande cortesia – o per la situazione politica – Sarebbe da presuntuoso volerti scrivere una lunga relazione da Parigi, dato che puoi leggerne una dozzina ogni mese sui giornali.
Il mistero, l’incognito, qualche volta l’incomprensibile, è rimasto al di là delle Alpi. Qui si respira un’altra aria:
Verso sera feci una passeggiata lungo i giardini e i prati e a un tratto udii venire da un pendio boscoso un canto che mi avvinse subito. Questo non mi era mai accaduto in Italia […] – anche perché si tratta di una melodia popolare su un testo tedesco, e – chi cantava erano tre giovinette, che nella luce del tramonto si sarebbero potute prendere per le tre Grazie.
14. Una volta concluso il viaggio Seume torna a Lipsia, dove
[…] adesso voglio vivere, e vivere bene e tranquillamente, per quanto è possibile farlo senza un soldo di risparmi.
Ci riesce, adottando il suo solito sistema: la riduzione al minimo dei bisogni e delle ambizioni. Una sua poesia recita:
Non bevo vino, caffè o liquori / Non fumo tabacco e non sniffo alcunché / Mangio solo i piatti più semplici, /e non mi sono mai ammalato, / né sul lago né sotto altro clima diverso.
Il suo giaccone polacco, che lo accompagnerà ancora a lungo, diventa popolare in città. Ma popolare è ormai lo stesso Seume. La Spaziergang nach Syrakus im Jahre 1802 viene pubblicata nel 1803. Attesa e sollecitata dai suoi molti amici, lo farà conoscere anche fuori da quella cerchia perché verrà apprezzata da diversi artisti e intellettuali di tutta la Germania. Molto meno dai suoi governanti e soprattutto dal governo imperiale, che non digerisce i giudizi negativi espressi sul sistema politico e amministrativo degli Asburgo e ne vieta la pubblicazione su tutto il territorio tedesco (ciò che non ne impedirà comunque la diffusione)
A Lipsia riprende il suo lavoro di traduttore e di curatore di testi classici, ma nel frattempo scrive anche in proprio: oltre a una raccolta di poesie e a diversi saggi critici pubblica una tragedia, prepara una raccolta di aforismi alla maniera di Lichtenberg edita lo scritto comparativo degli armamenti moderni con quelli antichi. Partecipa quindi alla vita intellettuale, ma da par suo, in sordina, mantenendosi sempre un po’ in ombra.
Già prima del viaggio in Italia non era un perfetto sconosciuto. Aveva incontrato Wieland, Schiller, Herder, Goethe, Böttiger, Kotzebue e Garlieb Merkel, il fior fiore dell’intelligencija tedesca, era in contatto epistolare con quasi tutti ed era stato presentato al principe Luigi Ferdinando di Prussia. Ora riprende le collaborazioni, scrive su una rivista letteraria assieme a Schiller e Wieland, ha fatto conoscenza sulla via del ritorno col principe von Metternich, ma non esce dal suo atteggiamento critico e riservato. Ad esempio, non manifesta alcun entusiasmo per il movimento romantico che comincia a dilagare nei vari centri culturali della Germania.
Riceve anche molte visite di suoi corrispondenti inglesi e francesi, che ha conosciuto attraverso il suo lavoro di traduttore e spesso e volentieri se li porta appresso in brevi vagabondaggi. Quella delle camminate a piedi e delle escursioni, soprattutto nelle zone montuose (lo Harz, il Bröchen, i Monti dei Giganti) è una abitudine che non vuol perdere, neppure quando cominciano a manifestarsi i primi segni di un cedimento della salute. Anche i suoi spostamenti per lavoro, a Dresda, a Lipsia o a Berlino, si svolgono rigorosamente a piedi.
Quando nel 1805 gli chiedono di unirsi alla sollevazione (antifrancese) per la patria, risponde che quella in cui un contadino deve combattere senza sapere il perché o addirittura per essere poi venduto come uno schiavo (esperienza che conosce bene), non può essere una patria: o almeno, non è quella che a lui interessa.
La verità è che noi non siamo ancora una nazione nel significato politico della parola, e forse nemmeno abbiamo un fondato motivo per desiderarlo, e forse mai per diventarlo: nelle nostre vecchie e barbariche istituzioni non si ritrova abbastanza giustizia e libertà da suscitare in un uomo entusiasmo per una causa che gli rimane estranea.
Allorché si combatterà per l’uguaglianza dei diritti (lui la chiama «isonomia») allora sarà della partita. Con i governanti che la Germania si ritrova non vuole avere a che fare. Rispetto alla svalutazione dell’individualità, allo sprezzo per i diritti e per la libertà del singolo manifestati in quegli stessi anni da Hegel, qui siamo davvero avanti.
15. Sempre nel 1805 intraprende un altro viaggio, ufficialmente come accompagnatore di un giovane nobile, questa volta volgendosi decisamente al nord. Tra i primi di aprile e la fine di settembre attraversa la Polonia e i paesi baltici e visita la Russia (dove arriva sino a Mosca e a Pietroburgo, e incontra la zarina), la Finlandia, la Svezia e la Danimarca. Anche questa volta il percorso si aggira attorno ai cinquemila chilometri, coperti solo parzialmente a piedi perché Seume comincia ad accusare problemi a una gamba.
Il viaggio è raccontato nel Mein Sommer im Jahr 1805 (La mia estate del 1805), pubblicato l’anno successivo e immediatamente censurato, questa volta non solo nell’impero asburgico e in Prussia ma anche su tutte le terre dello Zar. Non ha perso infatti l’occasione per criticare la situazione politica e sociale in Russia e in Polonia, e in particolare la condizione dei contadini, senza dimenticarsi di quella prussiana.
Anche questo secondo diario, a dispetto delle proibizioni, diventa popolare, soprattutto per le dichiarazioni contenute nell’introduzione, che consolidano la sua aura di “libero vagabondo”.
Con la sincerità ho cumulato tante esperienze, ma non ho guadagnato alcun favore; perché quasi ovunque qualcuno si è sentito offeso […].
Sulle motivazioni reali del viaggio c’è però mistero. Qualche biografo sostiene sia stato intrapreso in conseguenza alla fine deludente di una relazione amorosa (le sue storie sentimentali non furono mai molto fortunate). Il suo più intimo amico, l’editore Georg Joachim Göschen, scrive nell’occasione a un altro comune conoscente:
Non creda che Seume intraprenda il viaggio per qualche scopo. Mi fa rabbia che quest’uomo se ne vada per il mondo così, senza pensare; voglio dire, senza pensare ai giorni futuri della sua vita. Va così, tanto per andare, o per disfarsi di qualcosa camminando: ricavare, non ne ricaverà nulla. Eccolo che, mentre scrivo, entra questo orso di amico. Gli leggo quello che ho scritto. “Tutto a posto – risponde – deve restare tutto così com’è”.
Seume usa comunque le conoscenze e le referenze acquisite nella campagna di Polonia per arrivare sino alla corte imperiale russa, e forse per chiedere anche quel riconoscimento, morale ed economico, che non gli era stato attribuito a suo tempo.
Al ritorno gli viene offerto un lettorato in lingua inglese dall’Università di Lipsia, che gli amici gli consigliano di accettare ma che lui rifiuta dicendo «non lo farei nemmeno se mi offrissero mille fiorini». Non vuole svendersi. Afferma di essere disponibile solo per un’assunzione col titolo di professore, ma in realtà teme i vincoli alla sua indipendenza di pensiero che quell’impiego potrebbe comportare.
Si dedica così alla compilazione dei suoi Apocrypha e inizia anche a scrivere un’autobiografia, poi pubblicata postuma col titolo Mein Lieben. Ma la lascia incompiuta, (sarà completata dal suo amico Clodius), perché la salute alla fine lo tradisce. Muore prima dei cinquant’anni, nel 1810, a Teplitz, per una malattia ai reni che lui stesso aveva battezzato «Morbona». Tra i non molti che accompagnano il suo funerale c’è anche Fichte.
Muore ma non scompare, anche se la popolarità dei suoi libri di viaggio verrà da lì a poco di gran lunga superata da quelli di von Humboldt e di Goethe.
Pur non brillando di una luce particolarmente viva nel firmamento culturale tedesco, Seume in patria non è stato dimenticato. Per limitarci alle cose più recenti, nel 2005 è uscita una sua biografia firmata da Eberhard Zänker (Johann Gottfried Seume: Eine Biographie). Ancor più recentemente, nel 2012, Robert Eberhardt ha analizzato il rapporto con il compagno dell’avventura americana (Seume und Münchhausen. Mit dem Neudruck der Rückerinnerungen von 1797) mentre Christian Preischl lo ha affiancato ai due nomi per eccellenza della letteratura di viaggio germanica (Georg Forster, Johann Gottfried Seume, Alexander von Humboldt: Vertreter der authentischen Reportage). Anche in Italia peraltro era comparso nel 1978, per la penna della bravissima Marlis Ingenmey, un importante studio biografico (L’illuminismo pessimistico di J. G. Seume). Peccato che pochi se ne siano accorti, e che la biografia sia oggi altrettanto introvabile del libro di Seume.
16. Per tornare alla Germania, però, va segnalata ancora un’opera che rappresenta un indiretto omaggio a Seume e testimonia della sua attualità. Nel 1995 è stato pubblicato Der Spaziergang von Rostock nach Syrakus (La passeggiata da Rostock a Siracusa), un romanzo breve di Friedrich Christian Delius. Nel libro sono narrate le vicende di un cameriere, cittadino della Repubblica Democratica Tedesca, che coltiva per lunghi anni il sogno di un viaggio sino a Siracusa, sulle tracce di Seume. Il romanzo è basato sulla vicenda reale di Klaus Müller, che tra il giugno e l’ottobre del 1988 ha lasciato la DDR su una barchetta a vela per realizzare il suo progetto. Nella finzione narrativa il protagonista è rinominato Paul Gompitz.
Gompitz ha letto a scuola La passeggiata a Siracusa nel 1802, e da allora è determinato a recarsi in Italia almeno una volta nella vita. Spera a lungo di poter lasciare legalmente il paese: si prepara procurandosi moneta occidentale, studiando appassionatamente la storia e l’arte della romanità classica, la geografia italiana, oltre al diario di viaggio di Seume.
Arriva però alla conclusione che potrà farlo solo illegamente: impara addirittura a navigare per tentare la via del Baltico, poiché neppure una richiesta ufficiale rivoltagli dal sindaco di Brema, legata proprio ai suoi studi su Seume, gli guadagna la possibilità di uscire in modo legittimo.
Varcato il confine con uno stratagemma, Gompitz non può muoversi come Seume. Paradossalmente la circolazione in Europa è molto meno libera che ai tempi di Napoleone, e poi lascia nella DDR una moglie che non può partire con lui. Ha a disposizione quindi un tempo limitato e non può ripetere l’esperienza del viaggio a piedi. Utilizza treni a lunga percorrenza e sceglie di toccare soltanto alcune mete. Con questo spirito e sotto questa pressione già all’arrivo a Roma è colto dalla nostalgia per la moglie e decide di abbreviare notevolmente il viaggio. Ciò non gli impedisce di assaporare a Siracusa una certa aura “classica” e di vivere poi a Mantova, sulla via del ritorno, davanti al Palazzo Te, una sorta di epifania, legata a reminiscenze del Rigoletto e di un film visto nell’infanzia. Questo momento era la mia più alta ricompensa. Come Faust io gli dicevo: indugia ancora, sei così bello!
Come rientra nella DDR viene immediatamente arrestato, e in questo può senz’altro dire di aver ripetuto un’esperienza di Seume, ma viene poi rilasciato dopo essere riuscito a convincere i suoi inquisitori che l’espatrio clandestino non aveva motivazioni politiche e aver fatto ammenda (in una lettera inviata al vice-presidente della Repubblica Democratica poco prima del suo rientro ammette di «essersi alleato, per amore della conoscenza, con le forze del male», definendo «mefistofelico», in senso goethiano, lo spirito di violazione della legge che lo ha spinto a «cercare sempre, anche mettendosi a rischio»). D’altro canto, il richiamo a Goethe e alla sua immagine dell’Italia, oltre e forse più che a quella raccontata da Seume, è costante in tutto il libro di Delius.
Mi sono dilungato su questo romanzo perché mi sembra significativo non tanto della persistenza dalla memoria di Seume, quanto della differenza che ci separa dai suoi tempi e dagli uomini di quell’epoca.
Il più commosso omaggio alla memoria di Seume è venuto però da Beethoven. Negli anni immediatamente successivi la sua morte, il compositore si recò più volte a Teplitz, a visitarne la tomba, e confessò ad alcuni suoi corrispondenti di aver tratto dai suoi scritti più di una suggestione. In effetti, tra i non molti volumi dei quali si componeva la sua biblioteca, due erano di opere di Seume. È anche molto probabile che il movimento lento di apertura della sonata per pianoforte e voce Al chiar di luna sia stato composto proprio a partire dai versi del poemetto di Seume Die Beterin (Il supplice).
È un’ipotesi che ha più di un fondamento, qualche critico si spinge oltre e sostiene che i due avessero discusso e concordato la cosa. Non so e non mi interessa se ciò sia veramente accaduto, se si siano incontrati per parlare di poesia e di musica: è comunque una immagine troppo bella per rinunciare a chiudere con essa la straordinaria storia di Johann Gottfried Seume.
17. Penso non sia necessario a questo punto ribadire quanto Seume mi abbia conquistato. Lo avevo scoperto quasi per caso moltissimi anni fa, poche righe di Cesare De Seta nel suo saggio L’Italia nello specchio del Gran Tour, ne ho trovato in seguito menzione qua e là, ma sempre in brevi accenni, e comunque mi interessava solo come camminatore.
Quando ho potuto finalmente leggere la Passeggiata verso Siracusa è venuto invece fuori l’uomo. Sprigionava una simpatia immediata che è poi divenuta ancora più forte alla luce di tutta la sua storia. È una simpatia tanto più genuina perché è discreta, nasce dalla modesta semplicità che porta quest’uomo a essere positivamente curioso di tutto.
Nel diario di viaggio Seume parte in quarta e racconta, e si racconta, e dà l’impressione di non nascondere o alterare nulla. È tutt’altro che freddo, anzi, è partecipe ma questo non appanna la lucidità del suo sguardo. Sembra non portarsi dietro alcuno degli stereotipi creati dai viaggiatori precedenti. Guarda, osserva, ascolta e giudica, ben consapevole che il suo è uno sguardo straniero e che non può essere che parziale, e mantiene la sua indipendenza di giudizio.
Dovendo rimanere, per forza di cose, sempre sulla scena, non si propone come protagonista ma si ritaglia un ruolo da conduttore. Se nella prefazione ammette che «ognuno racconta sempre e solo se stesso, ed è naturale che sia così», racconta poi ciò che vede, e solo a margine annota ciò che sente. E alla fine del viaggio non appare cambiato rispetto all’inizio, non ne esce trasformato, ne esce arricchito, di coscienza e di conoscenza.
Seume è la tipica persona che vorresti come compagno di camminata. Al contrario dei maggiori teorici del camminare, si accompagna volentieri a occasionali compagni di viaggio e ne apprezza la conversazione. È vero che in un paio di occasioni confessa di aver volontariamente accelerato e finto di non sentire i richiami di chi gli si era attaccato a rimorchio, per toglierselo dalle calcagna: ma chi non lo ha fatto? Ci sono volte in cui, o per la particolare fastidiosità dei soggetti o per un particolare stato d’animo nostro, non si chiede altro che solitudine o silenzio.
Sa vivere bene sia la solitudine che la compagnia, così come sa adattarsi a tutte le situazioni: all’occorrenza si sporca di fango sino ai capelli o si immerge nei guadi fino al petto, senza tante scene (anzi, guardandosi ironicamente dall’esterno). Ama la vita, ama la natura che lo circonda, ama la gente che la abita, quasi tutta (con qualche eccezione per i frati). È disposto ad ammettere che al mondo c’è posto per tutti, anche se alcuni disturbano parecchio la scena e andrebbero possibilmente “riposizionati”.
In tutto il suo diario non compare un vero momento di sconforto: non si chiede mai «ma chi me lo ha fatto fare?». Intendiamoci, non è Candido: si arrabbia di fronte a spettacoli di palese ingiustizia, si innervosisce per le lungaggini e l’arroganza di una burocrazia beota o per i contrattempi e gli incidenti creati dalla stupidità, ma non sembra mai sull’orlo di arrendersi.
Ora, immagino che qualche momento più difficile lo abbia vissuto e magari non abbia voluto parlarne, a differenza dei più che usano il conflitto interiore dei sentimenti per aumentare il pathos della narrazione. Non Seume: è determinato, ha una meta, lì vuole arrivare, non ha tabelle di marcia stringenti, non ha lasciato a casa impegni che lo attendono. La sua vita è tutta concentrata in ciò che sta facendo, che ha voluto fortemente. Per questo tira avanti senza ripensamenti.
In altre occasioni ho parlato di quanto incida la sicurezza di sé nei rapporti umani, scindendola dalla fisicità. Seume non ha un fisico da corazziere. Lui stesso quando racconta dell’arruolamento dice di essere uno dei più bassi, ma non è tipo da lasciarsi pestare i piedi e nemmeno gli passa per la testa di calpestare quelli altrui. Il suo vero randello, la sua arma di difesa, è la cultura. Una cultura fortemente desiderata e conquistata a dispetto delle proibitive condizioni di partenza, non indossata come un abito o un guscio, ma digerita e assimilata bene, che gli circola nelle arterie assieme all’ossigeno e nutre il suo animo e il suo cervello.
Parla cinque lingue moderne e ne conosce tre antiche (oltre al greco e al latino, anche l’ebraico). È in grado di conversare alla pari con i mulattieri come con gli studiosi e con gli uomini politici, e sa ascoltare gli uni e gli altri senza riverenze per gli ultimi e senza supponenza nei confronti dei primi. Soprattutto, sa prendere se stesso e il mondo con la giusta dose di ironia che è l’espressione sottile e discreta di una sostanziale benevolenza. Questo può permetterselo solo chi è davvero sicuro di sé, è ciò che gli altri avvertono e per cui non possono provare che un altrettanto benevolo rispetto.
Ho accennato sopra all’unica biografia italiana di Seume, L’illuminismo pessimistico di J.G. Seume, di Marlis Ingenmey (che è la miglior traduttrice di letteratura italiana in lingua tedesca, ed è anche figura di primo piano nel dibattito culturale europeo odierno) (7). Come dicevo, anche questa è praticamente introvabile e ne sono venuto in possesso solo di recente: la lettura mi ha fornito un sacco di nuove informazioni, anche se non mi ha indotto a cambiare una virgola delle mie impressioni. Ho piuttosto trovato ingannevole quel pessimistico riferito all’illuminismo di Seume, che già dal titolo sembra voler scoraggiare il lettore o prepararlo a una lettura mesta e penitenziale.
Seume non è affatto un pessimista. È un realista, che come tutte le persone normali e intelligenti (sempre che l’intelligenza sia la normalità) ha coltivato in gioventù i suoi sogni, li ha visti presto svanire e ha saputo svegliarsi e tornare con i piedi per terra senza per questo rinnegarne la bellezza.
Il viaggio in America, quello in Italia e infine quello in Russia, in maniere diverse sono state occasioni per toccare con mano che il mondo e gli uomini rimangono gli stessi a qualsiasi longitudine, che ovunque prevale quell’ingiustizia che aveva ben conosciuta e sofferta sin da bambino, direttamente e attraverso le disgrazie del padre, e che le ideologie nazionalistiche sono gli strumenti dell’oppressione e dello sfruttamento allo stesso modo delle superstizioni religiose. Dove si è tentato di sottrarsi a questa condizione, in nome della libertà e dell’eguaglianza come in Francia e in Italia, o dalla patria come in Polonia e in Germania, le cose sono finite sempre egualmente male. D’altra parte, se tornasse in vita, si guardasse attorno e ripetesse oggi quei viaggi, ne uscirebbe con impressioni identiche.
Ciò non significa però che Seume, disperando della natura umana, si abbandoni a un rassegnato cinismo. Continua a combattere una sua personalissima battaglia, l’unica in cui è possibile davvero credere, che passa innanzitutto attraverso l’esemplarità. Questo non glielo può togliere nessuno. E se uno si intestardisce a comportarsi come ritiene dovrebbero comportarsi tutti, ma non pretende di imporlo a nessuno, significa che alla fin fine in una qualche positività della natura umana ci crede, senz’altro molto più di coloro che quella natura vogliono educarla e cambiarla a forza di rivoluzioni.
Su Seume, come su Leopardi, pesa quel fraintendimento che nasce dall’accezione distorta di “pessimismo”. Vedere le cose come stanno e indignarsi perché stanno così, almeno per quella parte imputabile alla cattiva volontà o all’ignavia nostra e non alle leggi della natura, non è pessimismo. È passione civile. Pensare che non sarà la provvidenza divina a cambiarle e che non esistono paradisi, né in cielo né in terra, ma che dipende da noi far sì che non esistano nemmeno inferni, è la più genuina manifestazione possibile di fiducia nei confronti degli uomini. È l’atto di fede della religione «della ragione, della generale giustizia per tutti, della libertà e dell’umanità».
A differenza della maggior parte di coloro che incontra, Johann Gottfried Seume non si limita a professare il suo credo, cerca di viverlo concretamente, in ogni rapporto con gli altri, indipendentemente dalle risposte che gli arrivano e a dispetto di un mondo che pare andare in direzione opposta. Non è da stupirsi che si arrabbi, sarebbe assurdo il contrario. Ma Seume sa anche che la coscienza e il civismo non sono derrate da esportazione, se non crescono in loco non sono commestibili. Non crede nella rivoluzione perché le rivoluzioni non cambiano nulla, aggiornano soltanto la situazione ai tempi. Non ci crede non per sfiducia nel cambiamento, ma perché vorrebbe cambiare sul serio.
È questo, il pessimismo?
Una Bibliografia minima
CRAVERI CROCE, E. – Poeti e scrittori tedeschi dell’ultimo settecento – LATERZA, 1951
EBERHARDT, R. – Seume und Münchhausen. Mit dem Neudruck der Rückerinnerungen von 1797 – WOLFF, ED 2012
INGENMEY, M. – L’illuminismo pessimistico di J. G. Seume – MARSILIO, 1978
ZÄNKER, E. – Johann Gottfried Seume: Eine Biographie – F&FABER, 2005
PREISCHL,– Georg Forster, Johann Gottfried Seume, Alexander Von Humboldt: Vertreter Der Authentischen Reportage – PETER LANG, ED 2013
SEUME, Johann Gottfried – L’Italia a piedi 1802 – LONGANESI 1973
SEUME, Johann Gottfried – Seumes Werke (2 vol)– AUFBAU, 1977
SEUME, Johann Gottfried – Mein Leben – HOLZINGER, 2014