di Paolo Repetto, 13 dicembre 2024
Chiacchierando con Vittorio (si parlava della mini-serie sui giallisti inglesi che ha postato recentemente su questo sito), abbiamo messo a confronto i nostri rispettivi rapporti con l’Inghilterra, con la sua storia, la sua cultura e i suoi abitanti. Il risultato era scontato, siamo entrambi anglofili ferventi, anche se con approcci diversi. E non è neppure una novità: ci conosciamo da tempo. Solo, non ne avevamo mai parlato diffusamente prima.
È nata di lì quindi l’idea di trasferire sulla carta le mie impressioni: una modesta dichiarazione d’affetto per la piccola grande isola, che mi accomuna peraltro a diversi connazionali illustri, come ad esempio – si parva licet – Luigi Meneghello o Beppe Fenoglio, o a coetanei d’oltreoceano, come Bill Bryson, professatisi inglesi d’elezione.
Una dichiarazione d’affetto non è una dichiarazione d’amore. L’amore è cieco, mentre il mio è un sentimento più controllato, che permette di rilevare gli aspetti di quella cultura che non mi piacciono, e di criticarli, ma di considerarli alla fin fine meno significativi di quelli che mi attraggono. Questo dovrebbe prevenire le obiezioni: ma la Brexit, ma gli hooligans, ma questo, ma quello … Certo, lo so, e non dico che me ne freghi niente, ma qui almeno ho come contropartita qualcosa di più della pizza e della canzone napoletana (non tiriamo in ballo le rovine classiche e i tesori d’arte che i nostri antenati hanno prodotto secoli fa, sono eredità non possono essere fatte pesare nel confronto – semmai testimoniano la nostra odierna decadenza). E poi, mica intendo stilare delle classifiche di cultura o di civiltà: semplicemente vorrei spiegare a me stesso – perché agli altri giustamente interesserà ben poco – cosa mi attrae di quella cultura e di quella civiltà, sapendo che il modo migliore per fare una cosa del genere è obbligarmi a mettere il tutto per iscritto.
Mentre ne parlavamo mi è venuto comunque in mente che io quel sentimento l’ho già espresso in più occasioni, è sparso nei vari pezzi che ho scritto, e che quindi potrò cavarmela con un’antologia di stralci dalle cose postate sul sito o dalla mia corrispondenza. Non è solo questione di pigrizia (anche se, insomma …), di autoreferenzialità o di insofferenza a ripetere cose che ho già detto. Credo davvero che solo le impressioni a caldo, e così pure quelle buttate giù a margine di altri argomenti, possano rendere con la giusta immediatezza un’attrazione difficilmente traducibile in argomentazioni lucide.
Devo premettere inoltre che nel mio caso il sentimento non nasce da un’assidua frequentazione, anzi: sono stato in Inghilterra cinque o sei volte, ne conosco solo una piccolissima parte, non ho mai avuto amici inglesi, non solo non parlo correntemente, ma conosco poco anche a livello elementare, la lingua. Il perché di questa affezione lo lascio alle pagine che ho raccolto di seguito, credo lo spieghino sufficientemente. Mi limito pertanto a pochissimi dati sulla frequentazione.
Ho vissuto a Londra per poco più di un mese cinquantacinque anni fa, nel 1969. C’ero finito al seguito di un amico conosciuto all’università, che vantava conoscenze nella capitale inglese, ragazzi italiani che ci avrebbero ospitato e “introdotto”. Già il viaggio, su una scassatissima cinquecento, si era rivelato un’avventura. All’arrivo la cosa si fece anche più interessante, perché gli amici erano naturalmente dei morti di fame come noi, che si barcamenavano alla meno peggio in sistemazioni e relazioni assurde. Sbarcammo a Londra come gli emigranti italiani di fine Ottocento a Long Island, e per tutto il tempo della nostra permanenza fummo occupati a trovare un tetto per la notte e qualcosa da mettere sotto i denti durante il giorno.
Un giorno dovrò raccontare tutto questo: per ora basti sapere che ero partito con sessantamila lire in tasca, che al cambio odierno sarebbero trenta euro, ma rivalutate in base all’inflazione corrisponderebbero a cinque-seicento euro. Coi quali però dovetti sostenere anche la metà delle spese di viaggio (benzina, traghetto, forature e inconvenienti vari), per cui al netto disponevo dell’equivalente di meno di trecento euro. Insomma, nelle ultime settimane ho fatto la fame e sono tornato a casa letteralmente senza una lira in tasca, dimagrito di cinque o sei chili.
In quelle condizioni confesso che l’impressione lasciatami dalla città non fu particolarmente positiva. Forse per questo non ho più messo piede in Inghilterra fino al nuovo secolo. Preferivo continuare a conoscerla attraverso i libri e i film, rispondevano meglio all’idea che mi ero fatto e non mi costringevano a diete ipocaloriche.
L’occasione di un ritorno è arrivata quando Chiara, la maggiore delle mie due figlie, si è trasferita per lavoro sull’isola, prendendovi casa e cittadinanza. È accaduto poco più di vent’anni fa, e da allora come dicevo sono tornato quattro o cinque volte (senza mai però toccare Londra, se non per il transito aeroportuale). Ho visitato il Somerset, il Devon e la Cornovaglia a sud, la Cumbria e il Lancashire al nord, ho solo sorvolato la Scozia e le Shetland. Che significa in pratica aver visto poco o nulla. In compenso ho conosciuto i colori della natura inglese in tutte le stagioni. E quelli qualcosa mi hanno aiutato a capire.
Nel buttare giù queste cose (e rileggendo quelle che ho scritto in più occasioni precedenti) mi chiedo se nella inossidabilità della mia anglofilia non ci sia qualche motivazione più profonda, magari inconscia, o subentrata di recente, che vada al di là delle giovanili suggestioni letterarie (per quanto queste continuino a ripetersi). E credo di poter individuare questa motivazione nel fatto che vedo ormai nell’Inghilterra l’ultimo baluardo della cultura e della civiltà occidentale.
Può sembrare paradossale, per un paese che ha il numero più alto in Europa di abitanti originari di altre parti del mondo, ma è così. In altri tempi l’Inghilterra è stata salvata dalle invasioni dal suo essere un’isola: oggi le sue difese non sono più quelle naturali, ma quelle culturali. La lingua, ad esempio: la maggioranza di coloro che sono migrati in Inghilterra nell’ultimo secolo non si è scontrata con una barriera linguistica, essendo ormai l’inglese una lingua universale: e questo non li ha indotti a fare gruppo solo con i propri connazionali o correligionari, ma ha consentito loro di integrarsi con relativa facilità, di assorbire costumi e mentalità dell’isola. Al contrario di quanto accade da noi, ma anche in Francia, in Germania, in Olanda, dove si sono insediate culture diverse che tendono a preservare gelosamente le loro differenze e a sviluppare una propria autonomia, in Inghilterra diventano bene o male tutti inglesi. E questo malgrado poi ottenere la cittadinanza inglese sia tutt’altro che semplice e a buon prezzo: mia figlia, che risiede là da quasi vent’anni, parla la lingua meglio degli autoctoni, ha un lavoro stabile e una casa di proprietà, ha dovuto sborsare più di mille sterline e superare due esami, uno di lingua e uno di cultura, due prove serie e non due ridicoli pro-forma, per essere accolta.
Questo produce un ulteriore paradosso: gli inglesi, che proprio attraverso la diffusione o l’imposizione della propria lingua (e della propria cultura) a livello mondiale sono stati tra i principali artefici della globalizzazione, risultano essere oggi uno dei popoli meno “globalizzati”, almeno nel senso che sono ancora tenacemente attaccati alla loro storia e alle loro tradizioni.
Ecco, sto naturalmente semplificando al massimo, ma credo che la differenza stia proprio lì: gli inglesi hanno stabilito delle regole. Non hanno nemmeno avuto bisogno di scriverle, le hanno sempre date per scontate: volevano imporle a casa degli altri, figuriamoci nella propria: se vuoi abitare qui, devi adeguarti alle leggi e alla consuetudine locale. Per il resto sei libero di pensare, credere, vestire e mangiare come vuoi.
Queste regole sono state fatte rispettare e hanno funzionato sino ad oggi, e se non hanno necessariamente favorito l’instaurarsi di relazioni d’amicizia (la fonte informata è sempre mia figlia) tra gli immigrati e gli “indigeni”, hanno quanto meno consentito una pacifica convivenza. È possibile che per il futuro le cose si complichino, i segnali già ci sono, ma al momento l’Inghilterra sembra ancora determinata a difendere il ridotto occidentale.
Ho cercato di scegliere, tra le centinaia di pagine che ho scritto in proposito, quelle che della cultura e della civiltà britannica coglievano le sfaccettature meno scontate. Naturalmente non mancheranno le ripetizioni, giustificate comunque dal fatto che quanto ho recuperato è stato scritto in tempi e in occasioni diverse, ed era destinato a differenti interlocutori.
Sono anche consapevole che tanto ripetute manifestazioni di “affetto” possano apparire esagerate e far sorridere. Ma corro il rischio volentieri, perché nel miglior spirito anglosassone nutro la pretesa che mi legge sia anche in grado di capirmi.
da Mr. Psmith nella Grande Mela (2018)
[…] Io sono malato di anglofilia, sono a tutti gli effetti un anglomane. Ma la mia è un’anglomania “povera”, coltivata per moltissimo tempo solo a tavolino, sulle letture in traduzione dei libri di Stevenson, di Kipling, di Wilde, di Conrad e di infiniti altri. Nemmeno oggi parlo l’inglese, lo leggo e lo capisco a stento. È anche un’anglomania selettiva: non sono mai stato un fan dei Beatles o dei Rolling Stones, e meno che mai di Elton John. E non è totalmente acritica: sono convinto che gli inglesi siano affetti da una incredibile spocchia e abbiano sempre guardato al resto del mondo come se avessero qualcosa da insegnargli (tra l’altro, sempre presumendo che gli altri non fossero comunque in grado di imparare). Quindi, in realtà ci sarebbe ben poco da amare: a meno di essere convinti che abbiano ragione.
Ebbene, non posso negare che una qualche idea del genere la coltivo, a dispetto anche dell’opinione della mia prima figlia, che in Inghilterra ci vive ed è cittadina inglese e dei suoi connazionali dice peste e corna. È una convinzione che viene rafforzata da ogni breve permanenza nell’isola (e lo è ulteriormente ogni volta che ne vengo via). Vedo qual è la realtà inglese attuale, e come gli inglesi si siano ridotti, ma continuo ad amarli, con tutti i loro difetti di ieri e di oggi. Cosa che non mi succede, ad esempio, coi romani.
Forse dovrei dire piuttosto che amo la “civiltà” inglese: ma quella civiltà è appunto il prodotto di uno spirito, di uno stile, di una cultura che mi appaiono straordinari, e che appartengono (o forse appartenevano) solo a loro. Posso affermarlo con cognizione di causa perché i miei interessi, che occupano uno spettro piuttosto ampio, hanno fatto sì che li incrociassi continuamente. Dovunque mi abbia portato il mio disordinatissimo percorso culturale, li ho trovati. Magari non erano approdati per primi, ma una volta arrivati c’erano rimasti. Ora, non è questione di qualità, non penso cioè (a differenza degli inglesi stessi) che nascano in Inghilterra intelletti “superiori”. Quelli possono nascere ovunque. È invece una faccenda di quantità, e un numero eccezionale di personaggi fuori dal comune: e il numero è tale che agli inglesi tanto straordinari poi non sono mai parsi. Lo sembrano a noi, dal di fuori. A me, senz’altro.
Sul perché di questa eccezionale fioritura ho le mie teorie, fondate sulla storia e non sulla biologia, delle quali ho già parlato in Due lezioni sulla storia inglese: ma per farsene un’idea è sufficiente leggere ad esempio, in Tour de France, di Richard Cobb, il racconto dell’adolescenza e del percorso di studi di uno storico anglosassone.
da Elisa nella stanza delle meraviglie (2003)
Letterature: gli inglesi
[…] Mi accorgo solo adesso che la letteratura inglese è quella che occupa il maggior numero di ripiani. Così su due piedi non saprei dartene una spiegazione. È evidente che gli inglesi hanno scritto molto di più rispetto ai rumeni o agli estoni, proporzionalmente e in assoluto: ma qui sono rappresentati in misura doppia anche rispetto ai francesi, ai russi, ai tedeschi e agli americani. E questo non è più un rapporto proporzionalmente oggettivo, dice di preferenze e di interessi soggettivi.
La mia consuetudine con la letteratura inglese è indubbiamente remotissima, dura ormai da cinquant’anni. Come già ti dicevo i classici per la gioventù me li sono fatti tutti (tranne Peter Pan, ora che ci penso: chissà perché nessuno ha mai pensato a regalarmelo. O forse ci hanno pensato, e poi han ripensato bene?) e probabilmente la spiegazione sta proprio lì. Nessun’altra letteratura offre tanti spunti e occasioni diverse per fantasticare (e per innamorarsi quindi dei libri) ai fanciulli e agli adolescenti. Ma c’è dell’altro. Con gli inglesi sei da subito in bilico tra la letteratura giovanile e quella adulta, anzi, entri immediatamente in quest’ultima perché leggi cose scritte per adulti ma facilmente riconducibili alla misura di un ragazzo. Uno dei primi libri che ho letto si intitolava Racconti da Shakespeare, erano riduzioni a novella delle sue tragedie. I contemporanei italiani di Shakespeare si chiamano Tasso e Marino: al di là del fatto che sfido chiunque a ridurre l’Adone per i ragazzi, se mai lo si fosse fatto per la Gerusalemme liberata (e comunque sarebbe risultato altrettanto difficile) si sarebbe gridato allo scandalo. Non parliamo poi de I promessi sposi!
 Gli inglesi invece scrivono Kim e Alice nel paese delle meraviglie, che puoi leggere con eguale soddisfazione a dieci o a sessant’anni, o le storie dei cavalieri della Tavola Rotonda, o le avventure di Robinson Crusoe e di Oliver Twist. Sono libri che non ti senti in dovere di nascondere, appena accedi alla letteratura adulta, come accade invece con Salgari, perché non sono bollati come appartenenti a generi “minori” o marginali. Fanno parte integrante della letteratura di quel paese, ti accompagnano nella tua maturazione lungo un percorso ininterrotto sui sentieri della fantasia. Nelle scuole inglesi degli anni Cinquanta e sessanta i miei coetanei leggevano Kipling, Conan Doyle, Stevenson: a me, se mi trovavano sotto il banco un romanzo di Scerbanenco, mi cacciavano dalla scuola.
Gli inglesi invece scrivono Kim e Alice nel paese delle meraviglie, che puoi leggere con eguale soddisfazione a dieci o a sessant’anni, o le storie dei cavalieri della Tavola Rotonda, o le avventure di Robinson Crusoe e di Oliver Twist. Sono libri che non ti senti in dovere di nascondere, appena accedi alla letteratura adulta, come accade invece con Salgari, perché non sono bollati come appartenenti a generi “minori” o marginali. Fanno parte integrante della letteratura di quel paese, ti accompagnano nella tua maturazione lungo un percorso ininterrotto sui sentieri della fantasia. Nelle scuole inglesi degli anni Cinquanta e sessanta i miei coetanei leggevano Kipling, Conan Doyle, Stevenson: a me, se mi trovavano sotto il banco un romanzo di Scerbanenco, mi cacciavano dalla scuola.
Vedi Elisa, torna in ballo la questione che abbiamo già affrontato a proposito della poesia: ci sono popoli che hanno saputo coltivare il piacere della cultura, del farla come del consumarla, ed altri che ne hanno invece sempre riverito e sofferto il “peso”. C’entrerà la religione, o il clima e gli inverni lunghi, non lo so: sta di fatto che l’ultimo libro di poesie di Tom Hugues ha venduto in sei mesi seicentomila copie, mentre Ossi di seppia non le ha vendute in ottant’anni.
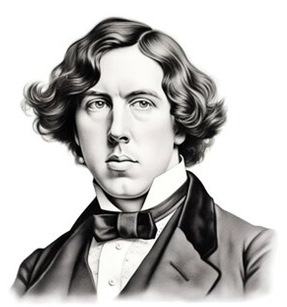 Nei confronti della letteratura inglese non c’è stata quindi una vera e propria “scoperta”, ma un passaggio graduale e conseguente. Forse potrei far coincidere l’ingresso nella fase totalmente “adulta” del rapporto con la lettura de Il ritratto di Dorian Grey, che mi ha preso a dispetto dell’inconsistenza della storia, per puro innamoramento dello stile e dell’arte del paradosso. Non so quanto abbia retto il romanzo a questi ultimi quarant’anni: ogni tanto c’è qualche studente che me lo chiede, forse perché intrigato dalla fama di libro un po’ “scandaloso”, ma quando lo riportano non vedo brillare nei loro occhi nessuna scintilla di entusiasmo. Io ormai non lo ricordo nemmeno più, ma ricordo che lo snobismo di Wilde, il suo culto dello stile, una qualche impressione deve avermela fatta, se mi ha spinto a leggere poi con gusto anche tutto il suo teatro, nonché i saggi (tra i quali è godibilissimo, e quanto mai attuale, La decadenza della menzogna).
Nei confronti della letteratura inglese non c’è stata quindi una vera e propria “scoperta”, ma un passaggio graduale e conseguente. Forse potrei far coincidere l’ingresso nella fase totalmente “adulta” del rapporto con la lettura de Il ritratto di Dorian Grey, che mi ha preso a dispetto dell’inconsistenza della storia, per puro innamoramento dello stile e dell’arte del paradosso. Non so quanto abbia retto il romanzo a questi ultimi quarant’anni: ogni tanto c’è qualche studente che me lo chiede, forse perché intrigato dalla fama di libro un po’ “scandaloso”, ma quando lo riportano non vedo brillare nei loro occhi nessuna scintilla di entusiasmo. Io ormai non lo ricordo nemmeno più, ma ricordo che lo snobismo di Wilde, il suo culto dello stile, una qualche impressione deve avermela fatta, se mi ha spinto a leggere poi con gusto anche tutto il suo teatro, nonché i saggi (tra i quali è godibilissimo, e quanto mai attuale, La decadenza della menzogna).
Questa dello stile, di vita intendo, oltre che letterario, è una fissazione comune un po’ a tutti gli autori inglesi, non solo a Wilde. E forse questa è l’altra spiegazione del primato della presenza inglese nei miei scaffali. Vedi, io ho vissuta nella fanciullezza un’intensa militanza da chierichetto, precettata da tua nonna ma anche in parte sentita. Per cinque o sei anni ho sbaragliato la concorrenza nelle classifiche a punti del servizio, per poi, quando la superiorità era ormai manifesta e schiacciante, perdere inesorabilmente la fede. Non è stato facile, non tanto resistere alle pressioni materne, quanto imparare a convivere con principi che ormai si erano radicati, ma che non avevano più nessuna giustificazione in un quadro morale ben definito. Dovevo costruirmi un’etica, non mi bastava più De Amicis e non potevo certo chiedere soccorso a Pellico o Manzoni. Quelli giusti erano Conrad e Kipling, insieme magari a London. L’etica del dovere e della solidarietà, e l’orgoglio della solitudine. Guarda che non so scherzando: probabilmente sono state più che altro delle conferme, trovavo lì la perfetta corrispondenza con ciò che sentivo, ma è indubbio che hanno contribuito a rafforzare le mie inclinazioni (e diciamo anche le mie manie: dopo aver letto Lawrence d’Arabia spegnevo i cerini e le candele con i polpastrelli delle dita, per temprarmi a resistere alla tortura).
Sono molti, in effetti, gli autori inglesi che vale la pena conoscere: praticamente tutti quelli che trovi qui, più gli altri distribuiti nelle sezioni “speciali”. Messi assieme occuperebbero un intero scaffale, da cima a fondo (ma è anche da dire che quattro o cinque come Dickens o Conrad, o come Kipling e Stevenson, per non parlare di Shakespeare, portano via da soli tre quarti dello spazio, soprattutto se si ha la pretesa di raccogliere praticamente tutto quel che è stato tradotto). Non è certo il caso che te li presenti uno ad uno: quando arriverà il momento incontrerai quelli giusti, si faranno avanti da soli. Al più posso segnalarti qualche lettura particolare, di quelle meno scontate. Ad esempio questo libretto di Kipling, Qualcosa di me, dove viene rievocata un’infanzia prima favolosa (è nato in India) e poi tristissima (è stato spedito a sei anni a studiare in Inghilterra), ma dove si capisce soprattutto perché un poeta inglese che canta l’imperialismo rimane un poeta, mentre un italiano che fa altrettanto (pensa a D’Annunzio) diventa un trombone. Anche Stevenson ha scritto cose “minori” simpaticissime: il suo Viaggio nelle Cevennes in compagnia di un asino mi aveva quasi convinto a recuperare un mulo dell’esercito per farne un compagno di escursioni. E poi c’è Jerome, Tre uomini in barca. Una volta era considerato un classico dell’umorismo, oggi, per palati educati alla comicità demenziale, potrebbe avere un sapore di stantio. Ma non è così: prova a godertelo nelle condizioni giuste, sotto un albero in aperta campagna, lontano da televisione e walkman, e riassaporerai il gusto perduto della finezza (anche qui, è questione di stile).
 Naturalmente, le donne. Ci stavo arrivando. Nella letteratura inglese non si può prescindere dalla scrittura al femminile, nemmeno io ho il coraggio di farlo. Sono passato per la Mary Shelley, per le Bronte, per Jane Austen, per la Barrett, su su fino ad arrivare alla Mansfield e a Virginia Woolf (e poi basta, però. Le voci femminili importanti sembrano fermarsi agli anni Venti. Deve essere accaduto qualcosa alle donne inglesi). Beh, queste devi leggertele tutte, non si scappa. Magari scegliendo, Senso e sensibilità ad esempio, o Jane Eire, se vuoi farti un’idea. E per entrare in argomento puoi iniziare con Flush, della Woolf, e proseguire subito dopo con Una stanza tutta per me, che della scrittura al femminile è un po’ il manifesto.
Naturalmente, le donne. Ci stavo arrivando. Nella letteratura inglese non si può prescindere dalla scrittura al femminile, nemmeno io ho il coraggio di farlo. Sono passato per la Mary Shelley, per le Bronte, per Jane Austen, per la Barrett, su su fino ad arrivare alla Mansfield e a Virginia Woolf (e poi basta, però. Le voci femminili importanti sembrano fermarsi agli anni Venti. Deve essere accaduto qualcosa alle donne inglesi). Beh, queste devi leggertele tutte, non si scappa. Magari scegliendo, Senso e sensibilità ad esempio, o Jane Eire, se vuoi farti un’idea. E per entrare in argomento puoi iniziare con Flush, della Woolf, e proseguire subito dopo con Una stanza tutta per me, che della scrittura al femminile è un po’ il manifesto.
Io non credo di essere il lettore più adatto a cogliere tutte le sfumature di una sensibilità femminile (te n’eri già accorta? Meglio così), per cui se mi chiedi cosa mi attiri veramente in queste autrici temo di darti delle spiegazioni deludenti. Ho l’impressione che tutte queste storie, anche quelle apparentemente più pacifiche della Austen, siano in realtà tese come corde di violino, giocate su un minimalismo dei fatti e un massimalismo della loro interpretazione che nella scrittura maschile sono assenti. Le storie al maschile sono più piane, più distese, anche quando sono infarcite di massacri e violenze e peregrinazioni: in quelle femminili il massacro è continuo, sottile, apparentemente incruento, la tensione non cade mai. E questo mi piace, lo capisco fino ad un certo punto, cioè capisco fino ad un certo punto come si possa vivere e pensare così, ma letterariamente mi piace.
Per questo mi piace molto anche un autore come E.M. Forster, perché ha una sensibilità molto prossima a quella femminile, ed è uno dei pochi (assieme a Flaubert e ad Henry James) in grado di rappresentare uno sguardo femminile sul mondo (se poi ci riesca davvero, ripeto, non lo so. A me pare di sì). Prova a leggere Camera con vista, tra qualche anno, e magari ne discuteremo. Ma mi rendo conto che sono le chicche quelle che aspetti. Allora, salta quei venti volumi di Conrad (nel senso non di “scàrtali”, ma di “acquistali in blocco”), mettendo magari da parte per un primo assaggio I duellanti (di là c’è anche la videocassetta del film che ne hanno tratto, può essere interessante, dopo) ed estrai quel libricino azzurro. Si, sono poesie, il titolo è Grazie nebbia, il poeta è W.H. Auden. Scegline una a caso, e prendi a metà: “Ma il Tempo, il dominio dei Fatti / richiede una Grammatica complessa / con molti Modi e Tempi / e in primo luogo l’Imperativo. / Noi siamo liberi di sceglierci la strada / ma scegliere dobbiamo, non ha importanza / dove conduca, e le storie che raccontiamo / del passato hanno da essere vere”. Hai capito? Via, non pretendiamo troppo, intendevo dire se hai capito perché mi piace: perché dice le cose più vere con le parole più semplici. Lì accanto ci sono gli altri volumi delle sue poesie La verità, vi prego, sull’amore e una raccolta antologica. Quando dovessi chiederti se esiste e cos’è la poesia, aprine uno.
 Auden ha combattuto in Spagna, al tempo della guerra civile, nelle Brigate Internazionali. C’era anche Orwell in quelle brigate, come militante anarchico, mentre Auden era comunista. Orwell è famoso per La fattoria degli animali, che puoi leggere anche subito, e per 1984, che ti consiglio di affrontare più in là. Ma qui ci sono anche i suoi saggi, Sul leggere, Sullo scrivere, Sul chiedere e sul non chiedere, Sul vivere e sul morire, raccolti sotto il titolo Nel ventre della balena. In realtà non sono veri e propri saggi, sono raccontini autobiografici di fattura squisita e di eccezionale sostanza etica, come l’autore, del resto.
Auden ha combattuto in Spagna, al tempo della guerra civile, nelle Brigate Internazionali. C’era anche Orwell in quelle brigate, come militante anarchico, mentre Auden era comunista. Orwell è famoso per La fattoria degli animali, che puoi leggere anche subito, e per 1984, che ti consiglio di affrontare più in là. Ma qui ci sono anche i suoi saggi, Sul leggere, Sullo scrivere, Sul chiedere e sul non chiedere, Sul vivere e sul morire, raccolti sotto il titolo Nel ventre della balena. In realtà non sono veri e propri saggi, sono raccontini autobiografici di fattura squisita e di eccezionale sostanza etica, come l’autore, del resto.
Io in genere non riesco a fare distinzione tra l’autore e l’opera. Dicono che non è giusto, che occorre leggere senza condizionamenti biografici, che se la mettiamo così anche Leopardi era un golosone e Foscolo uno sciagurato e Salgari si perdeva se usciva da Verona: ma non è a queste stupidaggini che mi riferisco, anzi, le trovo gustose. Voglio coerenza nelle cose importanti. Se uno scrive l’Emilio e manda cinque figli a morire al brefotrofio, ho delle difficoltà a dargli credito. Se uno (come Sartre) che non ha mosso un dito per gli ebrei durante l’occupazione nazista si riscatta, dopo la guerra, con un saggio sull’antisemitismo, e dopo aver attaccato nella maniera più feroce Koestler e Camus perché antistalinisti si scopre libertario nel ‘68, quale obiettività è possibile? Si salta a piè pari. Bene, Orwell è tra quelli che dimostrano che la coerenza è possibile, e che è quindi giusto pretenderla.
 Un’eccezione però riesco a farla. Per Chatwin. Come uomo Chatwin doveva essere di un’antipatia unica, l’ultima persona che vorresti avere come compagno di viaggio. Ho dovuto interrompere la lettura di una sua biografia (tra l’altro, scritta da un certo Nicholas Shakespeare) per eccesso di avvilimento. Ma come scrittore, di viaggio e non, è superbo. Utz e Sulle colline nere sono due gioiellini, il secondo non sfigura accanto ai libri di Thomas Hardy. È possibile che io non sia granché obiettivo nel giudizio, ma in senso favorevole all’autore, perché c’è di mezzo anche un mio diritto di prelazione: credo di essere stato uno tra i primissimi a leggere in Italia il libro che lo ha reso famoso, In Patagonia, subito dopo l’editore e i correttori di bozze, e per qualche mese ne ho tenuto l’esclusiva. E sai quanto godo di queste cose!
Un’eccezione però riesco a farla. Per Chatwin. Come uomo Chatwin doveva essere di un’antipatia unica, l’ultima persona che vorresti avere come compagno di viaggio. Ho dovuto interrompere la lettura di una sua biografia (tra l’altro, scritta da un certo Nicholas Shakespeare) per eccesso di avvilimento. Ma come scrittore, di viaggio e non, è superbo. Utz e Sulle colline nere sono due gioiellini, il secondo non sfigura accanto ai libri di Thomas Hardy. È possibile che io non sia granché obiettivo nel giudizio, ma in senso favorevole all’autore, perché c’è di mezzo anche un mio diritto di prelazione: credo di essere stato uno tra i primissimi a leggere in Italia il libro che lo ha reso famoso, In Patagonia, subito dopo l’editore e i correttori di bozze, e per qualche mese ne ho tenuto l’esclusiva. E sai quanto godo di queste cose!
Sono arrivato piuttosto tardi invece a Il signore degli anelli. Tardi, ma sempre con largo anticipo sulla cultura di sinistra, che per anni lo ha ostracizzato o ignorato e poi ne ha conteso il culto alla destra. Tardi, ma d’un fiato. Neppure tu, con le tue innate doti di pervicace rompiballe, saresti riuscita a distrarmi quando ho cominciato il viaggio con Gandalf e Frodo Baggin. Spero che l’aver visto il film non ti dissuada, come mi sembra stia accadendo ad un sacco di ragazzi. Sono millecinquecento pagine, ma quando arrivi in fondo avresti solo voglia che fossero il doppio.
 Tra l’altro, sempre a proposito di coerenza, nello scaffale opposto, dove arriveremo più tardi, c’è un librone di Humprey Carpenter, Gli Inklings. È una sorta di biografia collettiva di un gruppo di amici, tra i quali lo stesso Tolkien, C. S. Lewis, Charles Williams, tutti docenti ad Oxford negli anni Venti e Trenta, raccolti in circolo informale sotto il nome appunto di Inklings, che invece di cacciarsi le dita negli occhi a vicenda come in genere avviene nell’ambiente universitario si trovavano tutti i giovedì sera per discutere, leggere ciò che avevano scritto in settimana, farsi qualche bicchiere di Porto o di scotch. Quando uno di loro doveva tenere qualche conferenza nelle città vicine era una festa collettiva: partivano a piedi nel weekend, arrivavano a farsi anche cento chilometri, con frequentissime soste nelle osterie sul cammino, tornavano alla stessa maniera e riprendevano il loro lavoro accademico. Dove sta la coerenza? Nell’amicizia Elisa, nella capacità di non sacrificare l’amicizia alla loro professione o alla loro vocazione di scrittori. Non sapevo nulla di tutto questo quando ho letto Il signore degli anelli, ma non potevo fare a meno di accorgermi che chi scriveva conosceva davvero il valore dell’amicizia.
Tra l’altro, sempre a proposito di coerenza, nello scaffale opposto, dove arriveremo più tardi, c’è un librone di Humprey Carpenter, Gli Inklings. È una sorta di biografia collettiva di un gruppo di amici, tra i quali lo stesso Tolkien, C. S. Lewis, Charles Williams, tutti docenti ad Oxford negli anni Venti e Trenta, raccolti in circolo informale sotto il nome appunto di Inklings, che invece di cacciarsi le dita negli occhi a vicenda come in genere avviene nell’ambiente universitario si trovavano tutti i giovedì sera per discutere, leggere ciò che avevano scritto in settimana, farsi qualche bicchiere di Porto o di scotch. Quando uno di loro doveva tenere qualche conferenza nelle città vicine era una festa collettiva: partivano a piedi nel weekend, arrivavano a farsi anche cento chilometri, con frequentissime soste nelle osterie sul cammino, tornavano alla stessa maniera e riprendevano il loro lavoro accademico. Dove sta la coerenza? Nell’amicizia Elisa, nella capacità di non sacrificare l’amicizia alla loro professione o alla loro vocazione di scrittori. Non sapevo nulla di tutto questo quando ho letto Il signore degli anelli, ma non potevo fare a meno di accorgermi che chi scriveva conosceva davvero il valore dell’amicizia.
Gli Inklings sono diventati anche il modello per un’esperienza personale di questo tipo. Per qualche anno, poco prima che tu nascessi, è esistito un gruppo di amici che si ritrovava a cenare ritualmente, quasi ogni settimana, al nostro capanno, e tirava tardi discutendo di cinema e di politica, facendo pettegolezzi e progettando escursioni, mettendo in cantiere mostre e redigendo riviste. L’unica cosa in comune con gli Inklings era probabilmente il tasso alcolico, ma i Viandanti delle Nebbie hanno corrisposto ad uno dei periodi più autentici della mia vita. Il gruppo, come motore di iniziative, non esiste più, ma gli amici sono rimasti: e a tenerli legati è, ancora e sempre, il comune amore per la letteratura.
E adesso chiudiamo, perché bisogna pur arrivarne ad una e perché ho bisogno di una pausa per il caffè. Non prima però di averti fatto notare questo libretto di racconti di Alan Sillitoe, La solitudine del maratoneta. Negli ultimi vent’anni credo lo abbiano letto solo i miei studenti, non lo trovo citato in alcuna antologia o bibliografia sulla condizione adolescenziale. Ma è perfetto, nella sua secchezza, nella capacità di evocare il peso di una condizione carceraria senza ricorrere a trucchi granguignoleschi, nel gesto finale autolesionistico di dignità e di coerenza. Malgrado il traino di un film altrettanto bello che ne è stato tratto, qui da noi non ha avuto una grossa fortuna nemmeno negli anni della contestazione. Troppo inglese, troppo elegante, troppo aristocratica come etica, evidentemente.

da: I regali di un tempo (2013)
 Ho sentito la voglia di raccontarlo [ndr: Patrick Leigh Fermor] quindi per quattro ragioni, e direi che ce n’è d’avanzo: perché era un uomo coraggioso, perché era un intellettuale raffinato, perché era un grande camminatore e perché era uno snob quale solo gli inglesi sanno esserlo. Fermor appartiene alla dinastia dei Byron, George ma soprattutto Robert, quello de La via per l’Oxiana, e risalendo più in su ancora, del bucaniere Dampier, e allungando indietro lo sguardo, dei cavalieri della Tavola Rotonda. E anche di Orwell o di Auden, pronti a combattere per quella che ritengono la causa giusta, e a fermarsi appena hanno l’impressione che tanto giusta non sia, o che comunque non sia più la loro causa. Individualisti, per nulla disposti a sacrificare la loro autonomia di pensiero agli interessi di un’idea che, nel momento in cui non garantisce la massima libertà individuale, non riesce più accettabile.
Ho sentito la voglia di raccontarlo [ndr: Patrick Leigh Fermor] quindi per quattro ragioni, e direi che ce n’è d’avanzo: perché era un uomo coraggioso, perché era un intellettuale raffinato, perché era un grande camminatore e perché era uno snob quale solo gli inglesi sanno esserlo. Fermor appartiene alla dinastia dei Byron, George ma soprattutto Robert, quello de La via per l’Oxiana, e risalendo più in su ancora, del bucaniere Dampier, e allungando indietro lo sguardo, dei cavalieri della Tavola Rotonda. E anche di Orwell o di Auden, pronti a combattere per quella che ritengono la causa giusta, e a fermarsi appena hanno l’impressione che tanto giusta non sia, o che comunque non sia più la loro causa. Individualisti, per nulla disposti a sacrificare la loro autonomia di pensiero agli interessi di un’idea che, nel momento in cui non garantisce la massima libertà individuale, non riesce più accettabile.
Ecco, credo che stia lì la radice di tutto: crescendo nella lettura di Malory fin da ragazzino, in quella dei classici nell’adolescenza (ed è da notare che per gli inglesi i classici per eccellenza sono i greci, e non i latini, e l’autore classico più popolare e letto in assoluto è Plutarco. Col risultato che gli studenti italiani conoscono soprattutto Cicerone e Seneca, e per essi la classicità rimanda paradossalmente all’esistenza di uno stato, o comunque di una ragione esterna superiore, alla quale poi in realtà non credono perché se ne sentono vittime, e non protagonisti: mentre al contrario gli inglesi hanno il senso dello stato proprio perché esso sembra esistere apposta per garantire in primo luogo la loro libertà) e con i libri dei viaggiatori e degli esploratori, o comunque di gente che ha girato il mondo in lungo e in largo nella giovinezza (si pensi a Stevenson, a Kipling, a Conrad), se uno poco poco è permeabile si imbeve di un’idea della vita tutta particolare. Quella del mondo viene di conseguenza, ma direi che nella prospettiva inglese è secondaria. Mentre noi ci trinceriamo dietro il Fato, e ci arrendiamo senza troppe resistenze al condizionamento delle contingenze esterne, gli inglesi sono persuasi di poterle tranquillamente governare. Questo spiega perché la nostra letteratura veda come protagonisti di norma degli anti-eroi, inetti, sconfitti o annoiati, e perché il personaggio letterario che forse meglio rispecchia il nostro sentire sia Don Abbondio, mentre già un secolo prima gli anglosassoni si identificavano in Robinson Crusoe.
Fermor era un uomo libero, e questo lo iscrive di diritto nella galleria dei personaggi che vorrei contribuire a tenere in vita. In quanto libero, e intendo libero “dentro”, era di conseguenza coraggioso: al limite della temerarietà, ma non dell’incoscienza. Questo non perché dovesse provare a se stesso, o agli altri, il proprio coraggio: semplicemente, si divertiva. È un atteggiamento che non appartiene alla nostra cultura mediterranea, a dispetto della “solarità” che accampiamo e che gli stessi nordici ci attribuiscono. Noi crediamo di essere allegri, invece siamo solo poco seri e melodrammatici. Recitiamo costantemente una parte della quale non siamo convinti: e nemmeno sappiamo giocare lealmente. Gli inglesi in fondo chiamano “grande gioco” tutta la complicata vicenda che li vede contrapposti ai russi nel Medio Oriente nella seconda metà dell’Ottocento. E sono coloro che hanno inventato il concetto moderno di sport, da non confondere con quello postmoderno di industria dello sport. In sostanza, per loro la vita è una cosa seria, e appunto per questo va valorizzata: ma è anche una cosa molto breve, e appunto per questo va presa con il giusto distacco – l’ironia – e con divertimento. Il divertimento nasce solo dal gioco leale, dal concordare delle regole e poi rispettarle. Quindi, gli inglesi prendono la vita come un gioco, e qui sta il loro snobismo, ma sono seri nel gioco, e qui sta la loro forza. (Non sto tessendo il panegirico dello stile britannico, anche se di fatto risulta tale: negli intenti è un panegirico di quello stile che vorrei permeasse qualsiasi atteggiamento esistenziale. Che, chiaramente, non appartiene solo agli inglesi: ma mentre inglesi lo apprezzano, dalle nostre parti – si veda il caso di Berneri – sembra addirittura dare fastidio).

da: Tom Barnaby, antropologo (2018)
I telefilm di Barnaby non hanno la pretesa di documentare una realtà sociale, e meno che mai di denunciarne il degrado, ma propongono in compenso un campionario interessantissimo di materiale antropologico. Un repertorio sterminato di costumi, di manie, di riti sociali, di istituzioni non ufficiali ma investite di autorità dalla tradizione locale: tutto ciò insomma che dovrebbe caratterizzare nel profondo l’Old England.
Provo a farne un elenco a memoria, che sarà chiaramente molto difettoso, perché in effetti ogni singolo episodio ruota attorno ad un mondo particolare, a riti e a tradizioni diversi. Si va dagli appassionati di birdwatching ai coltivatori di orchidee, dalle gare dei cori a quelle dei campanari, dai club letterari alle bande musicali con majorettes, dagli ufologi alle sette sataniche o naturistiche, dai tassidermisti dilettanti ai micologi, fino ai collezionisti di monete, di punte di frecce preistoriche, di libri antichi e d’arte; e poi via via, i club sportivi, di canottaggio, di tiro con l’arco, di cricket, di pugilato, di equitazione, i passeggiatori a piedi o in bicicletta, gli amanti del mistero e dei fantasmi, delle visite ai cimiteri o alle case stregate, fino alle associazioni di ex-combattenti e ai patiti dei giochi di guerra. A fare incontrare tutta questa gente sono soprattutto le feste paesane, tutte uguali, con le gare di lancio del ferro di cavallo o di tiro con l’arco, la musica della banda sullo sfondo e Barnaby che si aggira fingendosi moderatamente divertito (è stato trascinato lì dalla moglie o dalla figlia) tra i quattro banchetti per l’assaggio delle torte e del sidro: fino a quando il primo omicidio non gli consente di rimettersi in azione. Ai nostri occhi di inveterati sagraioli queste feste di paese inglesi possono sembrare noiose e povere, soprattutto per l’assenza di caciara: in realtà sono molto più sentite e genuine di quelle nostrane, hanno alle spalle una reale tradizione, alla quale rimangono il più possibile fedeli, e soprattutto mirano a far incontrare i paesani, non a richiamare e a spolpare i turisti (questo l’ho constatato personalmente).
I telefilm di Barnaby mostrano in definitiva un’Inghilterra rurale che forse non c’è più (ma nemmeno è del tutto scomparsa), volutamente miniaturizzata in tante oleografiche cartoline, e capace di suscitare un velo di nostalgia. Intendiamoci: è l’Inghilterra che ha votato la Brexit: anzi, è l’immagine che quella Inghilterra ha di se stessa, o aveva sin quasi alla fine del secolo scorso. E che, questo è il punto, vorrebbe conservare. Ma qui scatta un primo paradosso. In effetti la serie quella immagine gliela rimanda, ma nel suo contesto Barnaby ha il ruolo di chi alza la pietra: sotto, appena rovista un po’ più in profondità, vien fuori di tutto: antichi rancori, faide secolari, vendette, invidie, livori, meschinità, cupidigie, drammi familiari, tradimenti, perversioni, superstizioni e manie religiose, insomma, una catena di piccoli viperai. In uno dei primi episodi l’ispettore commenta: “Questo paese sembra il paradiso terrestre: ma non lo è”. Una considerazione che potrebbe essere posta in esergo ad ogni puntata.
Questo aspetto del messaggio certamente piacerà poco a Farrange e alle destre fascistoidi: ma in realtà è perfettamente funzionale a raccontare il gioco complesso e delicato di equilibri sui quali si regge la vita di contea, quelli che l’ispettore è chiamato appunto a difendere e a ripristinare, e a suggerire perché non dovrebbero essere sconvolti. Un manifesto conservatore sottile e accattivante, che mescola abilmente mezze verità e ambigue suggestioni: tanto da non farti neppure vergognare di condividerlo.

da: Mr Psmith nella Grande Mela (2019)
[…] L’uso che Wodehouse fa della lingua non denuncia solo uno scarto temporale. Evidenzia anche la distanza che prima della definitiva globalizzazione mediatica correva tra la cultura inglese e tutte le altre, occidentali e no. Non esiste altrove il corrispettivo di un Jerome o di un Wodehouse.
Prendiamo il caso dell’Italia. Accennavo al fatto che tra le mie letture giovanili c’era Achille Campanile (che non la pensava come Psmith, perché riteneva che “In certi casi alla stretta d’un ragionamento ineccepibile non si può rispondere che con una bastonata”). Successivamente sono arrivati altri umoristi, da Marchesi a Guareschi a Benni. Ora, la differenza rispetto ai loro colleghi d’oltremanica è palese. Gli italiani, anche quelli più raffinati, usano sempre il linguaggio in una funzione urticante o demolitoria. Scombinano le architetture, giocano sui doppi sensi. Il loro sorriso è amaro, spesso cattivo, e quando forzano la mano può tradursi in uno sghignazzo. La cosa è più evidente ancora se si guarda al cinema, da Fantozzi ai cinepanettoni. La comicità (?) nostrana nasce dalla esasperazione dei caratteri e delle situazioni, e anche quando non è apertamente volgare è comunque sempre urlata.
L’’umorismo inglese è invece contenuto e distaccato: non esaspera le situazioni, ma le legge anzi sottotono, e si esercita prima di tutto sul narratore stesso (Jerome in questo è un maestro). Non è mosso dal sentimento pirandelliano del contrario, ma da quello del bizzarro. Il contrario lo si combatte, sul bizzarro si ironizza, al più si fa del sarcasmo. Mentre da noi Garibaldi voleva impiccare tutti i preti e con le budella dell’ultimo il papa, il lord cancelliere Disraeli, a proposito del suo più accanito avversario, diceva: “Se il signor Gladstone cadesse nel Tamigi sarebbe una disgrazia, ma se qualcuno lo riportasse a riva salvo sarebbe una calamità”. Questo intendo: fossi stato Gladstone, prima di cominciare a pensare a come ribattere avrei sorriso, e probabilmente lui lo ha fatto.
Non so cosa abbia poi risposto.

da: Thalatta! Thalatta! (2024)
 Ho sempre nutrito una grande ammirazione per lo spirito inglese, a dispetto di quanto ne dice mia figlia, che vive sull’isola, ne è cittadina, ma non ha dei suoi connazionali una grande opinione. La mia ammirazione ha una matrice letteraria, senz’altro, perché la letteratura inglese è quella cui ho maggiormente attinto sin da ragazzo e che ha alimentato alla grande la mia fame giovanile di viaggi e di avventura. Il riferimento obbligato in questo caso è naturalmente Stevenson. “Per un ragazzo di dodici anni traversare la Manica è come cambiare cielo; per un uomo di ventiquattro traversare l’Atlantico significa appena un lieve cambiamento di alimentazione. Ma io ero ormai uscito fuori dall’ombra dell’Impero Romano, che ci ha dominato dalla culla con le rovine dei suoi monumenti, le cui leggi e la cui letteratura ci assediano da ogni parte, piene di divieti e di costrizioni.” Schmitt avrebbe visto in queste parole una conferma della sua analisi.
Ho sempre nutrito una grande ammirazione per lo spirito inglese, a dispetto di quanto ne dice mia figlia, che vive sull’isola, ne è cittadina, ma non ha dei suoi connazionali una grande opinione. La mia ammirazione ha una matrice letteraria, senz’altro, perché la letteratura inglese è quella cui ho maggiormente attinto sin da ragazzo e che ha alimentato alla grande la mia fame giovanile di viaggi e di avventura. Il riferimento obbligato in questo caso è naturalmente Stevenson. “Per un ragazzo di dodici anni traversare la Manica è come cambiare cielo; per un uomo di ventiquattro traversare l’Atlantico significa appena un lieve cambiamento di alimentazione. Ma io ero ormai uscito fuori dall’ombra dell’Impero Romano, che ci ha dominato dalla culla con le rovine dei suoi monumenti, le cui leggi e la cui letteratura ci assediano da ogni parte, piene di divieti e di costrizioni.” Schmitt avrebbe visto in queste parole una conferma della sua analisi.
 Naturalmente parlo dell’Inghilterra di ieri, o perlomeno dell’immagine di sé che quel paese fino a ieri riusciva a trasmettere. Mi son fatto l’idea (e quando mi faccio un’idea rimane ben radicata) che quello inglese sia un popolo che ha saputo mediare tra la volontà di fuga e di rottura e l’attaccamento alla terra e alle convenzioni. Ha attraversato gli oceani non per dimenticare la sua isola, ma per espanderla, per portarne un pezzo altrove, e magari per rigenerarla. Credo anche che il suo rapporto col mare sia stato in gran parte determinato dalle condizioni di temperatura e di violenza di quest’ultimo. Il mare inglese, lo dico per esperienza diretta, non è fatto per starci ammollo ma per essere affrontato: le sue onde, le sue correnti e le sue maree vanno conosciute e rispettate. Conrad ne era consapevole, tanto da scrivere che “Il mare non è mai stato amico dell’uomo. Tutt’al più è stato complice della sua irrequietezza”. Ma questo non implica un rifiuto, anzi: “Scoprii quanto ero uomo di mare, nel cuore, nella mente e, per così dire, nel corpo: un uomo esclusivamente di mare e di navi; il mare, l’unico mondo che contasse, e le navi, un banco di prova di virilità, di carattere, di coraggio, di fedeltà e d’amore”. Anche qui mi riconosco.
Naturalmente parlo dell’Inghilterra di ieri, o perlomeno dell’immagine di sé che quel paese fino a ieri riusciva a trasmettere. Mi son fatto l’idea (e quando mi faccio un’idea rimane ben radicata) che quello inglese sia un popolo che ha saputo mediare tra la volontà di fuga e di rottura e l’attaccamento alla terra e alle convenzioni. Ha attraversato gli oceani non per dimenticare la sua isola, ma per espanderla, per portarne un pezzo altrove, e magari per rigenerarla. Credo anche che il suo rapporto col mare sia stato in gran parte determinato dalle condizioni di temperatura e di violenza di quest’ultimo. Il mare inglese, lo dico per esperienza diretta, non è fatto per starci ammollo ma per essere affrontato: le sue onde, le sue correnti e le sue maree vanno conosciute e rispettate. Conrad ne era consapevole, tanto da scrivere che “Il mare non è mai stato amico dell’uomo. Tutt’al più è stato complice della sua irrequietezza”. Ma questo non implica un rifiuto, anzi: “Scoprii quanto ero uomo di mare, nel cuore, nella mente e, per così dire, nel corpo: un uomo esclusivamente di mare e di navi; il mare, l’unico mondo che contasse, e le navi, un banco di prova di virilità, di carattere, di coraggio, di fedeltà e d’amore”. Anche qui mi riconosco.

dai: Carteggi a Lucia Barba (2018)
[…] Sono nuovamente reduce dall’Inghilterra, dove ho trascorso le feste con la mia figlia maggiore (c’erano anche Elisa e Mara), e mi viene di buttare lì alcune considerazioni spicciole. Intanto gli inglesi sentono le feste molto più di noi. Per essere un paese protestante, non l’avrei pensato. Ma devo dirla meglio: non è che festeggino di più, “sentono” proprio di più. Non si limitano alla compulsione da shopping pre-natalizio o da saldi post-epifania: cercano davvero di credere che le feste abbiano un significato interiore, e non solo vacanziero. Quanto poi ci riescano non lo so, ma almeno ci provano. È difficile spiegare da cosa lo si percepisca, è un’aura particolare che non ricordavo più e ho invece ritrovato passeggiando nel parco di Bournemouth e nelle vie del centro, o osservando gli amici di Chiara che passavano in visita. Non capivo nulla di quello che dicevano, ma sentivo che lo dicevano bene.
Forse riesco a farmi intendere meglio raccontandoti della programmazione televisiva. Nel pomeriggio di Natale il canale principale della BBC trasmetteva Sette spose per sette fratelli, che non rivedevo da quasi sessant’anni e che è davvero il capolavoro che ricordavo. La sera un documentario sulla Lapponia di due ore, il viaggio di due donne e tre slitte trainate da renne lungo una sterminata pianura innevata, macchiata solo qua e là da qualche albero, nella penombra della giornata boreale. Il tutto filmato in tempo reale, con immagini che arrivavano alternativamente da una camera fissa puntata sulla schiena della prima donna e su una chiappa della renna e da un’altra camera puntata sulla slitta di coda, sulla quale sedeva la seconda donna. Nessun commento musicale, nessuno scambio di parole tra le due, solo un brevissimo dialogo (in làppone, che somiglia all’abbaiare di un cane) a metà, quando arriva il momento di accendere le torce per proseguire. Nel primo quarto d’ora sono rimasto esterrefatto, credevo ad uno scherzo. Poi non ho potuto cambiare canale perché Elisa va matta per queste cose e ha sequestrato il telecomando. Infine, poco a poco, tutti abbiamo cessato di mugugnare e borbottare e fare dell’ironia, siamo come saliti sulle slitte e abbiamo atteso di arrivare, sempre nel silenzio totale, o meglio, col solo rumore dei pattini sulla neve.
Non so quanto posso aver reso l’idea, ma è stato bellissimo, incredibilmente natalizio, per come intendo io il natalizio. Mi obietterai che si tratta pur sempre di televisione, e che evidentemente i programmatori inglesi sono un po’ più furbi dei nostri. Ma è proprio questo che volevo dire. I programmatori televisivi sono probabilmente furbi né più né meno dei nostri, e quindi danno al pubblico quello che pensano il pubblico si aspetti: e il pubblico inglese si aspetta quelle cose, le sette spose e il viaggio nella tundra, anziché le vacanze di De Sica sulla neve, e questo vorrà pur dire qualcosa.
Intendiamoci, non sono un esterofilo da diporto. Non credo che gli inglesi, o i francesi, o i tedeschi, presi singolarmente, come individui, siano meglio di noi. Mia figlia poi me ne fa dei quadri ben poco edificanti. E tuttavia, non posso, ogni volta che valico le Alpi, non venire via col magone, al constatare quanto poco basterebbe per essere anche noi civili, e come quel poco non ci sia verso di ottenerlo. Che c’entra questo col Natale?, mi dirai. C’entra eccome. Perché è un discorso di sensibilità. Sette spose per sette fratelli è uno spettacolo che ancora oggi può tenere unite, strette sul divano, tre generazioni. Ci fosse stato mio nipote, l’avrebbe visto anche lui, invece di rintanarsi in un angolo a giocare con lo smartphone. E magari si sarebbe divertito anche con le renne.
Qui immagino invece un cicaleccio ininterrotto di cretini a gettone, ospiti a turno in tutti i diversi studi, o la sessantesima replica annuale dei film di Totò, a fare da sfondo alla delusione per i regali inutili e pacchiani ricevuti e al rammarico per averli contraccambiati al rialzo. Stiamo smarrendo la sensibilità, e questo è un fenomeno collettivo, prima e oltre che individuale. Là almeno sembra solo individuale, e il collettivo cerca di metterci una pezza. Mi spiego meglio. Il giorno dopo siamo usciti per un giro nei dintorni: che sono una splendida sorpresa. Lasciamo andare i paesaggi naturali, le fantastiche falesie, per le quali gli inglesi non hanno alcun merito, se non quello di non aver lasciato costruire per un chilometro almeno all’interno (ed è comunque già qualcosa). Ci imbattiamo ad un certo punto nei ruderi di un antico castello normanno (il Corfe Castle): dico ruderi ma è una costruzione imponente, che abbraccia un’intera collina. Ai piedi c’è un minuscolo villaggio, nato per ospitare chi lavorava all’edificazione del castello, quindi mille anni fa, e rimasto praticamente intatto: voglio dire che le case e la chiesa e le locande, malgrado il villaggio abbia continuato ininterrottamente ad essere abitato, sono state conservate per tutto questo tempo nella loro struttura originaria. Conservate, e non restaurate da una qualche soprintendenza che odia gli intonaci, anche quelli originali, o adempiendo a una normativa che impone comunque due metri e ottanta per i soffitti, e impianti a norma, e tutte quelle cagate lì. I soffitti sono alti quanto un uomo medio, e se sei un po’ fuori misura dopo un paio di capocciate ti adegui. Lo stesso vale per le strade, a doppio senso ma larghe quanto un’auto, così non si devono neppure indicare i limiti di velocità, si impongono da soli.
A questo mi riferisco, al fatto che un po’ di regole questa gente le ha introiettate, con le buone o con le cattive, e adesso non le subisce, ma le sente sue, a dispetto della maggiore o minore credibilità di chi le ha dettate e di chi è deputato oggi a farle rispettare. Questo significa, in linea di massima e almeno per ora, sentirsi responsabilmente coinvolti.

dai: Carteggi a Mario Mantelli (2018)
[…] Il mio, di resoconto, te lo anticipo invece, almeno in parte, per iscritto. Sono stato nei luoghi di Wordsworth, di Coleridge, di De Quincey e di Ruskin, nel Distretto dei Laghi insomma, e a dispetto di un colpo d’aria da low coast che mi ha lasciato rigido come un busto romano per tutto il viaggio ho ammirato uno dei luoghi più belli del mondo. Talmente bello da essere alla lunga insopportabile, credo, e questo spiegherebbe perché i suoi illustri abitatori non facessero altro che camminare in lungo e in largo, anche se alcuni solo nelle pause concesse dall’oppio. Ma di questo riparleremo.
Quella che voglio invece trasmetterti a caldo è un’impressione che non ha atteso certo il viaggio per nascere, ma che dal viaggio è stata decisamente e definitivamente confermata. Siamo un paese allo sfacelo, anzi, nemmeno siamo più un paese, siamo solo lo sfacelo. Fino ad ora, a dispetto del disgusto crescente avevo in qualche modo continuato a truccare le carte, trincerandomi dietro paragoni tutt’altro che significativi (gli ultimi viaggi li avevo fatti in Grecia e in Turchia, e già rispetto a quest’ultima il passivo era pesante). Ma appena sali oltre il quarantaseiesimo parallelo la verità è lì, evidente, spietata: stai attraversando un paese, stai incontrando un popolo, sei tra gente che in maniera più o meno fredda o anche rozza ha comunque introiettato l’idea di un qualcosa che appartiene a tutti, non nel senso italiano che tutti possono rubarne un pezzo, ma in quello per cui tutti ne sono responsabili. Thackeray in Italia non avrebbe scritto “La fiera delle vanità”, ma quella delle pretese. Un paese dove tutti pretendono e nessuno è mai responsabile e disponibile (non raccontiamoci palle sul fiorire del volontariato e compagnia bella: io parlo di qualcosa di più serio, non della vanità di fare “qualcosa in più”, ma dell’umiltà di fare semplicemente ciò che va fatto, senza attendere ricompense divine o ritorni in autostima).
Tutto questo, mi dirai, come lo percepisce uno che non biascica una parola di inglese? Proprio dal paesaggio. Ti guardi attorno e constati che le cose sono state fatte come dovevano essere fatte, che nulla stona, nemmeno, per dire, le pale eoliche. Le vedi stagliarsi lì, e pensi che prima di piazzarle hanno fatto due conti, di quelli veri, e non gli studi sulla compatibilità con eventuali colonie di chirotteri, non hanno dovuto fronteggiare cariche di integralisti della wilderness a casa altrui, semplicemente hanno usato il buon senso. E le pale sono entrate allora discretamente, senza protervia, nel paesaggio, e ci stanno benissimo. Oppure gli alberghi. Prospiciente il Dove Cottage, la casa di Wordsworth (nove euro per visitarla, nessun rimpianto. Altrettanto per quella di Ruskin, ma li vale solo il giardino) è stato costruito un albergo che a prima vista pare più antico del Cottage stesso. Hanno solo ripreso il modello degli edifici di fine Settecento, e parrebbe persino le tecniche costruttive. È un falso che non disturba affatto, perché senti che non è falso (a differenza dei recuperi nei nostri centri storici). Senza offesa per la categoria, ma verrebbe da dire: beati quei paesi che non hanno bisogno di grandi e innovative scuole architettoniche. Per non parlare poi dei giardini: danno l’idea di una natura appena appena addomesticata, tanto da conviverci: non le fanno indossare una livrea che presto sarà lercia per la trascuratezza di chi dovrebbe occuparsene e la preventiva, ma anche conseguente, maleducazione di chi li frequenta. In questo caso le scuole di architettura dei giardini ci sono eccome: ma prima di liberare la creatività educano evidentemente alla disciplina, alla serietà.
Vedi, si prova una sensazione totalmente diversa rispetto a quella suscitata dai luoghi pur bellissimi che ancora esistono, a dispetto di tutto, da noi: ti accorgi che gli inglesi queste cose non le esibiscono sfacciatamente (anche se paghi persino l’aria che respiri) ma le concedono, bontà loro e con riservata sufficienza, al tuo sguardo. Tu paghi, ma non hai mai l’impressione di quella smaccata e onnipresente marchetta che ti porti dietro dalle nostre parti. Per dirne ancora un’altra, prendiamo le feste di paese: là sono fatte dai e per i paesani, se passi di lì hai diritto a una o più birre, ma poi togliti dai piedi o stattene da una parte, perché non sei tu il destinatario di quei balli e di quelle musiche.
Insomma, la mia anglofilia è nuovamente esplosa. Ho perfettamente presente la spocchia degli inglesi, non sono un affezionato da diporto alla famiglia reale, ma non mi è mai capitato di pensare “Che bello questo paese: peccato che ci siano gli inglesi”, come invece mi capita quotidianamente da noi, e come pensava Jack Nicholson dell’America in Easy Ryder. Anzi, penso che l’Inghilterra sia bella proprio perché ci sono gli inglesi, che l’hanno fatta (perché di quella originale credo ci sia quasi più nulla) così.
dai: Carteggi da Vittorio Righini (agosto 2018)
Ho letto Barnaby, con piacere. Ricordo che l’ho visto, per intero, una volta sola, per il resto quando iniziava una puntata cambiavo canale. Il motivo è presto detto: io sono stato traumatizzato da Doc Martin, e ogni volta che comincia un telefilm (una volta li chiamavamo così) che si ambienta in Inghilterra con facce, panorami e colori di ripresa totalmente inglesi, vado in paranoia. Io mi auguro tu non abbia mai visto la serie di Doc Martin, e se lo hai fatto male te ne incorrerà! Se non l’hai fatto, ti spiego di cosa si tratta: Doc Martin è un medico chirurgo inglese, che siccome soffre alla vista del sangue, con scene di panico, vomito, fughe e altro, si è trasferito in un tranquillo villaggio di mare della Cornovaglia del nord. Lui è alto, bruttissimo, con due orecchie alla Dumbo, ed è la persona più antipatica che uno possa temere di avere soprattutto come medico, ma ha indubbie capacità nel suo lavoro. Il villaggio, invece di essere bello e attraente, non lo è affatto. Gli abitanti del villaggio hanno una media neuronica, cadauno, inferiore a due. Rarissime eccezioni. L’unico poliziotto è cerebro-leso. Il piccolo basso ciccione che gestisce l’unico ristorante (dopo aver fatto malamente l’idraulico per tutta la vita), è il paziente ideale per un buon vecchio manicomio, e cucina schifezze incommensurabili. La segretaria di Doc Martin sembra scesa dal pianeta delle scimmie, mentre la farmacista sembra uscita da un romanzo dell’orrore. I bambini sono tutti cattivi, rognosi, malaticci e pieni di paturnie.
Quindi, ti chiederai: ma perché lo guardi? non lo so, l’ho guardato per una decina di puntate, poi, come con la grappa, mi sono detto basta: il primo mi rende demente, la seconda mi dà troppa acidità di stomaco. Ma la mia rinuncia (a Doc Martin, non alla grappa), si è concretizzata solo pochi mesi addietro, allora non sono ancora del tutto disintossicato. Capisco perché mentre noi (con tutto il mare di difetti che abbiamo) costruivamo il Colosseo, loro si tingevano la faccia di blu. Ho anche pensato con ammirazione a Mario Appelius… e per tirarmi fuori dalle sabbie mobili prendevo in mano Sir Patrick, Robert Byron, Dalrimple, Hopkirk, Gerald Russell, i fratelli Durrell e così via, e ristabilivo i contatti con una nazione (pardon, un Regno), che, circa una volta all’anno, mi vede curioso viaggiatore al suo interno. Mi dirai: non sono mica tutti ebeti come quelli del villaggio di Doc Martin! certo, ma una gran parte del pubblico inglese è quello che vuole vedere, i suoi simili, temo. In Fantozzi lo sfigato è lui, mica il mega direttore galattico Balambam, e nemmeno la Sig.na Silvani o il Geom. Calboni sono idioti. Noi godiamo dei casini di uno sfigato, non del villaggio intero di smidollati. E questa differenza mi fa pensare, giuro. Tu, con la tua cultura enciclopedica, potresti meglio spiegare l’arcano.
L’uomo non mangiato dallo squalo.
dai: Carteggi a Vittorio Righini (2018)
Sono stato affetto anch’io dalla sindrome meridiana di Doc Martin. Era tassativo non perderne una puntata, e ancora oggi non mi capacito del perché. È rimasto uno dei grandi interrogativi della mia vita – ti lascio immaginare gli altri –, perché francamente era difficile identificarsi nel personaggio, o sognare di vivere a Portwenn (anche se adoro la Cornovaglia). Non so, forse sotto sotto il messaggio che si recepiva è che c’è speranza per tutti, anche per i meno adatti: e la cosa funzionava perché il protagonista era immerso in un mondo dove tutti o quasi erano dei disadattati. Mia figlia, che in Inghilterra abita ormai da quindici anni ed è anche cittadina inglese, assicura che la realtà è Portwenn, non Midsomer, e che in Doc Martin se ne vede solo il lato buono. Ma non è attendibile, perché è una donna in carriera e i suoi competitor sono tutti inglesi. In effetti, però, se ripenso alle amene disavventure che mi sono occorse nell’ultimo viaggio inglese, un paio di anni fa, nel distretto dei laghi (ubriachi che si manifestano in camera, completamente nudi, alle tre di notte – colpa mia, perché ho il maledetto vizio di non chiudere mai la porta, nemmeno quando sono in giro), battellieri non perfettamente sobri che litigano via radio coi colleghi o con la moglie e invertono la rotta di colpo, ecc…), devo ammettere che un po’ di ragione ce l’ha. Ma la cosa strana è che queste cose, che in Italia e sul continente mi farebbero incazzare a morte, lì mi paiono note di colore. Potenza della letteratura. Hanno saputo vendersi molto bene, da Shakespeare in poi, e ci hanno indotto una soggezione culturale. L’esatto contrario di quanto accade con gli americani. E ti dirò di più: è una sudditanza che mi piace, come in fondo mi piaceva Doc Martin. Varrà la pena tornarci un po’ su. Al più presto.
****
Bene, a questo punto penso che dell’Inghilterra, di quella mia, ne avrete sin sopra i capelli. Posso capirvi, ma questo non cambia una virgola di tutto ciò che ho proposto. Ci tenevo da un pezzo ad un’operazione del genere, e ho dovuto contenermi per non renderla ancora più pesante. Ora di questi materiali potete fare due usi differenti: dimenticarli il più rapidamente possibile o metterli a confronto col vostro sentire rispetto alla cultura inglese. Non trarrete alcuna utilità dal farlo, ma potreste anche divertirvi.





 È una costruzione imponente, tre piani che vanno calcolati con le misure di un tempo, quindi alta ad occhio e croce almeno una dozzina di metri. Ma non è facile farsi un’idea globale delle dimensioni, perché l’edificio non è mai visibile da una sufficiente distanza. Dall’esterno della macchia risulta totalmente nascosto, malgrado l’altezza, dalle piante secolari che lo circondano. Quando si è dentro lo si può guardare solo dal basso. Non riesco a valutare lo stato del tetto, ma i muri perimetrali sono tutti ancora in piedi, e non si vedono crepe. Persino l’intonaco regge, tranne in qualche punto sulla facciata che guarda a settentrione e nel cornicione che aggetta. Tutto il resto, naturalmente, le cornici in muratura degli infissi e i fregi e gli infissi stessi, è in totale rovina. La costruzione è forse databile agli inizi del secolo scorso, magari anche alla fine di quello precedente: lo stile sta tra il Liberty e l’Art Dèco.
È una costruzione imponente, tre piani che vanno calcolati con le misure di un tempo, quindi alta ad occhio e croce almeno una dozzina di metri. Ma non è facile farsi un’idea globale delle dimensioni, perché l’edificio non è mai visibile da una sufficiente distanza. Dall’esterno della macchia risulta totalmente nascosto, malgrado l’altezza, dalle piante secolari che lo circondano. Quando si è dentro lo si può guardare solo dal basso. Non riesco a valutare lo stato del tetto, ma i muri perimetrali sono tutti ancora in piedi, e non si vedono crepe. Persino l’intonaco regge, tranne in qualche punto sulla facciata che guarda a settentrione e nel cornicione che aggetta. Tutto il resto, naturalmente, le cornici in muratura degli infissi e i fregi e gli infissi stessi, è in totale rovina. La costruzione è forse databile agli inizi del secolo scorso, magari anche alla fine di quello precedente: lo stile sta tra il Liberty e l’Art Dèco. Bell’edificio triste inabitato!
Bell’edificio triste inabitato! Non ci avventuriamo ai piani superiori perché anche le scale sono fatiscenti, una grossa crepa taglia a metà il primo pianerottolo. Meno che mai osiamo scendere in un buio piano interrato, dove non arriva luce da nessuna apertura. In realtà non credo sia poi così pericoloso, ma l’impressione è che ci si debba muovere con tutta la delicatezza possibile, per non contribuire ad accelerare lo sfascio. È una casa che incute un certo rispetto.
Non ci avventuriamo ai piani superiori perché anche le scale sono fatiscenti, una grossa crepa taglia a metà il primo pianerottolo. Meno che mai osiamo scendere in un buio piano interrato, dove non arriva luce da nessuna apertura. In realtà non credo sia poi così pericoloso, ma l’impressione è che ci si debba muovere con tutta la delicatezza possibile, per non contribuire ad accelerare lo sfascio. È una casa che incute un certo rispetto. vera e propria sindrome, che rasenta l’autismo: ovunque vada sono immediatamente colpito da quel che è fuori posto, che potrebbe essere migliorato, sistemato, recuperato (così come mi irrita profondamente, nelle persone, ogni comportamento caciarone e scomposto). Una volta a casa di un amico ho rimesso in piedi tutta una serie di anfore abbattute sparse per il giardino, per poi scoprire che erano state messe così ad arte (il senso devo ancora capirlo oggi). Dopo aver restaurato e ridipinto i settanta metri di staccionata che chiudono il giardino di mia figlia a Bournemouth, mi aggiravo per la città a verificare quante altre staccionate avrebbero avuto bisogno di un sano intervento (e sarei stato disposto ad operarlo gratis). Insomma, è una malattia, che però non si limita a un decorso passivo, ma a modo suo mi rende immediatamente operativo.
vera e propria sindrome, che rasenta l’autismo: ovunque vada sono immediatamente colpito da quel che è fuori posto, che potrebbe essere migliorato, sistemato, recuperato (così come mi irrita profondamente, nelle persone, ogni comportamento caciarone e scomposto). Una volta a casa di un amico ho rimesso in piedi tutta una serie di anfore abbattute sparse per il giardino, per poi scoprire che erano state messe così ad arte (il senso devo ancora capirlo oggi). Dopo aver restaurato e ridipinto i settanta metri di staccionata che chiudono il giardino di mia figlia a Bournemouth, mi aggiravo per la città a verificare quante altre staccionate avrebbero avuto bisogno di un sano intervento (e sarei stato disposto ad operarlo gratis). Insomma, è una malattia, che però non si limita a un decorso passivo, ma a modo suo mi rende immediatamente operativo. Anche in questo caso finisco subito a realizzare che si potrebbe intervenire qui, rinforzare là, recuperare materiali, ripristinare. Cerco di figurarmi come potrebbero essere i locali una volta restaurati, e come sarebbe possibile farlo con interventi minimi, puramente conservativi. Mentre Stefano continua a raccogliere immagini, ogni tanto coinvolgendomi anche, comincio a fare mentalmente i conti: un tot a metro per il tetto e per gli intonaci, un calcolo approssimativo per le decorazioni esterne e per gli infissi, una bella botta per il ripristino degli interni. Siamo, molto all’ingrosso, nell’ordine del milione di euro. E questo a condizione di mettere all’opera gente seria, ad esempio i muratori con i quali ho lavorato, fino a pochissimi anni fa, per recuperare la mia casa. Altrimenti la cifra raddoppierebbe, e il risultato sarebbe disastroso. Il tutto naturalmente evitando ogni intromissione delle varie sovrintendenze e degli svariati e altrettanto inutili altri organismi di controllo, oggi tranquillamente indifferenti davanti al fatto che un edifico del genere vada allo sfascio, ma che domani, casomai un folle decidesse di metterci mano, interverrebbero di corsa a imporgli i vincoli più stupidi e le direttive più insensate.
Anche in questo caso finisco subito a realizzare che si potrebbe intervenire qui, rinforzare là, recuperare materiali, ripristinare. Cerco di figurarmi come potrebbero essere i locali una volta restaurati, e come sarebbe possibile farlo con interventi minimi, puramente conservativi. Mentre Stefano continua a raccogliere immagini, ogni tanto coinvolgendomi anche, comincio a fare mentalmente i conti: un tot a metro per il tetto e per gli intonaci, un calcolo approssimativo per le decorazioni esterne e per gli infissi, una bella botta per il ripristino degli interni. Siamo, molto all’ingrosso, nell’ordine del milione di euro. E questo a condizione di mettere all’opera gente seria, ad esempio i muratori con i quali ho lavorato, fino a pochissimi anni fa, per recuperare la mia casa. Altrimenti la cifra raddoppierebbe, e il risultato sarebbe disastroso. Il tutto naturalmente evitando ogni intromissione delle varie sovrintendenze e degli svariati e altrettanto inutili altri organismi di controllo, oggi tranquillamente indifferenti davanti al fatto che un edifico del genere vada allo sfascio, ma che domani, casomai un folle decidesse di metterci mano, interverrebbero di corsa a imporgli i vincoli più stupidi e le direttive più insensate.
 Anche quello che ipotizzo io è però un investimento che dà risposte concrete e immediate, oltre ad aprire a quelle a lungo termine. Attivando cantieri per diecimila interventi di recupero di questo tipo si creerebbero come minimo centomila posti di lavoro nel settore edilizio e si metterebbe in moto indirettamente un indotto che ne vale altrettanti. Una volta chiusi i cantieri, rimarrebbero attivi almeno ventimila posti per le attività di manutenzione e valorizzazione di quanto già recuperato, mentre potrebbero partire ulteriori progetti di risanamento “culturale”. Queste attività, se minimamente coordinate e inserite in circuito con altre forme di “offerta” (da quelle gastronomiche a quelle enologiche, dall’escursionismo alle più svariate pratiche di fitness, ci sta di tutto), una volta avviate potrebbero raggiungere facilmente l’autonomia finanziaria. A dispetto della nostra colpevole negligenza siamo ancora un paese ad altissima attrattiva turistica anche nel campo della cultura, e con uno sforzo intelligentemente mirato potremmo offrire quei percorsi alternativi ai grandi eventi, alle mostre-monstre, agli intruppamenti obbligati, che vengono invocati ogni volta che le nostre città d’arte arrivano al collasso, ma per i quali non è mai stato pensato alcun progetto serio.
Anche quello che ipotizzo io è però un investimento che dà risposte concrete e immediate, oltre ad aprire a quelle a lungo termine. Attivando cantieri per diecimila interventi di recupero di questo tipo si creerebbero come minimo centomila posti di lavoro nel settore edilizio e si metterebbe in moto indirettamente un indotto che ne vale altrettanti. Una volta chiusi i cantieri, rimarrebbero attivi almeno ventimila posti per le attività di manutenzione e valorizzazione di quanto già recuperato, mentre potrebbero partire ulteriori progetti di risanamento “culturale”. Queste attività, se minimamente coordinate e inserite in circuito con altre forme di “offerta” (da quelle gastronomiche a quelle enologiche, dall’escursionismo alle più svariate pratiche di fitness, ci sta di tutto), una volta avviate potrebbero raggiungere facilmente l’autonomia finanziaria. A dispetto della nostra colpevole negligenza siamo ancora un paese ad altissima attrattiva turistica anche nel campo della cultura, e con uno sforzo intelligentemente mirato potremmo offrire quei percorsi alternativi ai grandi eventi, alle mostre-monstre, agli intruppamenti obbligati, che vengono invocati ogni volta che le nostre città d’arte arrivano al collasso, ma per i quali non è mai stato pensato alcun progetto serio. Ora, mi si farà notare, tutta questa gente va comunque da subito pagata. Appunto. Ricordo che stiamo parlando di un settore nel quale da molto prima del covid una buona metà degli addetti stazionava in cassa integrazione, e la quota è aumentata con la pandemia; quindi si tratta in realtà di gente già pagata con soldi pubblici, e senza alcuna contropartita. Lo stesso vale naturalmente per i percettori del reddito di cittadinanza. Ci sono poi anche le spese per i materiali: ma teniamo presenti le sovvenzioni “di ristoro” che lo stato elargisce alle aziende messe in crisi dalla pandemia e dalle misure restrittive: con le stesse cifre si potrebbe acquisire già gran parte del fabbisogno. Anche in questo caso, sarebbero soldi destinati in parte a rientrare nelle casse dello stato e dell’ente previdenziale, sotto forma di imposte e di contributi. Rimane il tema scottante del tipo di occupazione offerta. Ma mi sembra sia giunta l’ora di mettere in chiaro come girano le cose. Non siamo in grado di creare “posti di lavoro” rispondenti a tutte le aspettative, siamo solo in grado di creare occasioni di lavoro, e dovremmo semmai poi assicurarci che questo si svolga in sicurezza, che sia adeguatamente retribuito, che crei a sua volta professionalità e conferisca quindi dignità. Non ha senso opporre che i nostri giovani, o anche i meno giovani, non sono “preparati” per questi tipi di attività. Nemmeno chi sbarca sulle nostre coste o arriva dall’est nel nostro paese è preparato, ma non tarda ad adeguarsi. Impareranno, e questo sarà per loro un valore aggiunto, oltre al fatto di guadagnarsi uno stipendio e poter fare progetti per il futuro. Se invece per quei duecentomila posti dovremo reclutare polacchi o senegalesi, ben venga allora anche l’immigrazione clandestina.
Ora, mi si farà notare, tutta questa gente va comunque da subito pagata. Appunto. Ricordo che stiamo parlando di un settore nel quale da molto prima del covid una buona metà degli addetti stazionava in cassa integrazione, e la quota è aumentata con la pandemia; quindi si tratta in realtà di gente già pagata con soldi pubblici, e senza alcuna contropartita. Lo stesso vale naturalmente per i percettori del reddito di cittadinanza. Ci sono poi anche le spese per i materiali: ma teniamo presenti le sovvenzioni “di ristoro” che lo stato elargisce alle aziende messe in crisi dalla pandemia e dalle misure restrittive: con le stesse cifre si potrebbe acquisire già gran parte del fabbisogno. Anche in questo caso, sarebbero soldi destinati in parte a rientrare nelle casse dello stato e dell’ente previdenziale, sotto forma di imposte e di contributi. Rimane il tema scottante del tipo di occupazione offerta. Ma mi sembra sia giunta l’ora di mettere in chiaro come girano le cose. Non siamo in grado di creare “posti di lavoro” rispondenti a tutte le aspettative, siamo solo in grado di creare occasioni di lavoro, e dovremmo semmai poi assicurarci che questo si svolga in sicurezza, che sia adeguatamente retribuito, che crei a sua volta professionalità e conferisca quindi dignità. Non ha senso opporre che i nostri giovani, o anche i meno giovani, non sono “preparati” per questi tipi di attività. Nemmeno chi sbarca sulle nostre coste o arriva dall’est nel nostro paese è preparato, ma non tarda ad adeguarsi. Impareranno, e questo sarà per loro un valore aggiunto, oltre al fatto di guadagnarsi uno stipendio e poter fare progetti per il futuro. Se invece per quei duecentomila posti dovremo reclutare polacchi o senegalesi, ben venga allora anche l’immigrazione clandestina.


 Confesso che non mi ero mai soffermato a decrittare l’allegoria racchiusa in questa immagine, mi accontentavo dell’interpretazione più immediata e superficiale. La verità è che non riuscivo affatto a scorgerci tutto quello che Benjamin sembra vedere, e non mi rendevo conto che era lui quello da decrittare, e non Paul Klee. Anche perché il quadro era suo, l’aveva voluto fortissimamente e acquistato, l’ha portato con sé in tutte le sue peregrinazioni, sino all’ultimo, e aveva tutti i diritti di leggerlo come voleva. Forse la passeggiata di ieri mi ha chiarito le idee, e riesco anch’io a guardarlo con occhi nuovi.
Confesso che non mi ero mai soffermato a decrittare l’allegoria racchiusa in questa immagine, mi accontentavo dell’interpretazione più immediata e superficiale. La verità è che non riuscivo affatto a scorgerci tutto quello che Benjamin sembra vedere, e non mi rendevo conto che era lui quello da decrittare, e non Paul Klee. Anche perché il quadro era suo, l’aveva voluto fortissimamente e acquistato, l’ha portato con sé in tutte le sue peregrinazioni, sino all’ultimo, e aveva tutti i diritti di leggerlo come voleva. Forse la passeggiata di ieri mi ha chiarito le idee, e riesco anch’io a guardarlo con occhi nuovi.
