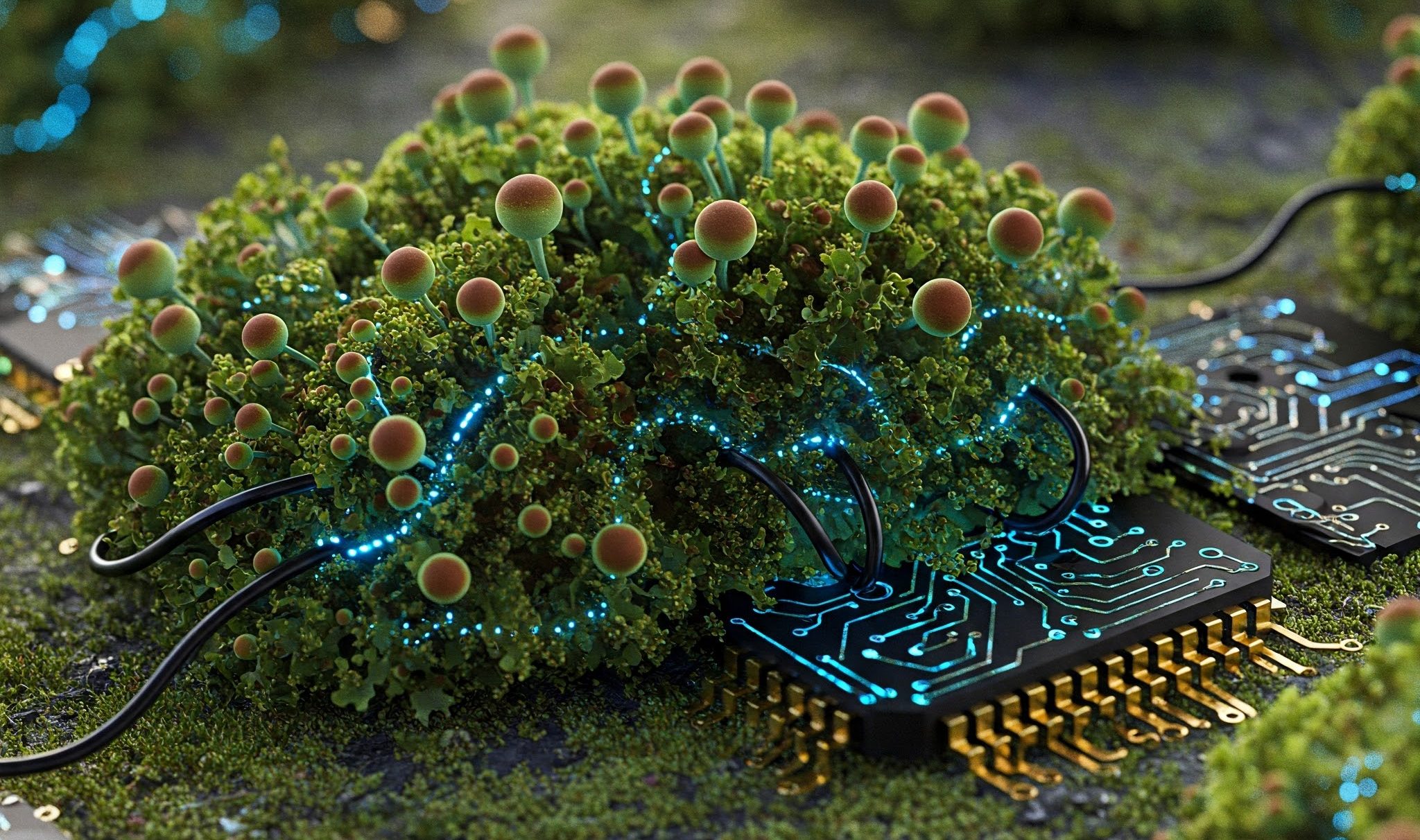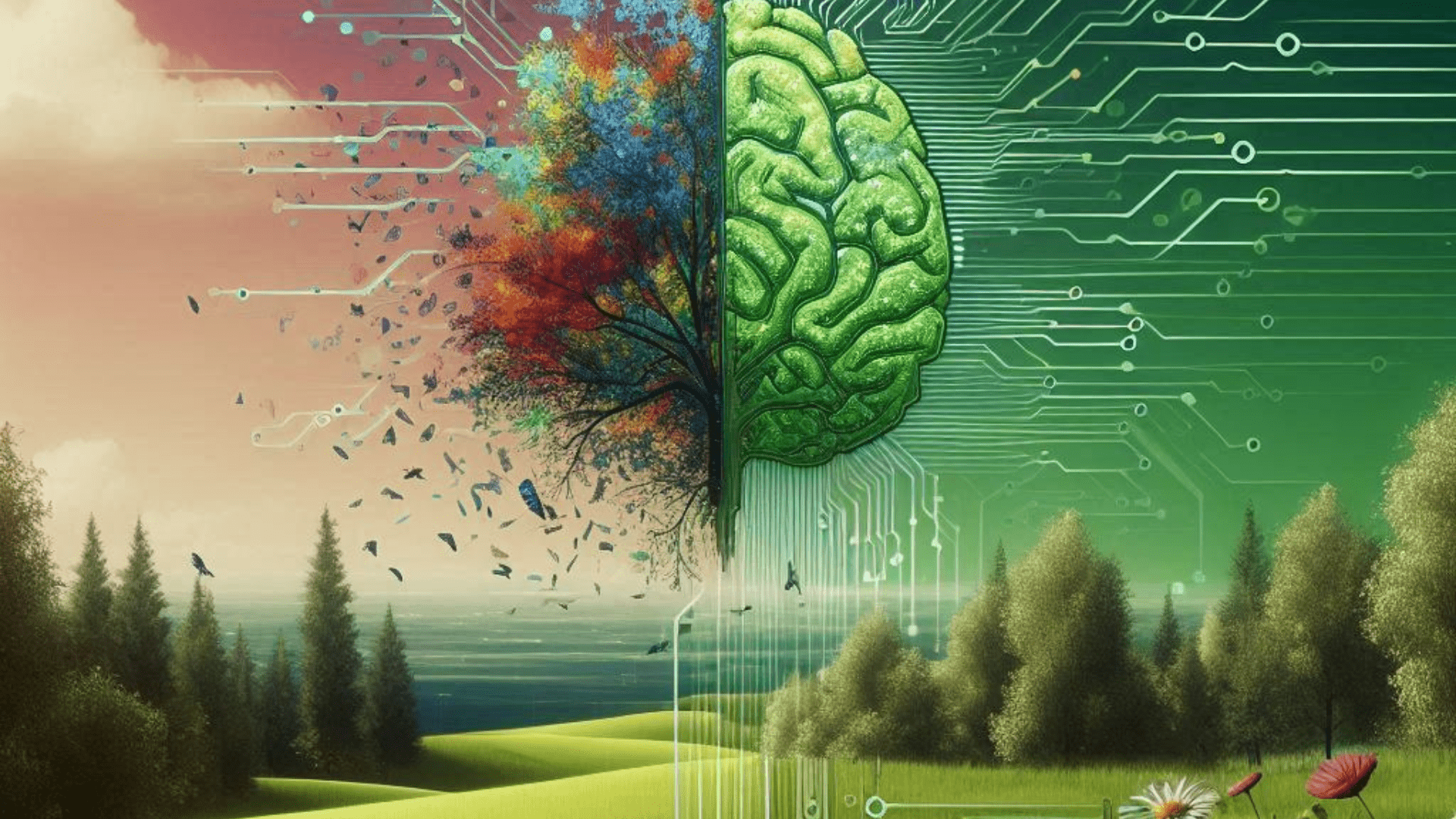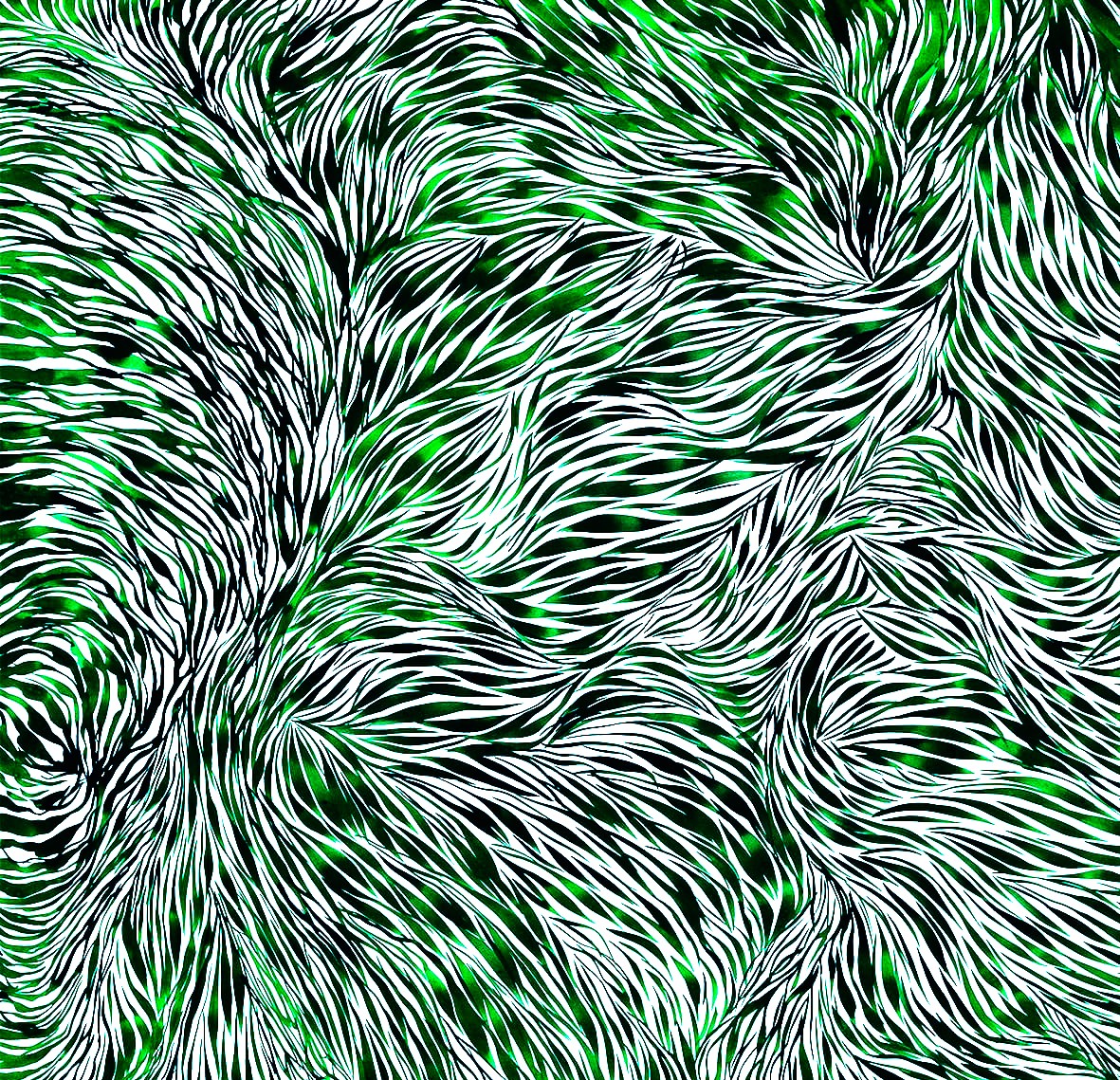diario di una giornata tra funghi e piccole filosofie boschive
di Fabrizio Rinaldi, 14 settembre 2025
Quando lo propongo a mia figlia, lei accetta ad una condizione: “solo se viene anche il nonno”. Una formula che dice tutto: la fiducia riposta in me vacilla, mentre la figura del vecchio resta intatta, nonostante gli ottant’anni passati e un’autorevolezza che neppure gli acciacchi scalfiscono.
Dunque, non ho più scampo: “Andiamo a funghi?”. Ecco di che si tratta: cercare il più prezioso frutto del bosco. Mio padre non ci va da tempo perché consapevole delle sue diminuite capacità fisiche; d’altra parte, non trovo mai il tempo neppure io: il lavoro, la famiglia, le scuse pronte che giustificano l’inerzia. È però scontato che accetterà la proposta: un po’ perché non riuscirebbe a negarsi al “ti prego, ti prego” di mia figlia, un po’ perché – lo leggo dai suoi occhi – ha una voglia matta di andarci, specie da quando ha intuito che quest’anno ce ne dovrebbero essere.
Perché il fungo, lo sappiamo, non si concede facilmente: pioggia al momento giusto, umidità calibrata, terreno adatto (“terra rossa chiama cocone[1]”), distinte specie boschive (castagni, rovere, faggi, …), arbusti di brugo, erba stciapoia[2] e rovi. Un’alchimia rara in un tempo sospeso e incerto, rapido e aleatorio, dove l’attesa, la delusione e la sorpresa, fanno parte dell’esperienza. Cercare funghi è quindi un inno all’imprevedibilità e alla contingenza di un’infinità di condizioni di cui, spesso, non siamo consapevoli, ma che percepiamo quasi istintivamente. A chi li cerca capita di pensare che intorno ad un determinato cespuglio o albero ci saranno sicuramente, mentre nove volte su dieci non c’è nulla; oppure, inaspettatamente, eccoli dove non avresti immaginato.

Appuntamento fissato: sabato, ore sei zero zero, sotto casa dei miei. Missione impossibile: riempire il cavagno d’anveriöi[3].
Metto la sveglia alle 5:20 solo per mia figlia; io non ne avrei bisogno, visto che mi sveglio sempre molto presto (tanto “molto”: 3:30-4:00). A quell’ora neppure i cani si muovono dal loro giaciglio. Il caffè diventa allora il gradito rituale che mi concedo davanti al portatile, nel tentativo — prima del quotidiano andare al lavoro o del frastuono femminile familiare — di ritagliarmi un po’ di tempo per leggere, scrivere o sistemare il sito. A proposito: sto creando le singole pagine dei molti autori che stanno contribuendo al nostro inutile ma caparbio contributo di idee.
Mettiamo nello zaino la borraccia, due felpe e i guanti. Non prendiamo neppure il cavagno, certi che ci penserà mio padre: e comunque non ci facciamo grandi illusioni sul bottino che ci aspetta. Alle sei recuperiamo il nonno. Iris mugugna per la levataccia, ma so che sotto sotto è contenta. E non è la sola.
Destinazione: boh! Il fungo è il Santo Graal del bosco: la geografia dei “posti buoni” si tramanda di generazione in generazione ed esige un’adeguata iniziazione, che prevede ruzzolate fra i rovi e imprecazioni quando non si trova il posto che ci si era prefissati. Oppure si va a casaccio, come è capitato molte volte a mio padre e a me. Posso solo dire che siamo dalle parti del Monte Colma, a Tagliolo Monferrato, ma su quale versante, lungo quale canalone ve li scordate. Altrimenti poi dovrei uccidervi.
Dopo una po’ di chilometri in auto, su strada prima asfaltata e poi sterrata, arriviamo ad uno slargo da cui anni fa eravamo partiti per una ricerca che aveva riservato misere soddisfazioni, pur essendo buone le premesse: boschi di castagno e rovere e sufficiente umidità.
Attraversiamo un prato e ci infiliamo nel bosco. Sono le 6:40, buio pesto. “A chi è venuto in mente di uscire così presto?”, mi chiedo, pur conoscendo la mia responsabilità. Iris si ostina a tenere la torcia del cellulare accesa, mentre noi procediamo a lume di fiducia.
Continuiamo fra i rami e tronchi fino a raggiungere e attraversare un ruscello e, sempre nel semibuio, cominciamo a salire. Già, perché la ricerca del fungo è sempre in salita: nell’attraversare il bosco in quel modo lo sguardo va sempre dal basso verso l’alto, così da intravvedere meglio l’eventuale e ambito gambo. Difficilmente si trovano percorrendo la discesa, accade solo se ce ne sono davvero parecchi. D’altra parte, la salita non si affronta mai in verticale seguendo un sentiero o facendo la diretta (vedi Tobbio), ma in diagonale: si prosegue con piccoli zig zag a salire, passando attorno all’albero, all’arbusto, alle foglie smosse.
“Eccone uno!”, esplode Iris. Ma no, dai è impossibile: è buio, li cerca a casaccio e con la torcia! Invece sì, ha scovato il primo porcino della giornata. La fortuna della principiante … È un po’ mangiucchiato dalle lumache, ma tant’è l’ha trovato.
La logica impone di sminuire i ritrovamenti altrui, così da non intaccare la smania di chi resta a mani vuote. Ma subito dopo, ecco che anche mio padre ne trova due. Io niente. Porca miseria.
Errore madornale da evitare sempre: non parlare ad alta voce se non vuoi che altri fungau arrivino come mosche, ma a quest’ora siamo i soli a cercarli. Più tardi ronzeranno fastidiosi.
L’incontro fra escursionisti nei boschi è normalmente, piacevole e accompagnato da un cordiale saluto, riconosci nell’altro la stessa passione nel camminare e – fra l’altro – l’inconfessato desiderio di esser ricordato qualora ti smarrissi; la persona incontrata potrebbe dare ai soccorritori le indicazioni giuste per il ritrovamento, possibilmente in vita.
In stagione di funghi, invece, il diffidente fungaiolo vede l’altro come invasore del proprio “posto buono”. Il saluto si riduce a un mugugno, seguito dalla menzognera svalutazione del proprio bottino: “poca roba e camulöi[4]; siamo saliti da questo versante e ci spostiamo di là”. Ovviamente non c’è da credere alle indicazioni ricevute. In tali circostanze emerge la gelosa preservazione dei “posti buoni”, anche se la raccolta è stata infruttuosa. Non sia mai che altri scovino l’agognato bottino.
La logica dell’esclusiva appropriazione ricorda i redivivi nazionalismi, la difesa ossessiva delle risorse e della propria (o presunta tale) identità cultura e sociale. Le comunità serrano i confini e pochi individui accumulano privilegi a discapito della moltitudine. Il patrimonio pubblico sottratto al benessere comune, come la giusta posizione della fungaia celata alle attenzioni degli altri, dei foresti. Il micelio, lui che condivide tutto, se fosse in grado di giudicare, riderebbe della nostra meschina avidità.

Tornando allo stare nel bosco di notte, a nessuno è venuto in mente che eravamo i soli nel bosco fitto e praticamente buio. Un aspetto che, in situazioni differenti, avrebbe sicuramente spaventato mia figlia. Sarà la sicurezza nei gesti del nonno, sarà il procedere con tranquillità nella boscaglia, sarà l’obiettivo ben chiaro, ma nessuno è stato sfiorato dal timore di inoltrarci in un territorio sconosciuto e senza la possibilità di chiedere aiuto in caso di difficoltà, tantomeno Iris. È il potere che conferisce l’avere la finalità da perseguire ben chiara e la motivazione alta. E, non ultimo, il piacere di cominciare a trovarli. Pure io!
La luce lentamente rischiara e finalmente Iris ripone il cellulare che usava come torcia per immergersi nella ricerca del porcino, il quale si mimetizza fra le foglie meglio dei Navy SEAL.
Iris finalmente la smette di commentare ogni cespuglio e tace: pure lei è in modalità fungaiola. E ne trova, anzi ne troviamo tutti. Dopo i primi, s’innesca la caccia insaziabile che fa macinare chilometri senza sentire la stanchezza. La voglia è compulsiva; scatta la febbre dell’accumulo, pure di quelli divorati da lumache o altri animali. L’appagamento non si placa neppure quando il cavagno è pieno. Mi tocca tirar fuori la borsa di fortuna che avevo portato per scaramanzia.
Tutti e tre proseguiamo salendo in quello stato di quasi trance che s’innesca quando si comincia a scovarne un po’: si prosegue guardinghi; si passa da una parte e dall’altra dell’albero; si alzano piano le foglie; si segue l’odore come un segugio; si interpreta l’ombra e la lama di luce che supera la barriera della chioma per raggiungere proprio quel rigonfiamento che cela, forse, l’agognato porcino; in sintesi, si segue l’istinto (per chi ce l’ha).
Interpretare il bosco, comprenderne gli infiniti gradienti e segnali, ha bisogno di osservazione acuta e di propensione al dettaglio minimale. Le certezze qui evaporano mettendo in evidenza la nostra infinita insignificanza rispetto al processo evolutivo, morfologico e sotterraneo in atto mentre lo attraversiamo. A pensarci bene piegare la schiena e l’orgoglio (inchinarsi) per cercare funghi è un gesto necessario ma anche altamente simbolico, è il riconoscere la nostra insignificanza al cospetto di un processo che ci supera in tutto. Possiamo cogliere solamente alcuni aspetti di questa infinita complessità, che regalano, a volte, l’agognato fungo. E, per questo, dobbiamo ritenerci fortunati, perché avremmo potuto tornare a casa man scrullanda, senza sapere neppure il perché. Il bosco, per definizione, è l’antitesi della razionalità umana: è un intreccio fitto di vita e di decomposizione, di crescita e di morte. Chi vi cammina attraverso ha una mappa del territorio solo abbozzata, con qualche intuizione ed indizio frutto dell’esperienza e degli studi, ma sicuramente incompleta.
Tra l’altro, si sa, il vero fungo è nel sottosuolo ed è in simbiosi con specifiche piante in una correlazione complessa di interscambio di informazioni e nutrimenti. Ciò che vediamo e apprezziamo è solo il corpo fruttifero, la punta di un sistema sotterraneo sterminato, il micelio, appunto, che è, per lo più, invisibile e inafferrabile, come le ragioni profonde che reggono la nostra esistenza. Noi, eterni abitanti della superficie, viviamo di queste apparizioni temporanee, senza padroneggiarne mai davvero il senso.
Altra piccola disgressione. La ricerca delle fungaie acquisisce significato – prima ancora dell’assaporarne il frutto – se accompagnata dalla sua narrazione, subita da parenti e amici in casa, al bar o sui social, dove i dettagli sono sviscerati (tranne ovviamente i luoghi dei ritrovamenti) e spesso le quantità si moltiplicano. La condivisione del porcino ancora nel bosco è stata una caduta anche per me: non sono riuscito a resistere dal mandare qualche foto al gruppo whatsapp “Family” …

Sono ormai le dieci passate e siamo nel pieno della ricerca, ma cominciano ad arrivare gli usurpatori del nostro territorio. Maledetti! Per segnalarci i ritrovamenti ci scambiamo fischi, versi gutturali e il “Mapo” di mia figlia — unico, o almeno così mi illudo — che dovrebbe risultare indecifrabile agli invasori. Ogni porcino stanato genera speranza in altri ritrovamenti; la si potrebbe chiamare avidità, se solo volessimo riconoscerla, ma al momento siamo immersi nella nostra spasmodica caccia.
Quella che era divenuta per noi una pratica quasi meditativa — cullati dall’attenzione al dettaglio, scandita dal passo lento, e consapevoli della limitatezza del nostro gesto — si è trasformata in un cercare compulsivo. Anche la borsa di riserva, dentro la quale avevo messo una scatola di cartone per non schiacciare i delicati esemplari (i veri fungaioli mi lincerebbero se lo sapessero), è ormai piena. A malincuore dobbiamo tornare indietro: non sappiamo più dove infilare i funghi e rischiamo di rovinarli se scivolassimo.
Scendere si rivela un’impresa non facile: il terreno è esposto e friabile. Tocca spostarsi a sinistra e risalire un tratto per cercare un canalone meno scosceso o una strada. Iris comincia a brontolare, lamentando la sua stanchezza e sostenendo che ci siamo persi. Finito l’entusiasmo del cercare e trovare funghi, le gambe protestano. E non è la sola. Mio padre è dolorante per una piccola storta ed io sono sfinito.
Non posso ammettere a mia figlia che una guida naturalistica e uno che va a funghi da quando era bambino non sanno ritrovare la strada del ritorno. Per fortuna non è così: sappiamo esattamente dove siamo (???). Infatti raggiungiamo la traccia di una strada usata per portare via la legna e la percorriamo per un po’. Iris ed io arranchiamo con i cavagni colmi; mio padre ci precede sorreggendosi al bastone. Si vede che è dolorante per la caviglia, ma non demorde e avanza dritto. Nonostante la prospettiva di ore di cammino e la certezza delle sgridate delle rispettive mogli, pare (la certezza non c’è mai) felice. Vengono in mente i versi di Primo Levi presenti ne L’approdo:
Felice l’uomo che ha raggiunto il porto,
che lascia dietro di sé mari e tempeste,
i cui sogni sono morti o mai nati,
e siede a bere all’osteria di Brema,
presso al camino, ed ha buona pace.
Felice l’uomo come una fiamma spenta,
felice l’uomo come sabbia d’estuario,
che ha deposto il carico e si è tersa la fronte,
e riposa al margine del cammino.
Non teme né spera né aspetta,
ma guarda fisso il sole che tramonta.

Raggiungiamo poi due cascine perfettamente ristrutturate; non le ricordavo così, ma sicuramente sono state sistemate di recente. Alla fine della strada ci troviamo davanti a un cancello chiuso: siamo entrati in una proprietà privata — o, più probabilmente, in uno di quegli abusi che nascono quando chi vive nel bosco vuole proteggersi da malintenzionati chiudendo un’antica mulattiera che dovrebbe rimanere di passaggio per chiunque. Ma lasciamo perdere, non posso permettermi di polemizzare con la vecchia e rancorosa proprietaria che ci sta sbraitando contro. Chiediamo scusa e questa ci apre il cancello nel momento fortuito in cui passa un conoscente di mio padre, anche lui qui per funghi.


Per mezzogiorno siamo di ritorno all’auto: poi, arriviamo da mia madre, cui affidiamo il bottino. Il cercare funghi non necessariamente è correlato ad un equivalente piacere nel mangiarli. Mio padre li vorrebbe pure a colazione, mentre per me il fungo è più simbolo che piatto: il frutto proibito del bosco, che appare solo a chi ha la pazienza di cercare. Gli champignon in vaschetta del supermercato non danno emozione né nel trovarli né nel gustarli; il porcino, invece, è un’apparizione che ci ha regalato una giornata che rimarrà nella mente di tutti noi. Mia figlia, lo so, quando leggerà questo pezzo mi rimprovererà per qualche omissione o per aver dimenticato qualche dettaglio. Fa parte del gioco della memoria e della condivisione: la fungaia diventa subito racconto, e il racconto si moltiplica in narrazioni ogni volta più suggestive, omettendo, naturalmente, di nominare il “posto buono” delle fungaie.
Arrivato a casa, ho riguardato due libri che mi sono cari: la Guida pratica ai funghi in Italia a cura di Hans Haas (Selezione dal Reader’s Digest, 1983), un classico fondamentale per gli estimatori, e La via del bosco di Long Litt Woon (Iperborea, 2019). Questo ultimo non è solo un manuale di micologia, né soltanto un percorso di redenzione: è il resoconto di un attraversamento dell’autrice, alla quale è mancato l’amato compagno, verso una differente visione della propria intimità. Leggendolo m’è tornata l’idea che la ricerca — qui quella dei funghi, ma estensibile a molti aspetti della vita — non è riducibile al possesso, bensì alla capacità di tollerare la perdita. Imparare a vivere con l’assenza è già un obiettivo di tutto rispetto.
Ora però bisogna inventarsi altro per riuscire a stornare l’attenzione delle figlie dal cellulare … la prossima volta si va a pesca!

NOTE
[1] Ovolo (Amanita caesarea).
[2] Molinia caerulea.
[3] Termine dialettale ovadese per definire i funghi porcini.
[4] Le camole dei funghi sono dei minuscoli insetti detti “ditteri” ed appartengono al genere Diptera ed alla famiglia dei Mycetophilidae.