di Paolo Repetto, 15 agosto 2024
Li ho ordinati martedì sera, sono arrivati giovedì mattina. Dalla Germania.
In linea di principio sono contrario agli acquisti di libri on-line, e credo la cosa valga per tutti i bibliofili stagionati come me (dove bibliofilo non sta solo per amante della lettura, ma per amante del libro come oggetto, e come oggetto posseduto). C’è di mezzo senz’altro la nostalgia per le librerie d’antan, quelle dove andavi a curiosare, a sfogliare, a chiacchierare col libraio o con gli altri frequentatori abituali. Erano occasioni importanti, dalle quali scaturivano conoscenze, gustosi pettegolezzi e a volte anche solide amicizie. Purtroppo però le librerie d’antan, così come i princìpi, non ci sono più. Le pochissime rimaste sono in genere “a tema” (femminismo, lgbt, ecologismo, ecc …), in linea con le nuove religioni secolari, e persino quelle dedicate all’alpinismo o ai viaggi sembrano rivolgersi a un pubblico di devoti piuttosto che di bibliofili. D’altro canto, entrare oggi in una libreria legata a un gruppo editoriale o a una catena della grande distribuzione equivale ad entrare in un supermercato, e giustamente chi ci lavora ha con i libri lo stesso rapporto che hanno i commessi dell’Esselunga con gli ingredienti delle zuppe surgelate. Allora, tanto vale: invece di sfogliare un libro ne leggi sullo schermo gli estratti, e un minuto di navigazione in rete, sia pure facendo lo slalom tra gli scogli della pubblicità, ti procura tutte le informazioni e le recensioni che desideri. Nel mio caso si aggiunge poi il fatto che mi interessa sempre meno quanto di nuovo viene pubblicato, mentre sono ancora in caccia di titoli che nel tempo mi sono passati sotto gli occhi, che ho annotato in memoria o sui miei taccuini, e che per motivi diversi non ho mai acquisito (ma la memoria è talmente satura e i taccuini sono tanti che i titoli saltano fuori di norma solo per caso).
Così non entro quasi più nelle librerie, anzi, le evito: odio vedere “mercificato” così spudoratamente ciò che un tempo era l’oggetto delle mie attese, dei miei desideri, dei miei piaceri, e che ritenevo appartenesse ad una dimensione superiore – non che i libri anche prima non fossero merce, ma lo erano con altra dignità. Mi irritano gli accostamenti insensati nelle vetrine e i criteri di visibilità sugli scaffali, le promozioni palesemente mirate solo al mercato, la rapidissima obsolescenza dei titoli, tutte cose che non badano alla qualità ma solo al consumo e al ricambio: credo che a breve sulla quarta di copertina troveremo anche la data di scadenza, come sui tappi del latte. I titoli o le case editrici sono ormai solo etichette dietro le quali vengono proposti prodotti altrettanto intercambiabili delle birre o dei detersivi.
La frequentazione la riservo piuttosto ancora ai mercatini. Dall’ultimo di Predosa sono venuto via con quarantasei volumi, due borsoni della Coop che pesavano mezzo quintale: ho stentato a riguadagnare il parcheggio. Vi ho trovato la conferma del convincimento maturato in una ormai pluridecennale militanza: occorre frequentare i mercatini poveri, quelli dove l’espositore paga quindici o venti euro (a Ovada il costo per tenere banco è di settantacinque: e infatti …). Solo lì puoi trovare figli, cognate o mogli che si disfano a basso costo, con una presenza una tantum, della biblioteca del marito (mai trovato un marito che si liberasse di quella della moglie), e che ti consentono di entrare in possesso di preziosissimi volumi della Fondazione Valla o de La Nuova Italia a un euro l’uno. In questo caso gioielli come gli scritti di Seneca “Sulla natura”, di Basilio di Cesarea o di Gregorio di Nissa, che chiaramente non leggerò mai, ma che solo a sfogliarli, o a guardarli, a sapere di possederli, danno un indicibile piacere. E poi saggi di Aby Warburg o di Ernst Curtius e di un sacco di altri “veri maestri” oggi ingiustamente negletti. Insomma, ho speso l’equivalente di tre pizze con birra media e mi son portato a casa un tesoro: che ho dovuto quasi fare entrare di soppiatto, perché mia moglie ha posto un veto sulle nuove acquisizioni, non essendoci più un centimetro di spazio in cui alloggiarli.
Al mercatino comunque non trovi le cose che cerchi: al contrario, trovi cose delle quali in genere ignoravi l’esistenza, fai delle scoperte, testi che col tempo “potrebbero rivelarsi” interessanti e che per intanto sono già appetibili per il prezzo.
La ricerca sul web è tutta un’altra faccenda. Navighi con una disposizione completamente diversa da quella con cui ti aggiri tra i banchi dell’usato. Vai in caccia di qualcosa di preciso, e quasi invariabilmente lo trovi. Certo, il sottile piacere connesso al desiderio, la soddisfazione di una ricerca che ti è costata fatica e si conclude positivamente, la gioia di un inaspettato ritrovamento: tutte queste cose te le scordi, ma anche nelle librerie-supermercato non hanno più alcun posto. Finisci allora per tagliare la testa al toro, digitare un titolo o un autore e accorgerti che ciò che pensavi ormai introvabile te lo offrono in cinquanta, e che se un’opera non è mai stata tradotta in italiano e non te la senti di affrontarla in inglese o addirittura in tedesco è disponibile magari in francese, scontatissima. A quel punto la linea di principio va a farsi benedire, e fai l’ordinativo. Trentasei ore dopo ti recapitano a casa cinque volumi, in arrivo direttamente da Berlino, con una spesa di spedizione di due euro e mezzo.
Di questi appunto volevo parlare. Quattro sono taccuini di viaggio, ma questa è l’unica cosa che li accomuna. Sono piuttosto l’esemplificazione perfetta di come si possa viaggiare e si possano poi raccontare i viaggi in maniera molto diversa. Il quinto è una raccolta di brevi biografie di viaggiatori particolarmente “eccentrici”, fuori dagli schemi, che ha anticipato, purtroppo sino a ieri a mia insaputa, se non i soggetti almeno l’idea di fondo che ispirava molte delle cose che ho scritto.
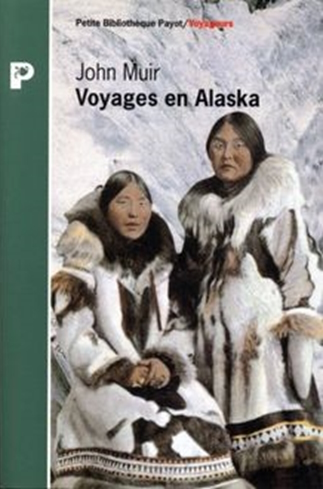 Voyages in Alaska, di John Muir, contiene i resoconti di tre viaggi di esplorazione compiuti dal naturalista americano tra il 1879 e il 1890. Di Muir avevo letto già altri tre libri, gli unici tradotti in Italia, e quindi sapevo pressappoco cosa attendermi: devo dire che ho ricevuto molto di più. Ho capito ad esempio di chi erano figli i racconti di Jack London, che ha saccheggiato da queste pagine molti protagonisti, umani e non, e ha preso lo spunto per diverse storie. Credo abbia vissuto la sua breve avventura di cercatore d’oro col libro di Muir nello zaino.
Voyages in Alaska, di John Muir, contiene i resoconti di tre viaggi di esplorazione compiuti dal naturalista americano tra il 1879 e il 1890. Di Muir avevo letto già altri tre libri, gli unici tradotti in Italia, e quindi sapevo pressappoco cosa attendermi: devo dire che ho ricevuto molto di più. Ho capito ad esempio di chi erano figli i racconti di Jack London, che ha saccheggiato da queste pagine molti protagonisti, umani e non, e ha preso lo spunto per diverse storie. Credo abbia vissuto la sua breve avventura di cercatore d’oro col libro di Muir nello zaino.
In Alaska Muir ha compiuto ben sette viaggi, gli ultimi con spedizioni ufficiali mirate soprattutto ad ampliare i territori di competenza degli Stati Uniti. Per questo si è limitato a raccogliere e a proporre i diari di questi tre, realizzati invece alla sua maniera, senza alcun supporto logistico, senza una precisa programmazione, senza un adeguato equipaggiamento, senza armi. Era particolarmente interessato ai ghiacciai, sul cui ruolo nel modellare il territorio formulò una teoria che si è poi rivelata assolutamente esatta. Nei primi viaggi si dichiara però intento soltanto all’ascolto e alla preservazione del “canto del mondo”.
Chi ha già letto La mia prima estate sulla Sierra e Mille miglia in cammino fino al golfo del Messico – dicevo – non trova molto di nuovo, se non la natura dei paesaggi. E deve mettere senz’altro in conto, per quanto concerne lo stile, l’entusiasmo pionieristico del nascente ecologismo d’oltre oceano, ispirato al trascendentalismo di Emerson. Voglio dire che i continui sbigottimenti e le urla di gioia e le danze nelle quali esprime l’eccitazione per gli spettacoli naturali alla lunga riescono un po’ fastidiosi, ma senz’altro corrispondono a un sentire, a una riconoscenza, ad una immedesimazione del tutto genuini e sinceri. Ne ha ben donde, del resto, perché a folgorarlo sono i panorami della Yosemite Valley, della Sierra Nevada o della Glacier Bay.
Si può scrivere della natura anche in questi termini, magari facendosi trasportare un po’ dall’eccesso, senza necessariamente scadere in una trita liturgia, in atteggiamenti devozionali. Ecco, Muir viaggia sempre a un livello spirituale altissimo, quasi mistico, ma mai religioso. Una lettura da consigliare vivamente, magari guidata, per evitare interpretazioni distorcenti, agli odierni fondamentalisti ecologici e ai cultori dell’integralismo animalista.
 Leggendo le prime pagine di Un petit tour dans l’Hindou Kouch (1958), di Eric Newby, ho avuto l’impressione di un deja vù. La situazione iniziale mi ha ricordato immediatamente Tre uomini in barca, di Jerome, e subito dopo Una passeggiata nei boschi, di Bill Bryson: due scriteriati, assolutamente digiuni di alpinismo e animati solo dall’incoscienza inglese, si mettono in testa di compiere alcune ascensioni sui settemila dell’Afghanistan, per la precisione nella regione più remota del paese, il Nuristan. Lo fanno dopo soli tre giorni di iniziazione all’arrampicata in Inghilterra, e con una organizzazioner logistica che rende improbabile persino l’avvicinamento a quelle montagne. Ad un certo punto ho temuto che il tutto si risolvesse in una solenne buffonata, in un rovesciamento esasperato e speculare dell’understatement inglese: invece, mano a mano che procedevo a seguire le loro disavventure, i dejà vu si sono moltiplicati e hanno rivelato la loro vera natura.
Leggendo le prime pagine di Un petit tour dans l’Hindou Kouch (1958), di Eric Newby, ho avuto l’impressione di un deja vù. La situazione iniziale mi ha ricordato immediatamente Tre uomini in barca, di Jerome, e subito dopo Una passeggiata nei boschi, di Bill Bryson: due scriteriati, assolutamente digiuni di alpinismo e animati solo dall’incoscienza inglese, si mettono in testa di compiere alcune ascensioni sui settemila dell’Afghanistan, per la precisione nella regione più remota del paese, il Nuristan. Lo fanno dopo soli tre giorni di iniziazione all’arrampicata in Inghilterra, e con una organizzazioner logistica che rende improbabile persino l’avvicinamento a quelle montagne. Ad un certo punto ho temuto che il tutto si risolvesse in una solenne buffonata, in un rovesciamento esasperato e speculare dell’understatement inglese: invece, mano a mano che procedevo a seguire le loro disavventure, i dejà vu si sono moltiplicati e hanno rivelato la loro vera natura.
L’avventura di Newby e del suo socio ha luogo nel 1956. Una quindicina di anni prima lo stesso loro itinerario era stato percorso dalla coppia Annemarie Schwarzenbach (che lo racconta in La via per Kabul), e Ella Maillart (La via crudele, 1947). Alla fine degli anni Quaranta quattro scriteriati francesi amanti dell’arte orientale intraprendono un viaggio quasi simile muovendo dal Nordafrica, e lo raccontano poi in Dal Nilo al Gange, di Pierre Rambach. Nei primi anni Cinquanta è Nicolas Bouvier a percorrere a ritroso con un compagno la via della seta, attraversando i Balcani, l’Anatolia, la Persia e l’Afghanistan. E dopo Newby, soprattutto negli anni Settanta, sono decine i convertiti all’esotismo new age che si avventurano in quella direzione. Con tutti questi resoconti in memoria, sarebbe strano ora se non riconoscessi luoghi, situazioni, personaggi. Anche se ciascuno queste cose le ha raccontate a modo suo. Newby senz’altro in una maniera tutta particolare.
Gli unici suoi libri tradotti in italiano sono Amore e guerra negli Appennini e L’ultima regata del grano. Questo, che probabilmente è il migliore, almeno per gli amanti della letteratura di viaggio, non è mai stato preso in considerazione, nemmeno in questo ultimo periodo di revival del genere. Credo di poterne dare una spiegazione. Il mondo e l’umanità che Newby descrive, sia pure filtrati attraverso una dose massiccia di humor, sono tutt’altro che attraenti. Tra Istanbul a Kabul lui e il suo compagno non incontrano che miseria, disorganizzazione, e le rovine di un passato che doveva essere stato prospero, ma che sembra non aver lasciato traccia negli animi. È vero che mette in conto tutte le disavventure che gli capitano alla impreparazione sua e del suo compagno, e le legge con la cifra di un umorismo che spesso ricorda Wodehouse: ma non può non testimoniare la desolazione materiale e spirituale di quei luoghi. A volte gli è sufficiente un’osservazione casuale, senza commenti: Due nomadi passavano con un cammello, seguiti a quattro o cinquecento metri da una ragazza molto giovane carica di un fardello, che barcollava per la spossatezza. Nessuno dei due uomini le prestava la minima attenzione, ma in compenso ci salutarono calorosamente al passaggio.
Credo dunque che la ragione per la quale il libro non è ancora stato tradotto in italiano stia nella sua apparente “scorrettezza politica”. Oggi verrebbe senza dubbio accusato di proporre una visione razzista, colonialistica, imperialista, semplicemente perché dice le cose come stavano negli anni Cinquanta (e probabilmente adesso stanno anche peggio). In realtà nell’atteggiamento di Newby non ho colto traccia alcuna della supponenza e dello snobismo che spesso (molto spesso) i viaggiatori inglesi portavano nel loro bagaglio: è troppo occupato a combattere con la dissenteria, con la polvere, con le cimici che si coricano con lui, con i suoi continui qui pro quo dovuti alla non conoscenza delle lingue locali (si getta in un pozzo nero, irritato dall’inerzia degli “indigeni”, per salvare un bambino che se la sta ridendo dietro il muro di casa) per tranciare giudizi. Anche quando commenta, in più occasioni: Cavolo, siamo in pieno medioevo, non lo fa con spocchia, ma da antico entusiasta lettore di Walter Scott.
In compenso, solo a titolo di cronaca, i due dopo un paio di attacchi a vuoto riescono ad arrivare in vista della vetta del monte Samir (di 5.809 metri, ma all’epoca era stimato oltre i seimila, ed era considerato dagli afgani inespugnabile), ma il loro exploit verrà considerato, sotto il profilo alpinistico “insignificante”. La montagna sarà espugnata tre anni dopo.
 Courrier de Tartarie (News from Tartary: A Journey from Peking to Kashmir, 1936) di Peter Fleming è la narrazione di un viaggio compiuto dall’autore a metà degli anni Trenta, pressappoco negli stessi luoghi visitati da Newby ma in direzione opposta, procedendo da est ad ovest, in compagnia dell’onnipresente Ella Maillart (che ha raccontato la stessa vicenda in Oasi proibite). Difficile immaginare due caratteri e due approcci al viaggio altrettanto diversi: a leggere i due resoconti parrebbero aver attraversato mondi completamente differenti.
Courrier de Tartarie (News from Tartary: A Journey from Peking to Kashmir, 1936) di Peter Fleming è la narrazione di un viaggio compiuto dall’autore a metà degli anni Trenta, pressappoco negli stessi luoghi visitati da Newby ma in direzione opposta, procedendo da est ad ovest, in compagnia dell’onnipresente Ella Maillart (che ha raccontato la stessa vicenda in Oasi proibite). Difficile immaginare due caratteri e due approcci al viaggio altrettanto diversi: a leggere i due resoconti parrebbero aver attraversato mondi completamente differenti.
Il viaggio, iniziato nel febbraio 1935, dura sette mesi e si snoda per 5600 chilometri da Pechino al Kashmir. Lo scopo è verificare cosa sta accadendo in un’area particolarmente turbolenta e quasi sconosciuta, il Turkestan cinese (o Tunganistan, ma oggi Xinjiang), situata al confine tra l’India, la Cina e la Russia.
Fleming (che tra l’altro è fratello del più celebre Jan, quello di James Bond) è uno storico tenuto in grande considerazione in Inghilterra, molto meno dalle nostre parti. L’unica traduzione in italiano di un suo scritto di viaggio (Avventura brasiliana, Longanesi, 1950) risale a settanta anni fa, e non è più stata ristampata. Varrebbe la pena proporre oggi anche questo diario asiatico, non fosse altro per confrontarlo con la versione della Maillart, ma soprattutto con la coeva descrizione fatta da Sven Hedin degli stessi luoghi e delle stesse vicende politiche.
A differenza del libro di Newby, questo è il resoconto dettagliato di tappe, spostamenti, distanze, incontri, redatto con uno stile molto più distaccato, e meno coinvolgente, nel quale l’umorismo britannico, assai trattenuto, è rivolto quasi esclusivamente agli altri. Un umorismo molto aristocratico: leggere un propagandista, un uomo con interessi intellettuali acquisiti, è noioso quanto cenare con un vegetariano.
È evidente anche che Fleming non prova simpatia per le popolazioni che incontra, e le valuta col metro dei vantaggi o degli inconvenienti che possono procurare agli interessi britannici, ancora nell’ottica del Grande Gioco (all’epoca è un agente dell’MI6, il servizio di spionaggio: del resto, ai loro servizi segreti sono legati un po’ tutti i personaggi, inglesi, russi, tedeschi, che negli anni Trenta si aggirano da quelle parti). L’autore rivendica però ripetutamente la sua posizione quasi da “osservatore esterno”: Non so nulla, e mi interessa meno, della teoria politica; la furfanteria, l’oppressione e l’inettitudine, come perpetrate dai governi, mi interessano solo nelle loro manifestazioni concrete, nel loro impatto sull’umanità: non nelle loro nebulose origini dottrinali.
Ciò non significa che il libro non sia interessante, anzi, sul piano della conoscenza dei costumi e dei caratteri di quei popoli è molto più ricco di quello di Newby: ma non è, a mio parere, altrettanto divertente.
 Courrier des Andes è il titolo francese dato a Three Letters from the Andes (1991) di Patrick Leigh Fermor. Non ho ancora capito se ne esiste una traduzione italiana, a giudicare dagli esiti della ricerca in rete parrebbe di no. Paddy Fermor si aggrega nel 1955 ad una piccola spedizione esplorativa che non si pone traguardi particolarmente ambiziosi. È una sorta di ospite d’onore, e si comporta come tale. Lascia siano gli altri a scalare qualche vetta e fare le rilevazioni scientifiche, mentre inventa per sé un ruolo di custode della stufa da campo, di cronista ufficiale dell’avventura e di soprattutto di motivatore (ruolo questo che gli veniva automaticamente riconosciuto, state la sua esuberanza, da chiunque gli si accompagnasse, dai partigiani greci ai frequentatori dei circoli inglesi.). Le lettere cui si riferisce il titolo inglese sono indirizzate alla moglie Joan.
Courrier des Andes è il titolo francese dato a Three Letters from the Andes (1991) di Patrick Leigh Fermor. Non ho ancora capito se ne esiste una traduzione italiana, a giudicare dagli esiti della ricerca in rete parrebbe di no. Paddy Fermor si aggrega nel 1955 ad una piccola spedizione esplorativa che non si pone traguardi particolarmente ambiziosi. È una sorta di ospite d’onore, e si comporta come tale. Lascia siano gli altri a scalare qualche vetta e fare le rilevazioni scientifiche, mentre inventa per sé un ruolo di custode della stufa da campo, di cronista ufficiale dell’avventura e di soprattutto di motivatore (ruolo questo che gli veniva automaticamente riconosciuto, state la sua esuberanza, da chiunque gli si accompagnasse, dai partigiani greci ai frequentatori dei circoli inglesi.). Le lettere cui si riferisce il titolo inglese sono indirizzate alla moglie Joan.
Si tratta palesemente di una operazione di recupero, intesa a sfruttare la popolarità che il viaggiatore inglese stava conoscendo alla fine del secolo scorso. Fermor naturalmente rimane se stesso, la sua scrittura continua ad essere estremamente pulita e raffinata, ma al di là di qualche gustoso aneddoto o di qualche acuta osservazione sui costumi e sui comportamenti delle popolazioni andine non ha molto da offrirci. Il testo dà l’impressione di essere stato buttato giù di getto, senza passare attraverso le innumerevoli riscritture che per Paddy erano abituali: e questo è forse il suo maggior pregio.
 Infine il quinto, Voyageurs excentriques, di John Keay (1982). Keay è conosciuto in Italia per due bellissimi libri di taglio storico Quando uomini e montagne si incontrano (1977) e La via delle spezie (2005), pubblicati entrambi nella benemerita collana Il cammello Battriano di Neri Pozza. Il primo soprattutto mi aveva a suo tempo affascinato, ma quando l’ho letto io, nel 2005, in Inghilterra era considerato un classico da quasi trent’anni. Eccentric Travellers, uscito nei primi anni Ottanta, in Italia non è mai stato tradotto. Ed è strano, perché ha tutti i requisiti per essere considerato a sua volta un piccolo classico. Racchiude gli schizzi biografici di sette viaggiatori pochissimo noti dalle nostre parti (immagino invece conosciutissimi in Inghilterra) e ciascuno a suo modo davvero singolari. Lo avessi letto prima, mi sarei risparmiato probabilmente lo scritto su Charles Waterton (L’inventore dei capelli a spazzola). Ma forse è stato meglio così: Waterton me lo sono guadagnato tutto e adesso lo sento davvero mio. Gli altri andrò a conoscerli meglio con calma.
Infine il quinto, Voyageurs excentriques, di John Keay (1982). Keay è conosciuto in Italia per due bellissimi libri di taglio storico Quando uomini e montagne si incontrano (1977) e La via delle spezie (2005), pubblicati entrambi nella benemerita collana Il cammello Battriano di Neri Pozza. Il primo soprattutto mi aveva a suo tempo affascinato, ma quando l’ho letto io, nel 2005, in Inghilterra era considerato un classico da quasi trent’anni. Eccentric Travellers, uscito nei primi anni Ottanta, in Italia non è mai stato tradotto. Ed è strano, perché ha tutti i requisiti per essere considerato a sua volta un piccolo classico. Racchiude gli schizzi biografici di sette viaggiatori pochissimo noti dalle nostre parti (immagino invece conosciutissimi in Inghilterra) e ciascuno a suo modo davvero singolari. Lo avessi letto prima, mi sarei risparmiato probabilmente lo scritto su Charles Waterton (L’inventore dei capelli a spazzola). Ma forse è stato meglio così: Waterton me lo sono guadagnato tutto e adesso lo sento davvero mio. Gli altri andrò a conoscerli meglio con calma.
Non posso negare che la lettura mi abbia suscitato un po’ d’invidia, qualche rammarico e alcune considerazioni. Avevo parlato dell’eventualità di un’operazione “divulgativa” di questo tipo già mezzo secolo fa con un amico, docente di storia delle esplorazioni geografiche. Non aveva bocciato l’idea, ma mi aveva fatto notare che nel nostro panorama editoriale, a differenza che in quello anglosassone o d’oltralpe, non c’era molto spazio per queste cose. Una collana miscellanea da lui stesso all’epoca diretta esigeva contributi ineccepibili sotto il profilo del protocollo storiografico, ovvero zeppi di note, di citazioni puntualmente identificabili, di riferimenti bibliografici, ecc. …: tutte cose sacrosante in vista di una preparazione all’attività storiografica, ma che risultano di norma scoraggianti per una lettura amatoriale (e tanto più dissuasivi per una scrittura non “accademica”). Aveva solo parzialmente ragione, come ha dimostrato successivamente proprio il successo de Il cammello battriano di Stefano Malatesta, ma aveva toccato anche un tasto reale, quello di una attitudine della cultura italiana al rispetto ossequioso dei “canoni” di genere, della quale mi rendo conto d’essere io stesso imbevuto.
Il che ci porta alla vera ratio di questo pezzo. Sempre diversi anni fa, in risposta ad un mio scritto comparso anche su Luomoconlavaligia (Perché non esiste in Italia una letteratura del viaggio), una collaboratrice del sito smontava le mie argomentazioni asserendo che erano frutto di una preconcetta esterofilia e sostenendo che in realtà la letteratura di viaggio era diffusissima in Italia e vantava una lunga e gloriosa tradizione. Per dimostrare quanto azzardate fossero entrambe queste affermazioni era sufficiente consultare il catalogo delle edizioni Payot, specializzate nell’editoria di viaggio e dal quale ho attinto tutti i titoli presentati sopra, e rendersi conto che negli anni Novanta del secolo scorso offrivano un solo titolo in traduzione dall’italiano, a fronte degli oltre centoventi presenti (e non per sciovinismo, perché la stragrande maggioranza erano traduzioni di opere inglesi). In quello delle edizioni La Découverte, altra collana specializzata, non ne compariva uno.
Ma basterebbero anche a mio giudizio le assenze che ho dovuto colmare trent’anni dopo cercando le traduzioni in un’altra lingua, o i ritardi coi quali sono stati presentati al pubblico italiano classici del viaggio ottocentesco come Eothen, di William Kinglake, il Viaggio all’interno dell’Africa di Mungo Park o il Viaggio a Timbouctu di René Caillié. Inoltre, in realtà nel mio articolo facevo riferimento non tanto alla letteratura, ma ad una più ampia “cultura del viaggio”.
Ora, non nego che anche in Italia, sia pure come sempre di riflesso, sia aumentato l’interesse per la letteratura di viaggio: di sicuro c’è che se ne scrive (e forse se ne legge) molta di più. Ma ho l’impressione che questo abbia poco a che vedere con una vera “cultura del viaggio”. Sembra infatti che si viaggi quasi solo in funzione del poterne scrivere, e che per giustificare la scrittura si cerchino soprattutto performance da sballati o da guinness dei primati, nelle quali si esaurisce poi tutto l’interesse: giri del mondo in monopattino o in vasche da bagno motorizzate, vie classiche, religiose o storiche percorse camminando all’indietro o ad occhi chiusi: insomma, buffonate. Oppure che ci si muova al traino delle mode e delle mete del momento, quelle “certificabili” con la progressione su Instagram o certificate ufficialmente dai grossi barnum messi in piedi per sfruttare il trend (dal camino di Compostela alla via Francigena e similari), col risultato di intrupparsi in un traffico che non ha nulla da invidiare a quello dei marciapiedi delle città cinesi. Questo accade ovunque, certamente, così come è vero che ovunque si voglia andare si è già stati preceduti dalla folla: ma rimango dell’idea che chi ha potuto crescere nutrendosi di una tradizione che il viaggio lo dava per scontato, che ad esso associava l’arricchimento spirituale (e magari anche materiale), l’apertura mentale, l’autoconsapevolezza, e non solo la fuga, l’esilio, la forzata migrazione, lo strazio del distacco, insomma, tutta la piagnucolosa retorica dell’“addio monti” che da noi sino a ieri ha dettato i canoni del sentire, ebbene, costui riesca a viaggiare ancora oggi con uno spirito diverso.
Magari mi sbaglio, magari siamo ormai tutti uniformati a consumare chilometri anziché a provare emozioni e curiosità genuine: ma avrei voluto poter leggere anch’io prima dei vent’anni Newby, e persino Peter Fleming.





 Stig Dagerman potrebbe essere ospitato anche nel mese degli anarchici, ma io l’ho conosciuto prima di tutto come letterato. Ero rimasto folgorato dal suo ultimo libro di racconti, Il Viaggiatore. Folgorato significa in questo caso annichilito, agghiacciato: un simile spietato faccia a faccia con la realtà l’ho ritrovato poi solo nei libri di Thomas Bernhard. La stupefazione non si è ripetuta con i romanzi, perché c’è un limite anche a quanto a lungo uno è disposto a reggere un simile sguardo: ma ho poi letto quel concentrato di disperazione e angoscia, mista alla volontà di sperare, che è Il nostro bisogno di consolazione. Per leggerlo occorrono non più di cinque minuti: il problema è poi digerirlo. Qui ne riporto un paio di citazioni che potrebbero andare in esergo ad un possibile mini-saggio:
Stig Dagerman potrebbe essere ospitato anche nel mese degli anarchici, ma io l’ho conosciuto prima di tutto come letterato. Ero rimasto folgorato dal suo ultimo libro di racconti, Il Viaggiatore. Folgorato significa in questo caso annichilito, agghiacciato: un simile spietato faccia a faccia con la realtà l’ho ritrovato poi solo nei libri di Thomas Bernhard. La stupefazione non si è ripetuta con i romanzi, perché c’è un limite anche a quanto a lungo uno è disposto a reggere un simile sguardo: ma ho poi letto quel concentrato di disperazione e angoscia, mista alla volontà di sperare, che è Il nostro bisogno di consolazione. Per leggerlo occorrono non più di cinque minuti: il problema è poi digerirlo. Qui ne riporto un paio di citazioni che potrebbero andare in esergo ad un possibile mini-saggio: Dunque: inaugurato l’anno con i letterati, febbraio l’avrei potuto riservare agli artisti. Il mese corrisponde bene all’immagine (quasi sempre falsa) di vite povere e disperate, di pasti saltati e di studi gelidi. È un’immagine che va bene per Modigliani, per Van Gogh e per Caravaggio, un po’ meno per Pellizza da Volpedo e per Egon Schiele, per nulla con Raffaello. Tutti sono comunque accomunati da un’attività frenetica. Schiele, ad esempio, che avevo scelto come testimonial ufficiale della categoria e che è morto di spagnola a soli ventotto anni, ha lasciato circa trecentoquaranta dipinti e duemilaottocento tra acquarelli e disegni, mentre Van Gogh fu autore di quasi novecento dipinti e di più di mille disegni. Danno l’idea di una corsa disperata a produrre, quasi presaghi di un tempo limitato a disposizione.
Dunque: inaugurato l’anno con i letterati, febbraio l’avrei potuto riservare agli artisti. Il mese corrisponde bene all’immagine (quasi sempre falsa) di vite povere e disperate, di pasti saltati e di studi gelidi. È un’immagine che va bene per Modigliani, per Van Gogh e per Caravaggio, un po’ meno per Pellizza da Volpedo e per Egon Schiele, per nulla con Raffaello. Tutti sono comunque accomunati da un’attività frenetica. Schiele, ad esempio, che avevo scelto come testimonial ufficiale della categoria e che è morto di spagnola a soli ventotto anni, ha lasciato circa trecentoquaranta dipinti e duemilaottocento tra acquarelli e disegni, mentre Van Gogh fu autore di quasi novecento dipinti e di più di mille disegni. Danno l’idea di una corsa disperata a produrre, quasi presaghi di un tempo limitato a disposizione. Marzo sembra un mese adatto ai viaggiatori e agli esploratori. Il nome che compare nella mia lista definitiva è quello di Mungo Park. È probabile lo avessi scelto perché non avevo ancora trovato né una edizione dei suoi scritti né una biografia dedicata. A tutt’oggi i suoi Viaggi all’interno dell’Africa non sono mai stati tradotti in italiano, così come non esistono nella nostra lingua sue biografie. Per averne notizie bisogna ancora rivolgersi alla Treccani. La stessa cosa accade comunque per René Caille, mentre le vicende di Meriwether Lewis e di John Hanning Speke sono abbastanza conosciute, non fosse altro perché sono stata raccontate in un paio di bel film.
Marzo sembra un mese adatto ai viaggiatori e agli esploratori. Il nome che compare nella mia lista definitiva è quello di Mungo Park. È probabile lo avessi scelto perché non avevo ancora trovato né una edizione dei suoi scritti né una biografia dedicata. A tutt’oggi i suoi Viaggi all’interno dell’Africa non sono mai stati tradotti in italiano, così come non esistono nella nostra lingua sue biografie. Per averne notizie bisogna ancora rivolgersi alla Treccani. La stessa cosa accade comunque per René Caille, mentre le vicende di Meriwether Lewis e di John Hanning Speke sono abbastanza conosciute, non fosse altro perché sono stata raccontate in un paio di bel film. Aprile, “il più crudele dei mesi”, non poteva essere dedicato che agli alpinisti. Sono quelli con le più alte probabilità di uscire prematuramente di scena. La ricerca di nomi da iscrivere nella lista non era stata difficile: ne compaiono addirittura dieci. Si parte da Mummery, che ricompare nell’elenco ristretto, perché in effetti la sua figura mi ha sempre affascinato, e poi vengono nell’ordine Mallory, Comici, Gervasutti, Paul Preuss, Willo Welzenbach, Casarotto, Gian Piero Motti e Andrea Oggioni. Ho poi saldato il mio debito con tutti costoro ne
Aprile, “il più crudele dei mesi”, non poteva essere dedicato che agli alpinisti. Sono quelli con le più alte probabilità di uscire prematuramente di scena. La ricerca di nomi da iscrivere nella lista non era stata difficile: ne compaiono addirittura dieci. Si parte da Mummery, che ricompare nell’elenco ristretto, perché in effetti la sua figura mi ha sempre affascinato, e poi vengono nell’ordine Mallory, Comici, Gervasutti, Paul Preuss, Willo Welzenbach, Casarotto, Gian Piero Motti e Andrea Oggioni. Ho poi saldato il mio debito con tutti costoro ne  Il commento lo lascio a uno morto anche lui troppo presto, non tanto però da rientrare nei “cari agli dei”: Gustav Landauer.
Il commento lo lascio a uno morto anche lui troppo presto, non tanto però da rientrare nei “cari agli dei”: Gustav Landauer. È diventato quasi un dogma tra gli anarchici considerare l’uccisione dei capi di Stato, una volta compiuta, come qualcosa di anarchico. Si tenga conto che quasi tutti gli attentatori degli ultimi decenni si sono effettivamente nutriti di principi anarchici. Coincidenza singolare dirà l’ingenuo, perché cosa mai può 90 avere a che fare l’uccisione di altri uomini con l’anarchismo, con la dottrina del raggiungimento di una società senza Stato e senza costrizione autoritaria; cosa c’entra con il movimento contro lo Stato e contro la violenza legalizzata? Proprio niente. Ma gli anarchici si rendono conto che dottrine e proclami non bastano: non si può erigere la nuova società a causa della violenza di coloro che detengono il potere, pertanto – argomentano – accanto alla propaganda svolta con i discorsi e gli scritti e accanto all’opera di costruzione bisogna iniziare anche un’opera di distruzione. Sono troppo deboli per abbattere tutte le barriere, quindi è almeno necessario sollecitare l’azione, e poi con questa fare propaganda. Se i partiti politici fanno attività politica positiva, allora anche gli anarchici, come singoli, devono fare antipolitica positiva, cioè attività politica negativa. Tale ragionamento spiega l’attività politica degli anarchici, la propaganda del fatto, il terrorismo individuale. Non esito a dire con grande nettezza – e so bene che non mi guadagnerò encomi né da una parte né dall’altra – che l’antipolitica degli anarchici muove in parte dal tentativo di un piccolo gruppo di imitare i grandi partiti. Alla base c’è smania di protagonismo. Anche noi facciamo politica, dicono, non siamo inattivi, ed essi devono fare i conti con noi. A me pare che questi anarchici non siano abbastanza anarchici, perché rimangono un partito politico e addirittura portano avanti una primitiva politica riformatrice: uccidere uomini fa parte degli ingenui tentativi di miglioramento dei primitivi.
È diventato quasi un dogma tra gli anarchici considerare l’uccisione dei capi di Stato, una volta compiuta, come qualcosa di anarchico. Si tenga conto che quasi tutti gli attentatori degli ultimi decenni si sono effettivamente nutriti di principi anarchici. Coincidenza singolare dirà l’ingenuo, perché cosa mai può 90 avere a che fare l’uccisione di altri uomini con l’anarchismo, con la dottrina del raggiungimento di una società senza Stato e senza costrizione autoritaria; cosa c’entra con il movimento contro lo Stato e contro la violenza legalizzata? Proprio niente. Ma gli anarchici si rendono conto che dottrine e proclami non bastano: non si può erigere la nuova società a causa della violenza di coloro che detengono il potere, pertanto – argomentano – accanto alla propaganda svolta con i discorsi e gli scritti e accanto all’opera di costruzione bisogna iniziare anche un’opera di distruzione. Sono troppo deboli per abbattere tutte le barriere, quindi è almeno necessario sollecitare l’azione, e poi con questa fare propaganda. Se i partiti politici fanno attività politica positiva, allora anche gli anarchici, come singoli, devono fare antipolitica positiva, cioè attività politica negativa. Tale ragionamento spiega l’attività politica degli anarchici, la propaganda del fatto, il terrorismo individuale. Non esito a dire con grande nettezza – e so bene che non mi guadagnerò encomi né da una parte né dall’altra – che l’antipolitica degli anarchici muove in parte dal tentativo di un piccolo gruppo di imitare i grandi partiti. Alla base c’è smania di protagonismo. Anche noi facciamo politica, dicono, non siamo inattivi, ed essi devono fare i conti con noi. A me pare che questi anarchici non siano abbastanza anarchici, perché rimangono un partito politico e addirittura portano avanti una primitiva politica riformatrice: uccidere uomini fa parte degli ingenui tentativi di miglioramento dei primitivi. Dove le condizioni obiettive non sono mature per uno sviluppo rigoroso, abbiamo processi patologici che dagli stessi principi conducono a conseguenze contrastanti; il liberismo diventa socialismo di stato, il liberalismo democrazia demagogica o nazionalismo dilettantesco, come in sede culturale la dialettica cede all’eristica e alla retorica.
Dove le condizioni obiettive non sono mature per uno sviluppo rigoroso, abbiamo processi patologici che dagli stessi principi conducono a conseguenze contrastanti; il liberismo diventa socialismo di stato, il liberalismo democrazia demagogica o nazionalismo dilettantesco, come in sede culturale la dialettica cede all’eristica e alla retorica. Non mi ero appuntato molti altri nomi: solo Otto Weininger, Carlo Michelstaedter e Claudio Baglietto. I pensatori e gli studiosi sembrano vivere molto a lungo (è scientificamente provato che pensare allunga l’esistenza: immagino sia per questo che l’aspettativa di vita ultimamente si sta abbassando) e comunque, dovessi stilare oggi la lista, non saprei chi aggiungere. Non era solo l’età del decesso ad intrigarmi, ma ciò che l’aveva preceduta. Weininger e Michelstaedter addirittura si erano dati la morte a ventitré anni, ma prima avevano prodotto cose come Sesso e carattere e La Persuasione e la Rettorica. L’una e l’altra opera possono essere discutibili sotto molti aspetti (quella di Weininger praticamente sotto tutti), ma appunto, obbligano alla riflessione, alla discussione, e lasciano intravvedere uno sforzo intellettuale immane. Forse proprio il timore di non poter andare oltre ha determinato le tragiche scelte degli autori. Baglietto era invece allora un filosofo quasi sconosciuto, e lo rimane ancor più oggi. Non ha lasciato opere epocali, ma ha testimoniato la sua tempra etica, di stampo kantiano, rompendo con l’ambiente accademico che gli faceva ponti d’oro (Gentile era un suo sponsor convinto) e scegliendo di contrapporsi al fascismo con l’esilio.
Non mi ero appuntato molti altri nomi: solo Otto Weininger, Carlo Michelstaedter e Claudio Baglietto. I pensatori e gli studiosi sembrano vivere molto a lungo (è scientificamente provato che pensare allunga l’esistenza: immagino sia per questo che l’aspettativa di vita ultimamente si sta abbassando) e comunque, dovessi stilare oggi la lista, non saprei chi aggiungere. Non era solo l’età del decesso ad intrigarmi, ma ciò che l’aveva preceduta. Weininger e Michelstaedter addirittura si erano dati la morte a ventitré anni, ma prima avevano prodotto cose come Sesso e carattere e La Persuasione e la Rettorica. L’una e l’altra opera possono essere discutibili sotto molti aspetti (quella di Weininger praticamente sotto tutti), ma appunto, obbligano alla riflessione, alla discussione, e lasciano intravvedere uno sforzo intellettuale immane. Forse proprio il timore di non poter andare oltre ha determinato le tragiche scelte degli autori. Baglietto era invece allora un filosofo quasi sconosciuto, e lo rimane ancor più oggi. Non ha lasciato opere epocali, ma ha testimoniato la sua tempra etica, di stampo kantiano, rompendo con l’ambiente accademico che gli faceva ponti d’oro (Gentile era un suo sponsor convinto) e scegliendo di contrapporsi al fascismo con l’esilio. Agosto vede comunque protagonisti gli scienziati. Nella lista avevo appuntato un paio di matematici, Evariste Galois, naturalmente, e Niels Abel, e altrettanti fisici, Ettore Majorana e Aldo Pontremoli, accomunati soprattutto dalla tragicità delle loro vicende e in un paio di casi dal mistero che ancora le circonda. Galois è famoso, prima ancora che per il suo contributo alla soluzione delle equazioni algebriche, per l’assurdità delle circostanze della sua morte. Il norvegese invece non lo è, mentre meriterebbe cento volte di esserlo, sia per l’impulso fondamentale dato alla disciplina che a risarcimento della sfortuna che lo accompagnò lungo tutta la sua breve esistenza. Per due volte Abel presentò a università diverse, in Danimarca e a Parigi, delle memorie scientifiche che avrebbero rivoluzionato gli studi matematici, ed entrambe le volte l’ambiente accademico le smarrì. Il che può farci immaginare quanto altro sapere debba essere andato disperso nel confronto con istituzioni culturali come minimo fossilizzate e distratte, e più spesso governate da logiche lobbistiche. È quindi Abel, cui fu recapitata la nomina ad una cattedra all’università di Berlino due giorni dopo che era morto praticamente di stenti, l’uomo di agosto.
Agosto vede comunque protagonisti gli scienziati. Nella lista avevo appuntato un paio di matematici, Evariste Galois, naturalmente, e Niels Abel, e altrettanti fisici, Ettore Majorana e Aldo Pontremoli, accomunati soprattutto dalla tragicità delle loro vicende e in un paio di casi dal mistero che ancora le circonda. Galois è famoso, prima ancora che per il suo contributo alla soluzione delle equazioni algebriche, per l’assurdità delle circostanze della sua morte. Il norvegese invece non lo è, mentre meriterebbe cento volte di esserlo, sia per l’impulso fondamentale dato alla disciplina che a risarcimento della sfortuna che lo accompagnò lungo tutta la sua breve esistenza. Per due volte Abel presentò a università diverse, in Danimarca e a Parigi, delle memorie scientifiche che avrebbero rivoluzionato gli studi matematici, ed entrambe le volte l’ambiente accademico le smarrì. Il che può farci immaginare quanto altro sapere debba essere andato disperso nel confronto con istituzioni culturali come minimo fossilizzate e distratte, e più spesso governate da logiche lobbistiche. È quindi Abel, cui fu recapitata la nomina ad una cattedra all’università di Berlino due giorni dopo che era morto praticamente di stenti, l’uomo di agosto. Credo che per i musicisti valga almeno in parte quanto ho già detto per i pittori e gli artisti in generale. Il rischio è la ripetitività. E tuttavia la reazione indotta è diversa: un ascoltatore è portato a cercare e ad apprezzare il riconoscimento di una particolare “impronta”. L’ambizione di ogni musicofilo è di riconoscere da quattro note prese a caso qualsiasi sinfonia. Ora, non voglio infilarmi in speculazioni per le quali non ho gli strumenti, ma mi sembra ovvio che nasca tutto dalla diversa modalità della percezione. Nell’ascolto entra in ballo il tempo anziché lo spazio. Mentre i colori e forme sono fissati e immobili, i suoni arrivano in sequenza, viaggiano, e sono resi più significativi proprio dal loro ritorno. Ho trovato qualche giorno fa questa considerazione (di un pittore che ama la musica): “Il brano mi provoca l’emozione in quanto ce l’ho dentro, lo conosco e so che di lì a poco, mentre ascolto il susseguirsi delle note iniziali, sta per arrivare la parte che mi colpisce maggiormente. È come quando aspetti una persona cara alla stazione, e sai che quando il treno si ferma scenderà, a momenti”. Rende bene l’idea. È vero che mi procura emozione anche vedere un dipinto, e che se si tratta di un’opera che amo particolarmente questa emozione si ripete ad ogni nuovo incontro; ma non posso negare che di fronte alla sua “immobilità” si attivi anche la razionalità analitica, che mi spinge di volta in volta a coglierne sempre più i dettagli anziché l’assieme. Questo mi spiega perché, ad esempio, dell’impressionismo apprezzi più l’espressione musicale (Ravel, Debussy, …) che non quella pittorica. E perché all’epoca avessi scelto George Bizet come uomo di settembre.
Credo che per i musicisti valga almeno in parte quanto ho già detto per i pittori e gli artisti in generale. Il rischio è la ripetitività. E tuttavia la reazione indotta è diversa: un ascoltatore è portato a cercare e ad apprezzare il riconoscimento di una particolare “impronta”. L’ambizione di ogni musicofilo è di riconoscere da quattro note prese a caso qualsiasi sinfonia. Ora, non voglio infilarmi in speculazioni per le quali non ho gli strumenti, ma mi sembra ovvio che nasca tutto dalla diversa modalità della percezione. Nell’ascolto entra in ballo il tempo anziché lo spazio. Mentre i colori e forme sono fissati e immobili, i suoni arrivano in sequenza, viaggiano, e sono resi più significativi proprio dal loro ritorno. Ho trovato qualche giorno fa questa considerazione (di un pittore che ama la musica): “Il brano mi provoca l’emozione in quanto ce l’ho dentro, lo conosco e so che di lì a poco, mentre ascolto il susseguirsi delle note iniziali, sta per arrivare la parte che mi colpisce maggiormente. È come quando aspetti una persona cara alla stazione, e sai che quando il treno si ferma scenderà, a momenti”. Rende bene l’idea. È vero che mi procura emozione anche vedere un dipinto, e che se si tratta di un’opera che amo particolarmente questa emozione si ripete ad ogni nuovo incontro; ma non posso negare che di fronte alla sua “immobilità” si attivi anche la razionalità analitica, che mi spinge di volta in volta a coglierne sempre più i dettagli anziché l’assieme. Questo mi spiega perché, ad esempio, dell’impressionismo apprezzi più l’espressione musicale (Ravel, Debussy, …) che non quella pittorica. E perché all’epoca avessi scelto George Bizet come uomo di settembre. Le due categorie successive risultano in realtà un po’ forzate e non del tutto congruenti con il progetto dell’almanacco. Quella dei personaggi dello sport, ad esempio, per la quale avevo annotato i nomi di Serse Coppi, di Stan Ockers, di Alessandro Fantini e di Tommy Simpson (quest’ultimo poi inserito anche nella lista ristretta), non ha molto senso. È evidente che uno sportivo a quarant’anni deve aver già dato tutto il meglio di sé, sia esso un pugile o un ciclista. A meno di far rientrare nella categoria i giocatori di scacchi, quelli di bocce o quelli di biliardo. Io avevo pescato solo nel mio sport preferito. Ci sarebbe stata anche la boxe, e lì il problema non era certo quello di trovare atleti morti prematuramente: negli ultimi centotrenta anni ne sono deceduti sul ring più di seicento. Era piuttosto di trovare un senso, una giustificazione a queste morti, che infatti non ne hanno. I ciclisti che ho nominato sono scomparsi invece all’apice di sfolgoranti carriere, due di loro erano stati campioni del mondo, tutti avevano vinto grandi classiche. La loro parabola era almeno parzialmente compiuta. Sono rimasti nella storia dello sport come dei vincenti. Tutto sommato è giusto che illustrino il mese di ottobre, quello in cui si chiudono le competizioni su strada e si fanno i bilanci.
Le due categorie successive risultano in realtà un po’ forzate e non del tutto congruenti con il progetto dell’almanacco. Quella dei personaggi dello sport, ad esempio, per la quale avevo annotato i nomi di Serse Coppi, di Stan Ockers, di Alessandro Fantini e di Tommy Simpson (quest’ultimo poi inserito anche nella lista ristretta), non ha molto senso. È evidente che uno sportivo a quarant’anni deve aver già dato tutto il meglio di sé, sia esso un pugile o un ciclista. A meno di far rientrare nella categoria i giocatori di scacchi, quelli di bocce o quelli di biliardo. Io avevo pescato solo nel mio sport preferito. Ci sarebbe stata anche la boxe, e lì il problema non era certo quello di trovare atleti morti prematuramente: negli ultimi centotrenta anni ne sono deceduti sul ring più di seicento. Era piuttosto di trovare un senso, una giustificazione a queste morti, che infatti non ne hanno. I ciclisti che ho nominato sono scomparsi invece all’apice di sfolgoranti carriere, due di loro erano stati campioni del mondo, tutti avevano vinto grandi classiche. La loro parabola era almeno parzialmente compiuta. Sono rimasti nella storia dello sport come dei vincenti. Tutto sommato è giusto che illustrino il mese di ottobre, quello in cui si chiudono le competizioni su strada e si fanno i bilanci. L’eroe-simbolo del mese di novembre è dunque Garfield, del quale riporto una battuta tratta da Il postino suona sempre due volte: “È come quando stai aspettando una lettera che non vedi l’ora di ricevere, e tu fai su e giù davanti alla porta per paura di non sentire il postino. Non tieni conto che il postino suona sempre due volte”.
L’eroe-simbolo del mese di novembre è dunque Garfield, del quale riporto una battuta tratta da Il postino suona sempre due volte: “È come quando stai aspettando una lettera che non vedi l’ora di ricevere, e tu fai su e giù davanti alla porta per paura di non sentire il postino. Non tieni conto che il postino suona sempre due volte”. Se qualcuno è riuscito a seguirmi sino a questo punto si sarà accorto che non ho ancora citato una sola figura femminile. Nella lista originaria in realtà alcuni nomi di donna c’erano, ma ho preferito raggrupparli in una categoria e in un mese a parte. Senza alcun intento discriminatorio, checché se ne vorrà pensare: se non avessi fatto così avrei rischiato davvero di non citarle o di lasciarle a margine. Nella lista compaiono i nomi di Ada Lovelace, la figlia di Byron, una matematica che già nella prima metà dell’Ottocento aveva contribuito alla realizzazione della prima macchina analitica, un rudimentale computer; di Rosalind Franklin, che scoprì il DNA ma venne vergognosamente esclusa da un Nobel strameritato, di Charlotte Brönte, delle viaggiatrici Isabelle Eberhardt, Annemarie Swarzenbach e Amelia Earhart, e infine quello di Simone Weil, poi transitato nell’elenco ristretto, per la filosofia. Sulla Weil, che era stata oggetto del mio primo (ed unico) corso tenuto all’università, sono tornato a più riprese, anche ultimamente, prendendo a dire il vero una sempre maggiore distanza. Non è dunque lei la regina di dicembre. In un libro letto recentemente
Se qualcuno è riuscito a seguirmi sino a questo punto si sarà accorto che non ho ancora citato una sola figura femminile. Nella lista originaria in realtà alcuni nomi di donna c’erano, ma ho preferito raggrupparli in una categoria e in un mese a parte. Senza alcun intento discriminatorio, checché se ne vorrà pensare: se non avessi fatto così avrei rischiato davvero di non citarle o di lasciarle a margine. Nella lista compaiono i nomi di Ada Lovelace, la figlia di Byron, una matematica che già nella prima metà dell’Ottocento aveva contribuito alla realizzazione della prima macchina analitica, un rudimentale computer; di Rosalind Franklin, che scoprì il DNA ma venne vergognosamente esclusa da un Nobel strameritato, di Charlotte Brönte, delle viaggiatrici Isabelle Eberhardt, Annemarie Swarzenbach e Amelia Earhart, e infine quello di Simone Weil, poi transitato nell’elenco ristretto, per la filosofia. Sulla Weil, che era stata oggetto del mio primo (ed unico) corso tenuto all’università, sono tornato a più riprese, anche ultimamente, prendendo a dire il vero una sempre maggiore distanza. Non è dunque lei la regina di dicembre. In un libro letto recentemente