Wilkie Collins. Donne, diamanti e passeggiate oziose
di Paolo Repetto, 6 dicembre 2024
Appena ho accennato che su Wilkie Collins (1814-1889) avevo anch’io qualcosa da dire, a Vittorio non è parso vero ammollarmi l’ultimo capitoletto della sua rubrica. E così mi ritrovo a parlarvi di un libro letto tantissimi anni fa, e mai più riletto: ma anche di un autore che solo recentemente ho scoperto aver scritto dei gustosissimi diari di viaggio. Per cui questa recensione si dividerà in due parti, la prima dedicata al giallista e la seconda mirata a scoprire il viaggiatore.

Dalle nostre parti Wilkie Collins non gode di grande notorietà, anche se moltissimi dei suoi romanzi e dei suoi racconti sono disponibili in italiano (il più famoso dei primi, La pietra di luna, è stato edito in ben tredici traduzioni diverse), Forse ha pesato sulla scarsa fortuna italica dell’autore proprio l’etichetta di antesignano della letteratura poliziesca, un genere che qui da noi continua ad essere considerato bene o male di serie B.
In realtà Collins non è un giallista: o almeno, lui non sapeva di esserlo, e credo che nemmeno ci avrebbe tenuto. Scriveva storie di fantasmi e di misteri, nel solco della tradizione romantica, e influenzato senza dubbio dal suo amico Charles Dickens: ma infarciva i contenuti di tematiche sociali e psicologiche, mentre il suo stile lo apparentava piuttosto ai pre-raffaelliti (con molti dei quali era in relazione di amicizia) che agli autori “realisti” suoi contemporanei. Proprio in relazione al tipo e all’oggetto della sua scrittura fu coniato il termine di “sensation novel”. Tuttavia può entrare di diritto nella nostra galleria per aver strutturato quasi tutte le sue opere, anche quelle che con la giallistica non hanno nulla a che fare, sul modello dell’indagine poliziesca.
 L’opera più riuscita di Collins è considerata La donna in bianco (1860), che gioca tutto sulla misteriosa e inquietante somiglianza tra due donne che non si conoscono. La spiegazione del mistero arriverà solo al termine di una ricerca ricca di suspence e del susseguirsi di molteplici colpi di scena. La vera novità consiste però nel fatto che il romanzo ha la forma di un racconto corale, nel quale sono diversi testimoni a “deporre” circa la loro conoscenza dei fatti.
L’opera più riuscita di Collins è considerata La donna in bianco (1860), che gioca tutto sulla misteriosa e inquietante somiglianza tra due donne che non si conoscono. La spiegazione del mistero arriverà solo al termine di una ricerca ricca di suspence e del susseguirsi di molteplici colpi di scena. La vera novità consiste però nel fatto che il romanzo ha la forma di un racconto corale, nel quale sono diversi testimoni a “deporre” circa la loro conoscenza dei fatti.
 Qui prendiamo tuttavia in esame il romanzo forse più famoso, La pietra di Luna. La vicenda è assai complessa, anche in questo caso viene raccontata da più voci diverse, proposte attraverso le relazioni o le lettere di una decina di personaggi, e procede a ritroso: la verità la si scopre cioè frugando nel passato. C’è di mezzo un diamante grosso come un uovo, la Pietra di Luna appunto, trafugato in un tempio induista da un generale delle forze coloniali inglesi e lasciato in eredità ad una nipote. Ci sono un giovane onesto e un po’ sprovveduto, innamorato della ragazza, che ad un certo punto viene ingiustamente accusato di aver fatto sparire il prezioso, e un altro spasimante, una perfetta carogna, vero responsabile della sparizione. Ci sono anche tre bramini arrivati dritti dritti dall’India per recuperare il sacro talismano, che si muovono nell’ombra. Insomma, c’è tutto ciò serve che per farne un feuilleton con sfumature poliziesche (e infatti del romanzo sono state fatte varie versioni cinematografiche e televisive, una anche in Italia nel 1974, che all’epoca mi era parsa inguardabile – e tanto più probabilmente lo sarà oggi). Alla fine c’è naturalmente l’happy end, i misteri si sciolgono, i buoni hanno la loro rivincita, i bramini il loro diamante, lo spasimante sciagurato e fellone fa la fine che si merita.
Qui prendiamo tuttavia in esame il romanzo forse più famoso, La pietra di Luna. La vicenda è assai complessa, anche in questo caso viene raccontata da più voci diverse, proposte attraverso le relazioni o le lettere di una decina di personaggi, e procede a ritroso: la verità la si scopre cioè frugando nel passato. C’è di mezzo un diamante grosso come un uovo, la Pietra di Luna appunto, trafugato in un tempio induista da un generale delle forze coloniali inglesi e lasciato in eredità ad una nipote. Ci sono un giovane onesto e un po’ sprovveduto, innamorato della ragazza, che ad un certo punto viene ingiustamente accusato di aver fatto sparire il prezioso, e un altro spasimante, una perfetta carogna, vero responsabile della sparizione. Ci sono anche tre bramini arrivati dritti dritti dall’India per recuperare il sacro talismano, che si muovono nell’ombra. Insomma, c’è tutto ciò serve che per farne un feuilleton con sfumature poliziesche (e infatti del romanzo sono state fatte varie versioni cinematografiche e televisive, una anche in Italia nel 1974, che all’epoca mi era parsa inguardabile – e tanto più probabilmente lo sarà oggi). Alla fine c’è naturalmente l’happy end, i misteri si sciolgono, i buoni hanno la loro rivincita, i bramini il loro diamante, lo spasimante sciagurato e fellone fa la fine che si merita.
 È un bel libro? Onestamente, non lo so. L’ho letto quasi sessant’anni fa, e per questa occasione l’ho soltanto risfogliato. All’epoca digerivo mattoni di ogni peso e dimensione (ma anche questo come spessore non scherza): credo che oggi non riuscirei ad arrivare sino in fondo. Ricordo comunque l’impressione generale che ne avevo tratto, che era di una certa lentezza, ma la cosa non fa testo: arrivavo fresco della lettura di Salgari e di Kim, ero avido di azione e di avventura, e il modo in cui l’opera era strutturata, ma soprattutto la presenza di una storia sentimentale, con protagonista una figura femminile incapace di apprezzare, la buonafede del protagonista, di andare al di là delle apparenze, non aiutava certamente. Inoltre Collins scrive bene, ma non è Kipling o Stevenson, e nemmeno Dickens, che pure oltre che un amico era il suo mentore, e ne apprezzava lo stile. Io poi l’ho letto in una traduzione d’anteguerra (s’intitolava Il diamante indiano, il traduttore era Alfredo Pitta – l’ho ritrovata su Wikipedia), e anche se all’epoca allo stile badavo poco e Pitta era un eccellente traduttore, la trasposizione in italiano pesava parecchio (ho una mia teoria sulle trasformazioni minime subite dalla lingua inglese negli ultimi due secoli, al contrario di quanto è avvenuto per quella italiana.
È un bel libro? Onestamente, non lo so. L’ho letto quasi sessant’anni fa, e per questa occasione l’ho soltanto risfogliato. All’epoca digerivo mattoni di ogni peso e dimensione (ma anche questo come spessore non scherza): credo che oggi non riuscirei ad arrivare sino in fondo. Ricordo comunque l’impressione generale che ne avevo tratto, che era di una certa lentezza, ma la cosa non fa testo: arrivavo fresco della lettura di Salgari e di Kim, ero avido di azione e di avventura, e il modo in cui l’opera era strutturata, ma soprattutto la presenza di una storia sentimentale, con protagonista una figura femminile incapace di apprezzare, la buonafede del protagonista, di andare al di là delle apparenze, non aiutava certamente. Inoltre Collins scrive bene, ma non è Kipling o Stevenson, e nemmeno Dickens, che pure oltre che un amico era il suo mentore, e ne apprezzava lo stile. Io poi l’ho letto in una traduzione d’anteguerra (s’intitolava Il diamante indiano, il traduttore era Alfredo Pitta – l’ho ritrovata su Wikipedia), e anche se all’epoca allo stile badavo poco e Pitta era un eccellente traduttore, la trasposizione in italiano pesava parecchio (ho una mia teoria sulle trasformazioni minime subite dalla lingua inglese negli ultimi due secoli, al contrario di quanto è avvenuto per quella italiana.
Comunque, La Pietra di Luna conobbe alla sua uscita un incredibile successo, ma non fu una rivelazione: come ho anticipato Collins aveva già pubblicato anni prima quella che è probabilmente la sua opera più importante, La donna in bianco, e una serie di altri romanzi che gli avevano procurato una certa notorietà presso il grande pubblico.
E non era noto solo per le sue opere, ma anche per le sue stranezze. La natura non lo aveva trattato coi guanti. Era di statura men che mediocre, con una testa sproporzionatamente grande rispetto al corpo; inoltre un’evidente protuberanza gli deformava da un lato il capo. Era miope e goffo nei movimenti, e a partire dai trent’anni si rivelò affetto da una forma di diabete cui certamente non giovavano le abitudini di vita disordinate (l’alcool, l’amore per la buona cucina e per il sesso, il laudano. Quest’ultimo soprattutto: negli ultimi anni per lenire i crescenti dolori ne assumeva dosi che avrebbero stroncato un cavallo). Fin da giovanissimo sfidò tranquillamente tutte le convenzioni borghesi, nell’abbigliamento, nei rapporti (visse praticamente da bigamo, con una situazione sentimentale incasinatissima, ma che lui reggeva con estrema naturalezza), nelle tematiche affrontate. Nei suoi romanzi si parla ad esempio dei problemi connessi all’handicap fisico, di ossessioni sessuali narrate senza reticenze, dei lati oscuri dell’animo umano e di quello ipocrita della società vittoriana, delle conseguenze dei disturbi mentali e degli orrori della cronaca nera, ecc… Insomma, sembra che Collins abbia preso di petto la sua scarsa rispondenza ai canoni estetici e comportamentali dell’epoca per mettere questi ultimi in discussione senza troppi problemi, anzi, per infischiarsene tranquillamente. Ufficialmente era scapolo ma in realtà visse per trent’anni legato a due donne contemporaneamente, senza preoccuparsi dello scandalo: così come non si preoccupava delle critiche negative con le quali erano accolte ad esempio alcune sue commedie: se le rappresentazioni si rivelavano un fiasco, semplicemente riponeva il tutto nel cassetto e partiva a scriverne un’altra.
Torniamo però a La Pietra di Luna. Il romanzo fu pubblicato nel 1868 e secondo T.S. Eliot era “il primo, il più lungo e il migliore dei romanzi polizieschi inglesi”. Eliot giudicava infatti il sergente Cuff, colui che conduce l’inchiesta, come il detective perfetto, superiore a Sherlock Holmes, in quanto “persona viva e vera, brillante senza essere infallibile”. Altri invece hanno classificato l’opera come “romanzo epistolare”, esemplare raro nella tradizione letteraria britannica. E altri ancora come un preludio al decadentismo.
Insomma, questa recensione improvvisata credo mi indurrà a riprendere seriamente in mano il libro, per riscoprirlo. Per il momento però questo piacere lo lascio a voi.
****

Io volevo invece parlare di Wilkie Collins come scrittore di libri di viaggio. Per farlo devo fornire qualche ulteriore ragguaglio sulla sua biografia. La fortuna di Collins, che aveva cercato dapprima la sua strada nella pittura (era figlio e fratello di pittori affermati) senza ottenere grossi risultati, fu incontrare nel 1851 Charles Dickens, che conquistato dalla verve, dall’intelligenza e anche dalla spregiudicatezza del nostro lo invitò a scrivere sulla rivista letteraria della quale era editore e direttore. La collaborazione divenne ben presto un’amicizia destinata a durare a lungo, incrementata anche dallo stabilirsi di un rapporto di parentela indiretta (il fratello minore di Wilkie aveva sposato la figlia di Dickens) e cementata soprattutto dai viaggi che i due intrapresero assieme.
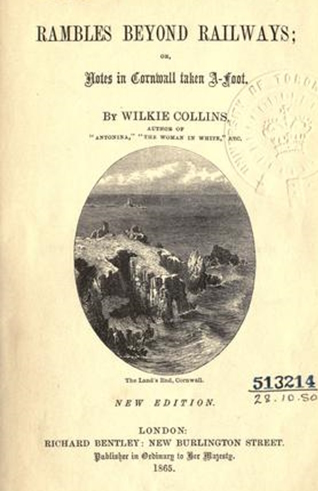 Collins aveva già viaggiato in precedenza, girando appena adolescente con la famiglia per un anno e mezzo in Italia in Francia, e tornando a più riprese sul continente negli anni successivi. Nel 1850, seguendo una moda che aveva preso piede nell’isola, aveva percorso insieme ad un amico, Henry Brandling, un itinerario a piedi attraverso la Cornovaglia. Brandling avrebbe poi illustrato il diario dato alle stampe da Wilkie col titolo Rambles beyond Railways (Passeggiate oltre la ferrovia), e proprio la lettura di quel diario aveva spinto Dickens a cercare di conoscerne l’autore. Nell’estate del 1853 l’amicizia tra i due era ormai così consolidata da indurli a partire, assieme al pittore Augustus Egg, per un lungo viaggio in Svizzera e in Italia, del quale entrambi lasciarono un resoconto attraverso le lettere.
Collins aveva già viaggiato in precedenza, girando appena adolescente con la famiglia per un anno e mezzo in Italia in Francia, e tornando a più riprese sul continente negli anni successivi. Nel 1850, seguendo una moda che aveva preso piede nell’isola, aveva percorso insieme ad un amico, Henry Brandling, un itinerario a piedi attraverso la Cornovaglia. Brandling avrebbe poi illustrato il diario dato alle stampe da Wilkie col titolo Rambles beyond Railways (Passeggiate oltre la ferrovia), e proprio la lettura di quel diario aveva spinto Dickens a cercare di conoscerne l’autore. Nell’estate del 1853 l’amicizia tra i due era ormai così consolidata da indurli a partire, assieme al pittore Augustus Egg, per un lungo viaggio in Svizzera e in Italia, del quale entrambi lasciarono un resoconto attraverso le lettere.
 Di qualche anno posteriore (1857) è invece la pubblicazione di un libro scritto a quattro mani, The Lazy Tour of Two Idle Apprentices (tradotto in italiano quarantacinque anni dopo come Il pigro viaggio di due apprendisti oziosi). Vi si racconta la vacanza spensierata che i due letterati si erano concessi, presumibilmente un paio d’anni prima, vagabondando senza alcuna meta prefissata dalla Cumbria allo Yorkshire, spostandosi in treno per fare tappa nelle diverse stazioni e girovagando poi su carrozzini o a piedi per le campagne circostanti. “I giovani fuorviati che così si sottrassero al loro dovere verso la padrona da cui avevano ricevuto molti favori (ndr: la letteratura), erano spinti dalla bassa idea di fare un viaggio perfettamente ozioso, in qualsiasi direzione. Non avevano intenzione di andare da nessuna parte in particolare; non volevano vedere nulla, non volevano sapere nulla, non volevano imparare nulla, non volevano fare nulla. Volevano solo essere oziosi”. Sono talmente decisi a lasciarsi alle spalle le grane del lavoro e lo stress della metropoli da assumere persino per l’occasione del viaggio identità nuove, scegliendosi nomi ad hoc. Dickens diventa pertanto Mr Francis Goodchild, Collins Mr Thomas Idle. E questo, ai fini della narrazione, consente a entrambi di essere liberamente sia autoironici che critici l’uno dell’altro, sottolineando e accentuando reciprocamente manie e difetti.
Di qualche anno posteriore (1857) è invece la pubblicazione di un libro scritto a quattro mani, The Lazy Tour of Two Idle Apprentices (tradotto in italiano quarantacinque anni dopo come Il pigro viaggio di due apprendisti oziosi). Vi si racconta la vacanza spensierata che i due letterati si erano concessi, presumibilmente un paio d’anni prima, vagabondando senza alcuna meta prefissata dalla Cumbria allo Yorkshire, spostandosi in treno per fare tappa nelle diverse stazioni e girovagando poi su carrozzini o a piedi per le campagne circostanti. “I giovani fuorviati che così si sottrassero al loro dovere verso la padrona da cui avevano ricevuto molti favori (ndr: la letteratura), erano spinti dalla bassa idea di fare un viaggio perfettamente ozioso, in qualsiasi direzione. Non avevano intenzione di andare da nessuna parte in particolare; non volevano vedere nulla, non volevano sapere nulla, non volevano imparare nulla, non volevano fare nulla. Volevano solo essere oziosi”. Sono talmente decisi a lasciarsi alle spalle le grane del lavoro e lo stress della metropoli da assumere persino per l’occasione del viaggio identità nuove, scegliendosi nomi ad hoc. Dickens diventa pertanto Mr Francis Goodchild, Collins Mr Thomas Idle. E questo, ai fini della narrazione, consente a entrambi di essere liberamente sia autoironici che critici l’uno dell’altro, sottolineando e accentuando reciprocamente manie e difetti.
In realtà il racconto dei due apprendisti oziosi sembra soprattutto un pretesto offerto agli autori per introdurre intermezzi di storie del fantastico, del mistero e del soprannaturale, narrate durante le soste del viaggio: anche se poi alcuni episodi, come l’ascensione sotto la pioggia alla montagna nera di Carrok Fells e la successiva discesa nella nebbia più fitta sono davvero pezzi da antologia dello humor britannico, degni del miglior Jerome.
Il libro è diviso in cinque capitoli, ciascuno dei quali ha una sua autonomia narrativa (dovuta anche al fatto che originariamente la storia era stata pubblicata a puntate su una rivista) ed è giocato sul contrasto tra i caratteri dei due: l’uno (Goodchild), iperattivo e nevrotico, portato a trasfigurare visionariamente gli accadimenti e gli incontri e a cogliere i particolari: “Goodchild era laboriosamente pigro, e si sarebbe preso su di sé qualsiasi quantità di fatica e lavoro per assicurarsi di essere pigro; in breve, non aveva un’idea migliore dell’ozio di quella che fosse un’inutile industria”; l’altro (Idle), indolente e tranquillo, realista e poco o nulla incline all’avventura. “Thomas Idle, d’altro canto, era un pigro del tipo irlandese o napoletano puro; un pigro passivo, un pigro nato e cresciuto, un pigro coerente, che praticava ciò che avrebbe predicato se non fosse stato troppo pigro per predicare; un intero e perfetto crisolito di ozio.”
Qui ci starebbe ora una bella tirata sull’idea di “ozio”, paragonabile in qualche maniera a quella latina di Cicerone e di Orazio, coltivata da altri scrittori inglesi come Stevenson e appunto Jerome: ma ve la risparmio, credo di averne già abbondantemente trattato in un altro pezzo (cfr. Per strada senza ombrello). Nel libro di cui sto parlando è naturalmente Collins a teorizzarla e a spingerla sino alle sue implicazioni più radicali: “Questi due avevano spedito il loro bagaglio personale in treno: tenendo solo uno zaino a testa. Idle ora si applicava a rimpiangere costantemente il treno, a seguirlo attraverso i meandri della Guida di Bradshaw e a scoprire dove si trovava ora, e dove ora, e dove ora, e a chiedersi a cosa servisse camminare, quando si poteva procedere a un ritmo del genere. Era per vedere il paese? Se era quello lo scopo, guardatelo dai finestrini della carrozza. C’era molto di più da vedere lì che qui. Inoltre, chi voleva vedere il paese? Nessuno. E ancora, chi camminava? Nessuno. I ragazzi partivano per camminare, ma non lo facevano mai. Tornavano e dicevano di averlo fatto, ma non lo facevano. Allora perché avrebbe dovuto camminare? Non avrebbe camminato. Lo giurava su questa pietra miliare!”.

A dispetto dei caratteri contrastanti, o forse proprio in ragione di essi, i due risultano perfettamente complementari. Dickens-Goodchild marcia instancabile e inossidabile al suo ritmo, vede mete interessanti ovunque ed escogita sempre nuove occasioni per testare il livello della propria “laboriosa” oziosità. Collins Idle oppone resistenza passiva, ma è troppo pigro anche per resistere, e finisce costantemente coinvolto. “Goodchild (che aveva già iniziato a dubitare di essere pigro: come è sempre il suo modo di fare quando non ha niente da fare) aveva letto di una certa vecchia collina o montagna nera del Cumberland, chiamata Carrock, o Carrock Fell; ed era giunto alla conclusione che sarebbe stato il trionfo culminante dell’Ozio scalarla. Thomas Idle, soffermandosi sulle pene inseparabili da quella conquista, aveva espresso i più forti dubbi sull’opportunità, e persino sulla sanità mentale, dell’impresa; ma Goodchild aveva vinto la sua battaglia, e se ne andarono.”
A condurre il gioco della narrazione, almeno per la parte diaristica, è però lui. Lo si desume dal fatto che è quasi sempre lui a proporre sconsolate considerazioni su ciò che sta accadendo, e a stigmatizzare così l’iperattivismo del compagno: “Non sei capace di divertirti. Non sai nemmeno cosa sia. Di ogni cosa fai un lavoro. Quando un altro si bagnerebbe la punta del piede nell’azione o nelle emozioni, tu ci sprofondi dentro. Un uomo che non può fare niente a metà mi sembra terribile”.
Le note paesaggistiche, antropologiche o di costume sembrano invece venire dagli occhi e dalla penna di Dickens: “L’oste non era abbastanza pigro, non era affatto pigro, il che era un suo grande difetto, ma era un bell’esemplare di uomo del nord, o di qualsiasi altro tipo di uomo. Aveva una guancia rubiconda, un occhio luminoso, una corporatura robusta, una mano immensa, una voce allegra e parlante e uno sguardo dritto, luminoso e ampio”.
Oppure “Buone case resistenti alle intemperie, calde e piacevoli, ben intonacate di calce bianca, punteggiano scarsamente la strada. Bambini puliti che escono per guardare, portando altri bambini puliti grandi quanto loro. Raccolto ancora in giro e molto piovuto; qua e là, raccolto ancora non mietuto. Giardini ben coltivati annessi ai cottage, con abbondanza di prodotti forzati fuori dal loro duro terreno. Angoli solitari e selvaggi; ma le persone possono nascere, sposarsi e seppellirsi in tali angoli, e possono vivere e amare ed essere amate, lì come altrove, grazie a Dio! (Osservazione del signor Goodchild)”.
 E ancora: “Qui, di nuovo, c’erano stazioni con niente in funzione se non una campana, e meravigliosi rasoi di legno piazzati in alto su grandi pali, che radevano l’aria. In questi campi, i cavalli, le pecore e il bestiame erano ben abituati al meteorite tonante, e non ci facevano caso; in quelli, erano tutti insieme a correre e una mandria di maiali li inseguiva. La campagna pastorale si oscurò, divenne carbonifera, fumosa, infernale, migliorò, peggiorò, migliorò di nuovo, divenne aspra, divenne romantica; era un bosco, un ruscello, una catena di colline, una gola, una brughiera, una città cattedrale, un luogo fortificato, una landa desolata. Ora, miserabili abitazioni nere, un canale nero e torri nere e malate di camini; ora, un giardino curato, dove i fiori erano luminosi e belli; ora, una landa desolata di orribili altari tutti in fiamme; ora, i prati umidi con i loro anelli delle fate; ora, la macchia rognosa di terreno edificabile incolto fuori dalla città stagnante, con l’anello più grande dove la settimana scorsa c’era il Circo. La temperatura cambiò, il dialetto cambiò, la gente cambiò, i volti si fecero più affilati, i modi si fecero più corti, gli occhi più astuti e duri”.
E ancora: “Qui, di nuovo, c’erano stazioni con niente in funzione se non una campana, e meravigliosi rasoi di legno piazzati in alto su grandi pali, che radevano l’aria. In questi campi, i cavalli, le pecore e il bestiame erano ben abituati al meteorite tonante, e non ci facevano caso; in quelli, erano tutti insieme a correre e una mandria di maiali li inseguiva. La campagna pastorale si oscurò, divenne carbonifera, fumosa, infernale, migliorò, peggiorò, migliorò di nuovo, divenne aspra, divenne romantica; era un bosco, un ruscello, una catena di colline, una gola, una brughiera, una città cattedrale, un luogo fortificato, una landa desolata. Ora, miserabili abitazioni nere, un canale nero e torri nere e malate di camini; ora, un giardino curato, dove i fiori erano luminosi e belli; ora, una landa desolata di orribili altari tutti in fiamme; ora, i prati umidi con i loro anelli delle fate; ora, la macchia rognosa di terreno edificabile incolto fuori dalla città stagnante, con l’anello più grande dove la settimana scorsa c’era il Circo. La temperatura cambiò, il dialetto cambiò, la gente cambiò, i volti si fecero più affilati, i modi si fecero più corti, gli occhi più astuti e duri”.
Per concludere però torno a Collins: “Sdraiato sul divano, Thomas non fece alcun tentativo di superare le ore, ma lasciò passivamente che le ore lo attraversassero. Laddove altri uomini nella sua situazione avrebbero letto libri e migliorato le loro menti, Thomas dormiva e riposava il suo corpo. Laddove altri uomini avrebbero meditato ansiosamente sulle loro prospettive future, Thomas sognava pigramente la sua vita passata. L’unica cosa solitaria che fece, che la maggior parte delle altre persone avrebbe fatto al suo posto, fu di decidere di apportare alcune modifiche e miglioramenti al suo modo di esistere, non appena gli effetti della sventura che lo aveva colpito fossero tutti passati. Ricordando che la corrente della sua vita fino a quel momento era fluita in un fluido flusso di pigrizia, occasionalmente turbata in superficie da una leggera increspatura passeggera di operosità, le sue idee attuali sull’argomento dell’auto-riforma lo portarono, non come il lettore potrebbe essere portato a immaginare, a progettare progetti per una nuova esistenza di intraprendenza e impegno, ma, al contrario, a decidere che non sarebbe mai più stato attivo o industrioso, se solo avesse potuto evitarlo, per tutta la sua futura carriera”.
A dispetto di quanto si vorrebbe pensare, una enunciazione di questo tenore non è affatto improbabile o esagerata, non c’è alcuna forzatura letteraria. Mi ha immediatamente fatto tornare alla memoria la dichiarazione d’intenti pronunciata da un amico che di Thomas Idle avrebbe potuto essere il gemello, in una notte di capodanno di molti anni fa festeggiata al Capanno, quando gli riuscì di rialzare la testa tra due lunghi abbiocchi: “Ho deciso: – disse – dal prossimo anno non lavoro più”. Che, considerati i precedenti, è considerata la miglior battuta del secolo scorso.
Il libro nel suo assieme invece mi ha fatto ricordare proprio quelle notti, e il profumo genuino e intenso di amicizia che vi si respirava, Ce n’è abbastanza per essere grato per sempre a Thomas Idle.






 Non fatevi ingannare da questa foto di Milne (Gran Bretagna, 1882 – 1956), ma è l’unica che ho trovato riproducibile. In base a questa foto, potreste pensare d’essere di fronte a un emulo di Sherlock Holmes. Invece Milne ha scritto un solo romanzo giallo nel 1922, The Red House Mistery (nella versione inglese), Il Dramma di Corte Rossa nell’edizione italiana, che personalmente non mi è dispiaciuto ma verso il quale ero predisposto ad affrontare uno di quei romanzi (come scriveva Buchan, vedi
Non fatevi ingannare da questa foto di Milne (Gran Bretagna, 1882 – 1956), ma è l’unica che ho trovato riproducibile. In base a questa foto, potreste pensare d’essere di fronte a un emulo di Sherlock Holmes. Invece Milne ha scritto un solo romanzo giallo nel 1922, The Red House Mistery (nella versione inglese), Il Dramma di Corte Rossa nell’edizione italiana, che personalmente non mi è dispiaciuto ma verso il quale ero predisposto ad affrontare uno di quei romanzi (come scriveva Buchan, vedi  «Questo libro potrà irritare il lettore, o sembrargli altrimenti piacevole. Perché è il condensato di tutto quanto non si sopporta più in un poliziesco. È talmente datato da sembrare un pezzo di antiquariato […] è il rispettabile capostipite di una lunga e alla fine lagnosa famiglia di britannici gialli campestri, arredati da personaggi fissi […] ricchi proprietari, colonnelli a riposo, esquires, servitù, treni locali e gioielli, rette ragazze, deboli dandies, ponderati poliziotti locali. Gli ingredienti di questa Arcadia gialla compaiono identici e blandamente dissacrati nei romanzi umoristici di Woodhouse… Erano gialli ‘‘perbene’’, insomma, e si deve dire che fu una cosciente e redditizia conversione editoriale di classe. Tutti gli anni Trenta sono farciti di questi romanzi, nonostante i gialli americani, nonostante Simenon”.
«Questo libro potrà irritare il lettore, o sembrargli altrimenti piacevole. Perché è il condensato di tutto quanto non si sopporta più in un poliziesco. È talmente datato da sembrare un pezzo di antiquariato […] è il rispettabile capostipite di una lunga e alla fine lagnosa famiglia di britannici gialli campestri, arredati da personaggi fissi […] ricchi proprietari, colonnelli a riposo, esquires, servitù, treni locali e gioielli, rette ragazze, deboli dandies, ponderati poliziotti locali. Gli ingredienti di questa Arcadia gialla compaiono identici e blandamente dissacrati nei romanzi umoristici di Woodhouse… Erano gialli ‘‘perbene’’, insomma, e si deve dire che fu una cosciente e redditizia conversione editoriale di classe. Tutti gli anni Trenta sono farciti di questi romanzi, nonostante i gialli americani, nonostante Simenon”. Ma la cosa più divertente è che a Milne di tutte queste chiacchiere non importò affatto. Il nostro infatti si è guadagnato il plauso e l’affetto di quasi tutti i bambini nati nella prima metà del ‘900, per aver inventato il dolcissimo personaggio di Winnie the Pooh, orsetto pupazzetto, che, accompagnato nei due libri dal disegnatore E. H. Shepard, fece la fortuna di Milne e delle sue generazioni successive, che ancora si dividono i diritti pagati dalla Disney almeno fino al 2027, con un successo planetario tra libri, cartoons, pellicole d’animazione e merchandising d’ogni tipo.
Ma la cosa più divertente è che a Milne di tutte queste chiacchiere non importò affatto. Il nostro infatti si è guadagnato il plauso e l’affetto di quasi tutti i bambini nati nella prima metà del ‘900, per aver inventato il dolcissimo personaggio di Winnie the Pooh, orsetto pupazzetto, che, accompagnato nei due libri dal disegnatore E. H. Shepard, fece la fortuna di Milne e delle sue generazioni successive, che ancora si dividono i diritti pagati dalla Disney almeno fino al 2027, con un successo planetario tra libri, cartoons, pellicole d’animazione e merchandising d’ogni tipo. Riprendo l’introduzione, a spizzichi e bocconi: “Il libro è scritto per lettori svagati, per gentili signore che non vogliono essere oppresse, per giovani che abbiano da riempire un’ora troppo calda, per vecchie signore che amano sonnecchiare […]”. Queste ultime considerazioni mi paiono un po’ troppo snob (io, in effetti, sono un vecchio signore che ama sonnecchiare, e allora?) e il libro non è così debole come sembra dipingerlo il recensore.
Riprendo l’introduzione, a spizzichi e bocconi: “Il libro è scritto per lettori svagati, per gentili signore che non vogliono essere oppresse, per giovani che abbiano da riempire un’ora troppo calda, per vecchie signore che amano sonnecchiare […]”. Queste ultime considerazioni mi paiono un po’ troppo snob (io, in effetti, sono un vecchio signore che ama sonnecchiare, e allora?) e il libro non è così debole come sembra dipingerlo il recensore.
 Non sto a tediarvi con le note sulla vita di Milne, non sono poi così interessanti, ma vi invito alla prossima puntata, l’ultima di questa piccola serie, che coinvolge il primo vero autore di romanzi gialli e il suo (lunghissimo …) capolavoro.
Non sto a tediarvi con le note sulla vita di Milne, non sono poi così interessanti, ma vi invito alla prossima puntata, l’ultima di questa piccola serie, che coinvolge il primo vero autore di romanzi gialli e il suo (lunghissimo …) capolavoro.
 Ho riletto I Trentanove Scalini ad anni di distanza dalla prima volta, perché è il romanzo più famoso di Buchan, il più facile da reperire, scorre veloce ed è leggero. Romanzo da ombrellone. Non è un giallo cervellotico, ha una trama piuttosto semplice e un epilogo immaginabile, ma, signori, è stato scritto nel 1915, quasi centodieci anni fa! Non è un’opera storica, che col tempo migliora, è un semplice giallo spionistico ambientato in gran parte nel sud rurale dell’Inghilterra ai primi del secolo scorso.
Ho riletto I Trentanove Scalini ad anni di distanza dalla prima volta, perché è il romanzo più famoso di Buchan, il più facile da reperire, scorre veloce ed è leggero. Romanzo da ombrellone. Non è un giallo cervellotico, ha una trama piuttosto semplice e un epilogo immaginabile, ma, signori, è stato scritto nel 1915, quasi centodieci anni fa! Non è un’opera storica, che col tempo migliora, è un semplice giallo spionistico ambientato in gran parte nel sud rurale dell’Inghilterra ai primi del secolo scorso. Il libro ebbe un enorme successo, e da questo romanzo Hitchcock trasse l’ispirazione per The 39 Steps, uscito in Italia nel 1935 col titolo Il Club dei 39, ottenendo anche in questo caso un grandissimo successo, e ispirando ben tre remakes, l’ultimo del 2008.
Il libro ebbe un enorme successo, e da questo romanzo Hitchcock trasse l’ispirazione per The 39 Steps, uscito in Italia nel 1935 col titolo Il Club dei 39, ottenendo anche in questo caso un grandissimo successo, e ispirando ben tre remakes, l’ultimo del 2008. L’autore ebbe davvero una vita intensa: nato a Perth nel 1875, in gioventù fu ottimo poeta, vincitore di alcuni premi letterari, poi si laureò in Legge, ma abbandonò subito l’attività legale per darsi alla politica. Fu Segretario di Arthur Milner, Amministratore delle colonie in Sud Africa, e gli anni trascorsi in quel paese gli servirono poi d’ispirazione per la sua carriera da romanziere.
L’autore ebbe davvero una vita intensa: nato a Perth nel 1875, in gioventù fu ottimo poeta, vincitore di alcuni premi letterari, poi si laureò in Legge, ma abbandonò subito l’attività legale per darsi alla politica. Fu Segretario di Arthur Milner, Amministratore delle colonie in Sud Africa, e gli anni trascorsi in quel paese gli servirono poi d’ispirazione per la sua carriera da romanziere. Morì nel 1940 in Canada, a Montreal, a seguito di uno sfortunato incidente in cui cadde battendo la testa e nonostante le cure e le operazioni non riuscì a ristabilirsi.
Morì nel 1940 in Canada, a Montreal, a seguito di uno sfortunato incidente in cui cadde battendo la testa e nonostante le cure e le operazioni non riuscì a ristabilirsi. Ho l’impressione che il target a cui si rivolge Buchan sia di livello più basso rispetto a quello che ci si poteva aspettare da un uomo colto come lui; volutamente più basso, per ottenere un successo inizialmente facile, che gli aprisse le porte alla pubblicazione di altri lavori e alla fama. Questo tipo di narrativa è un prodotto di massa, che si rivolge a lettori abituati ai romanzi a puntate che comparivano sulle riviste; e queste puntate devono contenere trame incalzanti, scrittura leggera, colpi di scena ad ogni uscita. Le ambientazioni spesso esotiche, i grandi complotti, le società segrete erano gli ingredienti più adatti per il palato di lettori che cercavano solo un’evasione non impegnata.
Ho l’impressione che il target a cui si rivolge Buchan sia di livello più basso rispetto a quello che ci si poteva aspettare da un uomo colto come lui; volutamente più basso, per ottenere un successo inizialmente facile, che gli aprisse le porte alla pubblicazione di altri lavori e alla fama. Questo tipo di narrativa è un prodotto di massa, che si rivolge a lettori abituati ai romanzi a puntate che comparivano sulle riviste; e queste puntate devono contenere trame incalzanti, scrittura leggera, colpi di scena ad ogni uscita. Le ambientazioni spesso esotiche, i grandi complotti, le società segrete erano gli ingredienti più adatti per il palato di lettori che cercavano solo un’evasione non impegnata.

 Perché parto subito in quarta? Perché questo libro, un giallo puro con un ispettore di Scotland Yard, con un assassinio e un’indagine, è di una complessità narrativa non indifferente; il tempo in nave non gli dev’essere mancato, per infilarci dentro tutti i particolari tipici del delitto ‘‘quasi’’ perfetto. La vicenda si svolge nell’immaginario College inglese di St Antony, dove di immaginario c’è solo il nome, perché l’ambiente è esattamente quello oxfordiano che Innes conosceva benissimo. L’uccisione di un anziano docente smuove le acque e porta a galla segreti, invidie e rivalità: per la scuola non è solo una tragedia, è la drammatica irruzione della volgarità in un ambiente che voleva credersi, e soprattutto apparire, immacolato. Il preside ne è sconvolto, mentre i colleghi del professor Umpleby (i sette sospettati) ne fanno un’occasione per gettarsi addosso l’un l’altro i sospetti e per confondere le idee dell’ispettore Appleby con falsi indizi e sotterfugi. Ma alla fine è l’ispettore, che inizialmente era piuttosto timoroso del confronto con tanta cultura accademica, a vincere nel gioco delle intelligenze e a dipanare la matassa. Il libro non è, tuttavia, un semplice esercizio intellettuale pretenzioso (lo avrei mollato subito), ma un racconto poliziesco ortodosso, anche se molto complesso e ingegnoso. Non nego che la lettura sia abbastanza complessa, e che in alcuni punti si avanzi a stento, ma l’ambientazione e i tempi della storia lo rendono comunque interessante. Il finale è giustificato da un percorso logico e perfettamente riconoscibile, pur nella baraonda generale creata dai vari indagati.
Perché parto subito in quarta? Perché questo libro, un giallo puro con un ispettore di Scotland Yard, con un assassinio e un’indagine, è di una complessità narrativa non indifferente; il tempo in nave non gli dev’essere mancato, per infilarci dentro tutti i particolari tipici del delitto ‘‘quasi’’ perfetto. La vicenda si svolge nell’immaginario College inglese di St Antony, dove di immaginario c’è solo il nome, perché l’ambiente è esattamente quello oxfordiano che Innes conosceva benissimo. L’uccisione di un anziano docente smuove le acque e porta a galla segreti, invidie e rivalità: per la scuola non è solo una tragedia, è la drammatica irruzione della volgarità in un ambiente che voleva credersi, e soprattutto apparire, immacolato. Il preside ne è sconvolto, mentre i colleghi del professor Umpleby (i sette sospettati) ne fanno un’occasione per gettarsi addosso l’un l’altro i sospetti e per confondere le idee dell’ispettore Appleby con falsi indizi e sotterfugi. Ma alla fine è l’ispettore, che inizialmente era piuttosto timoroso del confronto con tanta cultura accademica, a vincere nel gioco delle intelligenze e a dipanare la matassa. Il libro non è, tuttavia, un semplice esercizio intellettuale pretenzioso (lo avrei mollato subito), ma un racconto poliziesco ortodosso, anche se molto complesso e ingegnoso. Non nego che la lettura sia abbastanza complessa, e che in alcuni punti si avanzi a stento, ma l’ambientazione e i tempi della storia lo rendono comunque interessante. Il finale è giustificato da un percorso logico e perfettamente riconoscibile, pur nella baraonda generale creata dai vari indagati. Morte nello Studio del Rettore, pubblicato in Inghilterra nel 1936, conobbe subito un enorme successo di pubblico e di critica, e venne persino considerato all’epoca il miglior debutto di qualsiasi scrittore. Innes venne quindi immediatamente traghettato nell’olimpo dei giallisti. Scrisse circa un romanzo all’anno fino al 1986, ma il suo periodo migliore fu quello dal 1936 al 1940. In questi anni scrisse, dopo Morte nello Studio del Rettore, nel 1937 Hamlet, Revenge; nel 1938 Lament for a Maker; nel 1939 Stop Press. In una classifica dei migliori romanzi polizieschi inglesi del ‘900 tutti e quattro figurano tra i primi dieci, dietro solo ad Agatha Christie e a Dickson Carr. I successivi romanzi, tutti pubblicati sotto pseudonimo non furono al pari dei primi, ma raggiunsero la ragguardevole cifra di circa cinquanta libri, garantendogli una vita agiata e permettendogli comunque di esercitare la sua professione originaria.
Morte nello Studio del Rettore, pubblicato in Inghilterra nel 1936, conobbe subito un enorme successo di pubblico e di critica, e venne persino considerato all’epoca il miglior debutto di qualsiasi scrittore. Innes venne quindi immediatamente traghettato nell’olimpo dei giallisti. Scrisse circa un romanzo all’anno fino al 1986, ma il suo periodo migliore fu quello dal 1936 al 1940. In questi anni scrisse, dopo Morte nello Studio del Rettore, nel 1937 Hamlet, Revenge; nel 1938 Lament for a Maker; nel 1939 Stop Press. In una classifica dei migliori romanzi polizieschi inglesi del ‘900 tutti e quattro figurano tra i primi dieci, dietro solo ad Agatha Christie e a Dickson Carr. I successivi romanzi, tutti pubblicati sotto pseudonimo non furono al pari dei primi, ma raggiunsero la ragguardevole cifra di circa cinquanta libri, garantendogli una vita agiata e permettendogli comunque di esercitare la sua professione originaria.
 Scrisse a suo nome anche una ventina di romanzi di genere vario e sei opere di critica letteraria, su Joyce, Conrad, Shakespeare e altri eminenti scrittori inglesi: ma la sua fama rimane legata alla figura dell’Ispettore John Appleby (che nel corso degli anni si guadagnerà il titolo di Sir e diverrà il capo di Scotland Yard), poliziotto erudito, raffinato ed estremamente efficace. Nella sterminata galassia del giallo inglese il suo stile lo colloca nella scuola “donnish”, che vira sul fantastico e presenta numerose allusioni letterarie. Lui stesso definiva le sue come “opere di confine tra il racconto poliziesco e il fantasy; hanno un sapore un po’ letterario ma i loro valori rimangono quelli del melodramma e non della narrativa vera e propria”. E in effetti, pare le abbia sempre considerate soprattutto come pretesti per una prosa raffinata e per battute brillanti: il che, alla lunga, può diventare troppo scopertamente artificioso, e in definitiva noioso.
Scrisse a suo nome anche una ventina di romanzi di genere vario e sei opere di critica letteraria, su Joyce, Conrad, Shakespeare e altri eminenti scrittori inglesi: ma la sua fama rimane legata alla figura dell’Ispettore John Appleby (che nel corso degli anni si guadagnerà il titolo di Sir e diverrà il capo di Scotland Yard), poliziotto erudito, raffinato ed estremamente efficace. Nella sterminata galassia del giallo inglese il suo stile lo colloca nella scuola “donnish”, che vira sul fantastico e presenta numerose allusioni letterarie. Lui stesso definiva le sue come “opere di confine tra il racconto poliziesco e il fantasy; hanno un sapore un po’ letterario ma i loro valori rimangono quelli del melodramma e non della narrativa vera e propria”. E in effetti, pare le abbia sempre considerate soprattutto come pretesti per una prosa raffinata e per battute brillanti: il che, alla lunga, può diventare troppo scopertamente artificioso, e in definitiva noioso. Cosa che non ho potuto constatare personalmente, perché ho letto solo Morte nello Studio del Rettore. E questo mi sento tranquillamente di segnalarlo perché è veramente un giallo all’inglese che più tipico non si può; la narrazione a volte è complessa al punto da confondere la mente del lettore, perché tra gli indagati (tutti Fellows, quindi menti complesse) succede un po’ di tutto, le divagazioni psicologiche sono frequenti: ma alla fine la trama sta comodamente in piedi.
Cosa che non ho potuto constatare personalmente, perché ho letto solo Morte nello Studio del Rettore. E questo mi sento tranquillamente di segnalarlo perché è veramente un giallo all’inglese che più tipico non si può; la narrazione a volte è complessa al punto da confondere la mente del lettore, perché tra gli indagati (tutti Fellows, quindi menti complesse) succede un po’ di tutto, le divagazioni psicologiche sono frequenti: ma alla fine la trama sta comodamente in piedi.

 Quello che conta, per la mia breve indagine sui giallisti figli della perfida Albione (o, come in questo caso, dell’Ambasciata della perfida Albione) è scrivere appunto dei loro racconti polizieschi o di spionaggio, e con William Somerset Maugham il mio compito è estremamente facilitato. Mi risulta infatti che lo splendido Ashenden, l’inglese (nella mia vecchia edizione Garzanti del 1966, mentre oggi è ristampato come Ashenden, o L’agente inglese) sia il suo unico romanzo del genere; e non è un giallo ma un romanzo di spionaggio.
Quello che conta, per la mia breve indagine sui giallisti figli della perfida Albione (o, come in questo caso, dell’Ambasciata della perfida Albione) è scrivere appunto dei loro racconti polizieschi o di spionaggio, e con William Somerset Maugham il mio compito è estremamente facilitato. Mi risulta infatti che lo splendido Ashenden, l’inglese (nella mia vecchia edizione Garzanti del 1966, mentre oggi è ristampato come Ashenden, o L’agente inglese) sia il suo unico romanzo del genere; e non è un giallo ma un romanzo di spionaggio.

 Il primo di questi, I Quattro Giusti, uscito nel 1905, conobbe subito un largo successo, e può essere considerato il prototipo degli odierni thriller. In Italia è stato tradotto solo nel 1930. Non va confuso con un altro successivo, della stessa serie, nel quale i Giusti erano diventati tre, con un percorso inverso a quello dei Tre Moschettieri. A questo romanzo ne seguirono comunque altri 174, ai quali vanno sommati 24 lavori teatrali e un numero indefinito di racconti, di articoli giornalistici e di soggetti cinematografici (Pare abbia avuto una parte importante anche nella stesura del copione del film King Kong). Una produzione a livelli industriali, e di qualità molto diseguale.
Il primo di questi, I Quattro Giusti, uscito nel 1905, conobbe subito un largo successo, e può essere considerato il prototipo degli odierni thriller. In Italia è stato tradotto solo nel 1930. Non va confuso con un altro successivo, della stessa serie, nel quale i Giusti erano diventati tre, con un percorso inverso a quello dei Tre Moschettieri. A questo romanzo ne seguirono comunque altri 174, ai quali vanno sommati 24 lavori teatrali e un numero indefinito di racconti, di articoli giornalistici e di soggetti cinematografici (Pare abbia avuto una parte importante anche nella stesura del copione del film King Kong). Una produzione a livelli industriali, e di qualità molto diseguale. Una caratteristica interessante dei suoi romanzi è che non sono collegati uno all’altro: non c’è un personaggio (un detective, un ispettore, un commissario) che funga da trait d’union tra i racconti: le ambientazioni sono le più varie immaginabili, e le vicende sono slegate l’una dall’altra. Le indagini vengono spesso risolte da poliziotti anonimi, ma evidentemente dotati di grande fiuto. L’unico detective che compare con una certa frequenza è Mr. J.G. Reeder, uomo dall’aspetto risibile ma dotato di una mente “criminale”, che fortunatamente è al servizio della Polizia.
Una caratteristica interessante dei suoi romanzi è che non sono collegati uno all’altro: non c’è un personaggio (un detective, un ispettore, un commissario) che funga da trait d’union tra i racconti: le ambientazioni sono le più varie immaginabili, e le vicende sono slegate l’una dall’altra. Le indagini vengono spesso risolte da poliziotti anonimi, ma evidentemente dotati di grande fiuto. L’unico detective che compare con una certa frequenza è Mr. J.G. Reeder, uomo dall’aspetto risibile ma dotato di una mente “criminale”, che fortunatamente è al servizio della Polizia. Nell’estate scorsa ho letto un paio di questi romanzi: Stanza n. 13 del 1924 e Moneta Falsa del 1927. Curiosamente, entrambi trattano di falsari, di riproduttori di banconote false (per i quali Edgar provava evidentemente una certa ammirazione, magari anche un po’ d’invidia – per uno scialacquatore come lui avrebbe potuto essere una soluzione). Il primo è una storia abbastanza leggera, non priva di originalità ma piuttosto forzata, soprattutto nel finale. L’ambiente è quello della malavita inglese, la vicenda verte sulla ricerca del falsario imprendibile, tra ricatti famigliari, storie d’amore, infinite bassezze e vari morti sparati: comunque accettabile.
Nell’estate scorsa ho letto un paio di questi romanzi: Stanza n. 13 del 1924 e Moneta Falsa del 1927. Curiosamente, entrambi trattano di falsari, di riproduttori di banconote false (per i quali Edgar provava evidentemente una certa ammirazione, magari anche un po’ d’invidia – per uno scialacquatore come lui avrebbe potuto essere una soluzione). Il primo è una storia abbastanza leggera, non priva di originalità ma piuttosto forzata, soprattutto nel finale. L’ambiente è quello della malavita inglese, la vicenda verte sulla ricerca del falsario imprendibile, tra ricatti famigliari, storie d’amore, infinite bassezze e vari morti sparati: comunque accettabile. Il secondo romanzo è più interessante; nell’edizione inglese si intitola The Forger (Il Falsario), in quella italiana Moneta Falsa; non sarebbe stata difficile o sgradita la traduzione del titolo inglese, tutto sommato.
Il secondo romanzo è più interessante; nell’edizione inglese si intitola The Forger (Il Falsario), in quella italiana Moneta Falsa; non sarebbe stata difficile o sgradita la traduzione del titolo inglese, tutto sommato.


 Dopo le scuole dell’obbligo studiò in vari Istituti scolastici in città più grandi e seguì la professione della madre; intorno ai 25 anni, complice il lungo periodo di assistenza sanitaria che dovette fornire alla madre, interruppe il lavoro e cominciò a scrivere romanzi gialli. A volte erano ispirati a fatti da lei vissuti in prima persona nel suo periodo di insegnamento, con ambientazioni assimilabili a quelle conosciute in quei tempi, oppure si trattava di fatti riportati da altri, sui quali la grande fantasia e la profonda cultura della Tey intervenivano con successo. Scrisse dal 1926 al 1952, anno della sua scomparsa.
Dopo le scuole dell’obbligo studiò in vari Istituti scolastici in città più grandi e seguì la professione della madre; intorno ai 25 anni, complice il lungo periodo di assistenza sanitaria che dovette fornire alla madre, interruppe il lavoro e cominciò a scrivere romanzi gialli. A volte erano ispirati a fatti da lei vissuti in prima persona nel suo periodo di insegnamento, con ambientazioni assimilabili a quelle conosciute in quei tempi, oppure si trattava di fatti riportati da altri, sui quali la grande fantasia e la profonda cultura della Tey intervenivano con successo. Scrisse dal 1926 al 1952, anno della sua scomparsa. In Miss Pym, pubblicato tardi in Italia (in Inghilterra come Miss Pym Disposes), la Tey assiste a un’incidente in palestra che poi utilizza come la causa di un decesso nel romanzo, e non prevede ancora la figura dell’Ispettore Alan Grant, futuro punto di riferimento. Il primo romanzo che le procura una certa notorietà è The Man in the Queue (L’uomo in Coda, uscito da noi negli Oscar Mondadori). Qui compare per la prima volta Grant, e il romanzo, benché sia un poliziesco del tutto anomalo, ottiene un ottimo successo di critica e invoglia la Tey a proseguire nella sua carriera.
In Miss Pym, pubblicato tardi in Italia (in Inghilterra come Miss Pym Disposes), la Tey assiste a un’incidente in palestra che poi utilizza come la causa di un decesso nel romanzo, e non prevede ancora la figura dell’Ispettore Alan Grant, futuro punto di riferimento. Il primo romanzo che le procura una certa notorietà è The Man in the Queue (L’uomo in Coda, uscito da noi negli Oscar Mondadori). Qui compare per la prima volta Grant, e il romanzo, benché sia un poliziesco del tutto anomalo, ottiene un ottimo successo di critica e invoglia la Tey a proseguire nella sua carriera. C’è sempre l’Ispettore Grant, ricoverato però in ospedale per una caduta in una botola (mentre inseguiva un ladro), con relative fratture e contusioni. L’avvio può sembrare quello di La finestra sul cortile di Cornell Woolrich, uscito nel 1942 col titolo Ithad to be murder a nome Wiliam Irish (uno degli pseudonimi dell’autore americano) e poi ripubblicato nel 1944 come Rear Window, e infine ben più noto per la versione cinematografica di Alfred Hitchcok, con la splendida Grace Kelly e il bravo James Stewart. Ma il parallelismo finisce lì, con l’incidente che obbliga James Stewart e l’Isp. Grant nel letto di casa il primo e in quello d’ospedale il secondo.
C’è sempre l’Ispettore Grant, ricoverato però in ospedale per una caduta in una botola (mentre inseguiva un ladro), con relative fratture e contusioni. L’avvio può sembrare quello di La finestra sul cortile di Cornell Woolrich, uscito nel 1942 col titolo Ithad to be murder a nome Wiliam Irish (uno degli pseudonimi dell’autore americano) e poi ripubblicato nel 1944 come Rear Window, e infine ben più noto per la versione cinematografica di Alfred Hitchcok, con la splendida Grace Kelly e il bravo James Stewart. Ma il parallelismo finisce lì, con l’incidente che obbliga James Stewart e l’Isp. Grant nel letto di casa il primo e in quello d’ospedale il secondo. Alan Grant nota che l’aspetto di Riccardo III nella stampa non sembra quello di un mostro, capace di uccidere i suoi due nipotini, figli di suo fratello Edoardo morto in battaglia (al quale Riccardo tra l’altro era legatissimo) per evitare che possano subentrargli un giorno come regnanti. E in effetti, rileggendo vari libri nel periodo di degenza, si rende conto di alcune sviste nella narrazione storica, e della controversa figura di Tommaso Moro (Sir Thomas More, o per i cattolici San Tommaso Moro), che pur non essendo presente fisicamente in quegli anni (quando morì Riccardo III, Moro aveva 5 anni) fu un netto propagandista della teoria Tudor che vedeva in Riccardo III un uomo abbietto e meschino, limitandosi a riportare informazioni di seconda o terza mano.
Alan Grant nota che l’aspetto di Riccardo III nella stampa non sembra quello di un mostro, capace di uccidere i suoi due nipotini, figli di suo fratello Edoardo morto in battaglia (al quale Riccardo tra l’altro era legatissimo) per evitare che possano subentrargli un giorno come regnanti. E in effetti, rileggendo vari libri nel periodo di degenza, si rende conto di alcune sviste nella narrazione storica, e della controversa figura di Tommaso Moro (Sir Thomas More, o per i cattolici San Tommaso Moro), che pur non essendo presente fisicamente in quegli anni (quando morì Riccardo III, Moro aveva 5 anni) fu un netto propagandista della teoria Tudor che vedeva in Riccardo III un uomo abbietto e meschino, limitandosi a riportare informazioni di seconda o terza mano.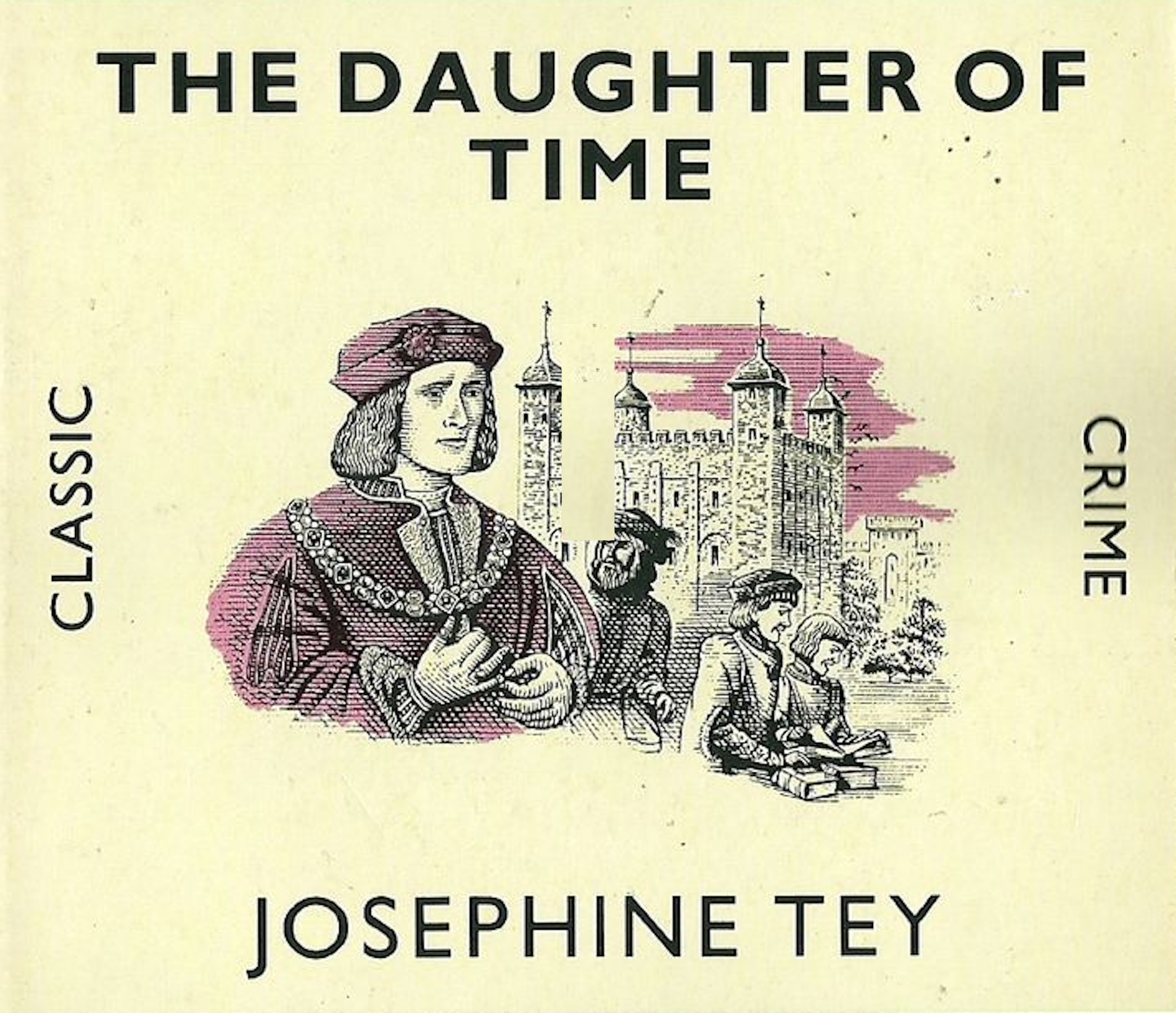




 di Vittorio Righini, 11 aprile 2020
di Vittorio Righini, 11 aprile 2020





 Come spot promozionale il serial si è rivelato senz’altro efficacissimo, tanto più perché non mirato ad una specifica area o località, ma giocato su un luogo ideale che riassume tutta la faccia in ombra del paese. Esiste ormai un consolidato flusso turistico di gente che percorre il Devon e il Surrey in cerca della cittadina di Caustom e alla riscoperta della vecchia Inghilterra, quella che dovrebbe conservare intatti lo spirito testardo e laborioso e le tradizioni autentiche di un grande popolo.
Come spot promozionale il serial si è rivelato senz’altro efficacissimo, tanto più perché non mirato ad una specifica area o località, ma giocato su un luogo ideale che riassume tutta la faccia in ombra del paese. Esiste ormai un consolidato flusso turistico di gente che percorre il Devon e il Surrey in cerca della cittadina di Caustom e alla riscoperta della vecchia Inghilterra, quella che dovrebbe conservare intatti lo spirito testardo e laborioso e le tradizioni autentiche di un grande popolo. Insomma, ne usciamo convinti anche noi che Midsomer non è un paradiso terrestre, tutt’altro, ma che ogni irruzione del nuovo non farebbe che peggiorarlo. Barnaby esprime un conservatorismo consapevole, niente affatto integralista, anzi, un po’ dolente: ritiene che un equilibrio anche poco equo sia sempre meglio di nessun equilibrio. Da buon antropologo non solo ne prende atto, ma si adopera per mantenerlo in vita, correggendone le derive criminali più clamorose, possibilmente senza interferire troppo. La sua posizione è perfettamente in linea con quella assunta da tutti gli antropologi classici, da Ewans-Pritchard a Levi-Strauss, che ci hanno raccontato le società tribali, e che è in fondo quella sostenuta ancora oggi da tutti i critici della civiltà occidentale.
Insomma, ne usciamo convinti anche noi che Midsomer non è un paradiso terrestre, tutt’altro, ma che ogni irruzione del nuovo non farebbe che peggiorarlo. Barnaby esprime un conservatorismo consapevole, niente affatto integralista, anzi, un po’ dolente: ritiene che un equilibrio anche poco equo sia sempre meglio di nessun equilibrio. Da buon antropologo non solo ne prende atto, ma si adopera per mantenerlo in vita, correggendone le derive criminali più clamorose, possibilmente senza interferire troppo. La sua posizione è perfettamente in linea con quella assunta da tutti gli antropologi classici, da Ewans-Pritchard a Levi-Strauss, che ci hanno raccontato le società tribali, e che è in fondo quella sostenuta ancora oggi da tutti i critici della civiltà occidentale. di Vittorio Righini, 2 agosto 2019
di Vittorio Righini, 2 agosto 2019