ottobre 2025
di Paolo Repetto, 5 dicembre 2025
Una breve escursione sull’isola dell’Asinara mi ha lasciato parecchi interrogativi e un’impressione tutt’altro che positiva.
I dubbi non riguardano la bellezza dell’isola, che persiste a dispetto di tutti gli sforzi fatti degli umani a partire almeno da seimila anni fa per rovinarla. La natura sa opporre resistenza, riadattandosi ogni volta alle diverse condizioni create dal suo peggior nemico. Certo, però, dal paleolitico ad oggi il paesaggio è cambiato molto: le specie animali introdotte dall’uomo e lo sfruttamento insensato del legname hanno diradato sin quasi alla scomparsa la vegetazione. Dove c’erano vaste aree boschive, testimoniate dai fossili, sopravvive solo la bassa macchia mediterranea: il resto sono nude superfici di roccia, che presentano anche strane e intriganti conformazioni. Non c’è una sorgente, un solo rivolo d’acqua. Sembra che un tempo ce ne fossero, ma ne sono rimaste solo le tracce. Per ovviare a questa assenza sono stati fatti prima tentativi con pozzi, rivelatisi infruttuosi, e poi sono stati creati in più punti piccoli invasi artificiali, dove viene raccolta e potabilizzata l’acqua piovana.
Tutto sommato comunque l’isola è quasi autosufficiente, e anche il paesaggio conserva un suo fascino. Ad inquietare semmai sono le tracce del passaggio dell’uomo sparse ovunque: che non hanno la dignità dei ruderi, non raccontano la storia, ma esprimono invece una desolazione da abbandono e un senso (molto ben motivato) di inutilità.
Eppure l’Asinara ne avrebbe di storia da raccontare. È stata colonizzata in tempi storici dai Romani, poi dai Vandali e successivamente dai bizantini. Quindi sono arrivate le prime incursioni arabe. Nel Basso Medioevo è passata sotto il dominio dei genovesi, a loro volta sconfitti poi dagli Aragonesi, anche se nel Cinquecento sembra aver ospitato per un breve periodo il covo dei saraceni del corsaro Barbarossa. È rimasta comunque almeno ufficialmente per tre secoli sotto la sovranità spagnola, inglobata nel regno di Sardegna. Quando ai primi del XVIII secolo il regno è entrato a far parte dei domini di casa Savoia l’Asinara ne ha seguite le sorti. Nel frattempo si erano susseguiti vari tentativi di ricolonizzazione, giustificati dall’importanza strategica che l’isoletta era andata acquisendo: tentativi effettuati allontanando gli abitanti originari, o quantomeno gli ultimi in ordine di tempo che vi si erano stanziati, e chiamando di volta in volta nuovi coloni dalla Liguria, dalla Toscana e dalla Sardegna stessa. In ognuno di questi frangenti il processo di sfruttamento e di desertificazione del territorio si era naturalmente intensificato.

Un po’ di respiro arriva nel 1885, quando il governo del neonato stato italiano decide di allontanare tutti gli abitanti, di interdire a chiunque l’accesso e di destinare l’isola a colonia penale agricola per detenuti in regime di semi-libertà, nonché a sede di un lazzaretto dove fare rispettare la quarantena ai natanti di passaggio sulla rotta per le coste francesi. Durante la Prima guerra mondiale nel lazzaretto vengono deportati quasi venticinquemila prigionieri di guerra, soprattutto austro-ungarici: buona parte di loro non ne uscirà viva. Vent’anni dopo, ai tempi della guerra d’Etiopia, ne seguiranno la sorte molti prigionieri etiopi, tra i quali una figlia dello stesso Negus. Finché durante il secondo conflitto le strutture vengono nuovamente adibite a tubercolosario.
Una svolta ulteriore si ha all’inizio degli anni Sessanta del secolo scorso. L’Asinara torna ad essere un penitenziario, questa volta di massima sicurezza, e ospita in poco più di trent’anni di funzionamento personaggi a loro modo “illustri”, tra i quali alcuni brigatisti rossi e pericolosi capi della mafia e della camorra (Cutolo, Riina, ecc…). La struttura acquista la fama di Alcatraz italiana, perché in tutta la sua storia un solo detenuto è riuscito ad evaderne e per le condizioni davvero dure della detenzione. Finché negli ultimi anni del secolo il carcere viene definitivamente chiuso e si decide di destinare l’isola a parco naturale, per preservarla da una ulteriore cementificazione e più in generale dalla distruzione ambientale.

Ora, ho voluto inserire questi brevissimi cenni storici, ripetendo quasi testualmente quanto mi è stato spiegato dalla guida che ci accompagnava, per un motivo preciso (so che queste notizie avreste potuto ricavarle benissimo, e molto più dettagliate, da una rapida ricerca su internet: ma dubito molto che lo avreste fatto). Mi serviva per rendere l’idea di quello che ho visto nell’arco di una sola giornata, per sostanziare l’impressione di una stratificazione storica che si è intensificata e cumulata soprattutto nell’ultimo secolo e mezzo, lasciando come dicevo sopra, ai margini del suo cammino non delle vestigia, che hanno una loro dignità, ma delle rovine.
Ho visto strutture utilizzate per pochissimi anni e poi abbandonate, o addirittura mai completate, perché nel frattempo la destinazione da dare all’isola era mutata. Ho visto edifici che dovevano sembrare fatiscenti già al momento in cui erano portati a termine, che trasudavano precarietà e umidità e trasandatezza da ogni apertura o dagli sbrecchi negli intonaci. Ho visto scelte logistiche assurde, con la dispersione in angoli remoti dell’isola delle diverse sezioni, ciò che non poteva non creare problemi di personale e di servizi essenziali. Insomma, altro che Alcatraz. Uno spreco totale di risorse, non certo di intelligenza, in nome di una sicurezza, prima sanitaria e poi carceraria, che in verità non c’è mai stata.
Per come l’isola e le sue strutture detentive mi si sono presentate, non mi capacito che ci siano stati così pochi tentativi di evasione, e che uno solo sia andato a termine. Il due bracci di mare che separano la punta estrema dell’Asinara dall’isoletta piana e poi dalla terraferma sarda possono essere tranquillamente superati da qualsiasi buon nuotatore. Forse il vivere in mezzo a tanta desolazione fiacca anche la volontà di venirne fuori.
Capisco invece benissimo perché un quarto dei militari prigionieri mandati lì a marcire, tutti ragazzi poco più che ventenni, ci abbia lasciato le penne. A ricordarli c’è un ossario fatto costruire un secolo fa dal governo austriaco, nel quale teschi, tibie, femori, clavicole, vertebre e tutto il resto sono esposti a vista, ammassati dietro delle grate. È un’immagine straziante: non hai di fronte delle lapidi tutto sommato anonime, anche perché recherebbero incisi nomi stranieri, ma ciò che rimane dei corpi di migliaia di ragazzi mandati a morire in maniera insensata.
L’ultimo capitolo della storia dell’Asinara, quello che ufficialmente avrebbe dovuto riabilitarla facendone un’oasi faunistica, non è in realtà meno sciagurato. A quanto pare l’idea che in un parco naturale protetto e totalmente isolato dalle acque la fauna non avrebbe trovato ostacoli naturali alla sua moltiplicazione non ha sfiorato le menti dei pianificatori: e così ci si trova oggi nella necessità di trasferire annualmente dall’isola migliaia di esemplari di capre, di asini, di cinghiali e persino di cavalli, pena la prospettiva di trovarla ridotta nel volgere di un decennio a uno scoglio roccioso privo di vegetazione. In compenso sono state create nuove strutture, destinate ad accogliere gli uffici del parco e ad ospitare turisti che non si capisce bene perché dovrebbero fermarsi più di un giorno, perché nell’arco di una giornata l’isola la visiti tutta, anche in bicicletta, o congressi e manifestazioni assolutamente inutili e a carico totale dell’amministrazione. Io, ad esempio, sono capitato proprio in mezzo ad un convegno “anniversario”, celebrativo dei due o tre mesi nei quali Falcone e Borsellino avevano lì soggiornato, nei primi anni Novanta, per garantirsi un po’ di sicurezza; e ho potuto constatare come per i numerosi magistrati convenuti si trattasse solo di una gita turistica.
Oddio, sull’isola c’è anche un Centro di recupero degli animali marini, che fa assistenza veterinaria di pronto intervento per le tartarughe marine. Istituto meritevolissimo, per carità, che ma in un paese in cui per stilare il referto di una biopsia occorre un anno suona un po’ stridente.

Le perplessità di cui parlavo all’inizio nascono dunque dalla constatazione di un triplice fallimento. Amministrativo, perché hai l’immagine tangibile di una serie di scelte contraddittorie e raffazzonate, come un po’ tutto quello che accade nel nostro paese, e sulle quali hanno probabilmente influito anche interessi esterni. Umanitario, perché se decidi di togliere dalla circolazione qualcuno, ma rimanendo nell’ottica di una sua rieducazione e di un suo recupero, non lo segreghi in luogo non raggiungibile e comunque poco adatto a coltivare pensieri edificanti, in strutture non molto diverse da quelle dello Spielberg di Pellico. E infine naturalistico, perché desertificando l’isola non fai altro che cancellarne la storia culturale, senza peraltro rimetterne in ordine quella naturale.
Eppure, a dispetto di tutto, a quanto pare un suo fascino l’Asinara lo conserva, se è vero che attira oltre centomila visitatori l’anno e dà lavoro ad un sacco di imprese turistiche che offrono escursioni, immersioni subacquee e pescaturismo. Per molti aspetti è un fascino creato artificialmente, per esempio spacciando gli asinelli bianchi per una specie a parte, quando altro non sono che individui albini che incontrano maggiori difficoltà di sopravvivenza, destinati quindi a soccombere alla proliferazione dei loro conspecifici più attrezzati. Oppure pigiando sul tasto del “turismo sostenibile” e del rapporto con una natura incontaminata, per il quale c’è oggi una grande sensibilità epidermica ma ben poca consapevolezza: o ancora, su quello della storia penitenziaria, che a quanto pare nell’immaginario attrae morbosamente, ma in loco è testimoniata poco più che da macerie.
Questo non significa che non valga la pena visitarla: l’isola in fondo è bella, è senz’altro “diversa”, almeno all’impatto visivo. Ma occorre farlo tenendo presente che è una sorta di piccola Disneyland naturalistica, frutto tutt’altro che incontaminato di scelte legate piuttosto all’insipienza e all’ improvvisazione che a un qualsivoglia progetto sensato. E avendo il pudore di ricordare che prima di noi l’hanno “visitata”, vi hanno soggiornato e vi sono sepolti decine di migliaia di poveri disgraziati che avrebbero preferito non vederla mai.
Questo mi è rimasto nel cuore, e per quanto mi riguarda è questo l’unico tipo di turismo davvero sostenibile.






 E allora tiriamo avanti così, fingendo di viaggiare verso un mondo più equo, social, solidale, bio, eco, rincorrendo insomma tutti i suffissi di moda oggi, ma in realtà usiamo queste parole per illuderci di credere ancora in un fantomatico progredire, per non guardare negli occhi il mostro marino che con i suoi tentacoli ci avvolge e ci trascina nell’abisso dei nostri convincimenti. “E naufragar m’è dolce in questo mare”, direbbe Leopardi. Tanto, “oramai”, cosa possiamo farci?
E allora tiriamo avanti così, fingendo di viaggiare verso un mondo più equo, social, solidale, bio, eco, rincorrendo insomma tutti i suffissi di moda oggi, ma in realtà usiamo queste parole per illuderci di credere ancora in un fantomatico progredire, per non guardare negli occhi il mostro marino che con i suoi tentacoli ci avvolge e ci trascina nell’abisso dei nostri convincimenti. “E naufragar m’è dolce in questo mare”, direbbe Leopardi. Tanto, “oramai”, cosa possiamo farci?
 Cosa significhi essere preparati lo testimonia la vicenda di Francesco Negri, un placido curato quarantenne della Ravenna del Seicento. La sua avventura è ricordata anche nel libro di Genovesi, portata ad esempio di come si può non accettare l’“oramai” imposto dal comune sentire. Negri avrebbe potuto continuare a crogiolarsi nelle sue sicurezze perseguendo una carriera ecclesiastica già ben avviata: preferì invece non affogare in quella palude di consuetudini per incamminarsi in un viaggio ai confini del mondo, incurante di chi lo sconsigliava ritenendolo “oramai” troppo vecchio per un’esplorazione che lo avrebbe portato in terre ignote e inospitali e dava per certo che non sarebbe sopravvissuto.
Cosa significhi essere preparati lo testimonia la vicenda di Francesco Negri, un placido curato quarantenne della Ravenna del Seicento. La sua avventura è ricordata anche nel libro di Genovesi, portata ad esempio di come si può non accettare l’“oramai” imposto dal comune sentire. Negri avrebbe potuto continuare a crogiolarsi nelle sue sicurezze perseguendo una carriera ecclesiastica già ben avviata: preferì invece non affogare in quella palude di consuetudini per incamminarsi in un viaggio ai confini del mondo, incurante di chi lo sconsigliava ritenendolo “oramai” troppo vecchio per un’esplorazione che lo avrebbe portato in terre ignote e inospitali e dava per certo che non sarebbe sopravvissuto. Impiegò tre lunghi anni (dal 1663 al 1666) per risalire tutto il continente e raggiungere Capo Nord, e durante il viaggio raccolse dati inediti su quelle terre estreme, la Svezia, la Norvegia e la Lapponia, dove “nessun frutto vi può rendere per l’estremo freddo al testimonio de’ scrittori; e pure vi si sostenta il genere umano. Non si trova altra terra abitata, che si sappia, sotto il suo parallelo, e la zona glaciale artica è totalmente ignota. Dunque è forza che quel paese abbia qualità agli altri non comuni, ma singolari; dunque sarà la più curiosa parte del mondo per osservarsi”.
Impiegò tre lunghi anni (dal 1663 al 1666) per risalire tutto il continente e raggiungere Capo Nord, e durante il viaggio raccolse dati inediti su quelle terre estreme, la Svezia, la Norvegia e la Lapponia, dove “nessun frutto vi può rendere per l’estremo freddo al testimonio de’ scrittori; e pure vi si sostenta il genere umano. Non si trova altra terra abitata, che si sappia, sotto il suo parallelo, e la zona glaciale artica è totalmente ignota. Dunque è forza che quel paese abbia qualità agli altri non comuni, ma singolari; dunque sarà la più curiosa parte del mondo per osservarsi”. Nel suo peregrinare imparò dai locali lo sci di fondo e sicuramente fu il primo italiano a praticarlo: “Hanno due tavolette sottili, che non eccedono in larghezza il piede, ma lunghe otto o nove palmi, con la punta alquanto rilevata per non intaccar nella neve. Nel mezzo di esse sono alcune funicelle, con le quali se le assettano bene una ad un piede e l’altra a l’altro, tenendo poi un bastone alla mano, conficcato in una rotella di legno all’estremità, perchè non fóri la neve; ovvero anche senza tal bastone camminano sopra la neve, in tempo che non è agghiacciata, nè atta a sostentar un uomo”. Naturalmente, trattandosi di un viaggiatore atipico, la sua relazione non suscitò alcuna attenzione, tanto che fino alla fine dell’Ottocento in Italia nessuno praticò lo sci, neppure sulle Alpi.
Nel suo peregrinare imparò dai locali lo sci di fondo e sicuramente fu il primo italiano a praticarlo: “Hanno due tavolette sottili, che non eccedono in larghezza il piede, ma lunghe otto o nove palmi, con la punta alquanto rilevata per non intaccar nella neve. Nel mezzo di esse sono alcune funicelle, con le quali se le assettano bene una ad un piede e l’altra a l’altro, tenendo poi un bastone alla mano, conficcato in una rotella di legno all’estremità, perchè non fóri la neve; ovvero anche senza tal bastone camminano sopra la neve, in tempo che non è agghiacciata, nè atta a sostentar un uomo”. Naturalmente, trattandosi di un viaggiatore atipico, la sua relazione non suscitò alcuna attenzione, tanto che fino alla fine dell’Ottocento in Italia nessuno praticò lo sci, neppure sulle Alpi. Usava il latino come lingua franca con i pastori protestanti che presidiavano il lontano territorio, e questi divenivano suoi mediatori con le popolazioni locali. A differenza di altri “turisti dell’esplorazione” venuti dopo, aveva grande considerazione del popolo Sami, delle sue pratiche quotidiane e religiose. Annotava ogni particolare, insieme alle storie, alle leggende e alle minuziose descrizioni di animali artici. Aveva poi un approccio molto pragmatico rispetto all’evangelizzazione dei Sami: liquidava le pratiche sciamaniche come marginali e sottolineava invece la spontanea generosità di quel popolo.
Usava il latino come lingua franca con i pastori protestanti che presidiavano il lontano territorio, e questi divenivano suoi mediatori con le popolazioni locali. A differenza di altri “turisti dell’esplorazione” venuti dopo, aveva grande considerazione del popolo Sami, delle sue pratiche quotidiane e religiose. Annotava ogni particolare, insieme alle storie, alle leggende e alle minuziose descrizioni di animali artici. Aveva poi un approccio molto pragmatico rispetto all’evangelizzazione dei Sami: liquidava le pratiche sciamaniche come marginali e sottolineava invece la spontanea generosità di quel popolo. Una volta rientrato a Ravenna si dedicò ad una puntigliosa revisione dei dati raccolti nel suo peregrinare parlando con pescatori, contadini e curati di quella parte del continente ancora in gran parte inesplorata, a verificare la correttezza dei dati e l’attendibilità delle fonti. Tre anni di viaggio e trent’anni per ponderare e redigere il volume “
Una volta rientrato a Ravenna si dedicò ad una puntigliosa revisione dei dati raccolti nel suo peregrinare parlando con pescatori, contadini e curati di quella parte del continente ancora in gran parte inesplorata, a verificare la correttezza dei dati e l’attendibilità delle fonti. Tre anni di viaggio e trent’anni per ponderare e redigere il volume “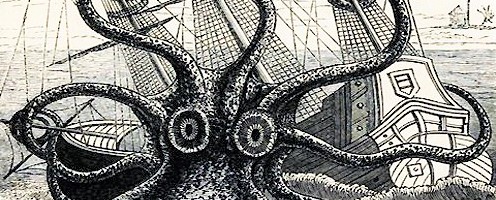
 Arrivato alla soglia dei cinquant’anni, posso affermare di essermi costruito la mia (credo) solida Pequod che naviga su un oceano tranquillo, fatto di famiglia, amici, lavoro e certezze. Al momento non vedo l’ombra oscura sotto la chiglia: ma temo comincino ad aggrapparsi ad essa alcuni tentacoli degli “oramai”, riferiti a ciò che non ho fatto, provato e visto. Dovrò premunirmi per tempo, per abbozzare almeno una risposta adeguata, prima che mi ghermiscano. Levigare l’arpione e controllare le vele per tentare una fuga, quando il Kraken mostrerà il suo occhio ammaliante.
Arrivato alla soglia dei cinquant’anni, posso affermare di essermi costruito la mia (credo) solida Pequod che naviga su un oceano tranquillo, fatto di famiglia, amici, lavoro e certezze. Al momento non vedo l’ombra oscura sotto la chiglia: ma temo comincino ad aggrapparsi ad essa alcuni tentacoli degli “oramai”, riferiti a ciò che non ho fatto, provato e visto. Dovrò premunirmi per tempo, per abbozzare almeno una risposta adeguata, prima che mi ghermiscano. Levigare l’arpione e controllare le vele per tentare una fuga, quando il Kraken mostrerà il suo occhio ammaliante. Non sto dicendo che si debba invece correre dietro ad ogni nostro sogno: nella vita occorre anche essere realisti, consapevoli delle nostre reali capacità, sapendo apprezzare quel che la stessa ci ha già dato, senza stare sempre sul piede di partenza per una prossima tappa. In caso contrario si va incontro ad una insoddisfazione perenne e davvero infantile. Ma nemmeno credo che sia tranquillamente praticabile la via della rassegnazione. Non è nella natura della nostra specie sentirsi appagata: e allora il problema sta semmai nel capire a cosa realisticamente aspira: e una volta che lo ha capito, non rinunciare a coltivare quel sogno. Questo implica necessariamente la messa in discussione delle certezze già raggiunte, che non significa buttare all’aria tutto, ma nemmeno permettere a ciò che ci circonda di diventare un vincolo paralizzante. In fondo, solo il mutamento ci aiuta a progredire nella conoscenza dei nostri limiti, e a volte è necessario intraprendere una strada differente anche solo per constatare che non porta da nessuna parte. Perlomeno vivremo, dopo, senza quel rimpianto.
Non sto dicendo che si debba invece correre dietro ad ogni nostro sogno: nella vita occorre anche essere realisti, consapevoli delle nostre reali capacità, sapendo apprezzare quel che la stessa ci ha già dato, senza stare sempre sul piede di partenza per una prossima tappa. In caso contrario si va incontro ad una insoddisfazione perenne e davvero infantile. Ma nemmeno credo che sia tranquillamente praticabile la via della rassegnazione. Non è nella natura della nostra specie sentirsi appagata: e allora il problema sta semmai nel capire a cosa realisticamente aspira: e una volta che lo ha capito, non rinunciare a coltivare quel sogno. Questo implica necessariamente la messa in discussione delle certezze già raggiunte, che non significa buttare all’aria tutto, ma nemmeno permettere a ciò che ci circonda di diventare un vincolo paralizzante. In fondo, solo il mutamento ci aiuta a progredire nella conoscenza dei nostri limiti, e a volte è necessario intraprendere una strada differente anche solo per constatare che non porta da nessuna parte. Perlomeno vivremo, dopo, senza quel rimpianto.
 Nell’epoca della precarietà lavorativa, dei costanti mutamenti di idee, convinzioni, ideologie e credi, restiamo ancorati ad un modello di rapporto sentimentale monogamo, figlio di secoli di letteratura romantica e decenni di televisione sdolcinata. Probabilmente è una contraddizione. Rischiando il linciaggio, affermo un’idea non originale: l’amore è il sentimento più sopravvalutato, a discapito di altri più fedeli e liberi (amicizia). I tentacoli della consuetudine, anziché trattenerci, potrebbero spingerci lontano dalla bonaccia, verso gli amori irrealizzati, ma poi sapremmo davvero compiacerci di aver raggiunto l’agognata “meta” o avremmo il rammarico di aver svelato ciò che è bene che resti nei nostri più intimi pensieri, al fine di preservarne l’illusoria speranza? Per non rischiare, ancora una volta di ripete anche qui l’ennesimo “oramai”.
Nell’epoca della precarietà lavorativa, dei costanti mutamenti di idee, convinzioni, ideologie e credi, restiamo ancorati ad un modello di rapporto sentimentale monogamo, figlio di secoli di letteratura romantica e decenni di televisione sdolcinata. Probabilmente è una contraddizione. Rischiando il linciaggio, affermo un’idea non originale: l’amore è il sentimento più sopravvalutato, a discapito di altri più fedeli e liberi (amicizia). I tentacoli della consuetudine, anziché trattenerci, potrebbero spingerci lontano dalla bonaccia, verso gli amori irrealizzati, ma poi sapremmo davvero compiacerci di aver raggiunto l’agognata “meta” o avremmo il rammarico di aver svelato ciò che è bene che resti nei nostri più intimi pensieri, al fine di preservarne l’illusoria speranza? Per non rischiare, ancora una volta di ripete anche qui l’ennesimo “oramai”.

