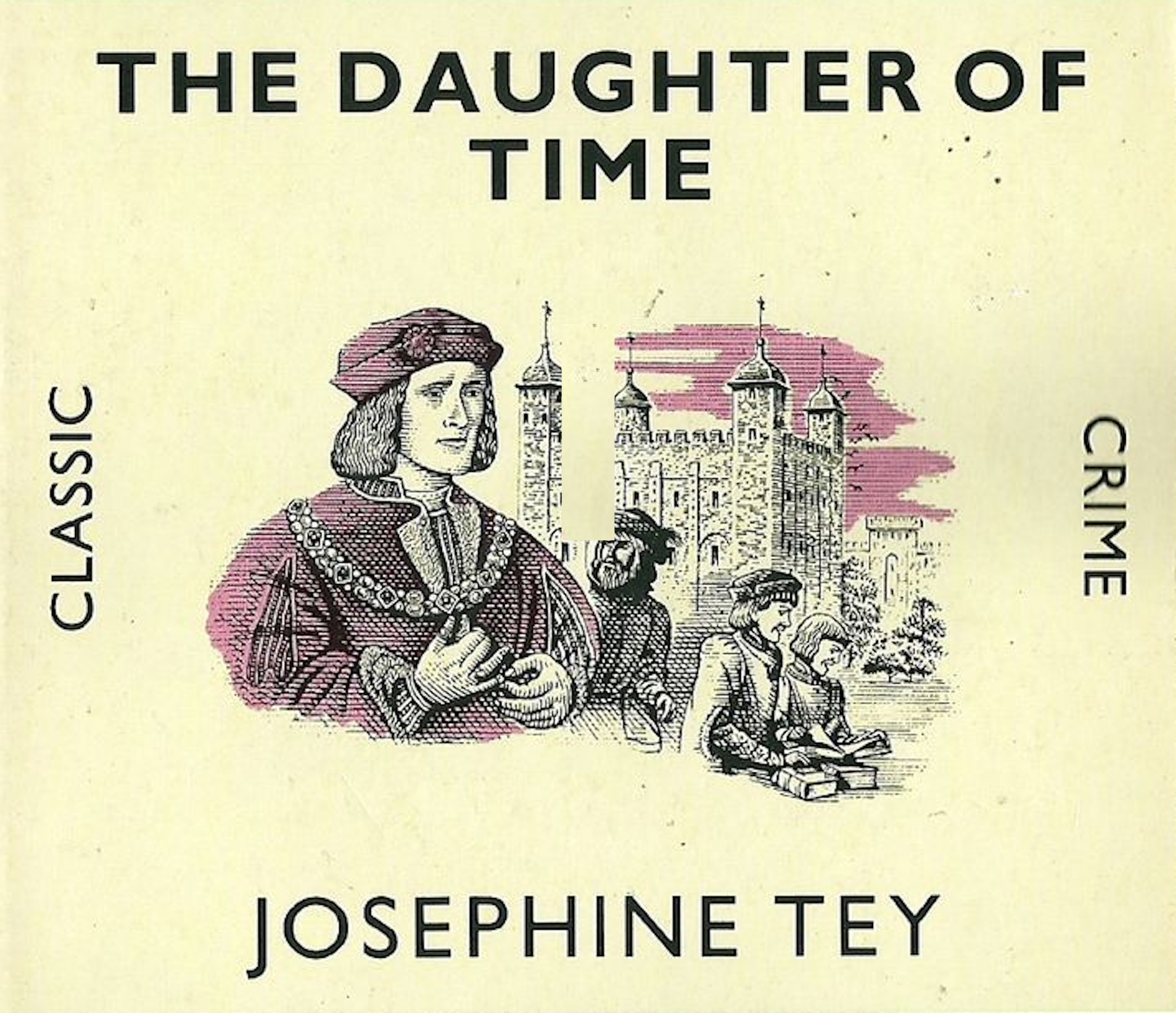di Vittorio Righini, 11 ottobre 2024
Prosegue la breve panoramica di giallisti inglesi dei quali ho letto qualche romanzo.
Oggi è la volta di Richard (Horatio Edgar) Wallace (Inghilterra, 1875 – Stati Uniti, 1932), noto come Edgar Wallace.
Il personaggio è notevole, paragonabile ad Arthur Conan Doyle e ad Agatha Christie: uno dei maggiori scrittori di romanzi gialli, almeno quantitativamente, con all’attivo oltre 150 lavori tra il 1905 e il 1932, ma noto anche come commediografo, giornalista, drammaturgo e sceneggiatore. Era un uomo pieno di luci e di ombre: facile ad entusiasmarsi come a cadere nella depressione, tutt’altro che ordinato nella gestione della propria vita, fumava 80 sigarette al giorno e beveva 40 tazze di tè (secondo me i biografi esagerano, ma dobbiamo fidarci di quel che troviamo, non potendolo chiedere a lui). Guadagnò moltissimo, ma spese ancor di più, e quando si spense era sommerso da una montagna di debiti. Vulcanico, iperattivo, geniale, scriveva un romanzo o una commedia in un week-end (e qui mi ricorda un altro come lui, il caro Simenon, gran fumatore e sciupafemmine).
Aveva iniziato come corrispondente estero nel 1898, raccontando la Guerra Boera sul Daily Mail. Per qualche anno campò dello stipendio di giornalista in Sud Africa, spendendo sempre più di quanto guadagnava, tanto che quando tornò in Inghilterra, nel 1902, aveva solo 12 scellini in tasca e una moglie a carico: ma aveva anche tante idee da sviluppare. Voleva intraprendere la carriera di romanziere, non per una vocazione irrinunciabile, ma per mettere a frutto economicamente l’innegabile facilità di scrittura e le esperienze che aveva maturato. Per campare dovette però affidarsi ancora per qualche tempo all’attività di corrispondente, e tra il 1904 e il 1905 raccontò la guerra russo-giapponese: occasione che gli fornì ulteriori spunti per i successivi romanzi.
 Il primo di questi, I Quattro Giusti, uscito nel 1905, conobbe subito un largo successo, e può essere considerato il prototipo degli odierni thriller. In Italia è stato tradotto solo nel 1930. Non va confuso con un altro successivo, della stessa serie, nel quale i Giusti erano diventati tre, con un percorso inverso a quello dei Tre Moschettieri. A questo romanzo ne seguirono comunque altri 174, ai quali vanno sommati 24 lavori teatrali e un numero indefinito di racconti, di articoli giornalistici e di soggetti cinematografici (Pare abbia avuto una parte importante anche nella stesura del copione del film King Kong). Una produzione a livelli industriali, e di qualità molto diseguale.
Il primo di questi, I Quattro Giusti, uscito nel 1905, conobbe subito un largo successo, e può essere considerato il prototipo degli odierni thriller. In Italia è stato tradotto solo nel 1930. Non va confuso con un altro successivo, della stessa serie, nel quale i Giusti erano diventati tre, con un percorso inverso a quello dei Tre Moschettieri. A questo romanzo ne seguirono comunque altri 174, ai quali vanno sommati 24 lavori teatrali e un numero indefinito di racconti, di articoli giornalistici e di soggetti cinematografici (Pare abbia avuto una parte importante anche nella stesura del copione del film King Kong). Una produzione a livelli industriali, e di qualità molto diseguale.
 Una caratteristica interessante dei suoi romanzi è che non sono collegati uno all’altro: non c’è un personaggio (un detective, un ispettore, un commissario) che funga da trait d’union tra i racconti: le ambientazioni sono le più varie immaginabili, e le vicende sono slegate l’una dall’altra. Le indagini vengono spesso risolte da poliziotti anonimi, ma evidentemente dotati di grande fiuto. L’unico detective che compare con una certa frequenza è Mr. J.G. Reeder, uomo dall’aspetto risibile ma dotato di una mente “criminale”, che fortunatamente è al servizio della Polizia.
Una caratteristica interessante dei suoi romanzi è che non sono collegati uno all’altro: non c’è un personaggio (un detective, un ispettore, un commissario) che funga da trait d’union tra i racconti: le ambientazioni sono le più varie immaginabili, e le vicende sono slegate l’una dall’altra. Le indagini vengono spesso risolte da poliziotti anonimi, ma evidentemente dotati di grande fiuto. L’unico detective che compare con una certa frequenza è Mr. J.G. Reeder, uomo dall’aspetto risibile ma dotato di una mente “criminale”, che fortunatamente è al servizio della Polizia.
 Nell’estate scorsa ho letto un paio di questi romanzi: Stanza n. 13 del 1924 e Moneta Falsa del 1927. Curiosamente, entrambi trattano di falsari, di riproduttori di banconote false (per i quali Edgar provava evidentemente una certa ammirazione, magari anche un po’ d’invidia – per uno scialacquatore come lui avrebbe potuto essere una soluzione). Il primo è una storia abbastanza leggera, non priva di originalità ma piuttosto forzata, soprattutto nel finale. L’ambiente è quello della malavita inglese, la vicenda verte sulla ricerca del falsario imprendibile, tra ricatti famigliari, storie d’amore, infinite bassezze e vari morti sparati: comunque accettabile.
Nell’estate scorsa ho letto un paio di questi romanzi: Stanza n. 13 del 1924 e Moneta Falsa del 1927. Curiosamente, entrambi trattano di falsari, di riproduttori di banconote false (per i quali Edgar provava evidentemente una certa ammirazione, magari anche un po’ d’invidia – per uno scialacquatore come lui avrebbe potuto essere una soluzione). Il primo è una storia abbastanza leggera, non priva di originalità ma piuttosto forzata, soprattutto nel finale. L’ambiente è quello della malavita inglese, la vicenda verte sulla ricerca del falsario imprendibile, tra ricatti famigliari, storie d’amore, infinite bassezze e vari morti sparati: comunque accettabile.
 Il secondo romanzo è più interessante; nell’edizione inglese si intitola The Forger (Il Falsario), in quella italiana Moneta Falsa; non sarebbe stata difficile o sgradita la traduzione del titolo inglese, tutto sommato.
Il secondo romanzo è più interessante; nell’edizione inglese si intitola The Forger (Il Falsario), in quella italiana Moneta Falsa; non sarebbe stata difficile o sgradita la traduzione del titolo inglese, tutto sommato.
L’ho letto in una edizione del 1935, la prima, comparsa nei Gialli Classici, in un paio di sere: mi si sbriciolava tra le mani, sul lettone, con gran gioia di mia moglie … Il traduttore doveva evidentemente rispettare i dettami fascisti, niente nomi stranieri ma italiani: così ha trasformato i bei nomi inglesi come Basil, Peter e Jane a favore di Basilio, Piero e Gina. Ora, Basilio Bianchi, per fare un esempio generico, è un bel nome e cognome italiano, abbinato con gusto, ma Basilio Hale non lo è; Gina Leith o Jane Leith? Peter Clifton o Piero Clifton? a voi l’ardua sentenza, saggi lettori dei Viandanti. Saranno delle belinate, come si dice anche qui nell’Alto e nel Basso Monferrato, ma per me hanno un valore. La storia invece è più interessante della precedente, e viene dato molto risalto a una presenza femminile, finalmente; in questi gialli inglesi le donne non hanno quasi mai nessuna importanza, qui invece hanno il ruolo di protagoniste.
Non ne ho letti altri perché, a mio modesto parere, il livello dei lavori di Wallace è inferiore a quelli di altri, meno noti e acclamati. Le storie si dipanano con molti colpi di scena, il lettore non si annoia, anzi, fino al finale resta avvinto al testo, e non nascondo di aver apprezzato una certa originalità nelle storie che ho letto: ma poi i finali, almeno quelli di questi due romanzi, lasciano il tempo che trovano, del tipo “e vissero felici e contenti”. Le vicende sono abbastanza truculente, la violenza psicologica è insita in molte pagine, c’è una abbondanza perfino eccessiva di eventi, che mi fa pensare che questi romanzi siano più americani che inglesi (d’altronde Wallace lavorò molto negli Stati Uniti, per conciliare le sue altre occupazioni come commediografo, giornalista, drammaturgo e sceneggiatore). Per capirci, nel romanzo della Tey che ho recensito la volta scorsa non compare un’arma o un fatto di sangue in tutto il libro, ma le sequenze narrative sono appassionanti anche senza queste componenti.
Dare un giudizio su Wallace dopo averne letti solo due titoli è riduttivo, ma mi sembra, da quanto ho letto, che non ci sia un romanzo capolavoro, un “faro” che sovrasta gli altri. Come non ce n’è uno indecente. Insomma, prevale un livello costante di mediocrità, sia pure intelligente, che temo faccia in definitiva somigliare una all’altra le varie storie. Non era di questo genere di autori che volevo scrivere, quando ho cominciato, ma non ho ritenuto giusto saltare Wallace solo perché lo trovo meno intrigante di altri.







 Dopo le scuole dell’obbligo studiò in vari Istituti scolastici in città più grandi e seguì la professione della madre; intorno ai 25 anni, complice il lungo periodo di assistenza sanitaria che dovette fornire alla madre, interruppe il lavoro e cominciò a scrivere romanzi gialli. A volte erano ispirati a fatti da lei vissuti in prima persona nel suo periodo di insegnamento, con ambientazioni assimilabili a quelle conosciute in quei tempi, oppure si trattava di fatti riportati da altri, sui quali la grande fantasia e la profonda cultura della Tey intervenivano con successo. Scrisse dal 1926 al 1952, anno della sua scomparsa.
Dopo le scuole dell’obbligo studiò in vari Istituti scolastici in città più grandi e seguì la professione della madre; intorno ai 25 anni, complice il lungo periodo di assistenza sanitaria che dovette fornire alla madre, interruppe il lavoro e cominciò a scrivere romanzi gialli. A volte erano ispirati a fatti da lei vissuti in prima persona nel suo periodo di insegnamento, con ambientazioni assimilabili a quelle conosciute in quei tempi, oppure si trattava di fatti riportati da altri, sui quali la grande fantasia e la profonda cultura della Tey intervenivano con successo. Scrisse dal 1926 al 1952, anno della sua scomparsa. In Miss Pym, pubblicato tardi in Italia (in Inghilterra come Miss Pym Disposes), la Tey assiste a un’incidente in palestra che poi utilizza come la causa di un decesso nel romanzo, e non prevede ancora la figura dell’Ispettore Alan Grant, futuro punto di riferimento. Il primo romanzo che le procura una certa notorietà è The Man in the Queue (L’uomo in Coda, uscito da noi negli Oscar Mondadori). Qui compare per la prima volta Grant, e il romanzo, benché sia un poliziesco del tutto anomalo, ottiene un ottimo successo di critica e invoglia la Tey a proseguire nella sua carriera.
In Miss Pym, pubblicato tardi in Italia (in Inghilterra come Miss Pym Disposes), la Tey assiste a un’incidente in palestra che poi utilizza come la causa di un decesso nel romanzo, e non prevede ancora la figura dell’Ispettore Alan Grant, futuro punto di riferimento. Il primo romanzo che le procura una certa notorietà è The Man in the Queue (L’uomo in Coda, uscito da noi negli Oscar Mondadori). Qui compare per la prima volta Grant, e il romanzo, benché sia un poliziesco del tutto anomalo, ottiene un ottimo successo di critica e invoglia la Tey a proseguire nella sua carriera. C’è sempre l’Ispettore Grant, ricoverato però in ospedale per una caduta in una botola (mentre inseguiva un ladro), con relative fratture e contusioni. L’avvio può sembrare quello di La finestra sul cortile di Cornell Woolrich, uscito nel 1942 col titolo Ithad to be murder a nome Wiliam Irish (uno degli pseudonimi dell’autore americano) e poi ripubblicato nel 1944 come Rear Window, e infine ben più noto per la versione cinematografica di Alfred Hitchcok, con la splendida Grace Kelly e il bravo James Stewart. Ma il parallelismo finisce lì, con l’incidente che obbliga James Stewart e l’Isp. Grant nel letto di casa il primo e in quello d’ospedale il secondo.
C’è sempre l’Ispettore Grant, ricoverato però in ospedale per una caduta in una botola (mentre inseguiva un ladro), con relative fratture e contusioni. L’avvio può sembrare quello di La finestra sul cortile di Cornell Woolrich, uscito nel 1942 col titolo Ithad to be murder a nome Wiliam Irish (uno degli pseudonimi dell’autore americano) e poi ripubblicato nel 1944 come Rear Window, e infine ben più noto per la versione cinematografica di Alfred Hitchcok, con la splendida Grace Kelly e il bravo James Stewart. Ma il parallelismo finisce lì, con l’incidente che obbliga James Stewart e l’Isp. Grant nel letto di casa il primo e in quello d’ospedale il secondo. Alan Grant nota che l’aspetto di Riccardo III nella stampa non sembra quello di un mostro, capace di uccidere i suoi due nipotini, figli di suo fratello Edoardo morto in battaglia (al quale Riccardo tra l’altro era legatissimo) per evitare che possano subentrargli un giorno come regnanti. E in effetti, rileggendo vari libri nel periodo di degenza, si rende conto di alcune sviste nella narrazione storica, e della controversa figura di Tommaso Moro (Sir Thomas More, o per i cattolici San Tommaso Moro), che pur non essendo presente fisicamente in quegli anni (quando morì Riccardo III, Moro aveva 5 anni) fu un netto propagandista della teoria Tudor che vedeva in Riccardo III un uomo abbietto e meschino, limitandosi a riportare informazioni di seconda o terza mano.
Alan Grant nota che l’aspetto di Riccardo III nella stampa non sembra quello di un mostro, capace di uccidere i suoi due nipotini, figli di suo fratello Edoardo morto in battaglia (al quale Riccardo tra l’altro era legatissimo) per evitare che possano subentrargli un giorno come regnanti. E in effetti, rileggendo vari libri nel periodo di degenza, si rende conto di alcune sviste nella narrazione storica, e della controversa figura di Tommaso Moro (Sir Thomas More, o per i cattolici San Tommaso Moro), che pur non essendo presente fisicamente in quegli anni (quando morì Riccardo III, Moro aveva 5 anni) fu un netto propagandista della teoria Tudor che vedeva in Riccardo III un uomo abbietto e meschino, limitandosi a riportare informazioni di seconda o terza mano.